|
Il
castello di Issogne si
mostra in prima battuta
come un anonimo palazzo
cittadino di tipo
rinascimentale, ed in
effetti l'esterno appare
sobrio spoglio, con le
torri e le mura nude e
segnate solo da qualche
finestra a croce e dal
finto bugnato dipinto
sugli
angoli.
La vera sorpresa è
invece l'interno,
caratterizzato dalla
corte e dal giardino,
abbracciati dai tre
corpi di fabbrica
disposti a ferro di
cavallo e circondati dai
porticati e dalle logge
che vivacizzano la
disposizione degli
ambienti nella struttura
del palazzo.
Esternamente
il castello appare come
una dimora fortificata
dall'aspetto poco
appariscente, senza
particolari decorazioni
o affreschi e con le
torrette angolari poco
più alte del resto
dell'edificio, situato
al centro dell'abitato
di Issogne.
La
pianta del castello è
di forma quadrangolare,
di cui tre lati sono
occupati dall'edificio
stesso e il quarto -
quello orientato verso
sud - è costituito da
un giardino all'italiana
separato dall'esterno da
un semplice muro di
cinta.
 IL
CORTILE E IL PORTICATO
- Il
cortile interno
racchiuso tra i tre lati
dell'edificio e il
giardino è uno degli
ambienti più suggestivi
del castello. Un tempo
vi si accedeva
attraverso il portone
che si apre sulla piazza
del paese e che conduce
sotto il porticato,
mentre attualmente per
motivi pratici si
utilizza l'ingresso
secondario sul lato
ovest, che si affaccia
esternamente su un ampio
prato. IL
CORTILE E IL PORTICATO
- Il
cortile interno
racchiuso tra i tre lati
dell'edificio e il
giardino è uno degli
ambienti più suggestivi
del castello. Un tempo
vi si accedeva
attraverso il portone
che si apre sulla piazza
del paese e che conduce
sotto il porticato,
mentre attualmente per
motivi pratici si
utilizza l'ingresso
secondario sul lato
ovest, che si affaccia
esternamente su un ampio
prato.
Sulle
facciate che si
affacciano sul cortile
si trova il cosiddetto
"miroir pour les
enfants de Challant",
una sequenza di stemmi
affrescati che
raffigurano i diversi
rami della famiglia
Challant e le principali
alleanze matrimoniali
della casata, per
conservarne il ricordo e
trasmetterlo alle future
generazioni. Il muro di
cinta del giardino era
invece decorato con
disegni monocromatici di
saggi ed eroi
dell'antichità, ormai
purtroppo quasi
cancellati.
Al
centro del cortile si
trova la celebre fontana
del melograno, una
vasca di pietra di forma
ottagonale dalla quale
si erge un albero di
melograno interamente in
ferro battuto donde
sgorgano zampilli di
acqua. Curiosamente
l'albero presenta i
frutti del melograno
mentre il fogliame,
forse per ragioni
simboliche volute
dall'artista, è quello
di un'altra pianta: la
quercia. La fontana fu
probabilmente fatta
realizzare da Giorgio di
Challant come dono per
le nozze del suo pupillo
Filiberto di Challant
con Louise d'Aarberg nel
1502 ed ha come detto
una forte valenza
simbolica, volendo unire
la fertilità e l'unità
della famiglia
rappresentate dal
melograno, con i suoi
frutti composti da molti
grani, con la forza e
l'antichità
simboleggiati dalla
quercia. Fra le fronde
del melograno-quercia
sono pure inseriti dei
minuscoli draghi, sempre
in ferro battuto e molto
difficili da scorgere.
Il
lato est del cortile è
occupato da un porticato
con le arcate a tutto
sesto e soffitto con
volta a crociera, sul
quale si apriva il
principale accesso al
castello e dal quale si
accede ora all'interno
dell'edificio. La
decorazione di tipo
geometrico delle
nervature delle volte a
crociera è tipica
dell'arte del
Quattrocento.
Le
lunette del porticato
sono decorate con
affreschi raffiguranti
con realismo e umorismo
botteghe artigiane e
scene di vita quotidiana
del tempo e
rappresentano una
importante testimonianza
iconografica
dell’epoca a cavallo
tra il XV e il XVI
secolo. La lunetta del
corpo di guardia mostra
alcuni soldati seduti ad
un tavolo intenti a
giocare a carte o a tric
trac in compagnia di
alcune prostitute,
mentre le loro armi o
armature (corazze,
balestre e alabarde)
sono appese ad una
rastrelliera addossata
alla parete. Il fornaio
inforna il pane appena
impastato ed il beccaio
gira lo spiedo mentre un
gatto cerca di rubargli
la carne. Nella bottega
del sarto si misurano e
si tagliano pezze di
tessuto, mentre negli
scaffali alle spalle
dello speziale sono
raffigurati numerosi
vasi di medicinali e
altri medicamenti.
La
lunetta del mercato
mostra una affollata
vendita di frutta e
verdura con numerosi
clienti e venditori
abbigliati nei costumi
dell’epoca. Nella
lunetta della bottega
del salumiere sono
infine raffigurate
alcune forme di
formaggio della tipica
forma della fontina,
considerate la più
antica raffigurazione
del tradizionale
formaggio valdostano.
Questi affreschi, oltre
ad una funzione
estetica, avevano
probabilmente anche un
significato celebrativo,
volendo mostrare
l'abbondanza e la pace
ottenute grazie alle
capacità del signore
del castello. L’intero
ciclo è attribuito ad
un artista conosciuto
come maestro Colin, in
virtù di un graffito
nella lunetta del corpo
di guardia che
identifica il
“Magister Collinus”
come autore
dell’opera, autore
anche dei dipinti della
cappella al primo piano
del castello.

PIANO
TERRENO - Il bel
portone in pietra [1]
con il profilo a chiglia
e lo stemma della
famiglia Challant
costituiva, in origine,
l'ingresso principale al
castello; tuttavia
essendo aperto nella
torre orientale del
complesso, si affaccia
sulla piazza del paese
di Issogne e motivi
pratici hanno
consigliato di disporre
l'ingresso ai visitatori
sul lato ovest, come è
ampiamente indicato in
loco.
 Dall'ingresso
primitivo si aveva
accesso diretto al
portico [2] che si apre
sul cortile [A] e sul
giardino [B] e che
distribuisce agli
ambienti della sala da
pranzo, della cucina e
ad un disimpegno che
conduce alle altre ali
del complesso. Dall'ingresso
primitivo si aveva
accesso diretto al
portico [2] che si apre
sul cortile [A] e sul
giardino [B] e che
distribuisce agli
ambienti della sala da
pranzo, della cucina e
ad un disimpegno che
conduce alle altre ali
del complesso.
A
metà circa della
lunghezza del porticato
si apre la porta che
conduce alla cosiddetta
sala da pranzo [3], la
quale comunica
direttamente con la
cucina [4] tramite un
passapiatti aperto nella
parete sotto la cappa
del camino. Il grande
ambiente della cucina è
diviso in due da una
doppia arcata ed è
caratterizzato dalla
presenza di tre grandi
camini. Entrambi gli
ambienti, sala da pranzo
e cucina, sono coperti
con volte che poggiano
su un fitto intreccio di
costoloni in pietra a
vista, i quali si
dipartono da peducci a
forma d'angelo.
Dalla
cucina si accede
direttamente alla scala
di servizio [5] e da
qui, tramite un
disimpegno, ai locali
destinati a dispensa [6]
e alla scala principale
[7] accessibile anche
dalla corte: si tratta
di una scala a
chiocciola in pietra,
tipologia caratteristica
dell'architettura
francese ma
tradizionalmente
presente anche in Valle
d'Aosta, che costituisce
un capolavoro di
maestria tecnica ed uno
splendido esempio di
design.
In
sostanza, i gradini in
pietra da taglio che
formano la scala hanno
la sagoma, come i
gradini di una qualsiasi
scala a chiocciola, di
un settore di corona
circolare, con lo
spessore equivalente
all'altezza del gradino,
ma nella loro parte più
sottile sono conclusi
con un elemento
cilindrico; la
sovrapposizione dei
gradini comporta
l'allineamento in
verticale di questi
elementi cilindrici,
come se fossero dei
piccoli rocchi. In
questo modo si forma la
colonna centrale di
sostegno, mentre i
gradini si aprono a
ventaglio per dare vita
alla scala,
sovrapponendosi tra loro
ed incastrandosi nella
muratura d'ambito per
migliorare la stabilità
della struttura.
A
completare il suggestivo
effetto della scala
contribuisce il soffitto
della rampa continua,
costituito direttamente
dall'intradosso dei
gradini del giro
superiore; e così la
scala è formata da un
unico nastro, che si
dipana attorno alla
colonna centrale,
formato dal susseguirsi
nello spazio di un unico
elemento semplice, il
gradino.
Adiacenti
alla scala principale
troviamo la sala d'onore
del castello [8]
conosciuta anche come
sala di giustizia o Salle
Basse e due camere:
la prima, detta Chambre
des cuisiniers, era
destinata agli addetti
alla cucina [9], e la
seconda, il Cabinet
de l'Apothicaire,
era la camera dello
speziale [10].
Si
accede alla sala di
giustizia tramite una
bussola in legno di
pregevole fattura;
troveremo in altri
locali la presenza di
bussole in legno,
utilizzate per creare
una sorta di anticamera
in quegli ambienti che
si aprono su spazi più
freddi
e per ridurre così le
dispersioni di calore.
L'ambiente della salle
basse, a pianta
rettangolare, è
decorato con stalli in
legno intagliato -i cui
originali si trovano nel
Museo
di Torino - nella parte
inferiore delle
pareti, mentre la parte
soprastante è dipinta a
stoffe e a vignette
inquadrate da colonne,
con la rappresentazione
di vedute di caccia, di
scene di vita cortese e
di paesaggi nordici.
Sulla parete opposta a
quella da cui si accede
alla sala si trova un
grande camino in pietra
la cui cappa è decorata
con lo stemma della
famiglia Challant
affiancato da due grifi,
mentre sulla parete a
sinistra, quella che dà
sulla corte, tra le due
finestre troviamo
affrescato il Giudizio
di Paride. Il soffitto
è realizzato in legno
con travi e travetti
lasciati a vista e
dipinti; le imposte e
gli scuri delle finestre
hanno i pannelli
intagliati a pergamene e
intrecci, come si
ritrova nella gran parte
delle finestre del
castello.
Alla
sinistra del grande
camino si apre una porta
che conduce in una
camera che l'inventario
del 1565, redatto dopo
la morte di René di
Challant, indicava come Petit
Poële [11] e da
questa si passa nella
camera dei Pellegrini - Cabinet
des coquilles [12] e
nel Petit Cabinet près
de celui des coquilles
[13].
Tornando
nel cortile [A], è
possibile accedere ad un
ala del complesso che
contiene la prigione
[14] che nell'inventario
del 1565 era
identificata come Cuisine
de la Buanderie, e
ad altri locali di
servizio: buraterie
prés du four [15], membre
au-dessus du cellier
[16], charnier
[17] e cabinet de
l'argenterie [18],
tutti coperti con volte
a botte.
 Adiacente
all'ingresso a questo
corpo si apre la scala,
coperta con volta
rampante a botte, che
conduce ai sotterranei
del castello [19], in
cui si trovano le
cantine. Per
curiosità ricordiamo
che l'inventario del
1565 riportava i locali
del sotterraneo
denominandoli
nell'ordine: première
cave; petit cave à la
suite de la précedente;
troisième cave et
membre ou l'on tient le
fromage; cave du coté
du four, prè du verger
du soleil couchant;
cellier à gauche. Adiacente
all'ingresso a questo
corpo si apre la scala,
coperta con volta
rampante a botte, che
conduce ai sotterranei
del castello [19], in
cui si trovano le
cantine. Per
curiosità ricordiamo
che l'inventario del
1565 riportava i locali
del sotterraneo
denominandoli
nell'ordine: première
cave; petit cave à la
suite de la précedente;
troisième cave et
membre ou l'on tient le
fromage; cave du coté
du four, prè du verger
du soleil couchant;
cellier à gauche.
Sul
giardino [B] invece si
affaccia la foresteria,
in origine destinata
agli uomini d'arme,
divisa in due ambienti
di cui il maggiore
coperto con volte a
crociera: si tratta
della salle du jardin
[20] e della chambre
du jardin [21].
Entrambi gli ambienti
sono dotati di camino e
hanno accesso anche
dall'esterno del
castello.
PRIMO
PIANO - Salendo al
primo piano con la scala
principale [7] ci si
imbatte nella camera che
è stata di Marguerite
de La Chambre prima e di
Manzia di Braganza dopo
[22] e da questa si
accede alla camera delle
figlie di Manzia [23],
che l'inventario del
1565 riporta come
garde-robe de la chambre
de La Chambre, e
all'adiacente cabinet près
le garde-robe de la
chambre de La Chambre
[24]. Dalla parte
opposta alla camera
delle figlie la camera
di Manzia comunica con
un piccolo ambiente
quadrato voltato a
crociera, l'oratorio di
Marguerite de La Chambre
[25].
Dalla
camera di Manzia di
Braganza, così come
dalla scala principale,
si accede alla sala
d'armi [26] soprastante
alla salle basse. La
sala d'armi, che
nell'inventario del 1565
è denominata chambre de
Savoie, presenta un
grande camino in pietra
decorato con lo stemma
della famiglia Savoia e
con quello Challant - De
La Palud del matrimonio
di Amedeo di Challant e
Anne De La Palud,
genitori di Giorgio di
Challant; tutto intorno
al soffitto corre invece
un fregio in cui lo
stemma Challant è
accoppiato a quello de
La Chambre. Il soffitto
ligneo è realizzato
lasciando a vista travi
e travetti a formare una
struttura a cassettoni.
Dalla
sala d'armi è possibile
accedere al garde-robe
de la chambre de Savoie
[27] ed alla loggia [28]
voltata a crociera, che
conduce, tramite una
serie di disimpegni,
alla camera della torre
[29]. Dalla
loggia si accede anche
ad un lungo corridoio
voltato a crociera che
termina con la bussola
lignea
di accesso alla camera
della contessina Jolanda
[31] presente
nell'inventario del 1565
come chambre des épouses.
È
da rilevare come
curiosità la presenza
di due piccoli vani,
compresi tra la camera
della torre [29] e il
corridoio [30],
antesignani dei moderni
servizi igienici.
Dalla
scala principale si
passa anche ad un locale
di disimpegno [32]
voltato a crociera
collegato alla scala di
servizio [5]; da qui si
accede, passando un
altro disimpegno, alla
chambre de la lingerie
[33].
 Sulla
scala di servizio si
aprono anche altri
ambienti. Innanzi tutto,
la camera di René di
Challant [34],
arricchita da un grande
camino. Questa stanza
contiene un polittico di
cui la tavola centrale,
andata perduta,
rappresentava
presumibilmente la
Madonna in Trono, mentre
gli sportelli intermedi
raffigurano René di
Challant e la moglie
Manzia di Braganza con
le figlie Filiberta ed
Isabella di Challant, e
le tavole laterali
rappresentano la Madonna
e l'arcangelo Gabriele.
Le due tavole
dell'Annunciazione
furono rinvenute nel
castello di Aymavilles
dal senatore Bombrini
quando lo acquistò nel
1882, ma l'intero
polittico si
trovava in
principio nella
cattedrale di Aosta. Sulla
scala di servizio si
aprono anche altri
ambienti. Innanzi tutto,
la camera di René di
Challant [34],
arricchita da un grande
camino. Questa stanza
contiene un polittico di
cui la tavola centrale,
andata perduta,
rappresentava
presumibilmente la
Madonna in Trono, mentre
gli sportelli intermedi
raffigurano René di
Challant e la moglie
Manzia di Braganza con
le figlie Filiberta ed
Isabella di Challant, e
le tavole laterali
rappresentano la Madonna
e l'arcangelo Gabriele.
Le due tavole
dell'Annunciazione
furono rinvenute nel
castello di Aymavilles
dal senatore Bombrini
quando lo acquistò nel
1882, ma l'intero
polittico si
trovava in
principio nella
cattedrale di Aosta.
La
camera di René di
Challant comunica con la
chambre prés de celle
de Challant [35] da una
parte e con la camera
del cardinale Madruzzo
[36] dall'altra. Dalla
camera del cardinale
Madruzzo, riportata
nell'inventario del 1565
come chambre de la
chapelle, si accede
appunto alla cappella, e
da questa alla sagrestia
(cabinet de la chapelle)
[37].
La
cappella è uno degli
ambienti più
interessanti dell'intero
edificio. Il lungo
spazio è ritmato dalla
successione di cinque
volte a crociera,
segnate dai costoloni
riccamente decorati e
riportanti in chiave lo
stemma della famiglia
Challant dipinto e
dorato. Una cancellata
in legno dal disegno
semplice ed elegante
separa l'ambiente in una
parte destinata ai
signori del castello e
in una destinata al
personale di servizio.
L'altare è arricchito
da un trittico fiammingo
e da un paliotto -il
paramento che copre la
parte anteriore
dell'altare- intagliato
a trafori su un fondo
colorato; le finestre
sono valorizzate da
vetrate a colori. Sulla
parete che separa la
cappella dalla camera
del cardinale Madruzzo
si trova un grande
camino che aveva l'ovvia
funzione di mitigare la temperatura
della cappella durante
le funzioni nelle rigide
giornate dell'inverno
valdostano.
SECONDO
PIANO - Si accede al
secondo piano
continuando a salire
lungo la scala a
chiocciola in pietra [7].
In corrispondenza delle
stanze di Marguerite de
La Chambre si trovano
qui i locali riservati a
Giorgio di Challant. La
camera di Giorgio di
Challant [39], detta
anche "camera di
San Maurizio" per
via del soffitto a
cassettoni decorato con
le croci dell'Ordine dei
Cavalieri di San
Maurizio è arredata in
modo analogo alla
sottostante camera di
Marguerite de la Chambre
e comprende un letto a
baldacchino del XVI
secolo e una credenza e
una seggetta
ottocentesche fatte
realizzare da Avondo in
stile tardogotico. La
stanza era scaldata da
un grande camino in
pietra decorato con lo
stemma di Giorgio di
Challant sorretto da un
grifone e un leone.
Da
questa stanza si accede
si accede allo studiolo
di Giorgio di Challant
[40], il garde-robe de
la chambre de
Saint-Maurice, secondo
l'inventario del 1565, e
da qui ancora alla
camera verde o cabinet
de la librerie [41].
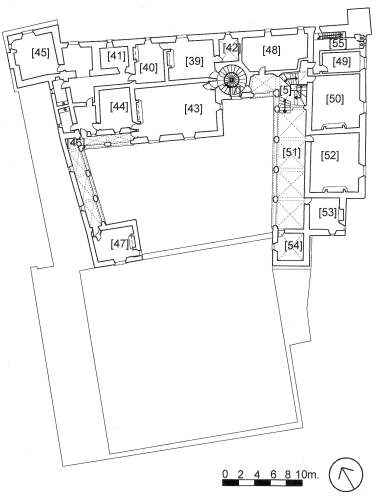 Dalla
camera di Giorgio di
Challant si accede al
suo oratorio privato [42],
collocato in
corrispondenza di quello
di Marguerite. Anche in
questo caso si tratta di
un piccolo locale a
pianta quadrata, coperto
da una volta a crociera
e completamente
affrescato. Gli
affreschi, opera dell’
anonimo artista forse
proveniente da oltralpe
autore anche degli
affreschi
nell’oratorio di
Marguerite de La
Chambre, raffigurano
scene della
crocifissione, della
pietà e della
deposizione di Cristo
nel sepolcro. Giorgio,
committente delle opere,
è ritratto
inginocchiato ai piedi
della croce. Come altri
dipinti del maniero
anche gli affreschi
dell'oratorio di Giorgio
sono stati ridipinti
durante un restauro nel
1936. Dalla
camera di Giorgio di
Challant si accede al
suo oratorio privato [42],
collocato in
corrispondenza di quello
di Marguerite. Anche in
questo caso si tratta di
un piccolo locale a
pianta quadrata, coperto
da una volta a crociera
e completamente
affrescato. Gli
affreschi, opera dell’
anonimo artista forse
proveniente da oltralpe
autore anche degli
affreschi
nell’oratorio di
Marguerite de La
Chambre, raffigurano
scene della
crocifissione, della
pietà e della
deposizione di Cristo
nel sepolcro. Giorgio,
committente delle opere,
è ritratto
inginocchiato ai piedi
della croce. Come altri
dipinti del maniero
anche gli affreschi
dell'oratorio di Giorgio
sono stati ridipinti
durante un restauro nel
1936.
Dalla
scala principale di
accede alla cosiddetta
"sala del re di
Francia" [43],
situata accanto alle
stanze di Giorgio di
Challant e al di sopra
della sala d'armi. Il
nome deriverebbe
dall'aver probabilmente
ospitato il re di
Francia Carlo VIII
durante il suo passaggio
in Italia nel 1494. Nel
XVI secolo questa era la
camera nuziale di Renato
di Challant e di sua
moglie Mencia.
La
camera deve il suo nome
al fatto che si dice che
qui abbia alloggiato
Carlo VIII. Questo è
storicamente verosimile
visto che Carlo
VIII, re di Francia dal
1470 al 1498, scese in
Italia nel 1494 alla
guida di un esercito di
30.000 uomini. L'impresa
fu facile e si dice
infatti che Carlo VIII
abbia conquistato
l'Italia con il gesso
usato per segnare gli
alloggiamenti delle
truppe, ma l'anno
seguente, dopo la
battaglia di Fornovo
Carlo VIII fu costretto,
da una lega formata dai
vari stati in cui
all'epoca era divisa la
penisola italiana, a
ripassare le Alpi.
Il
soffitto della salle du
roi è decorato a
riquadri con rose dorate
e sulla cappa del camino
campeggia lo stemma
gigliato di Francia con
il motto Vive le Roi. Le
pareti della stanza sono
dipinte ad imitare una
tappezzeria.
Dalla
salle du roi si accede
al garde-robe de la
chambre du roi [44] noto
anche come
camera
del Paggio, e da qui
tramite disimpegni si
raggiunge la chambre
haute de la tour,
autrefois appellée du
cuir [45] e due piccoli
locali che il Nigra
chiama gabinetti di
decenza.
La
camera del paggio si
affaccia sulla loggia
[46] voltata a crociera
che collega la salle du
Roi alla chambre de l'empereur
[47] che deve il suo
nome alla permanenza
dell'imperatore
Sigismondo in viaggio
nel 1414 per ritornare
in Germania dall'Italia.
Torniamo
ora alla scala
principale e continuiamo
a salire: ci troviamo
dopo pochi scalini in
una piccola loggia di
raccordo con la scala di
servizio [5] e con un
ampio locale denominato,
come annuncia una
scritta in grossi
caratteri gotici posta
presso la sommità della
scala di servizio,
garde-robe de la
tapysserie [48].
La
scala di servizio arriva
ad un pianerottolo di
sosta posto allo stesso
livello della loggia e
del garde-robe de la
tapysserie, e da qui si
divide in due rampe che
conducono la prima alla
chambre de Saint-Sébastien
[49] e alla chambre de
Miolans [50], e la
seconda alla loggia [51]
voltata a crociera e
alle stanze che su
questa si aprono: la
chambre de Varembon
[52], la chambre de
Valangin [53] e la
camera dello
scriba[54].
Nei
pressi della chambre de
Saint-Sébastien
troviamo altri due
gabinetti di decenza ed
una scala [55] che
conduce alle soffitte
del castello in cui si
trovano la Première
chambre du galetas, il
Dernière garde-robe e
La plus haute chambre
sur la porte du château
près du galetas. I
tetti del castello hanno
manto in lastre di
pietra e in pietra sono
pure le gronde.

GLI
AFFRESCHI - Il
castello di Issogne è
ricco di decorazioni
pittoriche, eseguite da
artisti differenti, non
sempre noti o
identificabili, in un
arco di tempo
relativamente breve, a
cavallo tra la fine del
XV e la prima parte del
XVI secolo.
Entrando
nel castello si
incontrano subito le
lunette delle botteghe
artigiane e del corpo di
guardia sotto le volte
del portico. Questi
affreschi che ci
mostrano la bottega del
sarto, la farmacia, la
macelleria, il corpo di
guardia, il mercato di
frutta e verdura, la
bottega del fornaio,
dello speziale, del
pizzicagnolo sono nitidi
squarci sulla vita
quotidiana dell'epoca:
le scene sono
rappresentate
vivacemente e insieme
con realismo, spontaneità
e a volte con un pizzico
di umorismo. Il ciclo
delle botteghe artigiane
è attribuito al pittore
Colin, che troviamo a
volte citato come
Magister Collinus, in
virtù di un graffito,
presente proprio al di
sopra della panca nella
lunetta del corpo di
guardia, che appunto
indica il suo nome come
autore dell'opera.
Nel
1499 Colin lavora ad
Aosta al decorazione
delle volte nella
collegiata dei Santi
Pietro ed Orso, che era
sottoposta a restauro
per volere del suo
priore, lo stesso
Giorgio di Challant che
dirige anche i lavori
nel castello di Issogne.
Colin giunge in Val
d'Aosta da Ivrea, dove
aveva realizzato,
presumibilmente nel
1493, il fondale della
pala con l'Adorazione
dei Magi per la cappella
dei Tre Re; è un
pittore di buone qualità,
cresciuto in Piemonte
ma, come abbiamo visto,
trasferito in Val
d'Aosta, chiamato da
Giorgio di Challant.
Anche
le pitture della
cappella del primo piano
sono attribuite a Colin:
qui troviamo raffigurati
i Profeti, gli Apostoli
e i quattro Dottori
della Chiesa, che sono
una sorte di
introduzione mistica ai
temi centrali della
storie della vita della
Vergine e dell'infanzia
di Cristo. Nella
cappella le
raffigurazioni
coinvolgono tutti gli
elementi dello spazio
architettonico andando
ad interessare sia il
polittico sia le pareti
e le vetrate, ma sono
compromesse nella qualità
artistica dalle pesanti
ridipinture del restauro
del 1936.
Un
altro maestro impegnato
nei lavori del castello
di Issogne è il Maestro
di Wuillerine. In realtà
non sappiamo molto di
lui, ma studi stilistici
hanno permesso di
individuare la stessa
mano negli affreschi
della salle basse di
Issogne ed in un ex voto
presente nella
collegiata di Sant'Orso
ad Aosta; questo ex voto
è datato al 1514 ed è
dedicato alla guarigione
della povera storpia
Wuillerine, da cui il
nome di Maestro di
Wuillerine. Rileviamo
che anche in questo caso
le maestranze alle
dipendenze di Giorgio di
Challant operano
indifferentemente ad
Issogne o ad Aosta.


Il
Maestro di Wuillerine è
l'autore delle
decorazioni del salone
al piano terra del corpo
centrale del castello
dove Giorgio di Challant
amministrava la
giustizia, la salle
basse. Le decorazioni di
questa sala sono state
portate a termine con
ogni probabilità entro
il 1509, anno della
morte del committente
Giorgio di Challant.
Sulle pareti si
dispiegano finte colonne
e drappi che segnano il
ritmo del racconto
figurato e incorniciano,
unitamente alla finta
balaustra, le scene di
cui gli stessi membri
della famiglia di
Challant sono
protagonisti. Questa
sorta di gioco raggiunge
il suo culmine nella
rappresentazione del
giudizio di Paride, in
cui lo stesso Giorgio
veste i panni pensosi di
Paride chiamato ad
esprimere il suo
giudizio, come tante
volte avrà fatto lo
stesso priore
nell'adempimento delle
sue funzioni.
L'osservazione attenta
delle scene raffigurate
nella sala ci consente
di ipotizzare
verosimilmente che il
capomastro di questo
cantiere pittorico, il
nostro Maestro di
Wuillerine, dovesse
provenire d'oltralpe;
questa affermazione è
giustificata dalla
presenza, nei paesaggi,
di architetture a
graticcio con i tetti
molto spioventi e di
mulini a pale che,
insieme ad un curioso
tromp l'oeil
raffigurante un bruco ed
una mosca sul piano
d'appoggio dello stemma
affrescato sulla cappa
del camino, ci riportano
all'ambito
franco-fiammingo.
Sempre
da oltralpe sembra
provenire anche l'ignoto
artista autore degli
affreschi negli oratori
di Marguerite de la
Chambre al primo piano
ed in quello di Giorgio
di Challant al secondo
piano del complesso; la
corretta attribuzione
degli affreschi è resa
particolarmente
difficoltosa dal pesante
intervento di
ridipintura promosso
dall'allora Ministro
dell'Istruzione
Nazionale Cesare Maria
De Vecchi nel 1935 e
attuato l'anno
successivo. Gli oratori sono due
piccoli ambienti a
pianta quadrata,
sovrapposti ed entrambi
voltati a crociera.
Nell'oratorio al primo
piano, in cui si
ritirava Marguerite de
la Chambre, troviamo
rappresentati
l'Assunzione della
Vergine e i martiri di
Santa Caterina e di
Santa Margherita; nel
soprastante oratorio,
teatro delle devote
meditazioni del priore
Giorgio di Challant, è
invece rappresentata la
Passione di Cristo nelle
scene della
Crocefissione, della
Pietà e della
Deposizione del
Sepolcro.
L'arredo
pittorico del castello
di Issogne spazia anche
all'esterno, andando ad
interessare anche il
cortile. Infatti sulle
facciate interne
dell'edificio troviamo
rappresentato il Miroir
pour les enfants de
Challant, una
rappresentazione degli
stemmi dei diversi rami
della grande famiglia.
Il Miroir è stato
pensato con molteplici
funzioni, quali
l'esaltazione della
casata, la conservazione
della memoria storica
dei legami familiari, il
fornire un esempio da
seguire per le
generazioni future. In
quest'ottica si
inseriscono anche le
decorazioni monocrome
sul muro interno del
giardino. Il tema
proposto è in questo
caso rappresentato da
filosofi e saggi
dell'antichità, forse
in origine affiancati
dai nove prodi e dalle
nove eroine. Questa
incertezza è dovuta al
fatto che in questo caso
le pitture, pur essendo
state recentemente
restaurate, sono pur
tuttavia in gran parte
andate perdute e
possiamo averne
informazione solo
tramite la testimonianza
di chi ci ha preceduti.
CENNI
STORICI
Le
prime notizie relative
alla fortificazione del
luogo in cui sorge il
castello di Issogne
risalgono all'anno 1151,
quando una bolla di papa
Eugenio III documenta la
presenza di un dominio
del vescovo di Aosta in
Issogne. In realtà
sullo stesso sito già
dal I secolo a.C. era
esistito un edificio
romano, di cui si
conservano i muri
perimetrali di alcuni
vani nel sottosuolo
delle cantine
dell'attuale castello.
Nel
1255 la casaforte di
Issogne è ancora sotto
il controllo
ecclesiastico, ed
infatti in quest'anno
l'allora vescovo di
Aosta, Pierre di Pra,
concede un regolamento
di giustizia per la
regolamentazione dei
suoi rapporti con la
comunità e della
convivenza tra gli
abitanti dei territori
del suo dominio. Ma
questo non è
sufficiente per
garantire che la pace
regni nei domini del
vescovo, ed infatti tra
il 1280 e il 1350 circa
un aspro conflitto
contrappone al vescovo i
signori di Verrès, fino
all'evento clou
dell'incendio appiccato
ala casaforte, che
comporterà gravi danni
alla struttura. Come
risultato di tutto ciò
il vescovo di Aosta nel
1379 infeuda della
giurisdizione di Issogne
Ibleto di Challant, che
era signore di Verrès
per aver acquisito i
territorio degli omonimi
signori.
 Ibleto
tra la fine del XIV e
l'inizio del XV secolo
inizia la costruzione di
una casaforte in luogo
della casaforte
vescovile, dando vita ad
una struttura complessa
di torri e corpi di
fabbrica di forme e
dimensioni differenti,
il tutto racchiuso da
una cinta muraria; pare
che il complesso, più
che un castello fosse
una elegante dimora
improntata ai dettami
del gotico cortese -o
internazionale- che si
sviluppò proprio tra la
metà del '300 e la metà
del '400. Ibleto
tra la fine del XIV e
l'inizio del XV secolo
inizia la costruzione di
una casaforte in luogo
della casaforte
vescovile, dando vita ad
una struttura complessa
di torri e corpi di
fabbrica di forme e
dimensioni differenti,
il tutto racchiuso da
una cinta muraria; pare
che il complesso, più
che un castello fosse
una elegante dimora
improntata ai dettami
del gotico cortese -o
internazionale- che si
sviluppò proprio tra la
metà del '300 e la metà
del '400.
Ibleto muore
nel 1409 e nel 1424 il
figlio François di
Challant, del ramo di
Ville-Challand e
Montjovet e signore di
Issogne, ottiene dal
duca di Savoia il titolo
di primo conte di
Issogne. Alla sua morte,
nel 1442, avendo egli
solo tre figlie femmine
si genera una lotta per
la successione che si
conclude nel 1456 con la
vittoria di Jacques del
ramo di Aymavilles, che
diviene così il secondo
conte di Issogne.
Verso
il 1480, sotto il
dominio di Louis di
Challant, figlio di
Jacques, iniziano i
lavori di sistemazione
del castello, e tra i
graffiti del castello
troviamo la
testimonianza dei lavori
in atto in una cantina.
Nel
1487 muore Louis di
Challant lasciando i due
giovani figli Philibert
e Charles, di cui sono
nominati tutori il
priore Giorgio di
Challant-Varey -cugino
di Louis- e della vedova
Marguerite de la
Chambre. In questo
periodo i lavori al
castello procedono con
grande fervore, tanto
che l'anno 1494, secondo
le notizie riportate dai
Computa Priorati
Sancti Ursi, è
quello in cui i lavori
svolti al castello di
Issogne raggiungono il
loro massimo sviluppo;
quando Giorgio di
Challant muore, nel
1509, i lavori sono
ormai terminati e il
signore del castello è
Philibert, che lo abita
insieme alla moglie
Louise d'Aarberg e al
figlio René. È proprio
sotto il dominio di René
di Challant, che nel
1528 prenderà in sposa
Manzia di Braganza, che
il castello assume
definitivamente
l'aspetto di una corte
ricca e raffinata, con
tutti gli arredi, le
suppellettili e le
stoffe preziose
descritte
nell'inventario redatto
nel 1565 dopo la morte
di René.
Nello
stesso anno 1565 i
nobili Madruzzo, della
famiglia dei principi e
dei vescovi di Trento,
subentrano a René di
Challant in virtù del
matrimonio tra Giovanni
Federico di Madruzzo e
Isabella di Challant,
figlia di René. Questo
fatto scatena le ire dei
cugini maschi di
Isabelle, che si
oppongono alla inusitata
successione per linea
femminile e danno luogo
ad un contenzioso che
avrà termine solo nel
1696. Nel contempo la
discendenza Madruzzo si
esaurisce nel 1658 con
la morte di Carlo
Emanuele vescovo di
Trento e l'eredità,
contesa da più parti,
spetta infine ad Henry
de Lenoncourt; ed anche
la dinastia di
Lenoncourt termina a
breve, nel 1693, con la
morte di
Charles-Joseph-Louis, e
i possessi legati al
titolo di conte di
Issogne passano alla
sorella Cristina
Maurizia del Carretto di
Balestrina.
 Ma
come abbiamo accennato
poc'anzi, il 1696 vede
finalmente la fine del
processo, durato 131
anni, che ha
contrapposto i
discendenti dei Madruzzo
e dei cugini di Isabella
di Challant: il
contenzioso è vinto da
questi ultimi, per cui i
del Carretto di
Balestrina devono
restituire l'eredità
del conte René ai
baroni di Challant-Châtillon. Ma
come abbiamo accennato
poc'anzi, il 1696 vede
finalmente la fine del
processo, durato 131
anni, che ha
contrapposto i
discendenti dei Madruzzo
e dei cugini di Isabella
di Challant: il
contenzioso è vinto da
questi ultimi, per cui i
del Carretto di
Balestrina devono
restituire l'eredità
del conte René ai
baroni di Challant-Châtillon.
Un
secolo più tardi, nel
1796, muore François
Maurice, l'ultimo conte
di Challant, e poiché
il figlioletto
Jules-Hyacinthe morirà
nel 1802 in tenera età,
la discendenza si
esaurisce ed inizia un
periodo di decadenza,
segnato innanzitutto da
una Guardia Nazionale
che nel 1800 sottrae
arredi e suppellettili.
Dal
1841, con la morte di
Gabriella di Canalis di
Cumiana, vedova di François
Maurice di Challant, il
castello passa al suo
secondo marito, il conte
Amédée-Louis Passerin
d'Entrèves.
Nel
1862 il castello di
Issogne, ormai privo dei
diritti signorili, viene
acquistato, insieme a
quello di Verrès, da
Alexandre Gaspard di Châtillon,
che aliena una parte
degli arredi originari e
cede il castello, nel
1869, al barone Marius
de Vautheleret,
ingegnere francese
impegnato nello studio
del collegamento
ferroviario tra Aosta ed
Ivrea; ma questi
fallisce e nel 1872 il
castello è messo
all'asta ed acquistato
dal pittore torinese
Vittorio Avondo, che si
impegna nel restauro
architettonico del
castello e nel
riallestimento degli
interni con arredi
originari o con copie
appositamente
commissionate.
Nel
1907 Avondo,
riservandosene
l'usufrutto, dona il
castello di Issogne allo
stato italiano, che ne
diviene proprietario a
tutti gli effetti alla
morte di Avondo, il 9
dicembre del 1910.
Nel
1935 il ministro
dell'Istruzione
Nazionale Cesare Maria
De Vecchi promuove degli
interventi di restauro
che comportano pesanti
ridipinture degli
affreschi degli oratori
e della cappella. Nel
1948, a seguito
dell'approvazione dello
statuto speciale della
Regione Valle d'Aosta,
il castello di Issogne
diviene proprietà
regionale. Nel biennio
1996-1998 gli interni
del castello vengono
riallestiti secondo
l'assetto voluto da
Vittorio Avondo,
ricostruito in base a
foto d'epoca e agli
inventari redatti nel
1907 e nel 1911; vengono
anche attuati interventi
di restauro e
manutenzione di arredi e
di suppellettili, e di
alcuni elementi
architettonici, e
insieme vengono studiati
impianti tecnici
rispondenti alle vigenti
normative di sicurezza,
nonché un impianto di
illuminazione volto alla
valorizzazione degli
ambienti. Nel contempo
viene dato il via al
complesso rilievo
geometrico dell'albero
della fontana:
attualmente nella corte
è ancora presente la
fontana originaria, che
però dovrà essere
sostituito da una copia
per consentirne il
restauro. Non è ancora
chiaro se, una volta
terminato l'intervento
di restauro, l'albero
originale sarà
conservato in museo ad
Aosta o se sarà
riportato.

|