|
Il Monte
Bianco, con
un'altitudine di 4807,
è la montagna più
alta delle Alpi,
d'Italia,
di Francia e
anche d'Europa,
secondo alcune
convenzioni
geografiche, da
cui i soprannomi
di tetto
d'Europa e
di Re delle
Alpi,
condividendo
assieme al monte
Elbrus nel Caucaso un
posto tra le
cosiddette Sette
Vette del Pianeta.
Posta
nel settore
delle Alpi
Nord-occidentali,
lungo la sezione
alpina delle Alpi
Graie,
sulla linea spartiacque tra
la Valle
d'Aosta (val
Veny e val
Ferret in Italia)
e l'Alta
Savoia (valle
dell'Arve in Francia),
nei territori
comunali di Courmayeur e Chamonix-Mont-Blanc,
dà il nome
all'omonimo massiccio,
appartenente
alla
sottosezione
delle Alpi
del Monte Bianco.
Prevalentemente
di natura granitica,
irta di guglie e
di creste,
intagliata da
profondi valloni nei
quali scorrono
numerosi ghiacciai,
è considerata
una montagna di
grande richiamo
per l'alpinismo internazionale e,
dal punto di
vista della
storiografia
alpinistica, la
nascita
dell'alpinismo
stesso coincide
con la data
della sua prima
ascensione: l'8
agosto 1786.
 Dalla
vista italiana,
il Tetto
delle Alpi non
è poi così
appariscente
rispetto alle
altre vette che
lo circondano. A
differenza
dell'altro
grande gigante
delle Alpi, il Monte
Rosa,
visibile in
tutta la Pianura
Padana nord-occidentale
fino alle prime alture
appenniniche,
il monte Bianco
compare solo
all'ultimo
momento lungo la
strada per Courmayeur,
nascosto da una
miriade di
satelliti
minori.
Guardandolo da
ovest è invece
ben visibile da
molto lontano,
dalle alture del Massiccio
Centrale
francese,
da quelle dei Vosgi,
dalle alture del Giura,
dalla Svizzera,
dalla Foresta
Nera. Dalla
vista italiana,
il Tetto
delle Alpi non
è poi così
appariscente
rispetto alle
altre vette che
lo circondano. A
differenza
dell'altro
grande gigante
delle Alpi, il Monte
Rosa,
visibile in
tutta la Pianura
Padana nord-occidentale
fino alle prime alture
appenniniche,
il monte Bianco
compare solo
all'ultimo
momento lungo la
strada per Courmayeur,
nascosto da una
miriade di
satelliti
minori.
Guardandolo da
ovest è invece
ben visibile da
molto lontano,
dalle alture del Massiccio
Centrale
francese,
da quelle dei Vosgi,
dalle alture del Giura,
dalla Svizzera,
dalla Foresta
Nera.
È
perennemente
innevato e si
trova nella
parte centrale
di una catena di
monti che si
estende in
lunghezza per 40 km,
in larghezza
dagli 8 ai 15 km,
su territori di
tre diversi
stati, occupando
una superficie
di circa 645 km²:
il massiccio del
Monte Bianco. Se
si esclude la parete
est del Monte
Rosa di Macugnaga,
la più alta
delle Alpi, in
questo massiccio
sono presenti
alcune tra le
pareti più
elevate del
sistema alpino
quali la Brenva
e la nord delle
Grandes Jorasses
e sono
raggruppate
quaranta cime al
di sopra dei
4.000 m,
con un terzo di
superficie a una
quota non
inferiore ai
3.000 m.
L'azione degli
agenti erosivi
sulle rocce
granitiche ha
formato nel
tempo creste
acuminate e
vette a guglia
di particolare
bellezza che
richiamano nella
regione
alpinisti da
ogni parte del
mondo.
Mentre
il versante
francese
discende
lentamente in
pendio, il
versante
italiano è
formato da una
ripida e
maestosa
muraglia
granitica che
dalle sommità
maggiori
precipita sul
fondo delle
valli Ferret e
Veny. Su questo
versante si
trovano le
pareti da
scalare più
difficili e
impegnative. I
luoghi abitati
sono situati al
disotto dei
2.800 m,
mentre rari e
difficili sono i valichi,
il più basso
dei quali è
quello del Gigante a
3.359 m.
Ecco alcune
emblematiche
cime:
-
Il Dente
del Gigante (4.014 m)
è una delle più
celebri cime. Si
erge per circa
160 m al di
sopra della
caratteristica gengiva di
neve.
-
Le Grandes
Jorasses:
sulla sua parte
sommitale, lunga
circa 1 km,
raggruppa una
sequenza di sei
punte, cinque
delle quali
superano i 4.000 m.
-
L'Aiguille
Noire de
Peuterey (3.773 m)
è uno dei
simboli del
Monte Bianco nel
versante
italiano: si
innalza
direttamente dai
prati della Val
Veny per
2.200 m di
dislivello; è
la cima più
importante della gran
cresta del Peuterey.
-
Il Dôme
du Goûter (4.306 m).
Se la parte
sommitale delle
Grandes Jorasses
è irta di cime,
quella del Dôme
du Goûter è
completamente
piatta ed è la
più estesa di
tutte le Alpi.
-
Il Mont
Dolent (3.820 m)
è una cima
piramidale;
curiosamente la
sua vetta è il
punto d'incontro
delle frontiere
di Italia,
Svizzera e
Francia.
-
le Guglie
di Chamonix,
tra i 3.000 e i
3.842 m,
dominano la
vallata di Chamonix e
rappresentano
uno dei paesaggi
più celebri
delle Alpi
francesi.

Al
di sotto della
calotta
sommitale, sotto
una coltre di
ghiaccio e di
neve spessa dai
16 ai 23 m,
a quota 4.792 m
si trova la cima
rocciosa,
spostata di 40 m
circa più a
ovest rispetto
alla vetta
stessa.
Nell'agosto del 1986 la
misurazione ortometrica rilevata
tramite
satellite
risultava di
4.804 m.
Successivamente
l'altezza
ufficiale è
stata per lungo
tempo 4.807 m,
per poi passare
nel 2001 a
4.810 m;
nel 2003 a
4.808 m;
nel 2005 fu
di 4.808 m;
nel 2007 a
4.810 m;
nel 2009 4.810
m e
nell'ultima
misurazione del
settembre 2015 a
4.808 m, più
basso rispetto
alla precedente
misurazione di
1,29 m.
Queste
variazioni sono
dovute ai venti che
accumulano la neve sulla
cima,
determinandone
conseguentemente
l'altezza. Se
durante l'anno
si registrano
meno giorni
ventosi rispetto
all'anno
precedente, di
conseguenza si
accumulerà meno
neve
condizionandone
l'altezza. A
causa delle
continue
variazioni della
calotta
ghiacciata a
partire dal 2001
ogni due anni
viene fatto un
rilevamento
ufficiale. Le
misurazioni
vengono
effettuate a
cura della
Camera
provinciale dei
geometri
dell'Alta Savoia
in
collaborazione
con una società
specializzata in
rilevamenti
tramite GPS.
Dopo la siccità del
2003 la
misurazione
effettuata nel
mese di
settembre di
quell'anno
attestava
l'altezza a
4.808,45 m
e si constatò
in
quell'occasione
che la cima si
era spostata di
0,75 cm
verso nord-ovest
rispetto alla
posizione del
2001.
Durante
quella campagna
di misurazioni
sono stati
sistemati sulla
calotta
sommitale più
di 500 punti
fissi di
riferimento al
fine di studiare
con precisione
il variare del
volume di
ghiaccio al di
sopra dei 4.800 m
che nel 2003 era
di 14.600 m³,
14.300 m³
nel 2005 per
arrivare ai
24.100 m³
attuali. Il
monte Bianco è
la montagna più
alta di tutta la
catena alpina e
considerata
anche la più
alta dell'Europa.
Tuttavia, se si
considera il Caucaso come
limite
geografico
sud-orientale
del continente
vengono citate
quali vette più
alte d'Europa quelle
situate in territorio
russo e georgiano,
come l'Elbrus che
culmina a 5.642 m,
il Dykh
Tau con
5.203 m, il Shkhara a
5.200 m e
il Kazbek 5.047
m.
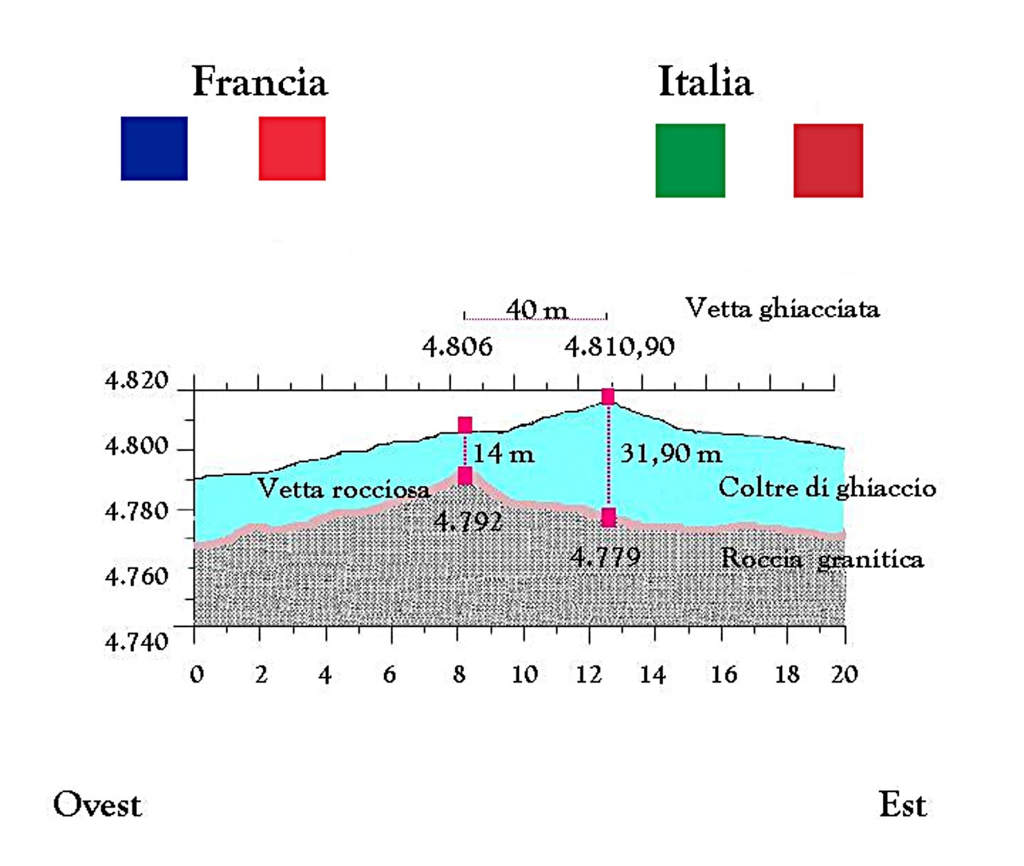
Il
complesso
montuoso delle
Alpi è stato
generato durante
l'Era
terziaria grazie
alla spinta
della placca
tettonica africana e
di quella
asiatica,
attraverso un
processo di
sopraelevazione
verticale. Circa
300 milioni di
anni fa, durante
l'orogenesi ercinica,
una grande
intrusione
granitica formò
la struttura di
base
dell'attuale massiccio
del Monte Bianco.
Moderni metodi
di rilevamento
mettono
oggigiorno in
evidenza come la
sopraelevazione
delle Alpi
prosegue
incessantemente
e supera ancora
gli effetti
dell'erosione.
Attorno al
nucleo granitico
(protogino)
affiorarono rocce
metamorfiche (gneiss, micascisti e calcescisti).
Le rocce più
frequenti sono:
-
i graniti,
che si
distinguono
nella parte
centrale del
Massiccio per le
creste a guglia
e le forme acute
dei rilievi.
Benché molto
dura, questa
roccia non
resiste agli
effetti
dell'erosione
provocata dai
ghiacci.
-
le rocce
metamorfiche,
che circondano i
graniti. Queste
rocce contengono
le stesse
famiglie di
cristalli dei graniti,
ma la loro
resistenza
all'erosione è
minima e
presentano forme
più slanciate
rispetto alle
altre.
-
le rocce
sedimentarie,
che vengono
raggruppate
generalmente in
due grandi
famiglie, ossia
le rocce basiche
(calcari, dolomie,
carniole,
calcescisti), e
le rocce acide (gres, scisti argillosi, quarzite).
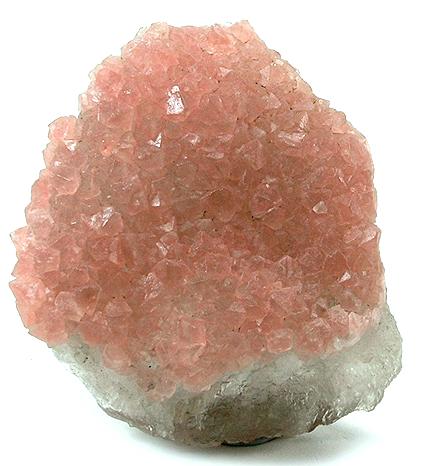 Milioni
di anni dopo
(come già
accennato, da 70
milioni di anni
è tuttora in
evoluzione)
l'orogenesi
alpina sollevò
questa
intrusione di
granito creando
delle fratture
nelle quali si
aprirono crepe e
fessure. La
formazione di
cristalli di
minerali è il
risultato di
un'iniezione d'acqua
mineralizzata in
queste fessure.
Il processo di
crescita dei
quarzi nelle
fessure alpine
non è ancora
completamente
conosciuto. Per
questa ragione
il Monte Bianco
è conosciuto
anche come
località
mineralogica e
dalle sue
pendici proviene
una gran quantità
di minerali diversi,
soprattutto quarzi di
rocca e fluoriti rosa
considerate le
migliori. Milioni
di anni dopo
(come già
accennato, da 70
milioni di anni
è tuttora in
evoluzione)
l'orogenesi
alpina sollevò
questa
intrusione di
granito creando
delle fratture
nelle quali si
aprirono crepe e
fessure. La
formazione di
cristalli di
minerali è il
risultato di
un'iniezione d'acqua
mineralizzata in
queste fessure.
Il processo di
crescita dei
quarzi nelle
fessure alpine
non è ancora
completamente
conosciuto. Per
questa ragione
il Monte Bianco
è conosciuto
anche come
località
mineralogica e
dalle sue
pendici proviene
una gran quantità
di minerali diversi,
soprattutto quarzi di
rocca e fluoriti rosa
considerate le
migliori.
A
testimonianza di
un passato di
sfruttamento
delle risorse
minerarie nel
massiccio, sul
versante
italiano si
trovano ancora
due antiche
miniere di
galena
argentifera e
di blenda,
abbandonate
ormai da tempo.
Una era
conosciuta già
nell'antichità
con il nome di Trou
des Romains e
pare realmente
che il suo
sfruttamento sia
iniziato in epoca
romana;
l'altra, la
miniera del
Miage è
stata
abbandonata
nell'Ottocento,
ed è
posizionata a
3.500 m
d'altezza, con
l'ingresso
direttamente
dalla parete
rocciosa, alle
falde della Tête
Carrée.
A 3,462 m di
quota, a Punta
Helbronner,
sulla Terrazza
dei Ghiacciai si
trova una mostra
permanente di
cristalli
provenienti dal
Massiccio e tra
i 150 minerali
esposti si
possono ammirare
le più
particolari
varietà di quarzo
di rocca,
di morioni
ialini e fumé;
le vesuviane e
i granati rinvenuti
presso Châtillon,
i minerali delle
antiche miniere,
tra i quali i
campioni di oro nativo
di Brusson e
di violano di Saint
Marcel, unica
località di
ritrovamento al
mondo.
GHIACCIAI
- Il
massiccio del
Bianco è una
delle più vaste
zone alpine
ricoperte dai
ghiacci e i suoi
ghiacciai, in
tutto 65,
occupano un'area
di 165 km².
I più estesi
sono localizzati
sul versante
francese dove i
pendii sono meno
ripidi ed
esposti a nord.
Tra questi il
ghiacciaio
dei Bossons e
la mer
de Glace che
arrivano fin
quasi alla
vallata di
Chamonix. Nelle
Alpi
quest'ultimo è
il terzo per
grandezza, con
circa 40 km² di
estensione, dopo
quello di Aletsch nelle Alpi
Bernesi in
Svizzera e
quello del
Gorner nel Monte
Rosa sempre
in Svizzera. Sul
versante
meridionale,
quello italiano,
sono presenti i
ghiacciai del Freney,
della Brenva,
del Miage, del
monte Bianco,
del Triolet, di Pré
de Bar,
per citarne
alcuni. Tra i
paesaggi
glaciali alpini,
quello della Val
Veny è uno dei
più singolari:
due imponenti
fiumane gelate
scendono dalla
cima del Bianco
fino a quota
1.200 m sul
fondo della
valle
sbarrandone
l'ingresso.
Continuando
nella valle
stessa, un'altra
lingua glaciale,
quella del
ghiacciaio del
Miage, irrompe
nella vallata
occupandola per
tutta la
larghezza per
quasi tre km di
lunghezza.
Attualmente
il monte Bianco
è sottoposto a
continui
monitoraggi per
meglio conoscere
e capire quanto
accade ai
ghiacci sulla
calotta
sommitale. A
causa dei
cambiamenti
climatici e del
conseguente
generalizzato
incremento
termico, da
alcuni decenni
quelli del
Bianco (e in
generale lungo
tutto l'arco
alpino) sono in
forte regresso,
specialmente i
più piccoli.
Secondo dati
provenienti
dalle più
recenti
ricerche, negli
ultimi anni si
assiste a un
particolare
fenomeno che fa
aumentare
considerevolmente
la coltre
ghiacciata oltre
i 4.000 m,
tanto che la
cima del monte
è aumentata di
2,15 m e
tutta la calotta
sommitale di
10.000 m³
di ghiaccio.
Secondo i
meteorologi,
questo
incremento è
spiegato dal
fatto che negli
ultimi anni è
aumentato il
numero delle
giornate
caratterizzate
da venti
provenienti da
occidente, ossia
quelli che
spingono verso
le Alpi le
perturbazioni
oceaniche molto
ricche di umidità.
Tale umidità si
trasforma in
neve ad alta
quota, e in
pioggia a quote
più basse.

FLORA
E FAUNA - Nel
territorio su
cui svetta il
monte Bianco i
pendii delle
montagne sono
ripidi e
levigati dai
ghiacciai, con
suoli
prevalentemente
acidi,
conseguentemente
l'ambiente è
piuttosto povero
di flora.
Generalmente le
nevi persistono
oltre i 2.800 m
di altitudine.
Sulla parte
ovest le prime
pendici si
situano sui
3.500 m
mentre
sull'opposto
versante partono
dai fondovalle
valdostani. Date
le condizioni
estreme, la vita
delle specie
vegetali e
animali è molto
limitata, ma tra
i crepacci o al
riparo tra le
pareti
granitiche,
alcune specie di
piante riescono
a sopravvivere
sino ai 4.000 m,
come il ranuncolo
dei ghiacciai.
A quelle
altitudini si
trovano anche
muschi e
licheni. A quote
più basse i
suoli spesso
originano da
calcescisti, o
da rocce
calcaree e
le condizioni di
vita per le
piante sono meno
estreme, pur
rimanendo
caratteristiche
di un severo ambiente di
montagna.
A
queste altitudini prevalgono
le foreste di conifere,
popolate
soprattutto
dall'abete
rosso e
dal larice,
ma localmente
anche dal pino
cembro e
dal pino
uncinato.
Nella prateria alpina
invece si
possono
osservare molte
specie di fiori
tra cui le
vistose
infiorescenze
gialle dell'Hugueninia
tanacetifolia,
una pianta endemica del
settore
occidentale
delle Alpi, e l'Anemone
narcissiflora,
e ancora la
genziana, la
notissima stella
alpina,
la rara campanula gialla.
Nel sottobosco
si può trovare
l'orchidea scarpetta
di Venere,
l'orchidea Dactylorhiza
sambucina,
il giglio martagone,
l'aquilegia,
la viola,
e le comuni
genzianelle blu.
Interessante la
presenza dell'ibrido tra
la genziana
purpurea e la
genziana
punteggiata.
Salendo più in
alto si
incontrano
arbusti come il rododendro
e il mirtillo.
Nel cuore del
massiccio, a
2.175 m s.l.m. si
trova il giardino
botanico più
alto d'Europa:
il Giardino
alpino Saussurea,
che raccoglie e
valorizza le
specie naturali
della flora
caratteristica
del Monte
Bianco.
Prende
il nome dal
fiore Saussurea
alpina,
chiamato così
in onore dello
scienziato
ginevrino Horace-Bénédict
De Saussure,
promotore della
prima ascesa al
monte Bianco nel
1786. I
mammiferi non
possono
sopravvivere a
condizioni così
difficili,
contrariamente a
certe specie di
uccelli. Ad
altitudini più
basse invece la fauna si
presenta più
ricca e variata.
La vicinanza di
due Parchi
Nazionali (Gran
Paradiso e
della Vanoise)
ha contribuito
al mantenimento
e alla
diffusione di
alcune specie
che si erano
ridotte a pochi
esemplari. Tra i mammiferi si
può incontrare
il camoscio
alpino,
che frequenta
sia la prateria
del piano alpino
sia i boschi del
piano subalpino,
dov'è anche
possibile
incontrare due
grandi erbivori come
il cervo e
il capriolo.
Le ampie
pietraie del
piano alpino
vedono la
presenza dello stambecco,
dell'aquila
reale e
della sua
principale fonte
di
alimentazione:
la marmotta.
Un animale che
si incontra sia
nelle praterie
di alta quota
sia nel
fondovalle è la volpe.
Il lupo è stato
segnalato nel
fondovalle.
Nell'area
del massiccio
sono state
osservate ben
184 specie di uccelli e
circa 110 di
queste sono
nidificanti.
Oltre
all'aquila, tra
i rapaci si
possono
avvistare la poiana,
l'astore,
il gheppio.
Talvolta
si può
osservare il
volo circolare
dell'avvoltoio
degli agnelli,
il gipeto estinto
sull'arco alpino
all'inizio del XX
secolo e
reintrodotto di
recente. Sono
presenti anche
il fagiano
di monte,
il francolino
di monte (nella
Savoia e nel Vallese,
ma non più
nella Valle
d'Aosta) e il
cervo
imperiale.
Poche sono
invece le specie
di rettili e
si trovano
comunque a quote
relativamente
basse, tra
questi la natrice dal
collare, mentre
dove il terreno
è pietroso e
soleggiato si può
incontrare l'aspide.

STORIA
- Alla
fine del secolo
XIX nelle
nazioni
dell'arco alpino
vennero creati
reparti speciali
addestrati per
la guerra in
montagna.
L'alpinismo entrò
così a far
parte della
preparazione
militare,
insieme all'uso
degli sci. Il 9
gennaio 1934 ad Aosta venne
costituita la Scuola
Militare di
Alpinismo,
con
distaccamenti a La
Thuile e
Courmayeur. Il
primo comandante
della scuola fu
il tenente
colonnello Luigi
Masini.
La Francia già
si era dotata
nel 1932 del l'ècole
de Haute
Montagne (E.H.M)
con sede a
Chamonix. Il
grandioso
scenario del
gruppo del
Bianco fu teatro
allora delle
spettacolari
esercitazioni
delle scuole
militari dei due
paesi, con
manovre in alta
quota di reparti
specializzati.
Alla scuola di
Aosta, diventata
l'Università
dell'alpinismo,
affluirono dalle
valli alpine
italiane i nomi
migliori
dell'alpinismo e
dello sci
nazionale. In
breve furono
organizzate e
portate a
termine imprese
che all'epoca
destarono grande
ammirazione.
Il
22 giugno 1935 oltre
200 allievi alpieri della
Scuola
prestarono
solenne
giuramento di
fedeltà alla Patria e
al Re sulla
cima del Bianco
scalandolo per
vie diverse,
alcune delle
quali tra le più
impegnative.
L'anno seguente
600 uomini
completamente
armati
attraversarono
la catena delle Grandes
Murailles,
da Valpelline a Valtournanche.
Nel 1937 una
imponente
esercitazione in
alta quota
impegnò
l'intero
battaglione Duca
degli Abruzzi
(500 uomini) che
occupò tutti i
valichi di
confine con la
Francia per
risalire, per
vie diverse,
sulla vetta del Tetto
delle Alpi. Nel 1938 fu
il turno delle
truppe
specializzate
francesi che si
ritrovarono sul
Bianco il 14
luglio.
 La
Scuola Militare
di Alpinismo di
Aosta divenne in
pochi anni
famosa e
conosciuta a
livello
internazionale.
Successivamente,
relativamente
proprio al Monte
Bianco, venne
istituito il Reparto
Autonomo Monte
Bianco,
costituito dagli
elementi
migliori degli alpini.
Il compito del
reparto
(corrispondente
come organico a
una compagnia)
era di
presidiare la
zona del Bianco
dal Colle
della Seigne al Col
Ferret.
Per meglio
organizzarlo, fu
diviso in tre
schieramenti
comandati da
nomi celebri
dell'alpinismo
italiano come Giusto
Gervasutti (il
Miage), Renato
Chabod (il
Gigante) ed Emanuele
Andreis (il
Ferret). La
scuola partecipò
fin dagli esordi
a eventi
agonistici
nell'ambito
degli sport
invernali e
vinse nel 1936 a Garmisch la
gara olimpica di
pattuglia
militare. Nel
triennio 1935-1937 vinse
inoltre il Trofeo
Mezzalama di sci
alpinismo. La
Scuola Militare
di Alpinismo di
Aosta divenne in
pochi anni
famosa e
conosciuta a
livello
internazionale.
Successivamente,
relativamente
proprio al Monte
Bianco, venne
istituito il Reparto
Autonomo Monte
Bianco,
costituito dagli
elementi
migliori degli alpini.
Il compito del
reparto
(corrispondente
come organico a
una compagnia)
era di
presidiare la
zona del Bianco
dal Colle
della Seigne al Col
Ferret.
Per meglio
organizzarlo, fu
diviso in tre
schieramenti
comandati da
nomi celebri
dell'alpinismo
italiano come Giusto
Gervasutti (il
Miage), Renato
Chabod (il
Gigante) ed Emanuele
Andreis (il
Ferret). La
scuola partecipò
fin dagli esordi
a eventi
agonistici
nell'ambito
degli sport
invernali e
vinse nel 1936 a Garmisch la
gara olimpica di
pattuglia
militare. Nel
triennio 1935-1937 vinse
inoltre il Trofeo
Mezzalama di sci
alpinismo.
Nel
corso della seconda
guerra mondiale il
monte Bianco
divenne il campo
di battaglia d'Europa più
alto in quota.
Prima il rifugio
Torino (3375 m),
poi il col
du Midi (3564 m)
furono teatro di
sanguinosi
scontri tra
soldati tedeschi
e partigiani francesi
e italiani.
Ancora prima,
nel 1940, Benito
Mussolini,
fino ad allora
non
belligerante,
persuaso che il
conflitto stava
terminando,
dichiarò guerra
alla Francia. Il
10 giugno 1940 il 5º
Reggimento
alpini e
il Battaglione
Duca degli
Abruzzi
sferrarono
l'attacco
partendo dalle
pendici del
Bianco, in Val
Veny,
verso il col
della Seigne,
incontrando
oltrefrontiera
una forte
resistenza nelle
fortificazioni
francesi a Sélonges in
Val de Glaciers.
Le
ostilità sul
fronte
occidentale
durarono poco
tempo e 14
giorni dopo, con l'armistizio
del 24 giugno
1940,
le operazioni si
fermarono
impedendo
ulteriori
avanzate
italiane.
Quattro anni più
tardi, dopo lo sbarco
alleato in
Normandia e quello
in Provenza nell'agosto
del 1944,
i tedeschi (Wehrmacht)
iniziarono il
ripiegamento
verso la
Germania
risalendo la valle
del Rodano inseguiti
dagli americani
della 7ª Armata
del generale Alexander
Patch e
dai francesi del
generale Jean
de Lattre de
Tassigny.
Alla Resistenza
francese gli
americani
assicuravano
rifornimenti di
viveri e armi.
Dal cielo
piovevano in
Savoia
contenitori
pieni di fucili,
mitra, pistole,
bombe, bazooka,
granate,
munizioni di
ogni tipo. Il 13
agosto il
comando delle forze
libere francesi chiese
il sostegno
della Resistenza
valdostana per
la liberazione
della Savoia.
Dopo
violenti
combattimenti il
presidio di
Chamonix si
arrese il 17
agosto. Due mesi
dopo, in
ottobre, a
difesa del
Massiccio fu
creato in
Francia il battaglione
Mont Blanc,
formato da tre
compagnie nelle
quali
confluirono le
formazioni di
partigiani
dell'alta Valle
dell'Arve, guide
di Chamonix,
maestri di sci e
guide del C.A.F. (Club
Alpin Français).
Il loro compito
era quello di
occupare e
presidiare i
rifugi di alta
quota. Al
rifugio Simond,
al col du Midi,
fu inviata una
sezione di S.E.S
(Section
d'Eclaireurs-Skieurs),
ossia una
sezione di
esploratori con
sci del corpo
dei Cacciatori
alpini francesi al
comando del
tenente Jacques
Rachel.
Approfittando
della mancata
presenza tedesca
sul Massiccio,
gli esploratori
alpini
occuparono il rifugio
Torino,
sul colle
del Gigante nel
versante
italiano. Da
quella posizione
potevano vedere
quanto avveniva
nel fondovalle,
controllando i
movimenti del
fronte opposto
che in quel
periodo si era
stabilizzato sul Piccolo
San Bernardo.
I tedeschi, che
si erano accorti
della loro
presenza,
pianificarono un
attacco per
neutralizzarli.
Il 2 ottobre
1944 una
pattuglia
formata da un
ufficiale e otto Gebirgsjäger (cacciatori alpini
tedeschi) salì
nella notte sul
colle del
Gigante
aspettando il
momento propizio
per attaccare.
Finita
una bufera di
neve che nel
frattempo
imperversava,
verso le 10:30
sferrarono a
sorpresa un
violento attacco
contro gli
occupanti del
rifugio che si
difesero
strenuamente
prima di
arrendersi.
Nella battaglia
persero la vita
tre partigiani
francesi e uno
italiano, gli
altri vennero
fatti
prigionieri e
portati a valle.
Il rifugio venne
poi danneggiato
per renderlo
inutilizzabile
dalla
Resistenza.
Venticinque
giorni dopo la
battaglia, il 27
ottobre, Sandro
Pertini,
futuro
presidente della Repubblica,
ritornando in
Italia dopo
l'esilio, passò
la notte proprio
nel rifugio
Torino
semidistrutto in
quell'azione. Il
giorno
successivo i
partigiani
valdostani lo
accompagnarono
verso zone non
controllate dai
tedeschi.

Nonostante
l'inverno
1944-1945 fosse
stato molto
rigido e con un
susseguirsi
ininterrotto di
bufere di neve
sul Bianco, gli
esploratori
francesi si
inoltravano
spesso sul
confine italiano
per controllare
i movimenti
nemici e
prevenire
eventuali
attacchi. I
tedeschi consci
di questa
continua
sorveglianza
decisero di
occupare la
displuviale fino
al rifugio
Simond sul col
du Midi e
neutralizzare la
teleferica. Dal
comando tedesco
fu così
pianificata
l'operazione Himmelfahrt ("ascensione
al cielo"),
sotto il comando
dell'Oberleutenant Hengster,
esperto
alpinista, che
poteva contare
su 176 uomini
tra ufficiali e
soldati delle
truppe scelte
per
combattimenti in
alta quota. I
loro movimenti e
le loro
esercitazioni
nelle settimane
precedenti
l'attacco furono
seguite
attentamente
dalla Resistenza
valdostana e
segnalate
tempestivamente
sia agli Alleati,
sia via radio in patois
valdostano alla Resistenza
francese.
Il 16 febbraio
1945 i tedeschi
salirono al
rifugio Torino
ma il giorno
stesso furono
individuati
dagli
esploratori
francesi. Il
giorno dopo partì
l'attacco.
I
tedeschi scesero
attraverso la Vallée
Blanche diretti
al rifugio
Simond. Il loro
piano prevedeva
un attacco
centrale
sostenuto dal
grosso delle
forze mentre due
distaccamenti
investivano il
col du Rognon
sulla destra e
sulla sinistra le
rocce del Tacul.
Il tenente
Rachel non volle
farsi
sorprendere e
decise di andare
incontro al
nemico con il
quale prese
contatto già
nella notte.
Dopo un violento
scontro i
francesi
decisero di
ritirarsi
arrampicandosi
sulla cresta del
Rognon, ma la
loro posizione
si rivelò ben
presto
indifendibile.
Ripiegarono
nuovamente
attraversando la
Vallée Blanche
sotto il tiro di
una
mitragliatrice
tedesca.
Raggiunsero le
forze rimaste al
col du Midi e si
arroccarono
rispondendo al
fuoco tedesco.
La radio dei
tedeschi era
fuori uso
cosicché questi
non ebbero modo
di utilizzare
l'artiglieria
mentre la loro
posizione
diventava sempre
più critica.
Decisero di
ritirarsi mentre
un aereo
francese,
comparso
improvvisamente,
buttava granate
dall'alto.
Ripiegarono e si
disposero a
difesa sul colle
del Gigante.
L'attacco a
sorpresa al
rifugio Simond
era fallito. I
tedeschi
subirono la
perdita di nove
soldati mentre i
francesi
contarono una
sola perdita.
A
quel punto i
Transalpini
rafforzarono il
loro presidio
sul Col du Midi
facendo arrivare
mitragliatrici e
due batterie da
montagna. Con
tali obici,
senza poterla
visualizzare,
tentarono di
colpire la funivia
sul mont Fréty,
quella che
collegava il
colle con il
fondovalle, ma
inutilmente.
Furono loro
invece bersaglio
degli obici
tedeschi che dal
monte Fréty
tirarono salve
sul rifugio
Simond e sulla
teleferica.
Riuscirono a
centrarli
entrambi,
spezzando un
cavo di sostegno
della funivia e
distruggendo il
rifugio. Questa
volta fu una
battaglia di
artiglierie. I
francesi
ripresero a
sparare il
giorno dopo
aiutati da un
aereo
ricognitore che
per radio dava
indicazioni
sulla riuscita
dei tiri. Un
colpo centrò il
pilone di
sostegno della
teleferica
mettendola fuori
uso.

Il caso
Vincendon Henry fu
una tragica
vicenda
alpinistica che
coinvolse due
giovani scalatori: Jean
Vincendon, parigino di
24 anni, e François
Henry,
22 anni, di Bruxelles.
I due partirono
il 22 dicembre 1956 per
passare il Capodanno sullo Sperone
della Brenva,
maestosa sommità
rocciosa nel
versante est del
Monte Bianco.
Durante il
percorso di
avvicinamento
incontrano Walter
Bonatti e Silvano
Gheser che
si avviavano
verso
l'ascensione
invernale della Via
della Poire.
L'ascensione di
entrambe le
cordate iniziò
alle 4 del
mattino di
Natale, orario
ideale per
l'itinerario di
Vincendon e
Henry, ma già
troppo tardi per
quello che
avrebbero dovuto
percorrere
Bonatti e
Gheser. Infatti,
dopo qualche ora
di sole le
condizioni del
ghiaccio
peggiorarono e
la cordata di
Bonatti fu
costretta a
discendere sulla
Brenva e a
seguire la
cordata di
Vincendon.
I
quattro
alpinisti
vennero però
colti da una
violenta
tempesta che li
costrinse a un
drammatico
bivacco di 18
ore a quota
4.100 m.
Bonatti e Gheser
riuscirono a
raggiungere il
rifugio Gonella
dove vennero
salvati, il 30
dicembre, dalle
guide alpine Gigi
Panei, Sergio
Viotto, Cesare
Gex e Albino
Pennard.
Gheser, colpito
da gravi
congelamenti,
avrà alcune
dita di entrambi
i piedi e di una
mano amputate.
Vincendon e
Henry, che
optarono per
raggiungere
direttamente
Chamonix,
morirono dopo
cinque giorni di
freddo a 4000 m di
altezza
nell'attesa che
le squadre di
soccorso,
bloccate dal
maltempo, li
prelevassero
(ancora vivi li
raggiungerà un
elicottero che
però cadrà sul
ghiacciaio). I
corpi dei due
giovani
alpinisti furono
recuperati solo
nel marzo del
1957. La
tragedia segnerà
l'istituzione
del PGHM, il
gruppo militare
di soccorso
alpino francese
(Peloton spécialisé
de haute
montagne).
Nel
mese di luglio
del 1961 sul
versante
italiano del
Bianco si consumò
una delle
vicende più
drammatiche
della storia
dell'alpinismo.
Il Pilone
Centrale del
Freney era
una meta molto
ambita dagli
scalatori di
tutto il mondo,
una delle ultime
non ancora
conquistate. La
sua parete di
granito rosso
era
difficilissima
da scalare e per
molti
addirittura
ritenuta
impossibile. Walter
Bonatti e Pierre
Mazeaud,
già entrambi
leggende
dell'alpinismo,
si incontrarono
domenica 9
luglio al Bivacco
della Fourche diretti
verso lo stesso
obiettivo e
decisero di
unire le forze
per tentare la
scalata insieme.

Con
loro Andrea
Oggioni, Roberto
Gallieni, Pierre
Kohlmann, Robert
Guillaume e Antoine
Vieille,
tutti rocciatori
conosciuti ed
esperti. Il
tempo era buono
ed erano
previste
condizioni
stabili. Dopo
una giornata e
mezza di
avvicinamento,
raggiunsero la
Chandelle, ossia
la cuspide
sommitale del
pilone, a 4.500 m
di quota. Quando
mancavano 120 m
alla fine della
scalata, la
cordata fu
investita da
un'improvvisa
bufera di neve
che li bloccò
sulla parete.
Erano le 2 del
pomeriggio di
martedì 11
luglio: il tempo
era cambiato
velocemente come
spesso accade
sul Monte
Bianco. Fu
impossibile
continuare,
bisognava
ritirarsi per
trovare riparo
nel rifugio
Gamba (attuale rifugio
Monzino).
Le guide alpine Gigi
Panei e Alberto
Tassotti furono
i primi a
mettersi alla
ricerca delle
due cordate
Bonatti-Mazeaud
e a comprendere
la disperata
situazione dei
sette alpinisti,
dopo averne
scoperto le
tracce al Bivacco
della Fourche.
A Courmayeur accorsero
giornalisti e
curiosi e tutta
l'Italia seguì
lo sviluppo
della tragedia,
raccontata ora
per ora in
diretta
televisiva e
radiofonica dai
giornalisti
Emilio
Fede e Andrea
Boscione.
Panei, dopo aver
letto sul libro
blu del rifugio
il messaggio di
Bonatti
("Meta il Pilastro
Centrale di
Freney"),
si precipitò
nella sede della Società
delle Guide
Alpine di
Courmayeur,
evitò Emilio
Fede che
avrebbe voluto
intervistarlo, e
andò diretto
verso il
consigliere
delle Guide Toni
Gobbi per
dargli la
notizia.
Partirono subito
i soccorsi,
coordinati da Ulisse
Brunod per
rintracciare gli
alpinisti oramai
bloccati da tre
giorni.
La
mattina del 15
luglio, stremato
dal freddo e
dalla fatica,
perse la vita
Antoine Vieille
ai Rochers
Gruber, dopo 5
bivacchi in
parete. Robert
Guillaume, nella
serata dello
stesso giorno,
precipitò in un
crepaccio del ghiacciaio
del Freney.
Nella notte tra
sabato e
domenica 16
luglio fu Andrea
Oggioni a
perdere la vita
sul colle dell'Innominata a
soli tre quarti
d'ora dal
rifugio Gamba. I
superstiti si
avvicinavano
lentamente alla
salvezza, ma
appena prima di
giungere al
rifugio Pierre
Kohlmann crollò
nella neve privo
di vita. Alle 3
del mattino di
domenica, Walter
Bonatti e
Gallieni
giunsero
finalmente al
rifugio Gamba
dove trovarono
gli uomini delle
squadre di
soccorso. Subito
dopo raggiunsero
Mazeaud rimasto
indietro,
salvandolo.
LA
FUNIVIA DEI
GHIACCIAI - A La
Palud,
nelle vicinanze
di Courmayeur,
ha inizio il
percorso della
funivia del
Monte Bianco
progettato e
ideato
dall'ingegnere
Dino Lora
Totino. In poco
meno di un'ora
si può
raggiungere
Chamonix, in
Francia,
scavalcando
completamente la
catena delle Alpi.
Concepita
inizialmente per
scopi
prevalentemente
militari, venne
inaugurata
nell'estate del 1947 e
fino al 2015 era
suddivisa in sei
diversi
tronconi: da La
Palud si
raggiunge il Pavillon
di Monte Frety a
quota 2.175 m;
si prosegue per
arrivare al rifugio
Torino presso
il Colle del
Gigante a quota
3.330 m,
(quasi 2.000
metri in undici
minuti); si
continua dal
Colle del
Gigante fino a Punta
Helbronner a
quota 3.462 m
da dove si può
godere di una
vista su tutto
l'arco
alpino:
dalla cima del
Monte Bianco al Dente
del Gigante,
ai celebri
"4.000"
d'Europa come
il Cervino,
il Monte
Rosa,
la Grivola,
il Gran
Paradiso.
Continuando da
Punta Helbronner
si prosegue
verso l'Aiguille
du Midi,
il punto più
alto a quota
3.842 m;
dall'Aiguille du
Midi è
possibile
scendere al Plan
de L'Aiguille, a
2.137 m,
per arrivare
infine a
Chamonix. La funivia è
stata ultimata
negli anni
sessanta,
e presenta
alcune soluzioni
tecniche uniche,
come il pilone
sospeso.
Dal 2011 sono
stati effettuati
lavori di
ristrutturazione
dell'intera
tratta italiana
con la
costruzione di
una nuova
stazione di
partenza e
l'eliminazione
di quella presso
il Rifugio
Torino, oltre
alla
sostituzione
delle cabine con
strutture più
moderne e
sicure. I lavori
sono stati
avviati il 10
aprile 2012 e
sono terminati
il 29 maggio
2015. Il 30
maggio 2015 la
funivia
rinnovata ha
riaperto al
pubblico con la
nuova
denominazione di
SkyWay Monte
Bianco. Il
secondo tratto
della nuova
funivia porta
direttamente dal Pavillon
di Monte Frety alla Punta
Helbronner.
In tal modo si
evita la tappa
intermedia al rifugio
Torino,
per cui l'intera
traversata è
adesso suddivisa
in solo cinque
tronconi, e non
più sei come in
precedenza.

PROTEZIONE
DEL MONTE BIANCO
- L'afflusso
di così tanti
turisti, benché
costituisca una
ricchezza, è di
per sé un
pericolo per l'ambiente.
Le comunità
valdostane,
savoiarde e
vallesi, con
l'aiuto delle
regioni e degli
Stati
interessati, con
un approccio
transfrontaliero
alle
problematiche
relative alla
protezione e
valorizzazione
del territorio
hanno trovato un
accordo per dar
vita al progetto Spazio
Monte Bianco.
Questa
iniziativa di
cooperazione
coinvolge 35
comuni tra
Savoia, Alta
Savoia, Valle
d'Aosta e Vallese ed
è coordinato
della Conferenza
Transfrontaliera
Monte
Bianco.
Sotto
la presidenza di
uno dei ministri
dell'ambiente,
la Conferenza
riunisce per
ciascuna nazione
5 rappresentanti
dello Stato e
delle
collettività
territoriali. Complessivamente
lo Spazio
Monte Bianco occupa
una superficie
di circa 2.800 km²
e comprende 35
comuni: 15 in
Savoia e Alta
Savoia, 5 in
Valle d'Aosta e
15 nel Vallese.
In totale
l'intera area
conta circa
100.000
abitanti. Recentemente
il sito del
Massiccio del
Monte Bianco è
stato candidato
presso l'UNESCO per
essere
classificato
come Patrimonio
dell'umanità.
 IL
TRAFORO DEL
MONTE BIANCO - Il traforo del
Monte Bianco è
un tunnel
autostradale che
collega
Courmayeur in
Valle
d'Aosta (Italia)
a Chamonix-Mont-Blanc in
Alta Savoia
(Francia). È
stato costruito
congiuntamente
tra Italia e
Francia. IL
TRAFORO DEL
MONTE BIANCO - Il traforo del
Monte Bianco è
un tunnel
autostradale che
collega
Courmayeur in
Valle
d'Aosta (Italia)
a Chamonix-Mont-Blanc in
Alta Savoia
(Francia). È
stato costruito
congiuntamente
tra Italia e
Francia.
I
lavori di
costruzione
ebbero inizio
nel 1957 e
terminarono nel
1965, anno
dell'apertura.
È composto da
una galleria
unica a doppio
senso di
circolazione e
costituisce una
delle maggiori
vie di trasporto
transalpino. La
sua lunghezza è
di 11,6 km
e la parte più
lunga rimane in
territorio
francese: 7.640 m,
con 3.960 m
in Italia.
L'altitudine è
di 1.381 m
sul versante
italiano, ai
piedi del
ghiacciaio
della Brenva,
mentre raggiunge
a metà galleria
i 1.395 m,
per scendere poi
ai 1.271 m
sul versante
francese, ai
piedi del
ghiacciaio
dei Bossons.
Il piano
stradale del
tunnel non è
orizzontale, ma
di forma concava
per facilitare
il deflusso
dell'acqua.
Rispetto
alla frontiera,
il traforo passa
esattamente
sotto la
verticale
(l'aplomb) de l'Aiguille
du Midi,
dove lo spessore
di copertura
granitica
raggiunge i
2.480 m,
misura record
per le gallerie
autostradali e
ferroviarie.
La
sua altezza è
di 4,35 m e
la sua larghezza
di 8 m
(2x3,5 m
per le corsie, e
2x0,5 m di
passaggio
laterale). Il
raddoppio del
tunnel, già
progettato, non
è mai stato
realizzato per
l'opposizione
degli abitanti
delle valli
interessate,
preoccupati per
un eccessivo
aumento della
circolazione dei
camion e del
conseguente
inquinamento. Il
traforo è stato
inaugurato il 19
luglio 1965 e la
sua gestione, su
base paritetica,
è divisa tra
due società
concessionarie:
l'italiana S.I.T.M.B (Società
italiana per il
Traforo del
Monte Bianco),
creata il 1º
settembre 1957 e
la francese A.T.M.B (Autoroutes
et tunnels du
Mont-Blanc),
creata il 30
aprile 1958.
È rimasto per
lungo tempo il
traforo
autostradale più
lungo al mondo.
Dal 1965 al 2004
vi hanno
transitato 45
milioni di
veicoli con una
media di 3.083
veicoli al
giorno.
I
LABORATORI DEL
MONTE BIANCO - Un
altro aspetto
meno conosciuto
del Monte Bianco
è quello di
studio e di
ricerca.
All'interno
della montagna
infatti si
trovano dei
laboratori molto
importanti
gestiti dall'Istituto
di Fisica dello
Spazio
Interplanetario del CNR (Centro
Nazionale
Ricerche) di Torino,
che lavora in
collaborazione
con l'INFN (Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare)
di Frascati (Roma)
e l'Università
di Milano.
In questi
laboratori si
conducono
ricerche sui raggi
cosmici e
sono serviti da prototipo per
altri due famosi
laboratori:
quello sotto il Gran
Sasso,
negli Appennini centrali,
costruito
successivamente,
e il laboratorio
gestito dal CERN di Ginevra che
studia le particelle
elementari.
In
passato si cercò
di costruirne
anche sulla
cima. Nel 1891,
lo scienziato
francese Pierre
Janssen,
si adoperò per
costruire un centro
di osservazione sulla
vetta, nella
speranza di
effettuare in
modo ottimale
misure e
ricerche sullo spettro
solare.
La mancanza di
fondamenta
solide e i
movimenti
continui del ghiaccio sulla
calotta
sommitale,
indussero nel 1906 gli
scienziati ad
abbandonarlo,
essendo divenuto
pericolante. Nel 1890,
sul versante
francese, a
quota 4.365 m,
il botanico e meteorologo Joseph
Vallot costruì
uno chalet laboratorio
a vocazione
pluridisciplinare,
tra le quali l'astronomia:
l'Osservatorio
Vallot.

Fonte:
|