|
La
straordinaria storia dei Bronzi di Riace, le due sculture di provenienza
greca, databili al V secolo a.C. e oggi conservate al Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria, comincia il 16 agosto del 1972: quel giorno,
il giovane subacqueo dilettante romano Stefano Mariottini, che stava
trascorrendo una vacanza in Calabria, segnalò la presenza di una statua che
spuntava dal fondale marino di Porto Franticchio, a Riace Marina, a
una distanza di circa duecento metri dalla costa e a una profondità di otto. Il
Centro Subacquei dei Carabinieri procedette con le operazioni di recupero,
condotte nei giorni successivi in condizioni difficili e in maniera tutt’altro
che esemplare (occorreva fare in fretta perché la notizia del ritrovamento
si era diffusa): il 21 agosto venne recuperato il Bronzo B, mentre il 22 fu la
volta del Bronzo A. Nella denuncia ufficiale, che fu depositata in
Soprintendenza il 17 agosto 1972, le due statue venivano presentate in questo
modo: “rappresentano delle figure maschili nude, l’una adagiata sul dorso,
con viso ricoperto di barba fluente, a riccioli, a braccia aperte e con una
gamba sopravanzata rispetto all’altra. L’altra statua risulta coricata su un
fianco con una gamba ripiegata e presenta sul braccio sinistro uno scudo. Le
statue sono di colore bruno scuro salvo alcune parti più chiare, si conservano
perfettamente, modellato pulito, privo di incrostazioni evidenti. Le dimensioni
sono all’incirca di 180 cm”.
Le statue erano
integre, ma si presentavano ricoperte di concrezioni marine e si rese
dunque necessaria una prima operazione di pulitura per leggere meglio le opere:
l’intervento fu eseguito al Museo Nazionale di Reggio Calabria, dopodiché i
Bronzi di Riace furono trasferiti a Firenze dove subirono un nuovo
restauro nei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure, eseguito da Renzo
Giachetti ed Edilberto Formigli. Fu necessario un anno solo per terminare
la pulitura, mentre il restauro complessivo durò ben cinque anni. Grazie a
quest’intervento fu possibile acquisire diverse importanti informazioni: per
esempio il fatto che la lega di bronzo era stata ottenuta con due combinazioni
diverse nelle due statue, che per evidenziare alcuni dettagli erano stati
utilizzati argento, avorio e altri materiali preziosi, che alcune saldature
erano state realizzate in epoca diversa. Inoltre, per il Bronzo B la colata
avvenne in un numero maggiore di getti rispetto a quelli che furono necessari
per il Bronzo A.
Alla fine le
due statue erano pronte per essere esposte al pubblico, che poté vederle per la
prima volta in una mostra di grande successo (fece registrare circa
quattrocentomila visitatori) al Museo Archeologico Nazionale di Firenze,
dal 15 dicembre del 1980 al 24 giugno del 1981. Dopo un’altra breve mostra che
si tenne a Roma, al Quirinale, dal 29 giugno al 12 luglio del 1981, fortemente
voluta dall’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, le due sculture
poterono tornare a Reggio Calabria per essere esposte al Museo Archeologico
Nazionale. Ci furono poi altri interventi, uno tra il 1984 e il 1987 e uno tra
il 1992 e il 1995: in quest’ultima occasione, in particolare, le statue furono
parzialmente svuotate delle terre di fusione, ovvero del materiale che era
servito per modellarle. Dopo un nuovo restauro nel 2009-2011, le due statue sono
state dotate nel 2013 di basi antisismiche realizzate in marmo di
Carrara e progettate dall’ingegner Gerardo De Canio al fine di isolare le
statue dalle sollecitazioni sia orizzontali sia verticali (all’interno delle
basi si trovano alcune calotte nelle quali sono state inserite quattro sfere
anch’esse di marmo che svolgono la funzione antisismica assorbendo le
sollecitazioni, con l’aiuto di alcuni elementi che srvono per dissipare le
oscillazioni). Da allora, il pubblico è tornato ad ammirarle nella sala, ad
accesso filtrato e controllato, a loro dedicata all’interno del museo di
Reggio Calabria.

I Bronzi di Riace, alti rispettivamente 198 e 197 centimetri e pesanti
all’incirca 160 kilogrammi ciascuno, raffigurano due uomini con barba e
capelli ricci, completamente nudi, con corpi atletici dai muscoli ben definiti,
le labbra che, nel caso del Bronzo A, si aprono a rivelare i denti,
un’espressione seria, e nella stessa posa: hanno il braccio destro steso lungo
il fianco, il sinistro piegato all’altezza del petto, e si presentano in
contrapposto, ovvero con la gamba sinistra (quella opposta al braccio a riposo)
che avanza, e il peso che viene scaricato su quella destra, tesa.
Il Bronzo B
indossa una cuffia, in greco kyne, che lo qualifica come re o stratega. Non
solo: in antico le due statue indossavano un elmo, e si presentavano con una
lancia o una spada nella mano destra e uno scudo sul braccio sinistro, elementi
che sono andati perduti. 
Sono
interamente in bronzo, fatta eccezione per alcuni particolari: il Bronzo A
presenta denti in argento, i capezzoli di entrambe le statue sono in rame, così
come le labbra e le ciglia, mentre gli occhi sono in calcite bianca, le iridi
(andate perdute) si presentavano anticamente in vetro e la ghiandola lacrimale
è di una pietra rosa. In origine, le due opere erano certamente colorate.
La statua A è
una scultura a tutto tondo realizzata in bronzo. È alta 1,98 m.
Rappresenta un uomo giovane e forte, completamente nudo e in posizione stante.
La distribuzione del peso e la posizione degli arti sono organizzati secondo il
criterio del pondus. La statua cioè, pur non esprimendo intenzione di
movimento ha una posa naturale, non rigida: il peso è sostenuto alla gamba
destra, la sinistra pertanto si presenta leggermente discosta dall’asse del
corpo e il ginocchio è flesso. Il carico del peso sull’arto destro determina
una lieve rotazione del bacino e il conseguente abbassamento
dell’anca sinistra. Per compensare questa asimmetria il torso compie una lieve
curva che a sua volta si ripercuote sulla posizione delle spalle, in cui si
nota un lieve abbassamento della destra rispetto alla sinistra. La testa è
volta e lievemente piegata verso il lato destro.
Il braccio
destro è disteso lungo il corpo, il sinistro è piegato e reca a
metà dell’avambraccio l’anello di impugnatura di uno scudo. Tra gli arti
portanti e quelli liberi c’è quindi una corrispondenza a chiasmo.
La muscolatura vigorosa,
del torace, della schiena e dei fianchi è modellata in modo anatomicamente
corretto. Sulle braccia e sulle mani le vene sono descritte in modo accurato.
Tutto l’apparato muscolare è tonico, teso, immortalato un momento prima della
contrazione.
I particolari
della testa e del volto sono realizzati con accuratezza
estrema. I capelli sono lunghi e ricci, stretti in una fascia che
cinge la fronte. La barba è lunga e folta, anch’essa densa di riccioli. La fronte è
corrugata in atteggiamento concentrato, le ciglia d'argento sottolineano la
linea degli occhi, il cui interno è realizzato in avorio e pasta vitrea, le labbra di rame sono
socchiuse e lasciano vedere i denti realizzati in argento.
L’espressione è quella di un guerriero che si sta preparando alla battaglia.
Le indagini
effettuate nel corso dell’ultimo restauro hanno messo in evidenza sulla testa
dei solchi che indicano in origine la presenza di un elmo,
portato al sommo del capo e non ancora abbassato a coprire il volto.
Altri segni
lungo il braccio destro e la posizione allargata dell’indice e del medio della
relativa mano, lasciano invece supporre che lungo il fianco fosse appoggiata una lancia,
lasciata appunto scorrere tra le due dita.
Nessun dubbio
invece circa la presenza dello scudo sul braccio sinistro.
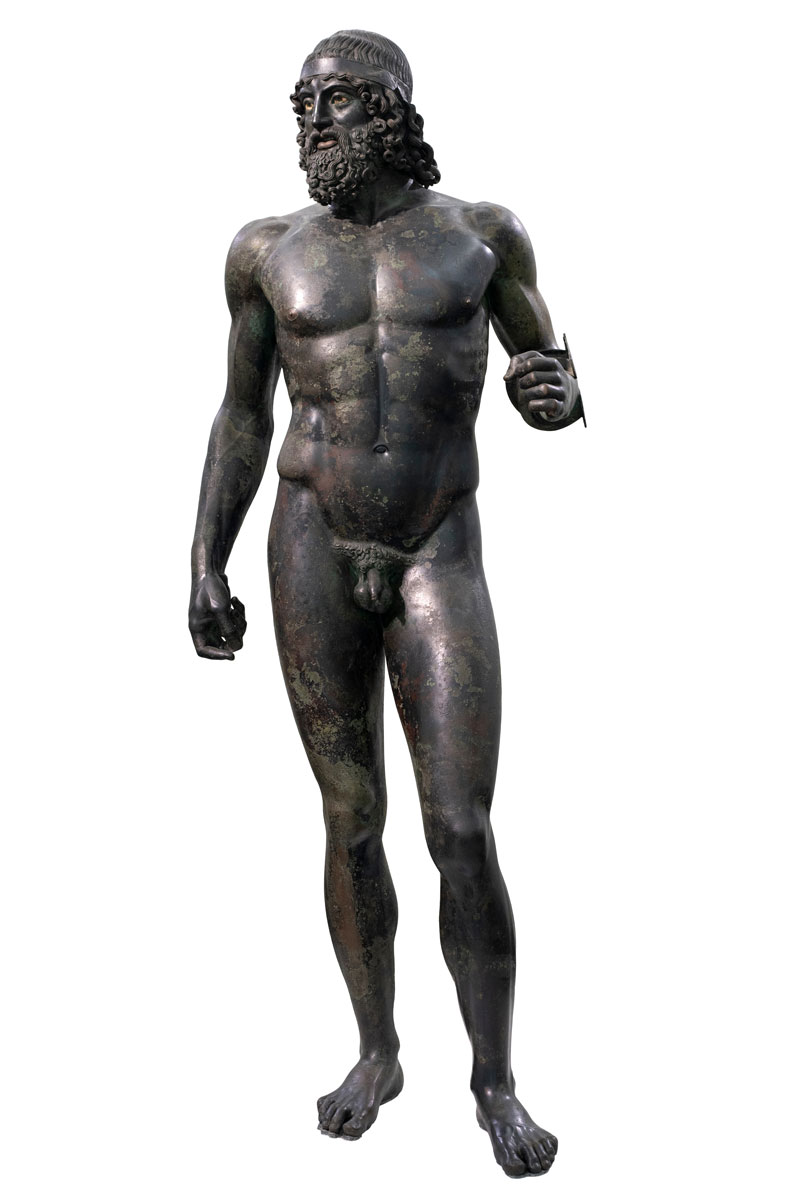
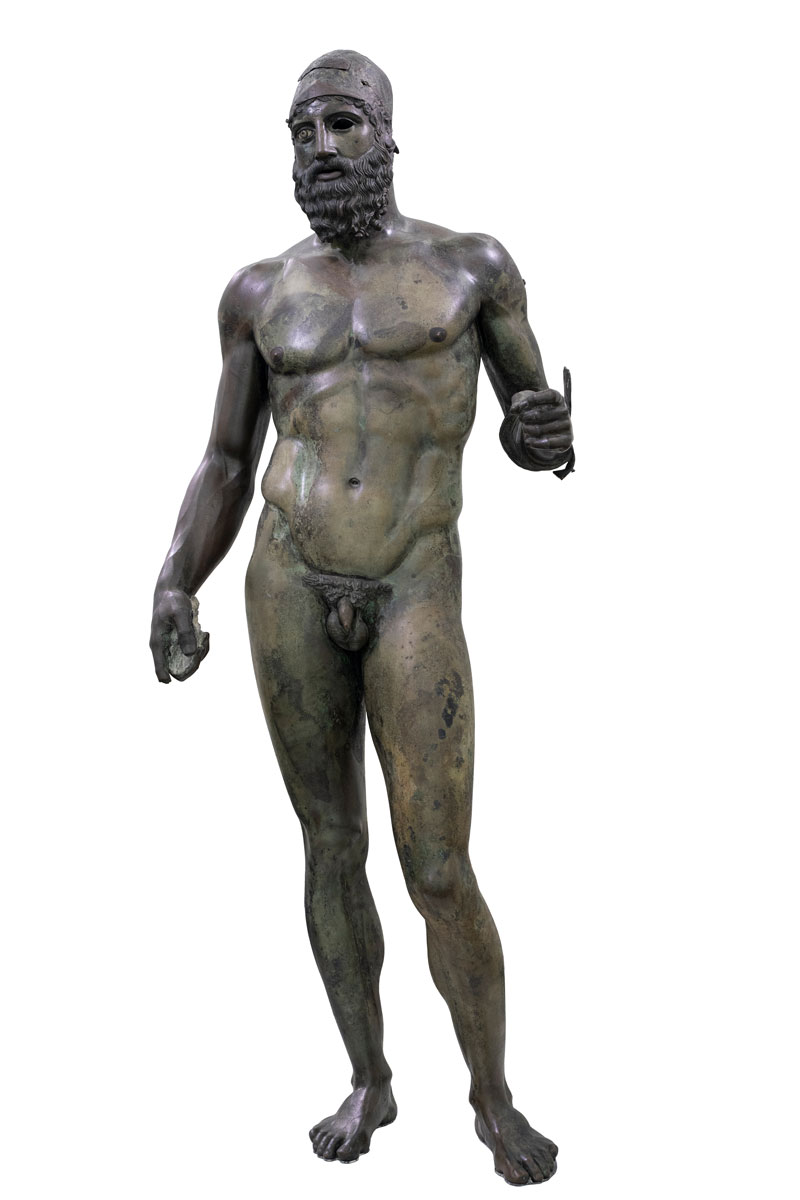
La statua
B, anch’essa in bronzo, è di un solo centimetro più bassa della prima. La struttura e
la posizione del corpo ricalcano in tutto quelle della statua A. Una
lieve differenza si nota nel polso destro, maggiormente flesso rispetto
alla prima statua. Il modellato della testa presenta invece alcune
differenze. La calotta cranica è liscia, non modellata, come se lo scultore
avesse tralasciato la descrizione dei capelli perché coperti da un copricapo.
La tecnica e i materiali utilizzati per le ciglia, gli occhi e le
labbra sono le stesse che per la statua A, in questo caso però la bocca è
chiusa e non si vedono i denti.
Il modellato
della barba è estremamente curato, folta come nella prima statua, è
caratterizzata da ciocche dall’andamento ondulato e meno riccio rispetto
all’esempio precedente.
All'interno
della mano destra, una sorta di anello di stagno lascia presumere che anche
questo personaggio portasse una lancia, ma in posizione più inclinata.
Sempre evidente sull’avambraccio sinistro il sostegno dello scudo.
La similitudine
delle due statueLe statue sono realizzate nella medesima tecnica, hanno
dimensioni pressoché uguali, sono in tutto simili nella postura e recano segni
dei medesimi attributi (elmo/copricapo, lancia, scudo). Sembra pertanto
difficile immaginare che esse possano essere state realizzate da artisti
diversi, e a distanza significativa di tempo l’una dall’altra. Altrettanto
difficile immaginare che esse possano non essere parte di un medesimo
progetto, di un unico gruppo.

Quasi tutti gli
studiosi sono concordi nell’individuare nei Bronzi di Riace due capolavori
dello stile severo, ovvero quella fase di transizione della scultura
greca dallo stile arcaico maturo al pieno classicismo, collocabile in un
periodo che va dal 480 al 450 a.C.: le statue di questo periodo storico (la più
famosa delle quali è probabilmente il Cronide di Capo Artemisio oggi
conservato al Museo Archeologico Nazionale di Atene) si presentano con
proporzioni slanciate, un realismo anatomico più credibile rispetto a quello
dello stile arcaico, un’accurato trattamento dei dettagli anatomici, una resa
altrettanto verosimile di barba e capelli, una certa semplicità (o severità,
da cui il nome con cui è stato convenzionalmente identificato questo stile)
delle forme, interesse per il movimento e una più spiccata caratterizzazione
individuale delle figure.
Le principali
differenze tra le due sculture si osservano nei volti: quello del Bronzo A
(detto anche Il giovane o L’eroe) appare molto più teso,
mentre più pacato è quello del Bronzo B (soprannominato Il vecchio o Lo
stratega). Proprio questa divergenza stilistica (più rigida la statua A, più
morbida la sua compagna) ha fatto pensare ad alcuni studiosi che ci sia un certo
scarto temporale di circa trent’anni tra le due opere. Per il resto, le due
sculture appaiono molto simili, circostanza che in passato ha fatto
supporre che dietro le due opere ci fosse un’unica mano (oggi invece vengono
assegnate a due officine diverse). Per ricostruire la loro storia e provare a
definire la loro identità occorre partire da alcuni punti fermi, riassunti così
dallo studioso Ludovico Rebaudo: “provengono dal medesimo contesto
secondario; hanno le stesse dimensioni; rappresentano lo stesso soggetto
generale secondo lo stesso schema, salvo varianti di dettaglio; sono simili ma
non identici dal punto di vista tecnico; sono diversi dal punto di vista
stilistico; le terre di fusione provengono dallo stesso bacino geologico ma da
microambienti diversi; il rame utilizzato nelle leghe di fusione proviene dal
bacino del Mediterraneo, ma da regioni molto lontane fra loro; il piombo dei
tenoni di fissaggio alle basi proviene dallo stesso giacimento; la datazione
mediante carbonio14 delle componenti organiche dei nuclei colloca l’esecuzione
delle statue nel V secolo a.C., senza possibilità di ulteriori raffinamenti”.
Ne consegue che qualsiasi soluzione proposta per risolvere uno o più
problemi relativi ai Bronzi di Riace deve necessariamente essere compatibile con
tutti questi punti.
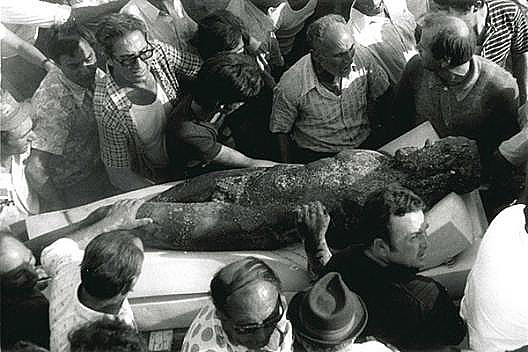 Le
prime analisi su alcuni piccoli campioni delle terre di fusione trovate
all’interno delle statue sembravano risultare compatibili con l’area della
città di Argo, nel Peloponneso, per il Bronzo A, e con il territorio
dell’Attica per il Bronzo B. Era stato dunque ipotizzato che la
prima scultura fosse stata realizzata da un artista argivo, e la seconda da un
ateniese (il professor Paolo Moreno aveva avanzato i nomi degli scultori
Ageladas e Alkamenes), che probabilmente collaborarono alla loro esecuzione in
vista della realizzazione di un unico monumento, lavorando però separatamente,
nelle loro botteghe. Le
prime analisi su alcuni piccoli campioni delle terre di fusione trovate
all’interno delle statue sembravano risultare compatibili con l’area della
città di Argo, nel Peloponneso, per il Bronzo A, e con il territorio
dell’Attica per il Bronzo B. Era stato dunque ipotizzato che la
prima scultura fosse stata realizzata da un artista argivo, e la seconda da un
ateniese (il professor Paolo Moreno aveva avanzato i nomi degli scultori
Ageladas e Alkamenes), che probabilmente collaborarono alla loro esecuzione in
vista della realizzazione di un unico monumento, lavorando però separatamente,
nelle loro botteghe.
Un’analisi
dei materiali più approfondita, condotta durante l’intervento
all’Istituto Centrale per il Restauro di Roma del 1995, ha permesso di
giungere a risultati più raffinati: è stato dunque riscontrato che “la
sostanziale identità nelle percentuali di ossidi la sostanziale identità nelle
percentuali di ossidi e di metalli delle terre rare”, scrive ancora Rebaudo,
“dimostra che le terre provengono dallo stesso bacino geologico, cioè dalla
medesima regione”, e che le differenze strutturali e composizionali fra le
argille, che nella statua A hanno una matrice carbonatica con frammenti
grossolani di quarzo e granitoidi, nella statua B una pasta scura di matrice
argillosa fine con pochi cristalli di quarzo e piccole lamelle micacee,
escludono la provenienza dallo stesso microambiente, cioè dallo stesso
giacimento". Tra le aree di provenienza sono state escluse la Sicilia, la
Magna Grecia, le isole egee, la Grecia settentrionale, Olimpia e Corinto, è
parsa poco probabile l’Attica, mentre risultano più plausibili l’Argolide,
soprattutto la piana orientale di Argo, e la Megaride.
Al momento
possiamo dire con certezza che i due Bronzi sono stati prodotti da due
officine diverse (lo riscontriamo dalla differenza dei getti, che denota
l’utilizzo di tecniche di lavoro diverse), convinzione peraltro rafforzata
dalla diversa provenienza del rame adoperato per i dettagli e dalla diversa
provenienza delle argille. Per quanto riguarda i loro autori, sono state
formulate ulteriori ipotesi oltre a quella del professor Moreno di cui s’è
detto sopra: piuttosto discussa l’ipotesi di Daniele Castrizio, secondo il
quale le sculture sarebbero opera di Pitagora di Reggio, importante
bronzista attivo tra il 480 e il 450 a.C. circa tra il Peloponneso e la Magna
Grecia, autore dell’Auriga di Delfi. L’idea che dietro le due opere ci
sia una sola mano, tuttavia, non è compatibile con le marcate differenze dei
materiali adoperati.
A oggi però
non possiamo formulare dei nomi sicuri, ragion per cui i Bronzi di Riace
rimangono tuttora opere di artisti ignoti, anche se siamo sicuri che fossero
bronzisti di grande esperienza e maestria. E siamo poi certi del fatto che le
due opere, diverse quanto a tecnica, condividessero la stessa cultura. Si
è pertanto rafforzata l’ipotesi che le due opere, pur se realizzate in due
officine diverse, appartenessero in antico allo stesso monumento. Sappiamo
peraltro che in qualche momento della storia i Bronzi di Riace furono trasportati
a Roma, in età imperiale, per un restauro, durante il quale vennero sostituiti
il braccio destro e l’avambraccio sinistro del Bronzo B attraverso un calco
degli originali e con una nuova fusione. Per nascondere l’operazione si rese
necessaria una ridipintura di nero lucido, le cui tracce si possono ancora
osservare oggigiorno.

I Bronzi di
Riace sono la raffigurazione di due opliti, ovvero di due guerrieri,
due soldati della fanteria pesante dell’antica Grecia. Non si tratta però di
opliti qualsiasi: sono due eroi, perché nell’arte della Grecia antica i
comuni mortali venivano raffigurati con i loro vestiti e le loro armature,
mentre la nudità era riservata alle divinità oppure, appunto, a personaggi
eroici. La convinzione più diffusa attualmente è che facessero parte di un unico
monumento. Si è discusso attorno a una notizia dello scrittore e geografo Pausania,
vissuto nel II secolo, che riferisce di un monumento dedicato all’impresa dei Sette
contro Tebe, che si trovava nell’agorà di Argo, e del quale sono stati
individuati effettivamente i resti (in particolare la struttura, le basi di
alcune statue e alcune iscrizioni).
Il mito dei
Sette contro Tebe è raccontato nell’omonima tragedia di Eschilo,
rappresentata per la prima volta ad Atene nel 467 a.C.: è la storia di Eteocle e Polinice,
figli di Edipo, re di Tebe, che si accordarono per spartirsi il potere sul regno
ereditato dal padre, governando ad anni alternati. Tuttavia Eteocle, alla fine
del proprio anno di governo, non volle abbandonare il trono e di conseguenza
Polinice gli mosse guerra. Polinice, che nel frattempo si era recato ad Argo,
assediò dunque la città, mettendo a presidio delle porte i sette suoi
guerrieri più forti: Tideo, Capaneo, Eteocolo, Ippomedonte, Partenopeo,
Anfiarao, e lui stesso a presidio della Settima Porta. Eteocle dovette fare
altrettanto, e schierò Melanippo, Polifonte, Megareo, Iperbio, Attore, Lastene,
e se stesso all’ultima porta, capendo che era suo destino scontrarsi col
fratello. Cominciò la guerra e le sei porte tennero grazie ai difensori che
sconfissero e uccisero tutti i guerrieri di Polinice, ma lo scontro finale tra i
due fratelli si conclude con la morte di entrambi, e con il coro che piange la
loro sorte.
“Ci si
potrebbe domandare”, ha scritto l’archeologo Sergio Rinaldo Tufi,
“perché Argo volesse celebrare con un grande monumento un’impresa così
sfortunata. In realtà, la base nell’agorà della città ospitava quattordici
statue: non solo i Sette, ma anche gli Epigoni, i ‘discendenti’ che, dieci
anni dopo, avevano vendicato quel disastro, distruggendo Tebe. Il riferimento
all’antichissima leggenda assumeva la funzione di proiezione nel mito (cosa
non insolita nella cultura greca) di eventi storici: in questo caso la lunga
lotta con Sparta. Nel 494 a.C. gli argivi erano stati battuti dagli spartani a
Sepeia, e avevano perso il controllo di Tirinto e Micene, ma nel 461, alleati
con Atene, avevano vinto a Oinoe, riprendendosi le due città.
In quella
stessa fase centrale del V secolo, la cupa grandezza dell’antica vicenda dei
Sette ispirava un grande poeta tragico come Eschilo: i Bronzi di Riace furono
eseguiti nel giro di anni in cui veniva completata e poi rappresentata la
tragedia, e il fatto che per uno dei due sia stato individuato un grande autore
argivo ha indotto Paolo Moreno a stabilire un nesso proprio con il monumento
illustrato da Pausania”. Secondo Moreno, infatti, i due personaggi potrebbero
rappresentare Tideo, l’eroe di Argo incontrato da Polinice prima della guerra,
caratterizzato da una ferocissima e sanguinaria violenza (arrivò infatti al
punto di mangiare il cervello del suo avversario, Melanippo), e Anfiarao,
l’unico sopravvissuto. Secondo Castrizio invece le due statue raffigurerebbero
i due contendenti, Eteocle e Polinice: lo studioso legherebbe la sua ipotesi a
una notizia, riportata in età imperiale da Taziano, secondo cui Pitagora da
Reggio avrebbe realizzato un gruppo scultoreo raffigurante proprio i due
fratricidi (l’ipotesi risale al 2011). Altre ipotesi hanno portato ad avanzare
identificazioni con Achille e Patroclo (Franco Maiullari nel 2006), Castore e
Polluce (Giuseppe Roma nel 2007), Erittonio ed Eumolpo (Vinzenz Brinkmann nel
2015).
Si tratta però
di ipotesi per le quali è al momento impossibile trovare riscontro. Se
possiamo essere pressoché certi del fatto che i Bronzi di Riace provenissero da
un unico monumento, risulta per adesso impossibile sulla base dei dati noti stabilire
quale fosse questo monumento e dove si trovasse (con un buon margine di
sicurezza si può però affermare che il luogo del monumento non fosse quello
dove i bronzi furono prodotti). Tuttavia possiamo essere abbastanza sicuri del
fatto che “il modello di riferimento”, afferma Rebaudo, “sono i grandi anathemata [monumenti
votivi-celebrativi, ndr] come il Donario di Lisandro o il Donario degli Arcadi a
Delfi, ai quali erano chiamati a collaborare artefici di scuole, città ed età
diverse e le cui le figure potevano essere inviate al santuario pronte per
essere installate sulle basi, dopo essere state eseguite altrove”.

Fonte
|