|
Palma
di Montechiaro sorge su una collina sulla fascia litoranea, poco
distante da Agrigento.
Il ritrovamento di reperti archeologici maltati risalenti al II
millennio a.C. e la presenza di numerose tombe sicane dimostrano che in
questo territorio, fin da tempi remoti, vi furono insediamenti umani i
cui abitanti erano dediti all'agricoltura e alla pastorizia.
Nel XII
secolo a.C., i rodio-cretesi che
popolavano la fascia costiera tra Gela e
Palma, a scopo difensivo, fortificarono i siti di Castellazzo e Piano
del Vento, punti strategici dai quali è visibile tutta la costa.
L'Itinerarium
Antonini indica l'esistenza di una statio, denominata Daedalium,
sita tra Agrigento e Finziade:
la stazione è stata localizzata in contrada Castellazzo, a Palma di
Montechiaro.
Il
primo atto della storia di Palma (solo nel 1865 la
città si chiamerà Palma di Montechiaro) è la costruzione del castello
Chiaramontano (1353),
che si staglia lungo la costa a metà strada tra Punta Bianca e la foce
del fiume Palma, ad opera di Federico
Prefoglio che di lì a poco passò ai Chiaramonte, da cui
prese il nome.
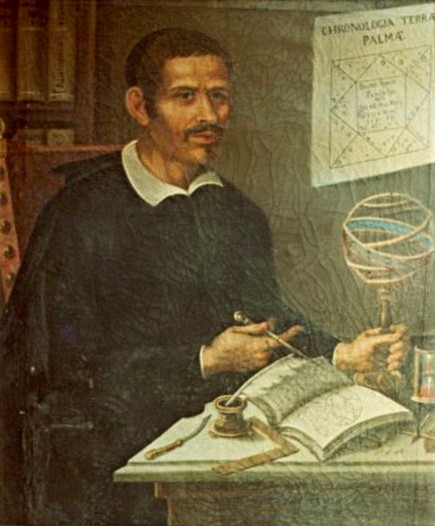 L'atto
di fondazione della città di Palma porta la data del 3 maggio 1637. L'atto
di fondazione della città di Palma porta la data del 3 maggio 1637.
Nello
stesso documento si rileva che a fondare la città fu Carlo
Caro Tomasi dopo avere ottenuto il 16 gennaio 1637 la
"licentia populandi" dal re Filippo
IV di Spagna. Il 3 maggio 1637 fu
posta la prima pietra. La scelta del luogo dove sorse la città fu
davvero felice se, non appena mezzo secolo dopo, l'abate Saint-Non nel
suo Voyage pittoresque ebbe a scrivere "Questa graziosa
cittadina è molto popolata ed ha una posizione incantevole: i dintorni
sono pieni di giardini deliziosi e tutto questo paese è in genere d'una
abbondanza enorme di vigneti, di coltivazioni e di ogni sorta di alberi
da frutta..."
La città
di Palma venne fondata il 3 maggio 1637 nella
baronia di Montechiaro, dai fratelli gemelli Carlo,
Barone Tomasi,
e Giulio, che pochi anni dopo gli sarebbe subentrato nel titolo.
L'effettivo artefice della fondazione fu però un potente zio dei
gemelli, Mario
Tomasi de Caro, capitano del Sant'Uffizio dell'Inquisizione di Licata,
e governatore della stessa città, da cui provenivano anche Carlo e Giulio
Tomasi. Anch'egli, insieme a suo cugino sacerdote Carlo
de Caro era presente alla posa della prima pietra della Chiesa
della Vergine del Rosario.
Il
progetto della città, disegnato secondo un ideale pianta ortogonale, e
ricordato da una relazione redatta dall'astronomo e primo arciprete di
Palma Giovan
Battista Odierna. In una tela che si conserva nella sacrestia
della Chiesa
di Maria Santissima del Rosario, la chiesa madre, si vede
raffigurato l'Odierna al suo tavolo di studio con sullo sfondo, bene in
evidenza, un disegno a pianta quadrata col titolo “Chronologia Terrae
Palmae”.
Il
paese sorge su un'altura rocciosa da cui domina la vallata sottostante
che si protende fino al mare. Spiccano in primo piano, ben visibili
dallo scorrimento veloce che attraversa la vallata, i monumenti storici
del secondo palazzo ducale, (1659), la chiesa madre, (1666), in cima ad
una larga scalinata e il monastero
delle Benedettine, (1637) primo edificio della città.
I primi
abitanti di Palma vennero da Ragusa, città natale dei Tomasi, e da
Agrigento, Licata, Naro, Caltanissetta. A difesa della città dagli
attacchi provenienti dal mare dei pirati saraceni il duca Carlo fece
costruire, dopo avere ottenuto il permesso da Filippo IV di Spagna, una
torre che dedicò a San Carlo. È da registrare che Palma, dopo pochi
anni dalla fondazione, ebbe un notevole aumento demografico tanto che
nel 1652 furono censite 2.470 abitanti e 473 abitazioni.
La
fondazione ex novo di città nella Sicilia del XVI e XVII
secolo è fenomeno di grandi proporzioni; nel caso di Palma, il motivo
della fondazione era una campagna di legittimazione dei Tomasi
di Lampedusa, famiglia nobiliare emergente ma ancora
insufficientemente radicata nel territorio e nell'aristocrazia della
Sicilia. Il capostipite, Mario Tomasi, era giunto in Sicilia al seguito
di Marcantonio
Colonna, che lo aveva nominato Capitano d'armi di Licata, solo
nel 1585.
Solo il suo matrimonio con Francesca Caro di Montechiaro aveva segnato
la sua accettazione nell'alto ceto. L'acquisizione da parte di Carlo,
Barone dal 1616,
della Licentia
populandi nel 1637 con
la conseguente elevazione al titolo di Duca
di Palma, è un evidente passo nella stessa direzione.
 Poco
dopo Carlo Tomasi, dalla salute fragile e da sempre attratto dalla vita
religiosa, lascia il ducato e la fidanzata Rosalia Traina, nipote del
potente Vescovo di Agrigento,
al fratello Giulio, per entrare nell'Ordine dei chierici
regolari teatini. Poco
dopo Carlo Tomasi, dalla salute fragile e da sempre attratto dalla vita
religiosa, lascia il ducato e la fidanzata Rosalia Traina, nipote del
potente Vescovo di Agrigento,
al fratello Giulio, per entrare nell'Ordine dei chierici
regolari teatini.
La dote
della nuova duchessa, numerosi feudi e un largo patrimonio liquido,
permettono il definitivo consolidamento della famiglia Tomasi nei più
alti strati dell'aristocrazia isolana, di cui alla fine doveva risultare
tra le più durature famiglie: è ben noto che il penultimo dei Tomasi
di Lampedusa Giuseppe,
autore de Il
Gattopardo possedeva ancora vaste seppur sterili proprietà
nella zona di Palma, e che vi ambientò gran parte delle vicende del suo
romanzo, appena mascherandone il nome in "Donnafugata".
Pur nel
generale clima di fervore religioso della Sicilia della Controriforma la
famiglia Tomasi spiccava. Palma, infatti, già dalla fondazione fu
concepita come un luogo fortemente spirituale, una "Nuova
Gerusalemme".
Il duca
Giulio (detto il Duca Santo), dopo aver cresciuto nel fervore
religioso i 6 figli avuti dalla moglie nel casto matrimonio, ottenne dal Papa lo
scioglimento in vita del matrimonio dalla moglie e la separazione, dopo
aver rinunciato al ducato e alle gioie del matrimonio, si ritira per
poter vivere gli ultimi anni della sua vita da eremita. La moglie
Rosalia Traina, prima duchessa di Palma, decide a sua volta di entrare
in monastero insieme alle figlie, col nome di Suor Maria Seppellita e lì
rimane sino alla sua morte. Il monastero era stato fortemente voluto da
una delle figlie del Duca, Isabella
Tomasi (la Beata Corbera del Gattopardo).
Il duca
preferì donare addirittura il suo palazzo e la sua cappella privata, e
costruirsi un altro palazzo ai piedi della chiesa madre. Isabella,
entrata nel monastero col nome di Suor Maria Crocifissa della Concezione
divenne una celebre mistica, punto di riferimento dei nobili della
Sicilia e non per il suo fervore religioso e il suo grande misticismo,
nella sua biografia si ricordano innumerevoli tentazioni da parte del
demonio, e lettere colme di fede e devozione. Una causa di
beatificazione è da anni in corso. Nel frattempo alla Tomasi è stato
concesso il titolo di Venerabile. Dei due fratelli maschi il
maggiore seguì lo zio fra i Teatini,
e diventerà infine cardinale.
È oggi venerato dalla Chiesa come San
Giuseppe Maria Tomasi, le sue spoglie si conservano a Roma in Sant'Andrea
della Valle. Il fratello minore sposò la figlia del principe di
Aragona e visse appena il tempo di dare un erede. Muore infatti a 17
anni.
 Al
seguito dei Tomasi arrivò a Palma don Giovanni Battista Hodierna, di Ragusa,
insigne pioniere della scienza ed intellettuale. Al
seguito dei Tomasi arrivò a Palma don Giovanni Battista Hodierna, di Ragusa,
insigne pioniere della scienza ed intellettuale.
Anche
nell'edificazione della città l'aspetto religioso è preponderante;
trent'anni dopo la fondazione Palma conta solo 4.630 abitanti, ma vanta
ben dieci chiese, più il Monastero del SS. Rosario, Il santuario extra
moenia del Calvario meta di processioni, sedici sacerdoti ed
altrettanti chierici, e le chiese risultano al visitatore tutte ben
tenute e dotate di ricchi arredi, tutti assolutamente conformi ai
dettami del recentissimo Concilio di
Trento; ingenti somme sono spese nell'acquisto di reliquie, che
d'altronde attraggono pellegrini anche da luoghi lontani.
L'organizzazione della società laica era basata sulle confraternite.
Nel 1812 Palma
venne eletto a comune autonomo.
L'11
luglio del 1943,
subito dopo lo sbarco
anglo-americano in Sicilia, la 3ª Divisione estese la testa di
ponte della Settima
Armata da Licata verso
ovest.
La
Settima Fanteria, dopo una dura battaglia casa per casa, spinse i
difensori italiani fuori da Palma di Montechiaro. Nello stesso tempo, il
Comando Combat A e la 2ª Divisione Armata, si unirono alla 3ª, fecero
un attacco alla successiva città di Naro.
Subisce il 24 settembre 1943 un massacro della popolazione che
protestava contro il richiamo alle armi, da parte di alcuni reparti
militari americani.
Nel
dopoguerra, diverrà terra di forte emigrazione, specie verso il nord
Italia ed i paesi dell'Europa Occidentale.
Chiesa
di Maria Santissima del Rosario
La
chiesa madre di Maria Santissima del Rosario è l'edificio sacro più
importante di tutte le chiese della cittadina in provincia di Agrigento,
che, con la sua grandiosa mole in cima ad un'ampia scalinata rappresenta
una delle opere più rappresentative e significative del barocco
siciliano. Fu fatta edificare dalla famiglia dei Tomasi di
Lampedusa, fondatori e feudatari della città.
La
storia della chiesa accompagna la storia stessa del centro abitato che
fu fondato nel 1637, nell'ambito del vasto fenomeno di ripopolamento dei
latifondi dell'isola da parte de possidenti nobiliari. Essa sorge ove
prima era situata la chiesetta di San Giuseppe che fu fondata nel 1644
dal ragusano don Vincenzo Ottaviano, venuto a Palma con i Tomasi e fu
poi demolita. A ricordo fu costruita nella nuova chiesa una cappella
consacrata a San Giuseppe.
L'atto
di fondazione della nuova Matrice risale al 2 ottobre 1666. La
progettazione della nuova chiesa fu di angelo Italia, architetto,
scultore.
Il
titolo di chiesa madre era appartenuto per breve tempo alla cappella
palatina del primitivo palazzo ducale - poi divenuto monastero - in
seguito fu trasferito presso la chiesa di Santa Rosalia (ormai in
rovina). L'attuale edificio fu voluto e finanziato da Giulio
Tomasi come si evince dall'atto notarile stipulato il 2
ottobre 1666 presso il notaio Giuseppe Cappello da Licata. Per
testamento il nobile lasciò un legato di mille onze perché
se ne portasse a termine il perfezionamento.
La
realizzazione della chiesa fu affidata al palmese Francesco Scicolone e
all'ingegnere che sovraintendeva ai lavori tale Pennica da Girgenti. La
facciata fu successivamente progettata da Angelo
Italia, uno dei primi architetti barocchi operanti in Sicilia.

Posta
sulla sommità di un'ampia scalinata, è caratterizzata da una facciata,
realizzata con conci di pietra delle cave del Cassarino (una contrada
vicino la cittadina), presenta due ordini soprapposti di colonne che
rilevano dalla muratura e frontoni spezzati con un portale centrale e da
due portali minori sormontati da due torri campanarie. La chiesa è a
pianta longitudinale con tre navate, transetto e cupola
L'interno
del duomo,vasto, a tre ampie navate separate da delle tozze colonne in
marmo rosso con un capitolo in stile dorico e con un'ariosa cupola sul
transetto rivela un movimentato scenario decorativo in stucco di sapore
neoclassico. In fondo alle navate è l'ampio presbiterio, cinto una
volta da splendide inferriate (ormai tolte secondo le nuove normative
pastorali).E due ricche cappelle intitolate a Maria Addolorata (ma
comunemente chiamato cappella del Santissimo Sacramento perché si può
trovare il tabernacolo contenente Gesù Eucaristia), e la seconda
cappella è dedicata alla Madonna del Rosario (entrambe le navate hanno
delle porticine nelle due cappelle per entrare nelle rispettive
confraternite). Nella prima cappella a sinistra del portone principale
si trova la Madonna di Fatima e l'urna contenente le reliquie di San
Traspadano quest'ultime donate a Carlo Tomasi, nel 1666, dal
cardinale Sforza Pallavicini, e basso a sinistra sempre nella stessa
cappella si trovano le spoglie di Don Giovanni Battista Odierna invece
nella prima cappella a destra dell'entrata si trova l'altare dedicato a San
Giuseppe. Numerose sono le reliquie conservate tra le quali
quelle di Santa
Cecilia, San
Luciano, San
Bonifacio, San
Pio da Pietrelcina, Sant'Emiliano, Sant'Elia, San
Clemente, San
Celso e molte altre reliquie di Santi.
 L'altare
maggiore è opera del palermitano Giuseppe Allegra; la cantoria
dell'organo in legno scolpito è di Calogero Provenzani, padre di
Domenico. L'altare
maggiore è opera del palermitano Giuseppe Allegra; la cantoria
dell'organo in legno scolpito è di Calogero Provenzani, padre di
Domenico.
Numerosi
e pregevoli sono i dipinti custoditi nella chiesa e che sono stati
realizzati da Domenico
Provenzani che li esegui nel 1784-1785 insieme al suo
maestro Gaspare
Serenari e Raffaele
Manzelli che vi lavorò nella seconda metà dell'800.
I
dipinti del Provenzani che si trovano nella Matrice sono: Il cuore di
Gesù con San Filippo Neri, San Camillo de Lellis e San Calcedonio, il
quadrone della Madonna dell'abbondanza con Santa Rita, San Paolo ed
altri santi (quest'ultimo non più esistente), il quadro di San
Gioacchino, Sant'Anna e Maria Bambina, il sacrificio del toro (affresco
nella volta della cappella del SS. Sacramento). A Gaspare Serenari,
allievo di Corrado
Giaquinto, si attribuisce per tradizione il quadrone
dell'incoronazione dell'Immacolata. Invece a Raffaele Manzelli
appartengono i quadri del soffitto che sono: la Trinità, gli
Evangelisti (nei peduncoli della cupola, la Trasfigurazione (nel
cappellone,), Gesù che offre l'eucarestia e molto altri. Ancora al
Manzelli appartengono i due quadri delle pareti del coro: il pagamento
di Giuda, Gesù nell'orto del Getsemani e il quadrone dell'altare
maggiore raffigurante la Madonna del Rosario con il cardinale Giuseppe
Maria Tomasi, rifacimento analogo del quadro bruciato anni prima, fatto
da Domenico Provenzani. Altri quadri che si trovano in sacrestia sono
attribuiti a Domenico Provenzani (senior) e raffigurano: il martirio di
San Traspadano e poi numerosi ritratti dei duchi della stessa cittadina
e i vari quadri degli Arcipreti, e un notevole quadro di Giulio Tomasi
(il duca Santo) di cui si dà una riproduzione fotografica reale e
inedita.
Disposti
a croce ai lati dell'edificio furono costruiti i l'Oratorio
del Santissimo Sacramento e l'Oratorio
della Vergine del Rosario.
Confraternita
della Vergine del Rosario - Altrimenti noto come Oratorio della
Beatissima Vergine del Santo Rosario o Oratorio del Santissimo
Rosario, l'ambiente ubicato sul lato est è dedicato alla patrona della
Terra di Palma. Sede dell'omonima confraternita istituita il 5 settembre
del 1638 dal duca Don Giulio Tomasi fino a tutto il '700. Qui, al
rintocco dell'Ave Maria, i confratelli si riunivano per la recita del
Rosario. L'edificio presenta una pianta rettangolare ed una volta
a botte arricchita di affreschi raffiguranti scene bibliche.
Tutto l'interno è impreziosito da una raffinata decorazione in stucco,
affreschi e tele di Domenico
Provenzani e un dipinto d'autore ignoto raffigurante la Vergine
del Rosario, opera già restaurata dall'artista palmese.
Confraternita
del Santissimo Sacramento - La confraternita del Santissimo
Sacramento fu fatta erigere nel 1638 da Carlo Tomasi, fratello di don
Giulio. Tra la fine del 600 e l'inizio del 700 risale la magnificenza
dell'arte che arricchisce l'antico oratorio ai cui confrati hanno
delegato la promozione della ricorrenza del Corpus Domini, della
processione del Venerdì Santo e della Pasqua di Resurrezione con il
tradizionale U Scontru. All'interno si conservano autentici tesori tra
cui una pala centrale, le tele del pittore Domenico Agresta, gli
affreschi, gli scanni lignei lavorati, calici, ostensori, pissidi,
turiboli con navetta, impronte, insegne raffiguranti il SS Sacramento,
aureole, statue del Cristo Risorto e del Cristo Morto. Ed inoltre vi si
conserva l'Urna Santa, opera di maestranze locali o siciliane ed,
infine, una ricca cornice lignea che incastona la pala sull'altare
maggiore, opera del bravo ebanista don Calogero Provenzani, padre del
famoso pittore dei Gattopardi Domenico Provenzani. La Confraternita del
SS Sacramento ebbe una ventata di rinnovamento tra il 1960 ed il 1962
sotto la guida di Giuseppe D'Orsi, chiamato dal popolo palmese Pinu
Piddru D'Orsi. Ma la svolta positiva per la sua salvaguardia è coincisa
negli ultimi anni con l'avvento degli ultimi due Governatori Calogero
Croce Paternò e Giuseppe Alotto.L'Oratorio, infatti, è stato
ripristinato per la sua fruizione, è stata avviata la pulitura della
pala centrale e delle tele, è stato riaperto al popolo cattolico e non
solo, con la possibilità di potere ammirare la cripta ed i simulacri in
cartapesta con le statue del Cristo Morto e del Cristo Risorto.
Monastero
delle Benedettine

Costruito
tra il 1653 e il 1659, inglobò il primo palazzo ducale e accolse con la
regola cassinese anche le figlie di Giulio, II duca di Palma, e in
seguito anche la moglie Rosalia Traina. Si trova su una semicircolare e
impervia gradinata, in una piazza quadrata con le strade che si
incrociano nel luogo che un tempo era segnato dalla colonna con la
croce. Venne inaugurato il 12 giugno 1659.
Il
monastero ha un aspetto semplice con finestre prive di decorazioni. Sul
cortile interno, invece, si affacciano delle finestre decorate in stile
barocco. All'interno il parlatorio ha volte a botte da cui si accede ad
un giardino ricco di alberi in cui è sistemata una scultura della
Madonna con San Benedetto.
Le
suore custodiscono, inoltre, la Madonna della Colomba Rosata e l'urna
della venerabile Maria
Crocifissa. Ancora oggi è uno dei pochi monasteri di clausura in
Sicilia, il cui accesso è impedito quasi a chiunque.
Calvario
In
siciliano: u'ghettu dè malati ma chiamato dalla popolazione locale u'cravaniu
(il calvario), all'ingresso del paese, dopo il parco
archeologico della Zubbia, si scorge la collina detta
"Calvario" con i ruderi dell'antica chiesa
di Santa Maria della Luce (1650), anch'essa dalle forme
barocche, dove c'è una botola nel pavimento della chiesa; di sotto sono
ancora presenti e rinchiusi i corpi delle persone lì ricoverate e morte
di peste del tra il 1550 e 1700
Il
Calvario segna spiritualmente l'ambiente e la storia di Palma. Infatti, Giulio
Tomasi volle riproporre nella realtà locale il percorso di
Gesù dal palazzo di Pilato al Golgota, collegando in un itinerario
ideale segnato da stazioni, il centro abitato con la solitudine della
collina del Calvario. Il Santo Duca, otteneva, come per i pellegrini
della Terra Santa, l'indulgenza plenaria per quanti avessero percorso il
tragitto sino alla collina del Calvario, dove nella chiesa di Santa
Maria della Luce era custodita una copia della Sacra Sindone donata a
Carlo Tomasi, Primo duca di Palma e teatino a Roma, dall'infanta Maria
di Savoia. Tale reliquia oggi viene conservata nella Chiesa del
Collegio.
L'eremo
fu inizialmente abitato dai preti Romiti e successivamente dall'ordine
dei Mercedari, preposto al riscatto dei cristiani prigionieri dei
pirati.
Inoltre,
per la sua possente struttura, quasi di fortezza e per la sua posizione
dominante, serviva come punto privilegiato per l'osservazione dell'ampia
valle del fiume Palma e della costa.
Palazzo
ducale
 Il
palazzo ducale fu costruito dopo che il primo venne inglobato nel
monastero delle Benedettine (1653-1659). Acquisito dal demanio comunale
e recentemente restaurato dopo anni di grave degrado, mostra un esterno
semplice e compatto con due grandi facciate, una verso il mare e l'altra
a oriente, unite a livello del piano nobile da un balcone angolare. Il
palazzo ducale fu costruito dopo che il primo venne inglobato nel
monastero delle Benedettine (1653-1659). Acquisito dal demanio comunale
e recentemente restaurato dopo anni di grave degrado, mostra un esterno
semplice e compatto con due grandi facciate, una verso il mare e l'altra
a oriente, unite a livello del piano nobile da un balcone angolare.
L'edificio
è caratterizzato da una estensione di soffitti a lacunari lignei
dipinti che coprono le otto sale del primo piano e corrono su due fasce
parallele, l'una verso il mare e l'altra verso la collina.
Si
distinguono i soffitti delle sale delle armi, quella degli ordini
militari equestri e religiosi, quella dedicata interamente all'Ordine di
San Giacomo della Spada di cui il duca Giulio era aggregato, quella con
lo stemma ducale dei Tomasi, inquartato con gli emblemi dei Caro, La
Restia, Traina e infine la sala angolare che conteneva l'arme dei Tomasi
col leopardo rampante sul profilo del monte a tre cime. Qui si trova la
decorazione più sfarzosa con i lacunari più profondamente intagliati e
dipinti in bianco, rosso e oro.
I
locali del piano terra ospitano la biblioteca "Giovanni
Falcone".
Palazzo
degli Scolopi

L'edificio,
oggi sede degli uffici comunali, è certamente uno dei più belli del
patrimonio tardo-barocco.
Edificato
nel 1698 da Giulio II duca di Palma e principe di Lampedusa, fu portato
a termine l'8 dicembre 1712, giorno dell'Immacolata e il cardinale
Giuseppe Maria Tomasi lo affidò ai Padri Scolopi di San Giuseppe
Calasanzio che vi insediarono l'istituto delle Scuole Pie che nell'800
divenne una vera e propria Università frequentata da diversi rampolli
dell'aristocrazia isolana.
Addossata
al palazzo è la chiesa della Sacra Famiglia con la quale costituisce un
unico complesso architettonico.
Castello
Il castello
di Montechiaro, l'unico dei manieri chiaramontani in Sicilia, fu
edificato su un costone roccioso a picco sul mare.
Realizzato
nel 1353 su ordine di Federico III Chiaramonte fu, per la sua
posizione strategica, di grande importanza nella storia della lotta
contro i pirati.
Dopo la
morte di Andrea Chiaramonte e la confisca di tutti i suoi
beni, il castello passò alla famiglia Moncada che ne cambiò
il nome in Montechiaro, con il chiaro intento di cancellare la memoria
dei precedenti signori.
 Dopo
vari passaggi la fortezza pervenne prima ai Caro, e poi nel XVII secolo,
per linea femminile, alla famiglia Tomasi un componente della
quale, Carlo Tomasi Caro, ricevette dal re Filippo IV di
Spagna il titolo di duca di Palma. Dopo
vari passaggi la fortezza pervenne prima ai Caro, e poi nel XVII secolo,
per linea femminile, alla famiglia Tomasi un componente della
quale, Carlo Tomasi Caro, ricevette dal re Filippo IV di
Spagna il titolo di duca di Palma.
Questi,
abbracciata la vita monastica, cedette tutti i suoi beni al fratello
Giulio che fu II duca di Palma e I principe di Lampedusa: per un
certo periodo soggiornarono nel castello i figli Isabella e il
futuro cardinale e santo Giuseppe Maria.
La
rocca successivamente passò ai marchesi Bilotti Ruggi d'Aragona.
Abbandonato al degrado per parecchio tempo, l'edificio ha subito dei
lavori di restauro, con interventi inappropriati e discutibili, come la
contornatura in mattoni di finestre, l'uso improprio di intonaci e di
moderne pavimentazioni in cotto.
È da
ricordare che all'interno della cappella è custodita una statua della
Madonna che il Caputo attribuisce ad Antonello Gagini.
Assai interessante è la leggenda in cui si narra che la statua,
sottratta dai vicini abitanti di Agrigento, fu riportata dai palmesi nel
castello dopo una lunga e furibonda lotta. Ad avvalorare tale fatto è
il nome dato ad un corso d'acqua che da allora fu indicato come il
"vallone della battaglia".

Torre
San Carlo
L'edificazione
della torre San Carlo, appena oltre la foce del fiume Palma, risale al
1639 ad opera di Carlo Tomasi, primo duca di Palma, che ottenne il
permesso da Filippo IV di Spagna ed ebbe scopi difensivi stante le
continue incursioni dei pirati saraceni sul litorale palmese.
La
fortezza fu fornita di armi, attrezzi da guerra e di un adeguato numero
di soldati.
Essa
s'innalza con un corpo quadrangolare su un basamento a forma di piramide
tronca. Vi sono tracce che indicano la presenza di un ponte levatoio e
mensoloni sui quali si dovevano poggiare i piombatoi.
Accanto
alla torre fu fatta costruire una piccola chiesa, oggi non più
esistente, col titolo del Santissimo Rosario, guidata da un cappellano,
per la messa dei soldati. Gli apparati difensivi furono mantenuti fino
al 1820.

|