|
Si
chiamava
Castellum,
presso
i
romani.
Generalmente
si
identificavano
con
questo
nome
fortificazioni
di
minore
entità
lungo
i
confini
dell'impero,
disposte
ad
intervalli
regolari
a
sorveglianza
di
ponti
e
strade,
al
di
qua
e
al
di
là
delle
frontiere.
I
castelli
erano
temporanei
o
permanenti:
i
primi
erano
semplici
ridotte,
di
forma
circolare
o
quadrata,
spesso
senza
baraccamenti
per
le
truppe;
gli
altri
erano
invece
recinti
rettangolari
saldamente
fortificati,
con
argini
e
terrapieni
dapprima,
poi
(dopo
Adriano)
cinti
di
mura
merlate,
con
torri
per
le
macchine
di
lancio
e
quattro
porte.
Le
loro
dimensioni
variavano
da
24
m.
x
15
m.
a
150
m.
x
150
m.
Nel
Medioevo
il
nome
di
Castello
passò
ad
identificare
una
residenza
fortificata
che
costituì
la
dimora
del
signore
feudale.
Dapprima
fu
un
fortilizio
isolato
nel
quale
l'abitazione
del
feudatario
si
riduceva
a
pochi
vasti
ambienti
ricavati
all'interno
delle
torri
e
delle
muraglie.
Poi,
quando
la
vita
delle
piccole
corti
feudali
si
volse
ad
una
maggiore
ricerca
di
agi
e
di
benessere,
il
castello
divenne
un
organismo
complesso,
del
quale
fecero
parte
l'apparato
difensivo,
costituito
dalla
cinta
muraria
per
la
difesa
esterna
e
dal
mastio
per
la
sorveglianza
dell'intero
edificio
e
l'eventuale
estrema
difesa,
il
nucleo
abitato,
costituito
dal
palazzo
del
signore,
le
abitazioni
dei
famigliari
e
dei
soldati,
la
cappella,
magazzini
e
servizi
comuni.
Nel
sistema
fortificato,
le
caratteristiche
strutturali
e
tecniche
delle
varie
parti
seguirono
i
progressi
dell'arte
militare:
si
passò
così
dalle
nude
muraglie
merlate
dei
primi
fortilizi
feudali,
alle
ben
studiate
disposizioni
difensive
dei
castelli
dal
'200
al
'400,
dominati
dall'alta
mole
del
mastio,
coronati
dalla
serie
delle
merlature
su
caditoie
del
cammino
di
ronda,
protetti
dalle
robuste
torri
distribuite
nei
punti
più
salienti.
In
questi
già
complessi
e
vasti
organismi
il
palazzo
del
signore
con
i
fabbricati
annessi
prese
importanza
e
aspetto
di
dimora
principesca
e
,
pur
conservando
all'esterno
le
disposizioni
necessarie
per
la
difesa
e
la
sicurezza
degli
abitanti,
si
arricchì,
nell'interno,
di
cortili
e
di
sale
dalle
amene
architetture
e
leggiadre
decorazioni.
Nel
XVI
secolo
il
castello
perde
il
duplice
carattere
di
fortezza
e
di
dimora
signorile.
Il
nome
castello
rimane
tuttavia
in
uso
per
indicare
le
grandi
dimore
di
campagna
che,
specialmente
in
Francia
e
nei
paesi
germanici,
si
sostituirono
alle
antiche
residenze
feudali,
sotto
forma
di
fastosi
palazzi
circondati
di
vasti
parchi.

I
castelli
in
stile
europeo
ebbero
origine
nei
secoli
IX
e
X
dopo
la
caduta
dell'impero
carolingio,
il
suo
territorio
finì
diviso
tra
singoli
signori
e
principi.
Questi
nobili
costruirono
castelli
per
controllare
l'area
immediatamente
circostante,
promuovendo
la
realizzazione
degli
edifici
in
questione
sia
a
scopi
offensivi
che
difensivi.
Questi
ultimi
si
potevano
ricomprendere
essenzialmente
nel
binomio
generato
dalla
possibilità
di
lanciare
incursioni
e
dalla
protezione
che
ne
derivava
dai
nemici.
Sebbene
le
loro
origini
militari
siano
spesso
enfatizzate
negli
studi
accademici,
i
castelli
fungevano
anche
da
centri
di
amministrazione
e
simboli
di
potere.
Quelli
urbani
avevano
la
funzione
di
fronteggiare
prontamente
insurrezioni
cittadine
e
sorvegliare
le
importanti
rotte
di
viaggio
adiacenti,
mentre
quelli
rurali
si
distinguevano
per
la
loro
collocazione
in
località
specifiche
e
rilevanti
dal
punto
di
vista
strategico
o
degli
approvvigionamenti
(ad
esempio
vicino
a
un
fiume,
a
mulini
o
a
campi
coltivati).
Molti
castelli
dell'Europa
settentrionale
erano
originariamente
costruiti
con
terra
e
legno,
ma
in
seguito
essi
scomparvero
in
favore
della pietra. La posizione delle strutture non si sceglieva non ricorrendo ad alcun
criterio,
poiché
si
soleva
sfruttare
i
vantaggi
offerti
da
specifiche
località
naturali:
si
pensi
ai
castelli
realizzati
nei
pressi
di
formazioni
rocciose
o
corsi
d'acqua,
i
quali,
nei
primi
tempi,
erano
prive
di
elementi
come
torri
e
feritoie
e
si
sviluppavano
da
una
base
di
partenza
costituita
da
un dongione centrale. Tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo si iniziò a
seguire
un approccio
scientifico nella
costruzione
dei
castelli,
valido
anche
per
il
perfezionamento
o
l'ammodernamento
delle
vecchie
strutture,
che
fu
reso
possibile
dalle
maggiori
conoscenze
in
campo
architettonico
e
ingegneristico.
Ciò
portò
alla
proliferazione
di
torri,
con
una
certa
enfasi
posta
sulla
difesa
dalla
tattica
del defilamento.
Molti
dei
nuovi
edifici
erano
poligonali
o,
più
di
rado,
ad
anello:
il
particolare
genere
dei castelli
concentrici
perseguiva
il
fine
di
massimizzare
la
potenza
di
fuoco
totale,
potendo
inoltre
disporre
di
una
maggiore
capacità
di
truppe.
Questi
cambiamenti
si
dovettero
a
vari
aspetti,
non
ultimi
l'esperienza
appresa
durante
le crociate e lo studio attento dei pregi di strutture più ataviche come i castra (accampamenti militari) di epoca
romana.
Non
tutti
gli
elementi
architettonici
sopperirono
sempre
esigenze
belliche,
ragion
per
cui
alcuni
meccanismi
difensivi,
come
il fossato,
affrontarono
un
processo
di
evoluzione
tale
per
cui
si
trasformarono
in
simboli
di
potere.
Alcuni
grandi
castelli
avevano
approcci
lunghi
e
tortuosi
destinati
a
impressionare
e
dominare
il
loro
paesaggio.
Sebbene
la polvere
da
sparo sia
stata
introdotta
in
Europa
nel
XIV
secolo,
essa
non
influenzò
in
modo
significativo
la
costruzione
del
castello
fino
al
XV
secolo,
cioè
quando
l'artiglieria
divenne
abbastanza
potente
da
sfondare
le
mura
in
pietra.
Mentre
i
castelli
continuarono
a
essere
costruiti
fino
al
XVI
secolo,
le
nuove
tecniche
per
far
fronte
al
miglioramento
del
fuoco
dei
cannoni
li
resero
luoghi
non
più
idonei
a
soddisfare
le
esigenze
a
cui
sopperivano
nei
secoli
precedenti
e
difficili
da
rifornire.
Di
conseguenza,
i
veri
castelli
andarono
in
declino
e
furono
sostituiti
da
forti
di
artiglieria
senza
ruolo
nell'amministrazione
civile
e
case
di
campagna
indifendibili.
Dal
XVIII
secolo
in
poi,
si
sviluppò
un
rinnovato
interesse
per
i
castelli,
estrinsecatosi
nel periodo
neogotico con
la
costruzione
di falsi
storici che
non
avevano
alcuno
scopo
militare,
ma
ne
riprendevano
le
antiche
fattezze.

Nel De
verborum
significatione di Sesto
Pompeo
Festo, lessicografo e grammatico romano
del II
secolo,
il
termine castella era
a
quei
tempi
il
nuovo
"moderno"
modo
di
chiamare
le dividicole,
cioè
quelle
robuste
costruzioni
agrarie
di
legname
che
Roma,
già
nei
suoi
tempi
repubblicani,
faceva
erigere
in
vicinanza
delle
più
importanti
sorgenti
d'acqua,
affidando
ai
loro
presidi
il
compito
di
permettere
e
garantire
a
tutti
gli
agricoltori
della
zona
il
godimento
di
quell’acqua,
tanto
necessaria
alle
loro
coltivazioni,
ed
evitando
così
soprusi
e
privilegi
nella
sua
distribuzione. Il termine castello deriva dal latino castĕllum,
che
a
sua
volta
è
un
diminutivo della parola castrum, il quale significa "luogo fortificato". L'inglese
antico castel e il moderno castle,
il francese
antico castel o chastel e il moderno château,
lo spagnolo castillo e
il portoghese castelo sono
solo
alcuni
degli
esempi
che
hanno
un'origine
comune,
cioè
da castellum.
La
definizione
di
castello
accettata
dagli
accademici
è
quella
di
"una
residenza
fortificata
privata". Si
tratta
comunque
di
una
definizione
non
valida
per
ogni
epoca
storica,
considerando
i burh anglosassoni e le città
murate
di
Costantinopoli
e
Antiochia
in
Medio
Oriente; i castelli non erano messi a disposizione della comunità, essendo
posseduti
dai
signori feudali locali,
sia
per
se
stessi
che
in
vece
del
monarca
che
li
aveva
incaricati
di
sorvegliarlo. Il feudalesimo si contraddistingueva per il legame tra un signore e il suo vassallo dove, in cambio di fedeltà e del servizio militare, il signore
concedeva
alla
controparte
la
gestione
delle
terre. Alla
fine
del
Novecento,
nella
definizione
di
castello
si
è
iniziato
ad
includere
il
criterio
della
proprietà
feudale.
Ciò
ha
di
fatto
fuso
il
legame
del
termine
con
il
periodo
medievale;
tuttavia,
si
tratta
di
una
definizione
comunque
non
in
grado
di
comprendere
esaustivamente
ogni
momento
di
quell'epoca
storica. Durante
la prima
crociata (1096-1099),
gli
eserciti
franchi
incontrarono
insediamenti
fortificati
e
forti
da
loro
indiscriminatamente
chiamati
castelli,
malgrado
esse
non
andrebbero
a
soddisfare
i
requisiti
richiesti
dalla
definizione
moderna.
I
castelli
sopperivano
a
una
serie
di
scopi,
perlopiù
militari,
amministrativi
e
domestici.
Oltre
alle
strutture
difensive,
i
castelli
rappresentavano
strumenti
pronti
a
offendere
se
impiegati
come
base
operativa
in
territorio
nemico.
A
titolo
di
esempio,
i
castelli
fondati
dagli invasori
normanni
in
Inghilterra sia
per
scopi
difensivi
che
per
imporre
la
propria
autorità
sugli
abitanti
del
paese.
Quando Guglielmo il
Conquistatore avanzò
attraverso
l'Inghilterra,
egli
fortificò
posizioni
chiave
per
proteggere
quanto
aveva
espugnato.
Tra
il
1066
e
il
1087
fondò
36
castelli,
tra
cui
quello
di Warwick, che usò per proteggersi dalla ribellione nelle Midlands.

Verso
la
fine
del
Medioevo,
i
castelli
cominciarono
a
perdere
la
loro
essenza
militare
a
causa
dell'avvento
di
potenti
cannoni
e
fortificazioni
di
artiglieria
permanenti.
Di
conseguenza,
gli
edifici
una
volta
imprescindibili
a
scopi
bellici
divennero
più
funzionali
come
residenze
e
come
dimostrazione
di
potere. Un castello poteva operare da
roccaforte
e
prigione,
avere
uno
scopo
deterrente
e
ospitare
sale
da
cui
il
signore
di
turno
poteva
esercitare
la
propria
autorità,
dialogare
e
incontrare
cavalieri
o
propri
pari. Nel
tempo,
l'aspetto
estetico
si
fece
più
importante,
poiché
l'aspetto
e
le
dimensioni
del
castello
iniziarono
a
riflettere
il
prestigio
e
il
potere
del
suo
occupante.
Fungendo
da
residenza,
con
il
tempo
si
provò
a
renderla
sempre
più
confortevole
all'interno
delle
mura
fortificate.
Sebbene
i
castelli
fornirono
ancora
una
parca
protezione
nel
caso
di
piccole
schermaglie
in
età
moderna,
alla
fine
l'avanzamento
tecnologico
e
ingegneristico
li
rese
obsoleti.
Castello è
talvolta
impiegato
come
termine
generico
per
indicare
vari
tipi
di fortificazione,
comportando,
in
alcuni
casi,
un
improprio
utilizzo
della
parola.
Si
pensi
a
tal
proposito
al
castello
di
Maiden,
in Cornovaglia, il quale, nonostante il nome, è una fortezza
di
collina risalente
all'età
del
Ferro che
aveva
un'origine
e
uno
scopo
assai
diversi.
Sebbene
"castello"
rimanga
un
termine
distinto
da maniero, molti manieri adottano l'errata denominazione di "castello"
nella
prassi,
pur
avendo
poche
caratteristiche
architettoniche
affini:
ciò
è
accaduto
perché,
di
solito,
i
proprietari
di
turno
amavano
richiamare
il
passato
e
ritenevano
che
applicare
il
termine
"castello"
fosse
più
signorile. In Francia, invece, alla trasformazione architettonica si affiancò quella
linguistica:
è
il
caso
dei
numerosi castelli
reali
della
valle
della
Loira,
trasformati
in
splendidi
palazzi,
per
cui
ancora
oggi
si
usa
distinguere
questi château dalle
fortezze
che
mantengono
aspetto
medievale,
chiamate
château-fort. Nella storiografia, il castello nella definizione di cui sopra è
generalmente
accettato
come
un
concetto
dalla
vasta
portata
geografica,
perché
pur
essendo
originario
dell'Europa
e
successivamente
diffuso
in
parti
del
Medio
Oriente,
grazie
ai
crociati
europei,
viene
talvolta,
in
maniera
discutibile,
applicato
anche
per
latitudini
lontane
come
l'Asia
orientale. Il
collegamento
tra
Asia
ed
Europa
fece
sì
che
le
tattiche
di
costruzione
venissero
apprese,
studiate
o
ammirate
dalle
varie
controparti
di
riferimento,
con
il
risultato
che
le
influenze
tra
le
varie
culture
si
fecero
ineluttabili.

ESEMPI
FUORI
DALL'EUROPA
-
Nelle
aree
più
lontane
dall'Europa,
in
particolare,
strutture
analoghe
condividevano
aspetti
comuni
insiti
nel
concetto
di
castello,
sebbene
avessero
avuto
origine
in
periodi
e
circostanze
differenti
e
avessero
subito
evoluzioni
e
influenze
diverse.
Ad
esempio,
gli shiro del Giappone, descritti alla stregua di castelli dallo storico Stephen
Turnbull,
hanno
sperimentato
"un
processo
di
sviluppo
completamente
diverso,
sono
stati
costruiti
in
un
modo
totalmente
non
paragonabile
e
sono
stati
progettati
per
resistere
ad
attacchi
di
natura
assolutamente
diversa". Mentre
i
castelli
europei
costruiti
dalla
fine
del
XII
e
dall'inizio
del
XIII
secolo
in
poi
erano
generalmente
in
pietra,
gli shiro erano
prevalentemente
in
legno
ancora
nel
XVI
secolo. Si
tratta
di
edifici
enormi,
a
corpo
unico,
con
pianta
quadrangolare
e
alti
basamenti
in
pietra. Lo shiro si
sviluppa
in
verticale
con
forme
tipicamente
a pagoda, sviluppandosi su più piani. Proprio nel Cinquecento, quando le culture
giapponese
ed
europea
si
incontrarono,
le
fortificazioni
in
Europa
avevano
superato
i
castelli
e
si
basavano
su
innovazioni
come
la fortificazione
all'italiana.
Per
quanto
riguardava
l'India,
i
suoi
abitanti
mantennero
contatti
con
l'Occidente
in
varie
epoche,
così,
qualche
secolo
dopo
il
Medioevo
europeo,
anche
in Asia
meridionale ebbe
luogo
un incastellamento da
parte
dei
feudatari.
Come
gli shiro,
anche
i
forti
indiani
condividevano
caratteristiche
comuni
con
i
castelli
in
Europa,
con
torri,
mura
e
camere
per
ospitare
il
signore
che
li
abitava,
e
la
natura
di
presidi. Oltre
a
distinguersi
però
per
una
maggior
attenzione
alle
decorazioni
architettoniche,
ovviamente
in
stile
orientale,
essi
affrontarono
comunque
un
percorso
di
sviluppo
autonomo
rispetto
a
quello
dell'Europa. Quando
gli
inglesi
raggiunsero
quella
regione
nel
XVII
secolo,
i
castelli
in
Europa
erano
generalmente
considerati
superati.
Ad
ogni
modo,
durante
la
colonizzazione
britannica,
vennero
costruiti
nuovi
forti,
pur
mantenendo
un
certo
gusto
orientaleggiante,
come
nel
caso
del Forte
Rosso a Delhi.
Termini
e
tipologie
di
castello

Castrum
-
Accampamento
delle
milizie
romane.
Sempre
di
forma
quadrata,
viene
protetto
da
un
recinto
costituito
da
una
semplice
palizzata
in
legno,
oppure
in
alcuni
casi
in
muratura.
Spesso
veniva
anche
dotato
di
un
fossato
per
una
maggiore
difesa.
Castellum
-
Fortilizio
di
modeste
dimensioni
costituito
da
una
torre
di
vedetta,
detta
specula,
protetta
da
uno
sbarramento
murato
e
generalmente
da
un
fossato.
Castello
medievale
(X°
secolo)
-
Spesso
costruito
su
preesistenti
fortificazioni,
è
costituito
da
un
recinto
in
pietra
con
il
versante
più
esposto
protetto
da
un
fossato
asciutto
o
riempito
d'acqua.
All'interno
del
recinto,
provvisto
di
torre
scudata,
si
trovano
le
abitazioni
degli
armigeri
e
la
torre
maestra
che
svolge
una
duplice
funzione,
difensiva
e
di
residenza
per
il
signore.
Castello
medievale
(XII°
secolo)
-
Con
il
tempo
il
castello
viene
ampliato.
Vicino
alla
torre
maestra
viene
edificato
il
mastio,
residenza
promiscua
del
feudatario
e
del
personale
di
servizio.
Alla
prima
cinta
di
mura
sovente
ne
viene
affiancata
una
seconda
per
garantire
una
maggiore
difesa.
Le
porte
d'ingresso
alle
varie
cinte
murarie
sono
quasi
sempre
ubicate
molto
distanti
fra
loro
per
obbligare
gli
assedianti
a
percorrere
un
maggiore
percorso
allo
scoperto
e
quindi
essere
esposti
maggiormente
al
tiro
degli
arcieri.
Castello
medievale
(XIII-XIV°
secolo)
-
Per
garantire
maggiore
protezione
ai
contadini
ed
artigiani
che
lavorano
all'interno
del
feudo,
viene
edificata
una
ulteriore
cerchia
di
mura,
all'interno
della
quale
vengono
costruite
le
diverse
abitazioni.
In
tal
modo
si
dà
origine
al
borgo
fortificato
che
in
alcuni
casi
darà
origine
a
vere
e
proprie
città
murate
ed
in
altre
maestose
fortezze.
Le
maggiori
esigenze
abitative
portarono
poi
all'ampliamento
del
mastio
che
si
ampliò
seguendo
il
circuito
murato.
Casaforte
-
Si
tratta
di
fortificazioni
aventi
diverse
funzioni:
residenza
protetta,
centro
di
una
proprietà,
rifugio
per
gli
abitanti
del
borgo.
Abbazia
fortificata
-
L'esigenza
di
fortificare
un
complesso
monastico
si
deve
al
fatto
che
molti
di
questi,
oltre
ad
essere
luoghi
di
culto,
erano
dei
veri
e
propri
feudi
con
la
giurisdizione
su
ampi
territori.
Il
complesso
è
costituito
da
un
circuito
murato
che
circonda
il
monastero
vero
e
proprio
composto
dalla
chiesa
con
il
campanile
(che
funge
anche
da
torre
maestra),
depositi
ed
abitazioni.
Centa
-
La
Centa
ha
come
principale
scopo
quello
di
difendere
un
abitato
urbano.
E'
costituita
da
un
circuito
murato
(circolare
o
poligonale)
sul
quale
sono
innestate
una
o
più
torri.
All'interno
trovano
posto
la
chiesa
con
il
campanile
che
funge
anche
da
torre
mastio,
quindi
le
abitazioni
ed
i
depositi.
Caratteristiche
comuni
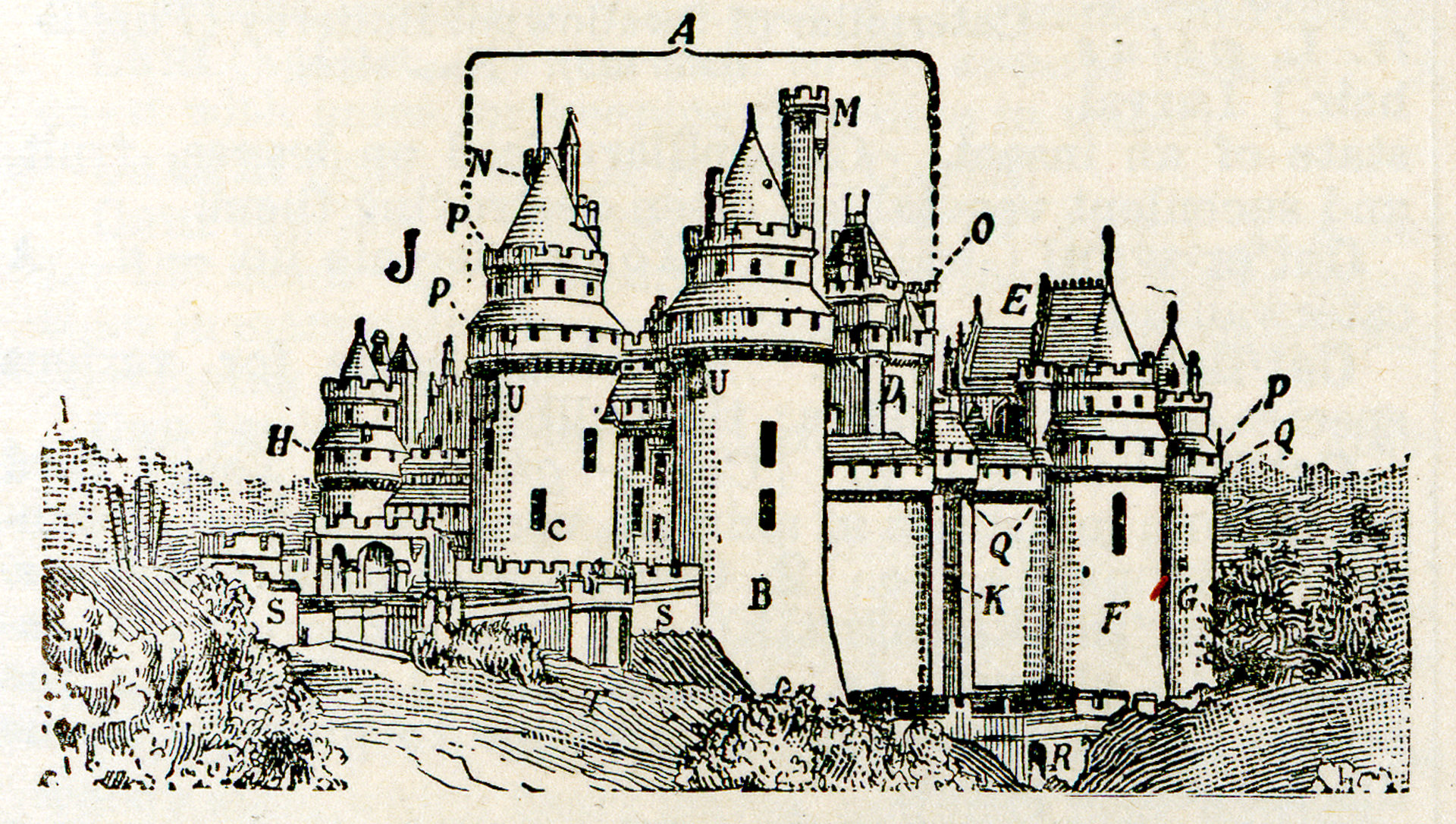
A -
Residenza
fortificata,
comprensiva
del mastio,
la
vera
e
propria
abitazione
della
famiglia
feudale
e
della corte
B e C -
Penusino
a
cappella
D - Mastio o donjon, la torre più grossa, residenza dei feudatari ed estrema difesa in caso di
invasione
della
corte
E - Cappella
G e H -
Torri
difensive
minori
K -
Accesso
laterale
M e N -
Torrette
del
mastio
collegate
con scale
a
chiocciola alle
torri
esterne
difensive
O -
Garitte
a
strapiombo,
camere
delle
sentinelle
e
torrette
di
guardia
P -
Merlatura
guelfa
Q - Cammino
di
ronda
R - Fossato
S - Barbacane
Antemurale
-
Opera
difensiva
leggera
anteposta
ad
una
successiva
e
più
consistente:
poteva
essere
costituito
da
un
muro
ma
anche
da
una
palizzata
o
da
un
terrapieno.
Balestriere
-
Le balestriere,
comunemente
chiamate
feritoie,
erano
strette
aperture
verticali
nelle
mura
difensive
che
consentivano
di
scoccare
frecce
o
dardi
di
balestra
all'indirizzo
degli
assalitori.
Le
strette
fessure
avevano
lo
scopo
di
esporre
quanto
meno
possibile
il
difensore,
ma
al
contempo
la
dimensione
dell'apertura
poteva
costituire
un
ostacolo
al
raggio
di
tiro
dell'arciere/balestriere.
In
alcuni
casi
si
sopperì
alla
relativamente
scarsa
libertà
di
visuale
aggiungendo
un'apertura
orizzontale
più
piccola
all'altezza
degli
occhi. A
volte
vi
era
una
sortita,
che
consentiva
una
via
di
fuga
da
cui
comunque
la
guarnigione
che
arretrava
poteva
ingaggiare
le
forze
assedianti. Era consuetudine che le latrine o i guardaroba presentassero solitamente un semplice buco con scarico all'esterno e
nel
fossato
circostante.
Battiponte
-
Piano
di
appoggio
di
un
ponte
levatoio
abbattuto,
cioè
abbassato.
Bertesca
-
Opera
leggera
in
legno
o
muratura
sporgente
dalle
mura
con
funzioni
di
guardia
o
di
avvistamento.
Bolzone
-
Meccanismo
di
sollevamento
di
un
ponte
levatoio.
Cammino
di
ronda
-
Passaggio
alla
sommità
delle
cortine,
all'interno
del
parapetto
merlato,
che
unitamente
alle
piazzole
delle
torri
formava
un
percorso
continuo
lungo
l'intero
perimetro
della
fortificazione
per
la
sorveglianza
verso
l'esterno.
Coronamento
-
Parte
terminale
delle
cortine
e
delle
torri
consistente
in
un
parapetto
per
la
protezione
dei
difensori,
generalmente
munito
di
merli
di
varia
foggia.
Corpo
di
guardia
-
L'ingresso
era
spesso
la
parte
più
vulnerabile
al
momento
della
difesa.
Per
ovviare
a
tale
problema,
si
sviluppò
la
creazione
del
corpo
di
guardia,
il
quale
consentiva
a
coloro
che
si
trovavano
all'interno
del
castello
di
supervisionare
il
flusso
del
traffico
delle
entrate
e
delle
uscite.
Nelle
versioni
in
terra
e
legno,
la
porta
fu
di
solito
il
primo
elemento
ad
essere
rimpiazzato
dalla
pietra.
La
parte
anteriore
della
porta
era
un
punto
cieco
e,
per
evitare
che
generasse
limitazioni
alla
visibilità,
si
aggiunsero
torri
sporgenti
su
ciascun
lato
della
porta
in
uno
stile
simile
a
quello
sviluppato
dai romani. Il corpo di guardia conteneva una serie di difese volte a rendere un
assalto
diretto
più
difficile
del
semplice
abbattimento
di
un
cancello.
In
genere,
una
o
più saracinesche (cioè
una
griglia
di
legno
rinforzata
con
metallo
che
bloccava
il
passaggio)
e
feritoie
agevolavano
il
compito
dei
difensori
contro
gli
aggressori.
Si
intuì
col
tempo
che
il
passaggio
attraverso
il
corpo
di
guardia
andava
aumentato
in
termini
di
metri,
poiché
ciò
avrebbe
consentito
di
aumentare
il
tempo
che
un
assalitore
doveva
spendere
sotto
il
fuoco
ostile
in
uno
spazio
ristretto
e
incapace
di
rispondervi
adeguatamente.
È
un
falso
mito
quello
che
le
cosiddette buche
assassine,
cioè
le
aperture
nel
soffitto
del
passaggio
all'ingresso,
fossero
usate
per
versare
olio
bollente
o
piombo
fuso
sugli
aggressori;
il
prezzo
di
queste
sostanze
e
la
distanza
del
corpo
di
guardia
dagli
incendi
rendevano
una
simile
strategia
impraticabile. A
questa
regola
non
scritta
sfuggivano
il Nord
Africa, il Medio Oriente e le fortificazioni sul mar
Mediterraneo,
dove
reperire
tali
risorse
era
compito
più
facile. Le si usava, più probabilmente, per far cadere oggetti sugli
aggressori
o
per
versare
acqua
sullo
scoppio
di
roghi
sottostanti. Al
piano
superiore
del
corpo
di
guardia
si
predisposero
alloggi
in
modo
che
il
cancello
non
fosse
mai
lasciato
indifeso,
malgrado
nei
secoli
si
finì
per
renderlo
più
confortevole
a
spese
della
difesa.
Durante
il
XIII
e
il
XIV
secolo
si
sviluppò
il barbacane. Esso consisteva in un baluardo, in un fossato e, talvolta, in una torre, posizionata davanti al corpo di
guardia
in
modo
da
proteggere
ulteriormente
l'ingresso. Lo
scopo
di
un
barbacane
non
era
solo
quello
di
fornire
un'altra
linea
di
difesa,
ma
anche
di
consentire
un'unica
strada
d'accesso
al
cancello.

Corte
e
cinta
-
La corte era uno spazio aperto solitamente situato all'ingresso di una
fortificazione.
Si
trattava
di
una
caratteristica
comune
dei
castelli,
tanto
che
la
maggior
parte
ne
aveva
almeno
una.
Il mastio in cima alla motta rappresentava il domicilio del signore a capo del
castello
e
un
baluardo
di
ultima
difesa,
mentre
la
corte
dava
accesso
alle
dimore
del
resto
della
famiglia
del
signore
e
permetteva
l'accesso
a
diverse
stanze.
Tra
queste,
vi
erano
le
caserme,
idonee
ad
ospitare
la
guarnigione,
le
stalle,
le
officine
e
i
depositi.
L'acqua
era
fornita
da
un pozzo o una cisterna. Nel corso del tempo, l'attenzione degli alloggi di alto rango si spostò
dal
mastio
alla
corte
interna;
questo
portò
alla
creazione
di
una
divisione
tra
la
via
che
conduceva
agli
edifici
principali
(come
le
camere
del
signore
e
la
cappella)
dalle
strutture
di
uso
quotidiano
come
le
officine
e
le
caserme.
Dalla
fine
del XII
secolo,
si
diffuse
la
tendenza
per
i
cavalieri
di
trasferirsi
dalle
piccole
residenze
che
avevano
precedentemente
occupato
all'interno
della
corte,
nello
specifico
in
piccole
strutture
fortificate
in
campagna. Sebbene
spesso
associati
alla
motta
castrale,
le
corti
esterne
si
potevano
trovare
anche
come
strutture
difensive
indipendenti. La cinta
muraria e
il muro
di
cortina rappresentavano
due
elementi
strettamente
connessi
e
che
sovente
rappresentavano
la
principale
barriera
difensiva
del
castello.
I
castelli
senza
mastio,
con
una
pianta
antica
e
risalenti
in
genere
a
prima
del X
secolo,
facevano
affidamento
sulle
loro
difese
esterne
per
la
protezione,
venendo
talvolta
chiamati
castelli
di
cinta.

Cortina
-
Le
cortine
continue
erano
mura
difensive
che
circondavano
e
difendevano
dagli
attacchi
esterni
una
corte.
L'altezza
costituiva
un
aspetto
importante,
considerato
lo
scopo
di
impedire
che
le
mura
potessero
venire
scalate.
Inoltre,
dovevano
essere
abbastanza
spesse
da
resistere
ai
bombardamenti
delle macchine
d'assedio che,
dal
XV
secolo
in
poi,
includevano
l'artiglieria
e
le
armi
che
funzionavano
con
la
polvere
da
sparo.
Un
muro
tipico
soleva
essere
spesso
tra
alto
tra
i
3
e
i
12
m,
malgrado
questa
non
vada
intesa
come
una
cifra
fissa
per
ogni
castello.
 Per
proteggersi
dal
rischio
di
realizzazione
di
passaggi
sotterranei,
alla
base
delle
pareti
divisorie
a
volte
veniva
realizzato
un
basamento
di
pietra
che
impediva
di
scavare.
La
facoltà
di
poter
camminare
lungo
le
passerelle
permetteva
di
rispondere
al
fuoco
nemico
o
di
usare
strumenti
quali
l'olio
bollente o il fuoco. La presenza delle torri, solitamente tutte ben
sorvegliate,
impediva
che
si
potesse
ricorrere
a
tattiche
di
fiancheggiamento. Le
feritoie
nelle
pareti
non
divennero
comuni
in
Europa
fino
al
XIII
secolo,
per
il
timore
che
potessero
compromettere
la
stabilità
delle
mura. Per
proteggersi
dal
rischio
di
realizzazione
di
passaggi
sotterranei,
alla
base
delle
pareti
divisorie
a
volte
veniva
realizzato
un
basamento
di
pietra
che
impediva
di
scavare.
La
facoltà
di
poter
camminare
lungo
le
passerelle
permetteva
di
rispondere
al
fuoco
nemico
o
di
usare
strumenti
quali
l'olio
bollente o il fuoco. La presenza delle torri, solitamente tutte ben
sorvegliate,
impediva
che
si
potesse
ricorrere
a
tattiche
di
fiancheggiamento. Le
feritoie
nelle
pareti
non
divennero
comuni
in
Europa
fino
al
XIII
secolo,
per
il
timore
che
potessero
compromettere
la
stabilità
delle
mura.
Dongione
-
Un dongione è una grande torre che, di solito, rappresenta il punto più
fortemente
difeso
di
un
castello.
Tale
caratteristica
tende
a
scemare
dopo
l'introduzione
dei
castelli
concentrici.
Nelle
fonti
in
latino,
tale
elemento
architettonico
veniva
indicato
come turris. Nelle
motte
castrali,
il
mastio
si
ergeva
imperioso
in
cima
alla
collina. Il
termine
dongione,
derivante
da donjon,
indicava
in
origine
una
prigione
oscura
e
inospitale. Sebbene spesso fosse la parte maggiormente robusta di un castello e
l'ultimo
luogo
dove
ritirarsi
in
caso
di
caduta
delle
difese
esterne,
il
mastio
non
veniva
lasciato
vuoto
in
caso
di
attacco,
ma
veniva
utilizzato
come
residenza
del
signore
che
possedeva
il
castello
oppure
occupato
dagli
eventuali
ospiti
o
dagli
ambasciatori.
In
alcuni
casi,
la
moglie
del
signore
abitava
in
una
residenza
separata
(domus, aula o mansio)
vicino
al
mastio,
con
quest'ultimo
che
fungeva
da
caserma
e
quartier
generale. Gradualmente le due funzioni si fusero nello stesso edificio, con i
piani
residenziali
più
alti
che
disponevano
di
grandi
finestre;
di
conseguenza,
per
molte
strutture
è
difficile
operare
una
corretta
e
distinta
suddivisione
architettonica. Gli
enormi
spazi
interni
visibili
in
molti
dongioni
superstiti
possono
trarre
in
inganno:
in
passato,
è
probabile
che
le
stanze
fossero
divise
da tramezzi leggeri, come in un moderno edificio per uffici. Anche in alcuni
grandi
castelli
la
grande
sala
era
separata
solo
da
un
tramezzo
dalla
stanza
personale
del
signore,
dalla
sua
camera
da
letto
e
da
quello
che
poteva
definirsi,
con
un
eufemismo
moderno,
il
suo
ufficio.

Feritoia
-
Stretta
apertura
praticata
nelle
mura
per
consentire
ai
difensori
di
colpire
gli
assalitori
senza
esporsi
al
loro
tiro.
Poteva
essere
foggiata
in
modo
diverso
secondo
il
tipo
di
armi
utilizzate:
si
ebbero
così
feritoie
arciere
(verticali),
balestriere
(orizzontali)
oppure
a
croce
per
consentire
indifferentemente
l'uso
degli
archi
o
delle
balestre.
Per
dare
più
spazio
e
manovrabilità
alle
armi,
le
feritoie
erano
aperte
in
una
nicchia
più
o
meno
svasata
verso
l'interno
(detta
strombatura
o
sguancio)
sostenuta
nella
parte
superiore
da
uno
o
più
archi
di
scarico
a
sesto
ribassato
e
col
piano
alla
base
inclinato
per
consentire
anche
un
tiro
che
fosse
il
più
ravvicinato
possibile
alle
mura.
Fossato
-
Un
fossato
consisteva
in
uno scavo,
dalle
dimensioni
variabili,
che
circondava
un
castello
o
che
divideva
una
parte
della
struttura
da
un'altra:
poteva
inoltre
essere
asciutto
o
riempito
d'acqua.
Il
suo
scopo
era
spesso
e
volentieri
difensivo,
in
quanto
si
tentava
di
ridurre
la
portata
delle torri
d'assedio,
attutire
il
rischio
di
raggiungimento
delle
mura
tramite
scale
o
altri
mezzi
e
intrappolare
chi
si
avventurava
nello
scavo
perché
magari
impossibilitato
a
risalire
in
tempi
rapidi. Ciò
non
toglie
che
in
alcuni
casi
aveva
solo
un
mero
scopo
ornamentale. I
fossati
d'acqua
erano
realizzati
anche
in
zone
di
bassa
quota
e
di
solito
erano
attraversati
da
un ponte
levatoio,
sebbene
relativamente
presto
trovarono
spazio
i
ponti
in
pietra. Il
sito
del castello
di
Caerphilly del
XIII
secolo,
in Galles, si estende per oltre 120.000 m² e le difese idriche, create allagando la
valle
a
sud
del
castello,
appaiono
tra
le
più
imponenti
dell'Europa
occidentale.
Anche
quando
si
assistette
alla
diffusione
del
fossato,
alcuni
castelli
medievali
conservarono
la
caratteristica
di
un ingresso
sopraelevato rispetto
al
terreno,
essendo
in
tale
guisa
difficilmente
raggiungibile
dal
nemico.
Vi
si
accedeva
a
mezzo
di
una
scala
in
legno,
di
corda
o
tramite
un argano e una fune.
Macchine
da
guerra
-
Per
macchine
da
guerra
si
intendono
le
armi
non
individuali
e
i
mezzi
utilizzati
dagli
assalitori
durante
l'avvicinamento
e
l'assalto
a
una
fortificazione,
oppure
dai
difensori
per
bloccare
le
macchine
degli
assalitori;
gli
uni
e
gli
altri
utilizzavano
anche
le
macchine
da
getto,
cioè
le
artiglierie
meccaniche.
Mantelletta
-
Tavolato
ligneo,
spesso
con
rivestimento
in
lamiera
di
ferro
e
montato
su
intelaiatura
a
ruote,
usato
per
proteggere
i
soldati
e
in
particolare
i
guastatori
in
avvicinamento
alle
mura
di
una
fortificazione .
Merlatura
-
Le
merlature
rappresentavano
il
complesso
di merli sulla
parte
sommitale
di
un
edificio
fortificato
e
sulle
parti
superiori
dei
corpi
di
guardia.
Oltre
all'elemento
base
rappresentato
dunque
dal
merlo,
esse
comprendevano
diversi
elementi,
tra
cui
le bertesche,
le piombatoie e
le feritoie. Lo
stile
tipico
con
cui
si
realizzava
la
merlatura
vedeva
un'alternanza
di
merli
e
spazi
vuoti,
così
da
originare
forme
dentate. La
finalità
delle
merlature
era
la
protezione
dei
soldati
sui
camminamenti
dagli
attacchi
di
arcieri
e frombolieri.
Le
bertesche
erano
piccole
prominenze
rettangolari
attaccate
tramite
un arco
a
mensola al
muro
di
un'apertura
difensiva:
ciò
permetteva
una
maggiore
difesa
della
stessa
o
la
possibilità
di
far
cadere
oggetti
sugli
attaccanti
alla
base
del
muro
senza
doversi
chinare
pericolosamente
sui
merli,
esponendosi
così
al
fuoco
nemico. Le
piombatoie
(o
caditoie)
erano
sporgenze
di
pietra
in
cima
a
un
muro
con
piccole
aperture
che
permettevano
di
far
cadere
oggetti
su
un
nemico
alla
base
del
muro
in
modo
simile
alle
bertesche.
I
merli
presentano
due
stili
architettonici:
si
definiscono
merlature ghibelline (o
imperiali)
quelle
che
presentano
sommità
a
coda
di
rondine,
mentre guelfe (o
papali)
sono
le
merlature
a
corpi
quadrati.
Tuttavia
questa
definizione
è
impropria,
poiché
anche
se guelfi
e
ghibellini effettivamente
utilizzarono
queste
divisioni,
negli
anni
successivi
le
merlature
furono
costruite
a
discrezione
dei
progettisti.

Motta
-
Una motta è
un
sito
recintato
da
palizzate
in
legno
e
dominato
da
una
collina
su
cui
sorge
una
torre
protetta
da
una
seconda
palizzata.
Si
trattava
di
un'altura
spesso
artificiale,
malgrado
a
volte
incorporasse
una
caratteristica
preesistente
del
paesaggio. Lo
scavo
di
terra
per
realizzare
il
tumulo
dava
luogo
a
uno
spazio
meno
elevato
attorno
alla
motta,
detto
fossato
(che
poteva
essere
bagnato
o
asciutto).
La
motta
è
comunemente
associata
ai
castelli
quando
si
parla
di
"motta
castrale"
(in inglese motte-and-bailey),
ma
questa
locuzione
fa
riferimento
a
una
fase
di
sviluppo
successiva
rispetto
alle
strutture
originarie,
le
quali
non
vedevano
talvolta
la
presenza
di
seconde
palizzate.
Alla
struttura
fortificata
superiore,
simile
a
grosse
linee
a
un
mastio,
si
accedeva
percorrendo
un
ponte
che
procedeva
lungo
la controscarpa. La
struttura
era
mobile
e
rappresentava
l'antenato
del
ponte
levatoio
dei
secoli
a
venire. Tale
informazione
si
apprende
da
un'analisi
della
raffigurazione
compiuta
dall'arazzo
di
Bayeux del
castello
di Dinan. A volte una motta occultava un castello o una sala più antica, le cui
stanze
diventavano
depositi
sotterranei
e
prigioni
sotto
un
nuovo
mastio.

Ponte
levatoio
-
Ponte
mobile
costituito
da
un
tavolato
ligneo
incernierato
alla
basse
della
porta.
Il
sollevamento
poteva
avvenire
per
mezzo
di
meccanismi
di
vario
tipo
e
più
o
meno
complessi,
il
più
semplice
e
più
usato
dei
quali
era
quello
a
contrappeso.
Consisteva
in
una
coppia
di
travi
dette
bolzoni
incernierate
in
bilico
subito
sopra
la
porta
e
dotate
all'estremità
interna
di
un
contrappeso,
solitamente
formato
da
segmenti
di
travi
oppure
da
una
cassa
contenente
pietre
o
ghiaia,
di
peso
quasi
pari
a
quello
complessivo
del
ponte,
della
parte
esterna
delle
travi
e
delle
catene
di
sollevamento.
Per
il
sollevamento
era
dunque
sufficiente
una
piccola
forza
generata
dalla
trazione
di
funi
agganciate
all'estremità
contrappesata
dei
bolzoni.
Quando
il
ponte
veniva
abbassato,
poiché
la
sua
lunghezza
era
sempre
inferiore
alla
larghezza
del
fossato,
necessitava
di
un
piano
di
appoggio,
detto
battiponte,
costituito
in
questo
caso
dall'estremità
del
ponte
fisso
che
consentiva
di
raggiungere
il
bordo
del
fossato
verso
la
campagna.
Il
ponte
poteva
anche
essere
dotato
di
un
solo
bolzone,
al
quale
era
collegato
da
tre
segmenti
di
catena
agganciati
a
una
forcola;
aveva
larghezza
più
contenuta
ed
era
utilizzato
in
corrispondenza
di
pusterle.
Pseudotorre
-
Semplice
struttura
muraria
angolare
formata
da
due
sole
pareti,
sopraelevata
rispetto
alle
cortine.
Postierla
-
Una postierla era
un'angusta
porta
d'accesso
ai camminamenti
per
le
guardie
di
ronda nei
castelli
e
nelle
fortificazioni
nascosta
nelle
mura,
che
poteva
essere
usata
anche
come
uscita
o
ingresso
di
emergenza
in
caso
di
attacco
o
di
assedio.
Proprio
per
questa
sua
funzione
come
via
di
fuga,
era
distante
dalla
porta
principale
e
celata
quanto
più
possibile.
Sala
grande
-
La
sala
grande
era
un'ampia
stanza
decorata
dove
il
proprietario
o
feudatario
del
castello
riceveva
i
suoi
ospiti.
Essa
rappresentava
il
prestigio,
l'autorità
e
la
ricchezza
del
signore,
circostanza
che
spiega
la
presenza
di
decorazioni
artistiche
e
la
cura
dell'arredamento.
Nella
grande
sala
si
svolgevano
eventi
come
feste,
banchetti,
raduni
sociali
o
cerimoniali,
riunioni
del
consiglio
militare
e
processi
giudiziari.
A
volte,
la
grande
sala
esisteva
sotto
forma
di
un
edificio
separato.
Saracinesca
-
Serranda
per
bloccare
una
porta,
scorrevole
entro
scanalature
praticate
nel
muro;
era
manovrata
dall'alto
mediante
un
argano
posto
in
un
locale
o
su
un
ballatoio
sovrastanti
la
porta.
Poteva
avere
fogge
diverse
ma
generalmente
era
costituita
da
una
grata
di
grosse
sbarre
di
ferro
oppure
da
un
pesante
tavolato
di
legno.
Torre
passante
-
Torre
posta
a
cavaliere
di
una
porta.
Torre
scudata
-
Torre
aperta
verso
l'interno
del
recinto
per
un
duplice
scopo:
renderla
inutilizzabile
per
gli
assedianti
che
fossero
riusciti
ad
espugnarla
poiché
si
sarebbero
trovati
esposti
al
tiro
dei
difensori;
facilitare
il
trasferimento
di
armi,
proiettili
e
altri
materiali
da
terra
ai
piani
superiori.
Torri
-
La
torre
quadrata
fu
il
primo
tipo
ad
essere
costruito.
Permetteva
solo
alcune
linee
di
tiro
ed
era
spesso
soggetta
a
scavi
nelle fondamenta da
parte
dei
nemici
per
farla
crollare.
Più
tardi
un
secondo
tipo
più
raro
comparve
sulla
scena:
la
torre
poligonale,
che
offriva
più
linee
di
tiro.
Ultima
e
più
recente,
la
torre
rotonda,
ideata
tra
XII
e
XIII
secolo
dal
re
di
Francia Filippo
II
Augusto,
che
sostituì
le
precedenti
perché
non
poteva
essere
minacciata
dagli
scavatori
e
offriva
illimitate
linee
di
tiro.
Le
torri
potevano
essere
scoperte
o
coperte
da
un
tetto
a
capanna
o
conico.
Le
torri
alte
e
svettanti
divennero
all'inizio
dell'età
moderna
più
basse
e
larghe
fino
a
trasformarsi
in
bastioni
a
forma
di
punta,
per
meglio
deviare
i
colpi
d'artiglieria.
 Pag.
2
Pag.
2
Fonte:
|