|
Storia
Lo
storico
Charles
Coulson
afferma
che
l'accumulo
di
ricchezza
e
di
risorse,
al
fianco
di
quello
del
cibo,
abbia
portato
alla
necessità
realizzare
strutture
difensive.
Le
prime
fortificazioni
ebbero
origine
nella mezzaluna
fertile,
nella valle
dell'Indo,
in
Egitto
e
in Cina, dove gli insediamenti erano protetti da grandi mura. Il Nord Europa è
stato
più
lento
rispetto
all'oriente
nello
sviluppare
strutture
difensive
e
si
dovette
aspettare
l'età
del
bronzo perché
comparissero
le
prime fortificazioni
di
collina che
poi
prolificarono
su
tutto
il
territorio
durante
l'età
del
ferro. Queste strutture differivano dalle loro controparti orientali in quanto
usavano
la
terra
piuttosto
che
la
pietra
come
materiale
da
costruzione.
Oggi sopravvivono molti di questi earthworks,
insieme
a
testimonianze
di
palizzate
che
accompagnavano
i
fossati.
In
Europa,
l'oppidum emerse nel II secolo a.C.; questi erano insediamenti fortificati
densamente
abitati,
come
l'oppidum di Manching, e si svilupparono dai forti delle colline. I romani incontrarono
insediamenti
fortificati
come
fortezze
collinari
e oppidum durante
l'espansione
del
loro
territorio
nel
nord
Europa. Sebbene
primitivi,
erano
spesso
efficaci
e
furono
superati
solo
dall'ampio
uso
di macchine
d'assedio e
altre
tecniche
di
guerra,
come
avvenne
ad
esempio
nella battaglia
di
Alesia.
Le
fortificazioni
dei
romani
(castra) variavano da semplici cumuli di terra temporanei ammassati da eserciti di
passaggio,
fino
a
più
complesse
strutture
permanenti
di
pietra,
come
il
celebre vallo
di
Adriano.
I
forti
romani
erano
generalmente
rettangolari
con
angoli
arrotondati.
Con
la caduta
dell'Impero
romano
d'Occidente e
il
conseguente
annullamento
del
potere
centrale
si
cominciò
a
sviluppare
l'idea
di
un
edificio
fortificato
adatto
a
difendere
un
territorio.
In
principio,
dovette
avere
fortuna
l'idea
delle torri di
guardia
isolate,
solitamente
di legno, adatte a proteggere appezzamenti di terreno e a controllare passaggi
obbligati.

Il
tema
della
nascita
dei
castelli
in
Europa
è
una
questione
complessa
che
ha
suscitato
un
notevole
dibattito.
È
certo
che
i
castelli
furono
influenzati
da
precedenti
forme
di
architettura
d'élite,
contribuendo
alle
variazioni
regionali
ma
permettendo
la
persecuzione
di
scopi
che
non
si
limitavano
alla
mera
costituzione
di
una
struttura
di
difesa. Le discussioni hanno tipicamente attribuito l'ascesa del castello a
una
reazione
agli
attacchi
dei magiari, dei musulmani e dei vichinghi e alla necessità di disporre di una difesa privata. Il crollo
dell'impero
carolingio portò
alla
crescita
esponenziale
del
sistema
del feudalesimo e
i
signori
locali
si
assunsero
la
responsabilità
della
gestione
dell'economia
e
della
giustizia. Tuttavia, mentre i castelli proliferarono nel IX e X
sec.,
il
legame tra aumento degli attacchi subito e costruzione di nuove fortificazioni
non
procedette
sempre
di
pari
passo.
Mentre
alcune
regioni
di
confine
disponevano
infatti
di
relativamente
pochi
forti,
altre
zone,
considerate
meno
esposte
a
rischi,
paradossalmente
presentavano
più
edifici
difensivi.
E' probabile
che
il
castello
si
sia
evoluto
dalla
pratica
di
fortificare
una
dimora
signorile.
La
più
grande
minaccia
per
la
residenza
o
la
sala
principale
riservata
al
signore
di
turno
era
costituita
dal
fuoco,
poiché
di
solito
era
una
struttura
in
legno.
Per
scongiurare
tale
rischio,
così
come
altre
minacce
di
vario
genere,
vi
erano
diverse
linee
d'azione
disponibili:
creare
terrapieni
di
contorno
per
tenere
a
distanza
un
nemico;
costruire
la
sala
in
pietra;
o
sollevarla
su
un
tumulo
artificiale,
detto
motta,
al
fine
di
originare
un
ostacolo
arduo
da
superare
per
gli
aggressori. Mentre il concetto di fossato, bastione e mura di pietra come misure
difensive
hanno
origini
antiche,
la
realizzazione
di
una
motta
rappresentava
un'innovazione
medievale.
Nelle isole
britanniche,
il ringwork rappresentava
un
elemento
fondamentale
nell'epoca
antecedente
alla
realizzazione
dei
castelli.
Si
trattava
di
un
terrapieno
e
un
fossato
con
un
recinto
difensivo
privo
di
una
motte. La
costruzione
della
sala
in
pietra
non
la
rendeva
necessariamente
immune
al
fuoco,
essendovi
porte
e
finestre
di
legno.
Ciò
portò
allo
spostamento
delle
finestre
al
secondo
piano,
al
fine
di
rendere
meno
probabile
il
pericolo
di
incendi,
e
a
spostare
l'ingresso
dal
piano
terra
al
secondo
piano.
Queste
caratteristiche
si
intuiscono
in
molti
dei
castelli
superstiti
appartenenti
alla
categoria
dei ringworks,
i
quali
altro
non
rappresentavano
se
non
una
versione
sofisticata
delle
vecchie
sale. I castelli non sopperivano solo a scopi difensivi, poiché
rafforzavano
altresì
l'auctoritas di
un
signore
sulle
sue
terre:
il
secolare
compito
di
meglio
sorvegliare
l'area
circostante
poteva
meglio
venir
eseguito
ricorrendo
a
queste
strutture,
le
quali
finirono
per
assorbire
al
loro
interno
pure
l'espletamento
di
funzioni
amministrative,
giudiziarie
ed
esecutive
(la corte
regia è l'esempio principe).
La
costruzione
di
un
castello
a
volte
richiedeva
il
consenso
del
sovrano
o
di
un
altro
funzionario
di
altro
grado.
Nell'864,
il
re
dei
Franchi
Occidentali Carlo
il
Calvo proibì
la
costruzione
di castella senza
il
suo
permesso,
ordinando
la
distruzione
di
quelli
che
non
erano
stati
eretti
senza
il
suo
placet.
Questo
è
forse
il
primo
riferimento
ai
castelli,
sebbene
lo
storico
militare
R.
Allen
Brown
sottolinei
che
la
parola
"castella"
avrebbe
potuto
indicare
una
qualsiasi
fortificazione
dell'epoca.
In
alcune
località,
il
monarca
aveva
scarso
controllo
sui
signori
o
richiedeva
la
costruzione
di
nuovi
castelli
per
aiutare
a
proteggere
luoghi
che
riteneva
non
protetti. Per
questo
motivo,
non
si
preoccupava
di
concedere
un'autorizzazione,
come
avvenne
in Inghilterra all'indomani della conquista normanna e in Terra
Santa durante
le
crociate.
La Svizzera rappresentava il perfetto esempio di assoluta inesistenza di una
gestione
statale
sulla
realizzazione
di
castelli:
ecco
perché
se
ne
contavano
ben
4.000
alla
fine
dell'Alto
Medioevo. Pochissimi
sono
i
castelli
datati
con
certezza
alla
metà
del
IX
secolo.
Trasformato
in
mastio
intorno
al
950,
il
transalpino Doué-la-Fontaine rappresenta
il
caso
di
più
antico
castello
esistente
in Europa.
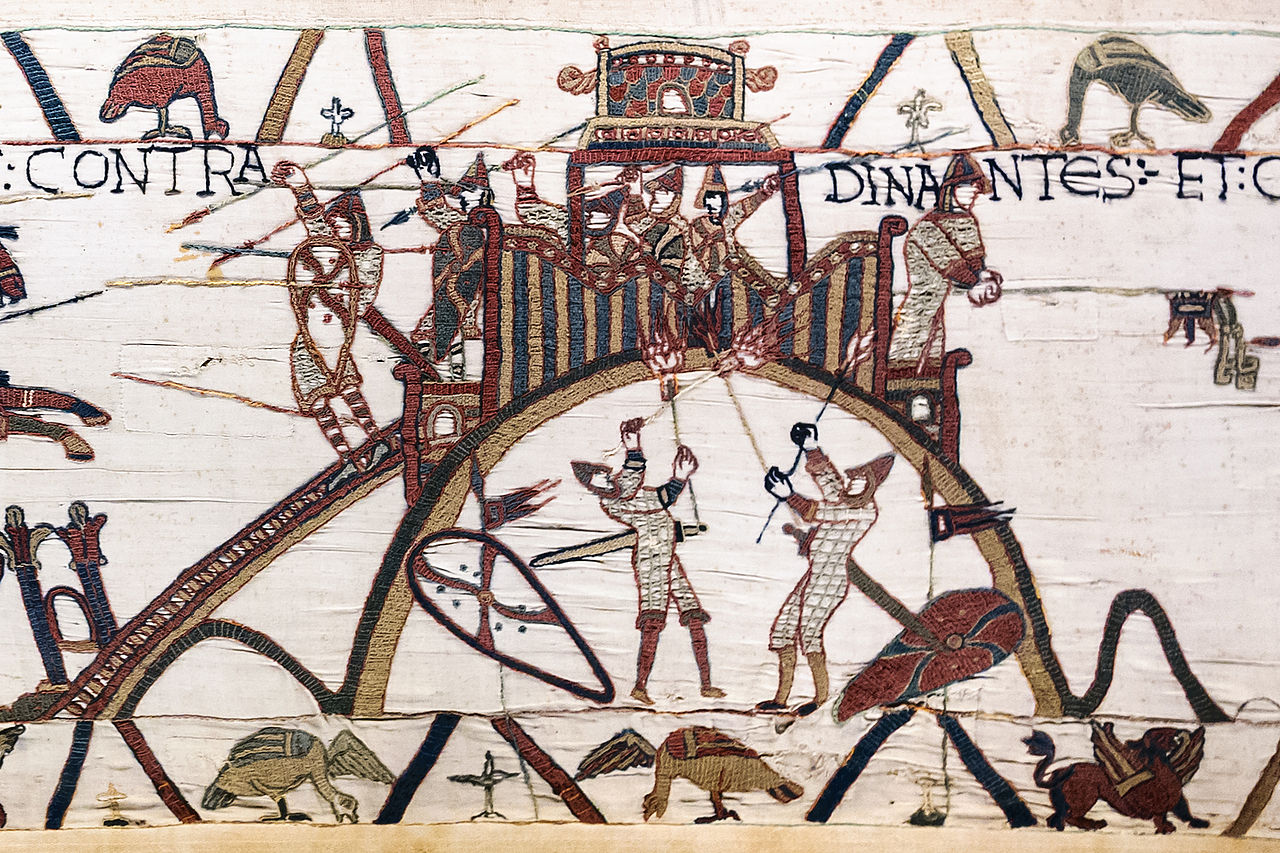
Dal
1000
in
poi,
i
riferimenti
alle
strutture
in
esame
in
scritti
come
gli
atti
ufficiali
aumentarono
sensibilmente:
si
consacra
così
la
stagione
dell'incastellamento.
Gli
storici
hanno
interpretato
questo
incremento
come
la
prova
di
un
vertiginoso
aumento
del
numero
dei
castelli
in
Europa
in
questo
periodo:
avvalora
tale
tesi
l'indagine
archeologica
che
ha
datato
la
costruzione
di
vari
siti
attraverso
l'esame
della
ceramica. La crescita in Italia cominciò negli anni 950, con un aumento compreso fra tre e cinque
ogni
anno
per
un
cinquantennio,
mentre
in
altre
parti
d'Europa
come Francia e Spagna la crescita rimase più lenta. In Sicilia si affermarono alcuni castelli, come a Sperlinga e Gagliano
Castelferrato,
nella provincia
di
Enna,
in
origine
essenzialmente
scavati
nella
roccia,
che
vedevano
aggiunte,
al
fianco
di
queste
strutture
rupestri,
imponenti
porzioni
in
muratura
nel
periodo
normanno. Nel 950, la Provenza ospitava 12 castelli, mentre nel 1000 questa cifra era salita a 30 e
nel
1030
superava
quota
100. Sebbene
l'aumento
sia
stato
meno
accelerato
in
Spagna,
gli
anni
'20
videro
una
particolare
crescita
del
numero
di
castelli
nella
regione,
in
particolare
nelle
aree
di
confine
contese
tra
terre
cristiane
e
musulmane.
Il
fatto
che
i
castelli
emersero
in
un
arco
temporale
comune
in
tutta
Europa
non
deve
far
pensare
che
il
loro
aspetto
non
variasse
da
regione
a
regione.
All'inizio
dell'XI
secolo,
la
motta
e
il
torrione
(un
tumulo
artificiale
con
una
palizzata
e
una
torre
in
cima)
risultavano
il
genere
di
castello
più
usuale
del
continente,
tranne
che
in Scandinavia. Mentre
Inghilterra,
Francia
e
Italia
condividevano
una
tradizione
di
costruzione
in
legno
che
era
continuata
nell'architettura
dei
castelli,
in
Spagna
si
usavano
più
comunemente
pietre
o
mattoni
di
fango
come
materiale
principale.
La conquista
islamica
della
penisola
iberica nell'VIII
secolo
introdusse
uno
stile
di
costruzione
sviluppatosi
nel Nord
Africa per
ovviare
alla
scarsità
di
legname
basato
sui tapial,
ovvero
ciottoli
in
cemento. Così, benché la costruzione in pietra sarebbe poi diventata comune
anche
al
di
fuori
della penisola
iberica,
dall'XI
secolo
in
poi
i
castelli
cristiani
castelli
in
Spagna
erano
soprattutto
in
pietra,
mentre
allo
stesso
tempo
il
legno
dominava
ancora
tra
i
materiali
di
costruzione
nell'Europa
nord-occidentale. Gli storici hanno interpretato la diffusa presenza di castelli in
tutta
Europa
nell'XI
e
XII
secolo
come
prova
che
la
guerra
accadeva
spesso
e
con
schermaglie
su
scala
ridotta. I
castelli
furono
introdotti
in
Inghilterra
poco
prima
della
conquista
normanna
nel
1066. Prima
del
XII
secolo,
i
castelli
erano
rari
in Danimarca come
lo
erano
stati
in
Inghilterra
prima
della
conquista
normanna.
L'introduzione
dei
castelli
in
terra
danese
si
dimostrò
necessaria
per
diminuire
la
portata
degli
attacchi
dei
pirati,
tanto
che
finirono per trovare soprattutto impiego lungo le coste. La
motta
e
il
cortile
rimasero
la
forma
dominante
di
castello
in
Inghilterra, Galles e Irlanda fino
al
XII
secolo.
Man
mano
che
trascorreva
il
XII
secolo,
l'architettura
dei
castelli
nell'Europa
continentale
si
fece
più
sofisticata. Il dongione fu al centro di questo cambiamento nell'architettura del castello. Le
torri
centrali
proliferavano,
e
tipicamente
avevano
una
pianta
quadrata,
con
pareti
spesse
tra
i
3
e
i
4
m.
La
loro
decorazione
emulava
lo stile
romanico e, talvolta, incorporava doppie finestre simili a quelle che si
trovano
nei
campanili
delle
chiese.
I torrioni, che ospitavano la residenza del signore del castello,
affrontarono
un
processo
di
espansione
in
termini
di
spazio.
L'enfasi
progettuale
dei
mastri
mutò
per
riflettere
un
passaggio
da
requisiti
funzionali
a
requisiti
decorativi,
imponendo
un
simbolo
di
potere
signorile
sul
paesaggio.
Ciò
a
volte
portò
a
casi
in
cui
la
qualità
della
difesa
veniva
sacrificata
per
motivi
non
attinenti
alla
sfera
bellica.

Innovazione
ed
approccio
scientifico
(XII
sec.)
-
Fino
al
XII
secolo,
i
castelli
in
pietra
e
terra
e
legno
convissero
insieme,
ma
alla
fine
di
quel
centennio
il
numero
di
nuove
costruzioni
affrontò
una
fase
di
declino. Ciò si attribuì in parte al costo più elevato delle fortificazioni
in
pietra
e
all'obsolescenza
del
legname
e
dei
siti
di
terrapieno,
il
che
significava
che
era
preferibile
costruire
nella
più
resistente
pietra. Benché
il
progresso
sembrava
tracciare
un
cammino
ben
nitido,
i
castelli
in
legno
e
in
terra
battuta
non
si
rivelarono
ancora
del
tutto
superati.
Questo
si
evince
dalla
continua
manutenzione
dei
castelli
in
legno
per
lunghi
periodi,
a
volte
diversi
secoli;
il
castello
in
legno
di Owain
Glyndŵr dell'XI
secolo
a
Sycharth
era
ancora
in
uso
all'inizio
del
XV
secolo,
con
la
sua
struttura
che
sopravviveva
da
400
anni.
Allo
stesso
tempo,
si
affrontarono
dei
cambiamenti
dal
punto
di
vista
ingegneristico.
Fino
alla
fine
del
XII
secolo,
i
castelli
disponevano
generalmente
di
poche
torri;
una
porta
con
poche
caratteristiche
difensive
come
feritoie
o
saracinesche;
un
grande
mastio
o
dongione,
generalmente
quadrato
e
senza
feritoie;
e
la
forma
sarebbe
stata
dettata
dalla
conformazione
del
terreno
(il
risultato
originava
spesso
strutture
irregolari
o
curvilinee).
Pur
essendo
l'aspetto
non
uniforme,
le
caratteristiche
sopra
esposte
contraddistinguevano
un
castello
tipico
della
metà
del
XII
secolo. Alla fine del XII secolo o all'inizio del XIII secolo, si affermarono
castelli
di
nuova
costruzione
di
forma
poligonale,
con
torri
agli
angoli
per
fornire
fuoco
laterale
a
sostegno
delle
mura
esterne.
Le
feritoie
presenti
a
ogni
livello
consentivano
dalle
torri
agli
arcieri
di
colpire
chiunque
si
avvicinasse
o
si
avvicinasse
alla
cortina.
Questi
castelli
di
epoca
successiva
non
avevano
sempre
un
mastio,
forse
per
via
della
conformazione
più
complessa
nel
suo
insieme,
che
innalzava
i
costi,
e
il
mastio
veniva
sacrificato
per
risparmiare
denaro.
Le
torri
più
grandi
fornivano
spazio
abitativo
per
sopperire
alla
perdita
dell'elemento
appena
citato. Dove
esistevano
i
torrioni,
questi
non
erano
più
quadrati
ma
poligonali
o
cilindrici.
Le
porte
erano
più
fortemente
difese,
con
l'ingresso
al
castello
solitamente
circoscritto
tra
due
torri
semicircolari
collegate
da
un
passaggio
sopra
la
porta
(sebbene
vi
fosse
una
grande
varietà
negli
stili
di
porta
e
ingressi)
e
una
o
più
saracinesche.
Una
caratteristica
peculiare
dei
castelli
musulmani
nella
penisola
iberica
era
l'uso
di
torri
staccate,
chiamate
albarrane,
attorno
al
perimetro,
come
nel
caso
dell'Alcazaba
(dall'arabo cittadella) di Badajoz. Concepite probabilmente nel XII secolo, le torri fornivano supporto
laterale
ed
erano
collegate
al
castello
da
ponti
di
legno
rimovibili,
ragion
per
cui,
anche
se
espugnate,
non
garantivano
l'accessibilità
al
resto
della
fortificazione.
 Nel cercare
di
spiegare
questo
cambiamento
nella
complessità
e
nello
stile
dei
castelli,
gli
studiosi
hanno
trovato
la
loro
risposta
nelle crociate. I partecipanti a queste ultime campagne appresero molto sulle
fortificazioni
dai
loro
conflitti
con
i
saraceni e da un più attento apprendimento dell'architettura
bizantina. Si
diffusero
a
tal
proposito
leggende
come
quella
di
Lalys
(un
architetto
della Palestina che
si
dice
sia
andato
in
Galles
dopo
le
crociate
e
abbia
imparato
come
migliorare
notevolmente
i
castelli
nel
sud
della
sua
terra)
e
si
immaginava
che
grandi
architetti
come
il
francese Giacomo
di
San
Giorgio fossero
originari
dell'Oriente.
Nel cercare
di
spiegare
questo
cambiamento
nella
complessità
e
nello
stile
dei
castelli,
gli
studiosi
hanno
trovato
la
loro
risposta
nelle crociate. I partecipanti a queste ultime campagne appresero molto sulle
fortificazioni
dai
loro
conflitti
con
i
saraceni e da un più attento apprendimento dell'architettura
bizantina. Si
diffusero
a
tal
proposito
leggende
come
quella
di
Lalys
(un
architetto
della Palestina che
si
dice
sia
andato
in
Galles
dopo
le
crociate
e
abbia
imparato
come
migliorare
notevolmente
i
castelli
nel
sud
della
sua
terra)
e
si
immaginava
che
grandi
architetti
come
il
francese Giacomo
di
San
Giorgio fossero
originari
dell'Oriente.
A
metà
del
Novecento,
questa
tradizionale
e
fallace
impostazione
storiografica
è
stata
messa
in
dubbio. Le
leggende
furono
screditate,
con
gli
studiosi
che
hanno
scoperto,
nel
caso
di
Giacomo
di
San
Giorgio,
che
l'uomo
proveniva
da
Saint-Georges-d'Espéranche,
in
Francia.
Se
le
innovazioni
nella
fortificazione
fossero
giunte
dall'Oriente,
ci
si
sarebbe
aspettato
che
la
loro
influenza
si
scorgesse
dal
1100
in
poi,
subito
dopo
che
i
cristiani
prevalsero
nella prima
crociata (1096-1099), piuttosto che quasi un centennio dopo. I
resti
di
strutture
romane
nell'Europa
occidentale
erano
ancora
in
piedi
in
molti
luoghi,
alcuni
dei
quali
presentavano
torri
rotonde
fiancheggianti
e
ingressi
con
due
torri
fiancheggianti.
I
costruttori
dell'Europa
occidentale
erano
influenzati
dal
mondo
romano:
i
forti
costieri
tardo
romani
sulla
sezione
britannica
della
cosiddetta costa
sassone
furono
riutilizzati
e,
in
Spagna,
le mura intorno
alla
città
di Avila imitavano l'architettura romana quando andarono costruite nel 1091.
Lo
storico
Smail,
nella
sua
opera Crusading
warfare,
ha
sostenuto
che
l'argomento
dell'influenza
della
fortificazione
orientale
sull'Occidente
è
stato
sopravvalutato
e
che
i
crociati
del
XII
secolo,
in
verità,
avevano
imparato
ben
poco
sulla
progettazione
scientifica
dalle
difese
bizantine
e
saracene. Un
castello
ben
posizionato,
che
sfruttava
caratteristiche
naturali
ed
era
dotato
di
robusti
fossati
e
mura,
non
aveva
bisogno
di
un
approccio
scientifico
per
apportare
dei
miglioramenti.
La
scelta
di
ricorrere
all'ausilio
fornito
da
ostacoli
naturali
emerge
chiaramente
nel
caso
di al-Karak, in Giordania. Pur non disponendo delle stesse conoscenze di coloro che lo
assaltarono
in
futuro,
i
costruttori
originali
avevano
reso
la
fortezza
quasi
inespugnabile,
tanto
che
nel
1187 Saladino preferì assediare gli occupanti e farli morire di inedia piuttosto
che
rischiare
un
assalto. Un
altro
celebre
esempio
era
il Castello
Moresco,
situato
sulla rocca
di
Gibilterra,
e
resistito
per
ben
700
anni
agli
assedi
degli
iberici.
Durante
la
fine
dell'XI
e
il
XII
secolo,
in
quella
che
oggi
è
la Turchia centro-meridionale, gli ospitalieri, i cavalieri
teutonici e
i templari si stabilirono nel Regno
armeno
di
Cilicia,
dove
avevano
scoperto
una
reticolata
serie
di
fortificazioni
sofisticate
che
ebbero
un
profondo
impatto
sull'architettura
dei
castelli
crociati.
La
maggioranza
dei
siti
militari
armeni
in
Cilicia
sono
caratterizzati
da:
molteplici
muraglie
posate
con
piani
irregolari
per
seguire
le
sinuosità
degli
affioramenti;
torri
rotonde
e,
soprattutto,
a
ferro
di
cavallo;
pietre
di
rivestimento
finemente
tagliate,
spesso bugnate; porte posteriori nascoste e complessi ingressi inclinati con piombatoie;
feritoie
incassate
per
gli
arcieri;
volte
a
botte,
a
sesto
acuto
o
a
crociera
su
sotterranei,
portoni
e
cappelle;
e
cisterne
con
elaborate
scarpate. Gli
insediamenti
civili
si
trovavano
spesso
nelle
immediate
vicinanze
di
queste
fortificazioni. Dopo
la
prima
crociata,
i
cristiani
che
non
tornarono
alle
loro
case
in
Europa
aiutarono
a
fondare
gli stati
crociati del principato
d'Antiochia,
della contea
di
Edessa,
del regno
di
Gerusalemme e
della contea
di
Tripoli.
I
castelli
che
fondarono
per
assicurarsi
le
loro
acquisizioni
furono
progettati
principalmente
da
maestri
muratori
siriani.
Il
loro
aspetto
era
molto
simile
a
quello
di
un
forte
romano
o
a
una tetrapyrgia bizantina,
la
quale
era
a
pianta
quadrata
e
aveva
torri
quadrate
ad
ogni
angolo
che
non
sporgevano
molto
oltre
la
cortina
muraria.
Il
mastio
di
questi
castelli
crociati
si
componeva
di
una
pianta
quadrata
e
generalmente
non
era
decorato.
Mentre
i
castelli
venivano
usati
per
preservare
il
controllo
di
snodi
geografici
importanti
e
supervisionare
lo
spostamento
delle
truppe,
in
Terra
Santa
alcune
posizioni
strategiche
chiave
non
erano
fortificate. L'architettura dei castelli in Oriente si fece più complessa intorno
alla
fine
del
XII
e
all'inizio
del
XIII
secolo,
dopo
lo
stallo
determinato
dalla terza
crociata (1189-1192). Sia i cristiani che i musulmani crearono fortificazioni
con
caratteristiche
differenti
ben
nitide. Safedino, sovrano dei saraceni del XIII secolo, si avvalse di strutture con grandi
torri
rettangolari
che
influenzarono
l'architettura
musulmana
e
furono
copiate
più
e
più
volte,
avendo
tuttavia
poco
impatto
sui
castelli
crociati
eretti
in
futuro.
Dal
XIII
al
XV
secolo
-
All'inizio
del
Duecento,
i
castelli
crociati
furono
perlopiù
costruiti
da ordini
religiosi
cavallereschi,
inclusi
gli
ospitalieri,
i
templari
e
i
cavalieri
teutonici.
A
questi
gruppi
di
monaci
guerrieri
si
deve
la
realizzazione
di
siti
quali
il krak
dei
Cavalieri, Qala'at
Marqab e Belvoir. L'aspetto variava non solo a seconda dell'ordine che lo costruiva, ma
anche
tra
i
singoli
castelli,
sebbene
fosse
comune
per
quelli
fondati
in
quel
frangente
storico
disporre
di
difese
concentriche.
Il
tentativo,
la
cui
origine
va
individuata
in
castelli
come
il
krak
dei
Cavalieri,
era
quello
di
ridurre
la
dipendenza
da
un
caposaldo
centrale
ed
enfatizzare
la
difesa
delle
mura
di
cinta. Alla
fine,
si
comprese
che,
per
concretizzare
efficacemente
questa
ipotesi,
bisognava
realizzare
più
anelli
di
mura
difensive,
uno
concentrico
rispetto
all'altro,
con
una
sezione
interna
che
doveva
raggiungere
una
quota
superiore
in
modo
che
il
suo
campo
di
fuoco
non
fosse
completamente
oscurato. Se
gli
assalitori
fossero
riusciti
a
valicare
la
prima
linea
di
difesa,
sarebbero
rimasti
intrappolati
nella
sezione
morta
tra
le
mura
interne
ed
esterne,
con
la
sola
facoltà
rimasta
di
assalire
il
secondo
muro
o
ritirarsi.
I castelli
concentrici si
diffusero
a
macchia
d'olio
in
tutta
Europa: Edoardo
I
d'Inghilterra,
che
aveva
partecipato
alle
crociate,
costruì
quattro
delle
otto
roccaforti
ultimate
in
Galles
alla
fine
del
XIII
secolo
seguendo
il
criterio
della
struttura
concentrica. Ad
ogni
modo,
non
si
emularono
tutte
le
caratteristiche
dei
castelli
crociati
del
XIII
secolo
in
Europa.
Nello
specifico,
non
si
ripresero
per
esempio
la
porta
principale
collocata
sul
lato
di
una
torre
e
il
corridoio
d'ingresso
particolarmente
lungo,
che
serviva
ad
aumentare
il
tempo
impiegato
dalle
persone
per
accedere
e
uscire
dal
perimetro
interno
(si
pensi
alla cittadella
di
Aleppo).
Il
tipo
d'ingresso
appena
menzionato,
lievemente
inclinato,
restò
nella
pratica
una
peculiarità
delle
fortificazioni
orientali.

Uno degli
effetti
della crociata
livoniana nel Baltico fu
l'introduzione
di
fortificazioni
in
pietra
e
mattoni. Sebbene
ci
fossero
centinaia
di
castelli
di
legno
in Prussia e Livonia, l'uso di mattoni e malta era sconosciuto nella regione prima dell'approdo
dei
crociati. Fino
al
XIII
secolo
e
all'inizio
del
XIV
secolo,
il
loro
aspetto
era
eterogeneo:
in
seguito,
emerse
il
ricorso
a
una
pianta
base
nella
regione,
dalla
forma
quadrata
e
con
i
quattro
lati
che
proteggevano
il
cortile
centrale. Era
comune
per
i
castelli
in
Oriente
avere
feritoie
nella
facciata
continua
a
più
livelli;
i
costruttori
contemporanei
in
Europa
erano
diffidenti
verso
questa
scelta,
in
quanto
credevano
che
esse
indebolissero
il
muro.
In
verità,
dal
punto
di
vista
ingegneristico
questo
timore
non
aveva
fondamento,
ma
fu
solo
il
programma
di
costruzione
dei
castelli
di
Edoardo
I
che
fugò
ogni
perplessità
nel
continente.
Le
crociate
portarono
anche
all'introduzione
delle piombatoie nell'architettura
occidentale.
Fino
al
XIII
secolo,
le
cime
delle
torri
erano
circondate
da
gallerie
di
legno,
le
quali
consentivano
ai
difensori
di
scagliare
oggetti
sugli
assalitori
sottostanti. Benché
le
caditoie
svolgessero
lo
stesso
scopo
delle
gallerie
di
legno,
si
trattava
probabilmente
di
un'invenzione
orientale
piuttosto
che
di
una
naturale
evoluzione
dei
progetti.
Le
caditoie
erano
infatti
usate
in
Oriente
molto
prima
dell'arrivo
dei
crociati,
forse
già
nella
prima
metà
dell'VIII
secolo
in Siria.
L'epoca
di
maggiore
spinta
costruttiva
dei
castelli
in
Spagna
si
verificò
tra
l'XI
e
il
XIII
secolo,
con
una
fitta
concentrazione
degli
stessi
all'altezza
dei
confini
contesi
tra
le
terre
cristiane
e
musulmane. Il
conflitto
e
l'interazione
tra
i
due
gruppi
portarono
a
uno
scambio
di
idee
architettoniche
e
i
cristiani
spagnoli
adottarono
l'uso
di
torri
staccate.
La Reconquista,
con
cui
si
intendeva
scacciare
i
musulmani
dalla
penisola
iberica,
fu
completata
nel
1492.
Sebbene
la
Francia
sia
stata
descritta
come
"il
cuore
dell'architettura
medievale",
gli
inglesi
assunsero
un
ruolo
non
trascurabile
nell'architettura
dei
castelli
nel
XII
secolo.
Lo
storico
transalpino
François
Gebelin
ha
commentato
a
tal
proposito:
"La
grande
rinascita
dell'architettura
militare
fu
guidata,
come
ci
si
potrebbe
aspettare,
dai
più
potenti
re
e
principi
dell'epoca;
è
il
caso
dei
figli
di
Guglielmo
il
Conquistatore
e
dei
loro
discendenti,
i Plantageneti,
quando
divennero
duchi
di Normandia.
Questi
furono
gli
uomini
che
costruirono
tutti
i
più
caratteristici
castelli
fortificati
del
XII
secolo
sopravvissuti
ancora
oggi".
Nonostante ciò, all'inizio del Quattrocento, il tasso di costruzione di
castelli
in
Inghilterra
e
Galles
sperimentò
un
calo.
I
nuovi
castelli
vissero
generalmente
lavori
più
leggeri
rispetto
alle
strutture
precedenti
e
presentavano
poche
innovazioni,
sebbene
fossero
ancora
create
delle
roccaforti
come
quella
di Raglan, in Galles. Allo stesso tempo, l'architettura dei castelli francesi salì
alla
ribalta
e
aprì
la
strada
nel
campo
delle
fortificazioni
medievali.
In
Europa,
in
particolare
nel
Baltico,
in
Germania
e
in Scozia,
si
continuarono
a
battezzare
nuovi
castelli
fino
al
XVI
secolo.

Avvento della
polvere
da
sparo
-
L'artiglieria
alimentata
con
la polvere
da
sparo fu
introdotta
in
Europa
nel
1320
e
si
diffuse
in
fretta.
Nel
1362
si
segnala
il
ricorso
ai fucili
a
pietra
focaia durante
l'assedio del castello
di
Kaunas nell'ambito
della crociata
lituana. Le pistole, inizialmente imprevedibili e imprecise, comparvero sui
campi
di
battaglia
dal
1380. Da
quel
momento,
i
castelli
furono
adattati
per
consentire
a
piccoli
pezzi
di
artiglieria
con
una
media
tra
19,6
e
22 kg
di
sparare
dalle
torri.
Questo
tipo
di
armamento
era
troppo
pesante
perché
potesse
essere
trasportato
e
azionato
da
un
solo
uomo.
Le
aperture
per
i
cannoni
sviluppate
in
questo
periodo
mostrano
una
caratteristica
unica,
ovvero
la
presenza
di
un
pezzo
di
legno
dalla
forma
orizzontale
attraverso
l'apertura. Un
gancio
all'estremità
dell'arma
poteva
essere
agganciato
al
legno
in
modo
che
l'artigliere
non
dovesse
subire
il
rinculo
completo
dell'arma.
Questo
adattamento
si
rintraccia
in
tutto
il
Vecchio
Continente,
benché
il
legname
sia
sopravvissuto
nel
corso
dei
secoli
in
rari
casi:
è
questa
la
situazione
del
castello
di
Doornenburg,
nei Paesi
Bassi meridionali,
dove
è
pervenuto
in
uno
stato
sorprendentemente
intatto. Le
bocche
dei
cannoni
assumevano
la
forma
delle
aperture
da
cui
sparavano,
con
un
foro
circolare
nella
parte
inferiore
per
l'arma
e
una
stretta
fessura
nella
parte
superiore
per
consentire
all'artigliere
di
mirare.
Questa
forma
è
molto
comune
nei
castelli
adattati
all'utilizzo
di
armi
presenti
in Egitto, Italia, Scozia, Spagna e altre località mediterranee. Altri tipi di
aperture,
sebbene
meno
comuni,
erano
fessure
orizzontali,
che
consentivano
solo
il
movimento
laterale,
e
grandi
aperture
quadrate,
che
permettevano
una
maggiore
manovrabilità. L'uso
di
cannoni
per
la
difesa
diede
il
via
all'affermazione
dei
castelli
di
artiglieria
come
quello
di Ham,
nella
Francia
settentrionale.
Le
difese
contro
le
armi
da
fuoco
non
subirono
un
processo
di
sviluppo
fino
a
un
momento
successivo. Ham
è
un
esempio
perfetto
della
tendenza
dei
nuovi
castelli
a
rinunciare
a
elementi
di
epoca
passata
quali
le
caditoie,
le
alte
torri
e
le
merlature.
Furono
sviluppati
cannoni
più
grandi
e,
nel
Quattrocento,
essi
divennero
un'alternativa
alle
macchine
d'assedio
come
il trabucco.
I
vantaggi
dei
primi
rispetto
ai
secondi
riguardavano
una
maggiore
gittata
e
una
più
elevata
potenza.
Nel
tentativo
di
renderli
più
efficaci,
i
cannoni
furono
resi
sempre
più
grandi,
anche
se
ciò
ostacolava
la
loro
capacità
di
raggiungere
castelli
remoti. Nel
1450,
i
cannoni
risultavano
l'arma
d'assedio
preferita
e
la
loro
efficacia
fu
dimostrata
da Maometto
II in
concomitanza
con
la caduta
di
Costantinopoli.
La
risposta
verso
cannoni
più
efficaci
passava
per
la
costruzione
di
mura
più
spesse
e
per
la
preferenza
delle
torri
rotonde,
poiché
i
lati
curvi
avevano
maggiori
probabilità
di
deviare
un
colpo
rispetto
a
una
superficie
piana.
Mentre
questo
era
sufficiente
per
i
nuovi
castelli,
le
strutture
preesistenti
dovettero
escogitare
un
modo
per
resistere
ai
colpi
delle
nuove
pericolose
arme.
In
alcune
situazioni
si
ricorse
all'accatastamento
di
terra
dietro
la
cinta
muraria
per
ridurre
l'impatto
causato
dalle
palle.
Spesso,
i
castelli
costruiti
prima
dell'avvento
della
polvere
da
sparo
non
apparivano
in
grado
di
posizionare
cannoni
perché
i
cammini
di
ronda erano
troppo
stretti. Una
soluzione
a
questo
era
abbattere
la
sezione
superiore
di
una
torre
e
riempire
la
parte
inferiore
con
le
macerie
per
fornire
una
superficie
da
cui
sparare
con
i
cannoni.
Abbassare
le
difese
in
questo
modo
ebbe
l'effetto
di
renderle
più
facili
da
scalare
con
le
scale.
Una
difesa
alternativa
più
popolare,
che
evitava
di
compiere
interventi
di
riparazione,
era
quella
di
stabilire baluardi oltre le difese del castello. Questi potevano essere
costruiti
con
terra
o
pietra
e
venivano
usati
per
montare
armi.
Bastioni
e
fortificazioni
alla
moderna
(XVI
secolo)
-
Intorno
al
1500
si
sviluppò
in
Italia
l'innovazione
del
bastione
angolato.
Una simile tecnologia rese la penisola pioniera con riguardo alle
fortificazioni
permanenti
di
artiglieria,
che
sostituirono
il
ruolo
difensivo
dei
castelli.
Questo
tipo
di
costruzione
assunse
la
felice
denominazione
di fortificazione
alla
moderna,
anche
detta
all'italiana. 
I
mastri
costruttori
responsabili
della
realizzazione
dei
castelli
si
trovarono
in
quella
parentesi
storica
davanti
a
un
bivio,
ovvero
quello
di
scegliere
tra
il
nuovo
tipo,
in
grado
di
resistere
ai
cannoni
e
al
fuoco
dell'artiglieria,
o
lo
stile
precedente,
più
elaborato,
complesso
e
che
si
stava
rivelando
in
parte
obsoleto.
Inoltre,
il
primo
stile
presentava
come
aspetti
negativi
la
scarsa
gradevolezza
estetica
e
una
parziale
scomodità
interna,
mentre
il
secondo
appariva
gradevole
alla
vista,
incuteva
timore
reverenziale
e
aveva
un
valore
che
esulava
dal
campo
bellico,
estendendosi
anche
alla
forza
che
il
signore
di
turno
sperava
di
dimostrare
con
il
castello.
Alla
luce
di
queste
riflessioni,
la
seconda
scelta
si
rivelò
più
popolare,
in
quanto
divenne
evidente
che
non
aveva
senso
sacrificare
la
difesa
ricorrendo
a
ideali
anacronistici.
Per
una
serie
di
motivi,
non
ultimo
il
fatto
che
molti
castelli
non
hanno
una
storia
documentata,
non
si
ha
contezza
di
un
numero
preciso
di
edifici
costruiti
nel
periodo
medievale.
Cionostante,
si
stima
che
il
totale
ammontava
tra
i
75.000
e
i
100.000
nell'Europa
occidentale:
di
questi
circa
1.700
erano
in
Inghilterra
e
Galles,
un
dato
nettamente
minore
rispetto
alle
aree
di
lingua
tedesca
(circa
14.000).
Viene
anche
abbandonata
la
fisionomia
difensiva
per
compartimenti
stagni
in
favore
di
una
più
ampia
accessibilità
delle
varie
parti,
in
modo
da
poter
agevolmente
raggiungere
i
punti
sotto
attacco
e
rifornirli
di
munizioni
e
uomini. Il
passaggio
dai
castelli
medievali
del
primo
tipo
(che
avevano
nella
compartimentazione
e
nell'altezza
i
propri
punti
di
forza)
a
quelli
aggiornati
per
la
difesa
dai
colpi
delle
armi
da
fuoco
sempre
più
potenti,
accadde
per
gradi,
con rocche
di
transizione,
come
quelle
della
Romagna
e
delle Marche .
Oltre
al
progressivo
infossamento
e
abbassamento
della
struttura
(nella
quale
il
fossato
non
serve
per
il
riempimento
con
acqua
ma
per
nascondere
in
basso
file
di bombarde pronte al tiro ficcante in caso di assedio), si ha il passaggio a
torrioni
tondi,
maggior
spessore
delle
mura,
aggiunta
di
una
punta
ai
torrioni
tondi
che
assumono
-
in
pianta
-
la
forma
ad
asso
di
picche. Questa
punta
serviva
ad
evitare
che
gli
attaccanti
potessero
raggiungere
un
punto
cieco,
sottraendosi
così
all'azione
dei
colpi
incrociati
provenienti
dagli
altri
torrioni
vicini.
Nelle
rocche
e
castelli
di
transizione
si
ha
anche
la
progressiva
trasformazione
della
bombardiera e
della
corrispondente
finestra
di
sfiato
fumi,
la
cui
fisionomia
permette
di
datare
le
strutture
e
di
riconoscere
le
varie
fasi
della
evoluzione
difensiva
di
determinate
opere
militari
dell'epoca
di
transizione.
Frattanto,
l'arte
della
costruzione
dei
castelli
sbarcò
anche
nelle Americhe per mano dei colonizzatori spagnoli e francesi.
La
prima
fase
della
costruzione
dei
forti
iberici
è
stata
definita
il
"periodo
del
castello",
che
durò
in
essere
dal
1492
fino
alla
fine
del
XVI
secolo. A partire dal completamento della fortezza di Ozama, nell'odierna Repubblica
Dominicana,
"questi
lavori
erano
essenzialmente
castelli
medievali
europei
trasposti
in
America". A fianco delle strutture difensive minori o differenti come fortezze e
cittadelle,
nella
Nuova
Francia
si
costruirono
anche
dei
castelli
verso
la
fine
del
Seicento. A Montreal l'artiglieria non era sviluppata come sui campi di battaglia d'Europa,
alcuni
dei
forti
periferici
della
regione
erano
stati
costruiti
come
i manieri
fortificati della
madrepatria.
Il
forte
di Longueuil,
costruito
dal
1695
al
1698
da
una
famiglia
baronale,
è
stato
descritto
come
"la
roccaforte
dall'aspetto
più
medievale
costruita
in
Canada". I manieri e le caserme erano all'interno di un cortile fortificato,
con
un'alta
torretta
rotonda
in
ogni
angolo.
Il
"forte
più
robusto
simile
a
un
castello"
vicino
a
Montréal
era
il
forte
di Senneville,
costruito
nel
1692
con
torri
quadrate
collegate
da
spesse
mura
di
pietra,
nonché
un
mulino
a
vento
fortificato. Le
fortezze
in
pietra
come
queste
fungevano
da
residenze
difensive,
oltre
che
da
imponenti
strutture
per
prevenire
le
incursioni
degli irochesi.
Sebbene
la
costruzione
dei
castelli
svanì
verso
la
fine
del
XVI
secolo,
tali
edifici
non
caddero
tutti
in
disuso.
Alcuni
mantennero
un
ruolo
nell'amministrazione
locale
e
furono
convertiti
in
tribunali,
mentre
altri,
in
mano
alle
famiglie
aristocratiche,
supplirono
al
compito
di
residenza
di
generazione
in
generazione.
Un
esempio
particolarmente
famoso
appartenente
a
questa
categoria
risulta
il castello
di
Windsor,
in
Inghilterra,
fondato
nell'XI
secolo
e
ancora
attualmente
posseduto
dalla
corona
del
Regno
Unito. In altri casi essi perseguivano ancora un ruolo difensivo: le casetorre,
strettamente
imparentate
con
i
castelli,
comprendevano
le pele, ovvero torri di difesa che erano residenze permanenti costruite tra il XIV
e
il
XVII
secolo.
Particolarmente
comuni
in
Irlanda
e
Scozia,
esse
potevano
essere
alte
fino
a
cinque
piani
e
venivano
utilizzate
quali
torri
d'osservazione
o
come
segnalatore
di
pericolo
per
allertare
le
guarnigioni
di
un
rischio
imminente. Sebbene
non
fornissero
la
stessa
protezione
di
un
castello
più
complesso,
la
loro
sicurezza
contro
minacce
dalla
portata
ristretta
non
può
essere
negata.

Gli
impieghi
successivi
e
il
revivalismo
dei
castelli
-
Secondo
gli
archeologi
Oliver
Creighton
e
Robert
Higham,
"le
grandi
case
di
campagna
dal
XVII
al
XX
secolo
erano,
in
senso
sociale,
i
castelli
del
loro
tempo". Sebbene
ci
fosse
una
tendenza
per
l'élite
a
spostarsi
dagli
antichi
presidi
alle
case
di
campagna
nel
XVII
secolo,
i
castelli
non
si
rivelarono
completamente
inutili.
Nei
conflitti
successivi,
come
la guerra
civile
inglese (1641-1651),
molti
castelli
furono
rifortificati,
anche
se
in
seguito
il
processo
si
interruppe
al
fine
di
evitare
che
venissero
utilizzati
di
nuovo. Ad alcune residenze di campagna, che non dovevano essere fortificate,
si
conferì
l'aspetto
di
un
castello
volto
a
intimorire
i
potenziali
invasori,
aggiungendo
torrette
e
ricorrendo
a
piccole
finestre.
Uno
dei
casi
che
seguono
quanto
affermato
si
rintraccia
nel
castello
di
Bubaqra
del
XVI
secolo,
a
Malta,
in
seguito
modificato
nel
Settecento.
I
castelli
in stile
revivalista o falsi
storici acquisirono
una
certa
fama
durante
il Romanticismo,
complice
la
rinnovata
riscoperta
del
Medioevo
e
degli
ideali
della
cavalleria.
Si
pensi
a
opere
architettoniche
quali Chapultepec,
in
Messico,
Neuschwanstein
in
Germania
e il castello di Drogo ultimato da Edwin
Lutyens (1911-1930),
l'ultimo
barlume
di
questo
movimento
nelle
isole
britanniche. Mentre chiese e cattedrali in stile gotico potevano imitare fedelmente
esempi
medievali,
le
nuove
case
di
campagna
costruite
nello
"stile
dei
castelli"
differivano
internamente
dai
loro
predecessori
medievali.
Ciò
si
spiegava
perché
l'aspetto
delle
vecchie
strutture
avrebbe
lasciato
le
case
fredde
e
buie
per
i
livelli
dell'Ottocento.
Anche
le
rovine
artificiali,
costruite
per
assomigliare
ai
resti
di
edifici
storici,
si
annoverano
nell'ambito
della
corrente
architettonica
sopra
esposta.
Di
solito,
esse
venivano
ultimate
per
abbellire
i
parchi
rievocando
delle
caratteristiche
dei
castelli
antichi. I capricci seguivano dettami e canoni simili, sebbene differissero dalle rovine
artificiali
in
quanto
non
facevano
parte
di
un
paesaggio
progettato
a
priori,
ma
si
proponevano
alla
stregua
di
edifici
stravaganti,
frivoli
o
buffi,
senza
perseguire
uno
scopo
pratico. Entrambi
si
ispiravano
a
elementi
dell'architettura
del
castello
come
le
torri
e
gli
archi,
ma
non
avevano
alcuno
scopo
militare,
bensì
squisitamente
artistico. Ad
oggi
i
castelli
costituiscono
un'attrazione
turistica
comune
anche
per
bambini
nei
campi
da
gioco
e
nei
parchi
divertimento,
come
quelli
proposti
nel
parco
dell'Italia
in
miniatura.
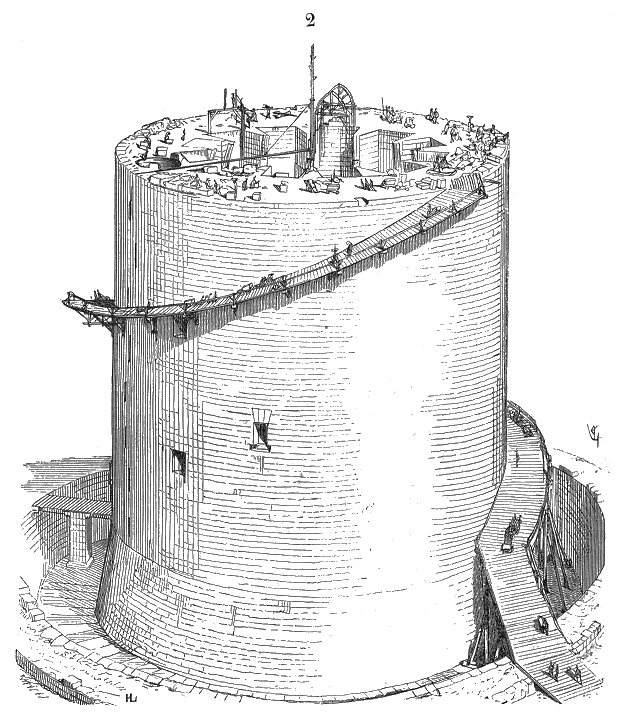 Costruzione
-
Una
volta
selezionato
il
sito
ritenuto
idoneo
per
la
costruzione,
solitamente
di
interesse
strategico
o
destinato
a
dominare
il
paesaggio
con
scopi
simbolici,
si
doveva
scegliere
il
materiale
da
costruzione. Un
castello
di
terra
e
legno
era
più
economico
e
più
facile
da
erigere
rispetto
a
uno
in
pietra.
I
costi
non
sono
sempre
noti
agli
studiosi,
in
quanto
i
dati
disponibili
riguardano
solo
gli
esosi
esborsi
per
i
castelli
reali. Un
castello
con
bastioni
di
terra,
una
motta,
difese
in
legno
ed
edifici
poteva
essere
costruito
anche
da
una
manodopera
non
qualificata. Costruzione
-
Una
volta
selezionato
il
sito
ritenuto
idoneo
per
la
costruzione,
solitamente
di
interesse
strategico
o
destinato
a
dominare
il
paesaggio
con
scopi
simbolici,
si
doveva
scegliere
il
materiale
da
costruzione. Un
castello
di
terra
e
legno
era
più
economico
e
più
facile
da
erigere
rispetto
a
uno
in
pietra.
I
costi
non
sono
sempre
noti
agli
studiosi,
in
quanto
i
dati
disponibili
riguardano
solo
gli
esosi
esborsi
per
i
castelli
reali. Un
castello
con
bastioni
di
terra,
una
motta,
difese
in
legno
ed
edifici
poteva
essere
costruito
anche
da
una
manodopera
non
qualificata.
La
fonte
della
forza
lavoro
proveniva
probabilmente
dalla
signoria
dove
era
collocata
la
roccaforte,
con
gli
inquilini
che
dovevano
avere
già
le
competenze
necessarie
per
abbattere
alberi,
scavare
e
lavorare
il
legname
necessario
per
realizzare
la
struttura
di
terra
e
legno.
Forse
perché
costretti
a
lavorare
per
il
loro
signore,
la
costruzione
di
un
castello
di
terra
e
legno
non
si
rivelava
un
salasso
insormontabile
per
il
committente.
In
termini
di
tempo,
si
stima
che
una
motta
di
dimensioni
medie
(alta
5
e
larga
15
m
alla
sommità)
avrebbe
impiegato
50
persone
circa
e
40
giorni
lavorativi.
Tra
le
motte
e
le
corti
eccezionalmente
costose
si
annovera Clones, in Irlanda, costruita nel 1211 al costo di 20 sterline. Il prezzo lievitò per via della necessità di assumere manodopera, non
disponendone
direttamente
il
signore.
Il
costo
di
costruzione
di
un
castello
variava
in
base
a
fattori
quali
la
loro
complessità
e
i
costi
di
trasporto
del
materiale.
Anche
una
torre
molto
piccola,
come
quella
del castello
di
Peveril,
poteva
raggiungere
il
costo
totale
di
circa
200
sterline.
Tra
gli
altri
castelli
per
cui
fu
necessario
spendere
delle
cifre
di
un
certo
calibro
si
annoverano
Orford,
ultimato
alla
fine
del
XII
secolo
per
1.400
£,
e Dover,
costato
circa
7.000
£
tra
il
1181
e
il
1191. Le spese sulle scale di vasti castelli come il castello
di
Gaillard (stimato
tra
15.000
e
20.000
£
tra
il
1196
e
il
1198)
erano
facilmente
sostenuti
dalla
corona,
ma
per
i
nobili
la
costruzione
del
castello
si
dimostrava
un'impresa
molto
impegnativa
e
costosa. In
condizioni
normali,
realizzare
un
castello
di
pietra
necessitava
quasi
un
decennio.
Il
costo
di
un
grande
castello
costruito
in
quel
periodo,
compreso
tra
1.000
e
10.000
£,
poteva
incidere
gravemente
sulle
finanze
di
un
signore,
tenuto
conto
dei
rischi
esterni
che
ci
si
assumeva:
il
contemporaneo
scoppio
di
una
guerra
o
di
una
pandemia
avrebbe
appesantito
ancora
maggiormente
le
spese. I
costi
alla
fine
del
XIII
secolo
erano
di
un
ordine
simile,
con
castelli
come
quello
di Beaumaris e Rhuddlan che costarono 14.500 e 9.000 £ rispettivamente. La campagna di
costruzione
di
castelli
di Edoardo
I in Galles necessitò l'uscita dalle casse statali di 80.000 £ tra il
1277
e
il
1304
e
di
95.000
tra
il
1277
e
il
1329.
Non
solo
i
castelli
di
pietra
erano
costosi
da
costruire,
ma
esigevano
una
costante
manutenzione
che
presupponeva
il
pagamento
di
ulteriori
costi.
La
presenza
di
numerose
cataste
di
legname,
spesso
non
stagionato,
necessitava
di
un'attenta
manutenzione
per
evitare
incidente.
Al
tramonto
del
XII
secolo,
le
riparazioni
di
castelli
come
quello
di Exeter e Gloucester costavano tra le 20 e le 50 £ all'anno.
La
rincorsa
alla
costruzione
di macchine
medievali che
potessero
espugnare
i
siti
difensivi,
come
la
gru
a
ruota,
innescò
una
gara
con
gli
ingegneri
che,
al
contrario,
tentavano
di
preservare
l'inviolabilità
delle
strutture. Così, la pietra surclassò il legno, ma generò in varie occasioni
problemi
di
logistica
in
merito
al
trasporto
del
materiale
di
costruzione:
per
questo,
una
delle
principali
preoccupazioni
dei
costruttori
medievali
era
rimanere
a
poca
distanza
dalle
cave.
Esistono
esempi
di
alcuni
castelli
in
cui
la
pietra
veniva
estratta
in
loco,
come Chinon, Coucy e Gaillard. Quando la si edificò in Francia nel 992, la
torre
in
pietra
del castello
di
Langeais era
alta
16
m,
larga
17,5
e
lunga
10
m,
con
mura
in
media
alte
1,5
m.
Queste
ultime
constano
attualmente
di
1.200
m³
di
pietra
e
occupano
una
superficie
totale
(sia
interna
che
esterna)
di
1.600
m².
Si
stima
occorsero
per
il
completamento
della
torre
circa
83.000
giorni
lavorativi
(227
anni
e
24
giorni),
coinvolgendo
soprattutto
manodopera
non
qualificata.
Molte
realtà
politiche
disponevano
di
castelli
sia
in
legno
che
in
pietra:
in
casi
come
la
Danimarca,
che
possedeva
poche
cave,
il
grosso
dei
suoi
castelli
si
componeva
di
terra
e
legname,
mentre
più
tardi
comparvero
i
mattoni. Le strutture in mattoni non erano necessariamente più deboli delle
loro
controparti
in
pietra:
meno
comuni
in
Inghilterra
delle
costruzioni
in
pietra
o
terra
e
legno,
spesso
venivano
scelte
per
gusti
estetici
o
perché
andavano
di
moda,
sulla
scia
degli
esempi
architettonici
forniti
dai Paesi
Bassi. È il caso del castello di Tattershall, che vide la luce tra il 1430 e il
1450:
l'abbondanza
di
pietre
nelle
vicinanze
era
innegabile,
ma
il
proprietario,
Ralph
Cromwell,
scelse
di
ricorrere
ai
mattoni. Si
impiegarono
circa
700.000
mattoni
per
costruire
il
castello,
che
è
stato
descritto
come
"il
miglior
esempio
di
muratura
medievale
in
Inghilterra". La
maggior
parte
dei
castelli
spagnoli
era
costruita
in
pietra,
mentre
quelli
dell'Europa
orientale erano
generalmente
in
legno.
Il De
constructione
castri
Saphet,
scritto
nei
primi
anni
del
1260,
descrive
le
fasi
della
costruzione
di
un
nuovo
castello
a Safad. Si tratta di "uno dei più esaustivi" resoconti medievali
incentrato
sulla
realizzazione
di
una
roccaforte.

Centro
di
aggregazione
sociale
-
La
presenza
del signore
fondiario in
un
castello
rendeva
l'edificio
un
centro
di
amministrazione
da
cui
controllava
le
sue
terre.
Questi
faceva
affidamento
sul
sostegno
di
coloro
che
erano
a
lui
sottoposti,
in
assenza
del
quale
ogni
possibilità
che
il
suo
potere
fosse
minato
restava
aperta. I
signori
di
successo
riunivano
regolarmente
la
corte
con
membri
immediatamente
al
di
sotto
del
loro
grado
nella
piramide
gerarchica
sociale,
ma
gli
assenti
potevano
aspettarsi
di
trovare
la
loro
influenza
indebolita.
Le
signorie
più
grandi
potevano
risultare
vaste
e,
poiché
sarebbe
stato
arduo
visitare
regolarmente
tutte
i
suoi
possedimenti,
il
nobile
di
turno
soleva
nominare
dei
funzionari. Ciò
valeva
soprattutto
per
le
famiglie
reali,
che
a
volte
possedevano
dislocate
in
regioni
lontane
le
une
dalle
altre.
Per
consentire
al
signore
di
concentrarsi
sui
suoi
doveri
di
amministrazione,
egli
disponeva
di
una
servitù
che
si
occupava
di
faccende
come
la
fornitura
di
cibo.
Alle
esigenze
della
sua
famiglia
provvedeva
un ciambellano,
mentre
un
tesoriere
si
occupava
di
supervisionare
il
patrimonio.
Le
dinastie
reali
assumevano
essenzialmente
la
stessa
forma
delle
famiglie
baronali,
sebbene
su
scala
molto
più
ampia
e
con
posizioni
più
prestigiose
aspirate
da
una
fetta
di
popolazione
più
ampia. Un ruolo preponderante dei domestici riguardava la preparazione
del
cibo;
le
cucine
del
castello
diventavano
un
luogo
affollato
quando
il
castello
era
occupato
da
numerose
persone,
circostanza
che
richiedeva
la
fornitura
di
pasti
abbondanti. Senza la presenza di una casa signorile, di solito perché alloggiava
altrove,
un
castello
risultava
in
teoria
un
luogo
tranquillo
con
pochi
residenti,
poiché
essi
si
potevano
meglio
concentrare
sulla
manutenzione
della
struttura
e
sopperire
assai
agevolmente
ai
bisogni
quotidiani.
Essendo
di
fatto
dei
centri
di
aggregazione
sociale,
i
castelli
avevano
un
valore
simbolico
imprescindibile. Proprio
per
questo,
il
signore
che
ne
possedeva
uno
soleva
esporre
la
propria
autorità
in
vari
modi,
che
passavano
per
la
presenza
di
tante
truppe,
dalla
cura
per
gli
interni
a
livello
artistico,
dal
numero
di
stanze,
dalle
tecnologie
difensive
annesse
e
da
tanti
altri
elementi.
I
castelli
venivano
paragonati
alle
cattedrali
come
oggetti
di
orgoglio
architettonico,
con
alcuni
edifici
che
incorporavano
i
giardini
come
elementi
ornamentali. Gli
ideali
di
cavalleria
a
cui
aspirava
l'élite
nel
Medioevo
si
tramandò
nei
secoli
a
venire,
suscitando
grande
interesse
nell'epoca
in
cui
si
squarciò
il
mito
del
Medioevo
come
epoca
buia
e
triste.
Le
strutture
realizzate
secondo
i
canoni
del
revivalismo
romantico
avrebbero
attinto
a
elementi
estetici
dell'architettura
del
castello,
come
i
merli. Proprio
quest'ultima
caratteristica
aveva
un
enorme
valore
in
epoca
medievale.
Il
diritto
alla
merlatura,
quando
concesso
da
un
monarca,
anche
se
non
era
sempre
necessario,
risultava
importante
non
solo
perché
consentiva
a
un
signore
di
difendere
la
sua
proprietà,
ma
perché
i
merli
e
altri
accessori
associati
ai
castelli
erano
associati
nell'immaginario
comune
al
mondo
aristocratico. Le licenze di merlatura provavano inoltre con certezza la concessione
di
un
favore
o
di
una
relazione
con
il
monarca,
che
era
il
responsabile
dell'assegnazione
del
permesso.
L'amor
cortese era
un
ideale
letterario
per
cui
il
vincolo
amoroso
veniva
stretto
tra
un
uomo
nobile
socialmente
inferiore
(solitamente
un
prode
cavaliere,
membro
dell'aristocrazia
militare)
e
una
dama
di
rango
più
elevato,
spesso
la
moglie
del
signore
feudale
del
cavaliere.
Sebbene
a
volte
espresso
attraverso eventi
cavallereschi come
i tornei,
dove
i
cavalieri
combattevano
indossando
un
oggetto
dalla
loro
dama,
questo
poteva
anche
essere
platonico
e
coltivato
in
segreto. La
leggenda
di Tristano
e
Isotta rappresenta
uno
dei
migliori
esempi
di
storie
di
amor
cortese
raccontate
nel
Medioevo,
ma
vari
spunti
si
rintracciano
anche
nella letteratura
italiana con
la Divina
Commedia di Dante
Alighieri e
le
liriche
di Francesco
Petrarca dedicate
a
Laura,
sia
pur
con
alcune
differenze. Così
come
la
donna,
anche
l'uomo
poteva
essere
sposato:
non
era
raro
o
ignobile
che
un
signore
fosse
adultero
(Enrico
I
d'Inghilterra aveva
più
di
20 figli
illegittimi),
ma
se
ciò
accadeva
nel
caso
di
una
donna
si
soleva
considerarla
responsabile
di
un'azione
promiscua
e
disdicevole.
 Lo
scopo
del
matrimonio
tra
i
membri
dell'aristocrazia
era
quello
di
assicurarsi
la
trasmissione
dei
feudi.
Le
ragazze
si
sposavano
in
età
adolescenziale,
mentre
i
ragazzi
non
si
sposavano
fino
alla
maggiore
età.
Nell'immaginario collettivo, si crede che le donne giocassero un ruolo marginale nei
castelli
medievali,
dominati
dal
signore
stesso.
Ciò
deriva
dal
mito
che
i
castelli
fossero
costantemente
coinvolti
in
eventi
bellici,
ma
la
maggior
parte
delle
strutture
in
Inghilterra,
Francia,
Irlanda
e
Scozia
non
furono
mai
coinvolte
in
conflitti
o
assedi,
ragion
per
cui
questo
aspetto
storiografico
andrebbe
approfondito
maggiormente. Alla
donna
si
dava
una controdote dei
beni
di
suo
marito,
di
solito
circa
un
terzo,
che
rimaneva
suo
per
tutta
la
vita,
fin
quando
suo
marito
lo
avrebbe
incamerato
alla
morte
di
lei.
Era
suo
dovere
gestirli
direttamente,
poiché
il
signore
amministrava
la
propria
terra. Nonostante fosse generalmente esclusa dal servizio militare, la donna
poteva
operare
come
custode
di
un
castello,
per
conto
del
marito
oppure
amministrarlo
interamente
quando
era
vedova. Lo
scopo
del
matrimonio
tra
i
membri
dell'aristocrazia
era
quello
di
assicurarsi
la
trasmissione
dei
feudi.
Le
ragazze
si
sposavano
in
età
adolescenziale,
mentre
i
ragazzi
non
si
sposavano
fino
alla
maggiore
età.
Nell'immaginario collettivo, si crede che le donne giocassero un ruolo marginale nei
castelli
medievali,
dominati
dal
signore
stesso.
Ciò
deriva
dal
mito
che
i
castelli
fossero
costantemente
coinvolti
in
eventi
bellici,
ma
la
maggior
parte
delle
strutture
in
Inghilterra,
Francia,
Irlanda
e
Scozia
non
furono
mai
coinvolte
in
conflitti
o
assedi,
ragion
per
cui
questo
aspetto
storiografico
andrebbe
approfondito
maggiormente. Alla
donna
si
dava
una controdote dei
beni
di
suo
marito,
di
solito
circa
un
terzo,
che
rimaneva
suo
per
tutta
la
vita,
fin
quando
suo
marito
lo
avrebbe
incamerato
alla
morte
di
lei.
Era
suo
dovere
gestirli
direttamente,
poiché
il
signore
amministrava
la
propria
terra. Nonostante fosse generalmente esclusa dal servizio militare, la donna
poteva
operare
come
custode
di
un
castello,
per
conto
del
marito
oppure
amministrarlo
interamente
quando
era
vedova.
La scelta
del
sito
di
costruzione
-
La
scelta
del
sito
di
costruzione
dei
castelli
passava
per
una
valutazione
della
geografia
offerta
dal
territorio.
Mentre
i
castelli
di
collina
come Marksburg erano comuni in Germania, dove il 66% di tutti quelli medievali
conosciuti
erano
collocati
su
altopiani
mentre
il
34%
su
terreni
pianeggianti,
lo
stesso
non
valeva
per
l'Inghilterra. Lo
stesso
discorso
vale
per
l'Italia,
dove
le
alture
venivano
sfruttate
ampiamente
per
la
creazione
di
castelli
(è
il
caso,
tra
i
tantissimi,
di Gradara, Zumelle, Rocca
Calascio,
Avella
e
Milazzo).
A
causa
della
gamma
di
funzioni
che
dovevano
svolgere,
la
scelta
era
un'operazione
che
andava
ponderata
con
attenzione.
Nella
scelta
di
un
sito
si
consideravano
infatti
molteplici
fattori,
bilanciando
la
necessità
di
una
posizione
difendibile
con
altre
considerazioni,
come
l'accessibilità
a
beni
fondamentali
come
l'acqua
e
a
materie
prime.
Molti
castelli
si
trovavano
in
prossimità
di
strade
romane,
rimaste
fondamentali
snodi
di
comunicazione
nel
Medioevo,
o
in
località
da
cui
sarebbero
transitate
vie
aperte
dopo
la
costruzione
degli
stessi.
Quando
risultava
possibile,
si
sfruttavano
le
difese
preesistenti,
come
la
costruzione
di
un
forte
romano
o
i
bastioni
di
una
fortezza
di
collina
dell'età
del
ferro.
La
posizione
geografica
poteva
anche
perseguire
scopi
deterrenti
oltre
che
in
campo
bellico,
conferendo
alla
costruzione
un'aura
di
simbolo
di
potere. I
castelli
urbani
erano
particolarmente
importanti
nel
controllare
i
centri
abitati
ed
economici,
anche
nel
caso
in
cui
una
nuova
potenza
che
rimpiazzava
la
precedente
li
avesse
espugnati.
Poiché
i
castelli
non
erano
semplici
edifici
militari,
ma
pure
centri
di
amministrazione
e
simboli
di
potere,
essi
avevano
un
impatto
significativo
sul
paesaggio
circostante. Collocati
lungo
una
strada
o
un
fiume
di
uso
frequente,
i
castelli
per
controllare
il
flusso
di
persone
e
merci
prevedevano
un
passaggio
condizionato
al
pagamento
di
ingenti
pedaggi,
consentendo
al
signore
di
incamerare
dei
guadagni. I
castelli
rurali
erano
spesso
affiancati
da
mulini
e
campi
coltivati,
cosa
che
finì
per
farli
assumere
un
maggiore
peso
sulla
produzione
e
sulla
conservazione
delle
risorse. Altri erano adiacenti o alle foreste reali o ai parchi dei cervi, dove
era
ancor
più
importante
la
cura
del
loro
stato.
Gli
stagni
con
dei
pesci
all'interno,
presenti
in
più
strutture
dislocate
in
Europa,
erano
un
lusso
che
si
potevano
concedere
solo
alcuni
aristocratici
particolarmente
abbienti.
Al
di
là
dello
scopo
pratico
della
fornitura
idrica
e
ittica,
essi
erano
diffusi
tra
chi
riusciva
a
ostentare
la
propria
ricchezza
senza
patire
eccessivamente
i
costi
necessari
alla
costruzione
e
alla
manutenzione.
Sebbene
a
volte
la
costruzione
di
un
castello
portò
alla
distruzione
di
un
agglomerato,
come
nel
caso
di
Eaton
Socon,
in
Inghilterra,
era
più
comune
che
i
villaggi
vicini
crescessero
a
livello
demografico
a
causa
della
presenza
di
un
castello.
A
volte,
gli
insediamenti
si
venivano
a
costituire
proprio
a
ridosso
del
castello
o
comunque
ne
veniva
incitata
la
creazione. I
benefici
della
vicinanza
a
un
centro
economico
anziché
la
scelta
di
vivere
nelle
campagne
consentiva
di
sentirsi
più
sicuri
dal
rischio
di
aggressioni.
Così
si
spiega
le
genesi
dei borghi, abitati dai sudditi che versavano tributi il signore e che,
all'occorrenza,
si
rifugiavano
all'interno
del
complesso
fortificato
sopportando
assedi.
Quando
la
stagione
dei
castelli
volse
al
termine,
il
vantaggio
appena
riferito
svanì
e
alcuni
insediamenti
si
spopolarono. I
benefici
derivanti
dalla
costruzione
di
castelli
sugli
insediamenti
non
si
limitavano
all'Europa.
Quando castello
di
Safad del
XIII
secolo
fu
fondato
in Galilea in Terra Santa, i 260 villaggi beneficiarono della nuova capacità
degli
abitanti
di
muoversi
liberamente. Una
volta
costruito,
un
castello
poteva
comportare
dei
mutamenti
al
paesaggio
locale,
con
le
strade
che
potevano
deviare
il
loro
antico
cammino
per
agevolare
il
raggiungimento
del
sito.
Durante
e
poco
dopo
la
conquista
normanna
dell'Inghilterra,
i
castelli
comparvero
in
importanti
città
preesistenti
per
controllare
e
gestire
i
sudditi
locali.
Di
solito,
essi
si
trovavano
vicino
a
una
qualsiasi
difesa
della
città
esistente,
come
le
mura
romane,
anche
se
ciò
a
volte
portò
alla
demolizione
di
strutture
che
occupavano
il
sito
di
costruzione
prescelto. Nel
caso
di Lincoln, 166 case furono distrutte per lasciare spazio al castello, mentre a York il terreno agricolo fu allagato per originare un fossato attorno al
castello.
Quando
i
normanni
invasero
l'Irlanda,
la
Scozia
e
il
Galles
nell'XI
e
XII
secolo,
gli
insediamenti
di
quelle
terre
erano
prevalentemente
non
urbane
e
la
fondazione
delle
città
era
spesso
collegata
alla
creazione
di
un
castello.

Un
altro
simbolo
di
potere
che
affiancava
il
castello,
trovandosi
a
volte
addirittura
all'interno
delle
sue
stesse
difese,
era
la chiesa
parrocchiale. Questo binomio stava a significare una vicina posizione tra la nobiltà
e
il
clero,
una
delle
istituzioni
più
importanti
della
società
medievale.
I
corsi
d'acqua
erano
un
altro
elemento
inevitabilmente
legato
ai
castelli.
La
presenza
di
fiumi,
laghi,
stagni
(anche
artificiali
per
originare
fossati)
o
di
un
porto
sul
mare
agganciato
alla
struttura
si
rintraccia
dal Portogallo all'Estonia, dall'Irlanda
al
LIbano
passando
per Cipro. Rientrano in questa categoria il castello
di
Trakai,
in Lituania, il castello di
Egeskov,
in
Danimarca, Burg
Vischering,
in
Germania, Bourtzi, in Grecia, Tokaj,
in Ungheria, il castello
Estense,
in Emilia-Romagna,
il castello
del
Mare
di
Sidone,
in Libano, Făgăraș,
in Romania, Kızkalesi, in Turchia, ecc.
Guerra
-
Essendo
una
struttura
statica,
i
castelli
potevano
spesso
essere
aggirati
da
chi
non
voleva
ingaggiar
battaglia.
L'area
di
influenza
immediatamente
coperta
si
estendeva
di
circa
400
m
e
le
loro
armi
avevano
una
gittata
limitata
anche
all'inizio
dell'era
dell'artiglieria. Tuttavia,
ignorare
un
nemico
in
territorio
vicino
avrebbe
potuto
consentire
limitazioni
negli
spostamenti,
rischi
nell'approvvigionamento
delle
provviste
e
problematiche
relative
allo
scambio
di
comunicazioni.
Le
guarnigioni
avevano
un
costo
non
trascurabile
e,
di
conseguenza,
non
andavano
oltre
una
certa
quota
numerica,
a
meno
che
il
castello
non
fosse
essenziale. Per
ridurre
le
spese,
in
tempo
di
pace
le
guarnigioni
erano
estremamente
ridotte,
tanto
che
alcuni
presidi
venivano
sorvegliati
forse
da
un
totale
di
quattro
persone
tra
guardie
sui
merli
e
presso
l'ingresso
principale.
Anche
in
caso
di
guerra,
le
guarnigioni
non
necessariamente
aumentavano
nel
totale,
poiché
troppe
persone
preposte
alla
difesa
avrebbero
messo
a
dura
prova
i
rifornimenti
e
avrebbero
compromesso
la
capacità
del
castello
di
resistere
a
un
lungo
assedio.
Nel
1403,
un'unità
di
37
arcieri
resistette
con
successo
il castello
di
Caernarfon contro
due
assalti
degli
alleati
di Owain
Glyndŵr durante
un
lungo
assedio,
dimostrando
che
non
necessariamente
un
piccolo
contingente
non
poteva
rivelarsi
efficace.
 All'inizio,
presidiare
un
castello
era
un
dovere
feudale
dei valvassori nei
confronti
dei
nobili
e
di
questi
ultimi
nei
confronti
del
re:
tuttavia,
in
seguito
questo
sistema
fu
sostituito
con
il
ricorso
a
guarnigioni
difensive
composte
da
mercenari. Una guarnigione era solitamente comandata da una figura specifica
(detto conestabile in Inghilterra e castellano altrove), il cui ruolo in tempo di pace restava quello di prendersi
cura
del
castello
in
assenza
del
proprietario.
A
lui
sottoposti
erano
i
cavalieri
che,
beneficiando
del
loro
addestramento
militare,
agivano
alla
stregua
di
una
sorta
di
classe
ufficiale.
Questi
ultimi,
a
loro
volta,
impartivano
gli
ordini
ad
arcieri
e
balestrieri,
il
cui
ruolo
era
quello
di
impedire
al
nemico
di
raggiungere
le
mura,
come
si
intuisce
dal
posizionamento
delle
feritoie. All'inizio,
presidiare
un
castello
era
un
dovere
feudale
dei valvassori nei
confronti
dei
nobili
e
di
questi
ultimi
nei
confronti
del
re:
tuttavia,
in
seguito
questo
sistema
fu
sostituito
con
il
ricorso
a
guarnigioni
difensive
composte
da
mercenari. Una guarnigione era solitamente comandata da una figura specifica
(detto conestabile in Inghilterra e castellano altrove), il cui ruolo in tempo di pace restava quello di prendersi
cura
del
castello
in
assenza
del
proprietario.
A
lui
sottoposti
erano
i
cavalieri
che,
beneficiando
del
loro
addestramento
militare,
agivano
alla
stregua
di
una
sorta
di
classe
ufficiale.
Questi
ultimi,
a
loro
volta,
impartivano
gli
ordini
ad
arcieri
e
balestrieri,
il
cui
ruolo
era
quello
di
impedire
al
nemico
di
raggiungere
le
mura,
come
si
intuisce
dal
posizionamento
delle
feritoie.
Se
era
necessario
conquistare
un
castello,
un
esercito
poteva
scagliare
un
assalto
o
cingerlo
d'assedio.
Nella
pratica
si
rivelava
più
efficiente
far
morire
di
fame
la
guarnigione
piuttosto
che
assalirla,
e
ciò
era
particolarmente
vero
per
quanto
concerneva
i
siti
più
difesi. Senza
la
disponibilità
di
una
fonte
di
supporto
esterna,
i
difensori
alla
fine
avrebbero
dovuto
cedere.
Gli
assedi
potevano
protrarsi
per
settimane,
mesi
e,
in
rari
casi,
anni
se
le
scorte
di
cibo
e
acqua
erano
abbondanti. Un
lungo
assedio
poteva
causare
con
riguardo
agli
aggressori
un
rallentamento
dell'esercito
o
il
rischio
dell'arrivo
di
aiuti
in
favore
dei
difensori:
questi
ultimi,
a
loro
volta,
si
esponevano
al
rischio
di
ritrovarsi
con
poco
cibo,
di
incorrere
in
una
pandemia
o
nel
pericolo
di
dover
fronteggiare
un'armata
ancora
più
numerosa
giunta
in
ausilio
degli
attaccanti.
Un
simile
approccio
non
appariva
limitato
ai
castelli,
ma
veniva
applicato
anche
alle
città
fortificate
dell'epoca. A
volte
venivano
costruite
delle
strutture
d'assedio
per
difendere
gli
assedianti
da
una
sortita
improvvisa,
le
quali
esaurivano
lo
scopo
dopo
che
l'assedio
fosse
finito
in
un
modo
o
nell'altro.
L'analisi
delle
fonti
coeve
insegna
che
le
opzioni
a
disposizione
degli
attaccanti
erano
molteplici.
Per
le
strutture
in
legno,
come
le
antiche
motte
castrali,
il
fuoco
costituiva
una
vera
minaccia,
come
si
può
intuire
dai
disegni
riportati
sull'arazzo
di
Bayeux. Le catapulte trovavano impiego fin dall'antichità: la manganella e
e
la petriera (rispettivamente di origine orientale e romana) erano quelle più
comuni
del
Medioevo.
Il trabucco,
che
potrebbe
risultare
per
alcuni
una
versione
aggiornata
della
petriera,
era
l'arma
d'assedio
più
efficace
disponibile
prima
dello
sviluppo
dei
cannoni. Queste
armi
erano
vulnerabili
al
fuoco
del
castello,
in
quanto
avevano
una
gittata
corta
ed
erano
macchine
di
grandi
dimensioni.
Al
contrario,
armi
come
i
trabucchi
potevano
sparare
dall'interno
del
castello
a
causa
dell'alta
traiettoria
del
proiettile
che
scagliavano
e
risultavano
protette
dal
fuoco
diretto
grazie
alle
cinte
murarie.
Le baliste o le spingarde erano macchine d'assedio che funzionavano secondo gli stessi principi
delle
balestre.
Con
le
loro
origini
da
rintracciarsi
nell'antica
Grecia,
la
tensione
veniva
usata
per
sparare
un
dardo
o
un
giavellotto.
La
traiettoria
raggiungibile
da
questi
strumenti
era
inferiore
rispetto
ai
trabucchi
o
alle
manganelle,
ma
più
precisa.
Per
questo
motivo,
si
preferiva
usarle
contro
bersagli
umani
anziché
contro
gli
edifici
di
un
castello. La maggiore potenza, maneggevolezza e manovrabilità permisero al
cannone
di
sopravanzare
gli
equipaggiamenti
di
epoca
passata.
Un'altra
tattica
utilizzata
era
quella
della
mina.
Fin
dai
primi
esempi
storici
di
assedi
documentati
archeologicamente
sono
state
trovate
tracce
di
gallerie
scavate
fin
sotto
le
mura
avversarie,
piazzando
numerosi
pali
di
sostegno
e
tavolati
per
impedire
crolli,
cui
si
dava
fuoco
una
volta
che
si
fosse
ragionevolmente
certi
di
essere
arrivati
sotto
le
mura
nemiche:
il
crollo
della
galleria
provocava
anche
il
crollo
delle
mura
sovrastanti,
con
conseguente
creazione
di
una
breccia. Questo
non
sempre
era
sufficiente,
perché
a
volte
una
sezione
di
mura
così
minata
si
limitava
a
sprofondare
per
un
paio
di
metri,
restando
beffardamente
in
piedi. Costruire
un
castello
su
uno
sperone
roccioso
o
circondarlo
con
un
fossato
ampio
e
profondo
aiutò
a
prevenire
i
rischi
causati
dalla
tattica
in
esame.
Inoltre,
si
poteva
scavare
una
contro-mina
verso
il
tunnel
degli
assedianti;
supponendo
che
le
due
fazioni
si
incontrassero,
ciò
avrebbe
causato
un
combattimento
corpo
a
corpo
sotterraneo.
L'attività
mineraria
si
rivelò
così
efficace
che
durante
l'assedio
di Margat nel
1285,
quando
la
guarnigione
del
presidio
venne
a
conoscenza
dello
scavo
di
gallerie,
si
arrese. Nei secoli trovarono impiego anche gli arieti,
di
solito
sotto
forma
di
tronco
d'albero
e
dotati
di
una
sezione
centrale
in
ferro.
La
loro
funzione
appariva
quella
di
sbaragliare
le
porte
del
castello,
ma
non
mancarono
casi
in
cui
vennero
impiegati
pure
contro
le
mura,
anche
se
sortendo
effetti
minori.
In
alternativa
al
compito
dispendioso
in
termini
di
tempo
di
creare
una
breccia,
si
poteva
tentare
di
utilizzare scale
d'assedio per
espugnare
le
mura
combattendo
lungo
il cammino
di
ronda. In
siffatta
situazione,
gli
aggressori
sarebbero
rimasti
esposti
alle
frecce
infuocate. Un'opzione più sicura per chi assaltava un castello era quella di
usare
una torre
d'assedio, a volte detta torre mobile. Una volta riempiti parzialmente i fossati
intorno
a
un
castello,
queste
torri
mobili
in
legno
potevano
essere
spinte
contro
la
cortina
muraria.
Oltre
a
offrire
protezione
a
chi
si
trovava
all'interno,
una
torre
d'assedio
poteva
avere
una
visuale
sull'interno
di
un
castello,
offrendo
agli
arcieri
una
posizione
vantaggiosa
da
cui
lanciare
dardi.

Pag.
1

 Pag.
3
Pag.
3
Fonte:
|