Una fortezza è
una costruzione militare progettata con una funzione tattica difensiva. Le fortezze sono state
utilizzate
per
migliaia
di
anni,
in
una
varietà
di
forme
sempre
più
complesse.
Un'opera
difensiva
con
caratteristiche
simili
alla
fortezza,
ma
in
genere
con
dimensioni
inferiori,
viene
chiamata forte o fortino.
La fortificazione è quel ramo dell'arte militare
che
insegna
ad
aumentare,
mediante
appropriati
lavori
o
con
apposite
costruzioni,
il
valore
naturale
delle
posizioni,
al
doppio
fine
di
favorire
l'azione
delle
truppe
e
l'efficacia
delle
armi
impiegate
e
di
provvedere
alla
conservazione
di
tutti
i
mezzi
di
difesa
(uomini,
armi,
materiali, munizioni e viveri) sia mentre si prepara
l'azione,
sia
durante
l'azione.
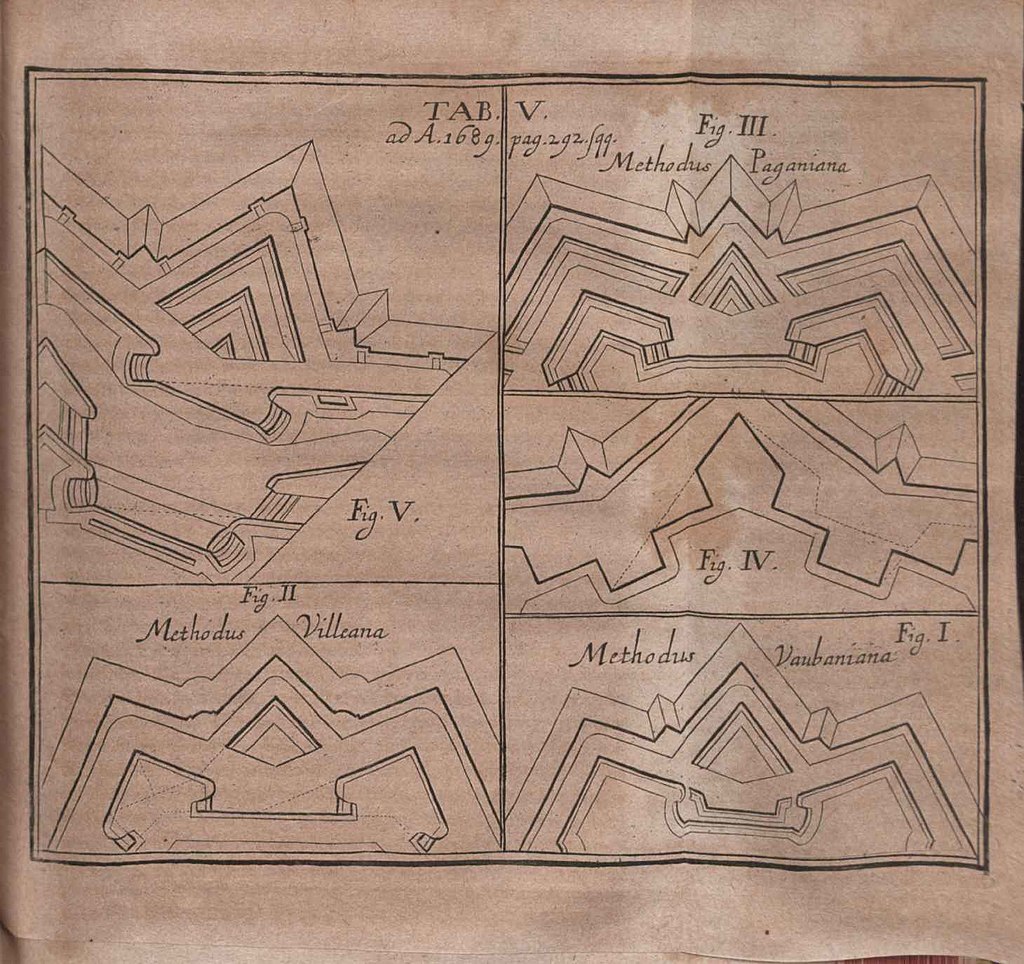
La fortificazione
è
anche
la
pratica
di
incrementare
le
difese
di
un'area
e
l'insegnamento
dei
modi
di
attaccare
e
di
difendere
un'opera
fortificata.
Il
valore
di
una
fortificazione
dipende
dalla
posizione,
che
dovrebbe
essere strategica, e dalla bontà delle opere che vi si
elevano;
ossia
è
la
risultante
del
valore
naturale
e
del
valore
artificiale
della
posizione
stessa.
In
generale,
non
conviene
fortificare
una
posizione
che
non
sia
forte
naturalmente.
L'arte
di
pianificare
un
campo
militare
o
di
costruire
una
fortificazione
viene
chiamata castrametazione, fin dai tempi delle legioni
romane. L'arte di portare l'assedio ad una fortezza e di distruggerla
viene
usualmente
detta poliorcetica; in alcuni testi questo termine viene
applicato
anche
all'arte
di
costruire
una
fortificazione.
Il progressivo
affermarsi
della guerra
con
la
polvere
da
sparo ha inesorabilmente, anche se con
un'imprevedibile
lentezza, ridimensionato
il
ruolo
delle
fortezze
all'interno
delle
strategie
militari.
Lo
scopo
che
si
vuol
raggiungere
nel
fortificare
una
posizione
può
essere organico, logistico o tattico. Lo scopo è organico quando la
posizione
è
un
punto
strategico
permanente,
ossia
interessa
la
difesa
generale
dello Stato. È logistico quando si tratta di un
punto
strategico
eventuale,
ossia
di
un
punto
che
riguarda
la
difesa
di
un
determinato
teatro
di
operazioni
militari.
Deve
in
questo
caso
favorire
lo
stare
ed
il
muoversi
delle
truppe.
È
tattico
quando
l'importanza
della
posizione
si
manifesta
solo
all'atto
in
cui
avviene,
o
si
prevede
che
debba
avvenire,
l'urto
fra
belligeranti,
ossia
quando
si
tratta
di
un
punto
tattico.
Qualunque
sia
lo
scopo
di
una
fortezza,
questa
deve
essere
studiata
nelle
sue
forme
in
modo
da
soddisfare
le
esigenze tattiche, poiché quando essa entra in azione
deve
favorire
il combattimento a chi lo occupa. Una fortezza
eretta
a
scopo
organico
soddisfa
anche
lo
scopo
logistico
quando
le
operazioni
di
guerra
si
svolgono
nel
teatro
in
cui
essa
è
collocata.
L'utilità
delle
fortificazioni,
se
fatte
in
modo
tale
da
raggiungere
gli
scopi
per
le
quali
sono
costruite,
è
quella
di
mettere
in
grado
le
forze
che
difendono
le
posizioni
da
esse
rafforzate
di
resistere
a
forze
numericamente
o
moralmente
superiori.
L'entità
di
un'opera
fortificata
dipende
dall'importanza
dello
scopo
che
si
vuole
raggiungere
con
essa,
dai
mezzi
e
dal
tempo
disponibile
per
erigerla
e
dalla
potenza
dei
mezzi
coi
quali
un
nemico
si
prevede
possa
attaccarla.
A seconda dei
mezzi
e
del
tempo
disponibile
per
erigerla,
le
fortificazioni
si
distinguono
in
permanenti
e
passeggere
o
occasionali.
Le
fortificazioni
permanenti
sono
quelle
erette
in
tempo
di
pace,
quindi
con
abbondanza
di
mezzi
e
di
tempo
e
che
sono
capaci
di
resistere
alle
offese
nemiche,
nonché
alle
ingiurie
del
tempo;
sono
sempre
costruite
a
scopo
organico
e
perciò
nei
punti
strategici
importanti.
Le
fortificazioni
passeggere
sono
quelle
costruite
in
caso
di guerra, prima che questa scoppi, o durante la
guerra
stessa,
e
talvolta
nelle
ultime
ore
precedenti
una battaglia, o anche durante una battaglia stessa,
e
perciò
con
mezzi
e
tempi
limitati,
talora
limitatissimi,
per
cui
non
possono
resistere
che
ad
azioni
meno
potenti
e
non
reggono
a
lungo
alle
ingiurie
del
tempo,
da
ciò
appunto
la
denominazione
passeggere.
La parte superiore
delle
fortezze
precedenti
all'introduzione
delle
armi
da
fuoco
è
spesso
contornata
dai merli, muri a dente di sega dietro il quale
si
appostano
i
soldati
per
coprirsi
dai
lanci
nemici
e
allo
stesso
controllare
dall'alto
tutti
i
movimenti.
Rispetto
alla
posizione
che
le
fortificazioni
occupano,
si
distinguono
in
fortificazione
di
frontiera
(terrestre
o
marittima)
e
in
fortificazioni
interne.

Le
fortificazione
passeggere
sono
fortificazioni
provvisorie,
campali,
opere
nate
da
esigenze
contingenti
al
conflitto
stesso,
benché
parzialmente
o
totalmente
previste
in
tempo
di
pace.
La
difesa
campale
è
la
forma
di
opera
difensiva
più
facilmente
attuabile
e
realizzabile
con
ogni
tipo
di
materiale
immediatamente
reperibile
purché
resistente,
e
perciò
ampiamente
usata
in
conflitti
limitati, guerre
civili, sommosse. Essa viene abbandonata o addirittura
smantellata,
per
recuperarne
almeno
parte
dei
componenti,
una
volta
cessata
l'esigenza
tecnica.
Sebbene abbiano
funzione
tattica
e
logistica,
possono
essere
ricomprese
in
un
più
ampio
programma
organico.
Paesi
come
l'Italia, perennemente afflitti da mancanze di
fondi
e
di
materie
prime,
possono
demandare
ad
opere
da
ergersi
alle
prime
turbative
politiche
internazionali
la
difesa
di
determinati
tratti
di
confine,
spesso
come
integrazione
di
preesistenti
opere
permanenti.
Già
i Romani, nelle loro vittoriose campagne di
conquista,
facevano
ampio
uso
di
fortificazioni
provvisorie,
addirittura
concepite
per
circondare
a
propria
volta
una
città murata nemica impedendo un ritorno offensivo delle truppe nemiche dislocate
in
altre
parti
del
territorio;
avevano
quindi
un
notevole
sviluppo,
ma
sparivano
una
volta
assolto
il
loro
scopo.
Parimenti,
proteggevano
i
campi
di
marcia
delle
legioni:
erette
in
poche
ore,
venivano
smantellate
una
volta
che
il
campo
era
tolto.
Tipicamente
venivano
usate
palizzate
erette
sopra
un
argine
in
terra
(aggere) che ne serrava la base, preceduto da
un fossato spesso cosparso di ostacoli o protetto da abbattute (rami aguzzi
piantati
con
un'inclinazione
di
45
o
60
gradi
nella
parete
del
fossato
stesso
e
rivolti
verso
l'attaccante).
Tipico
quindi
della
fortificazione
campale
l'ampio
uso
della
terra
e
del
legname
o
di
pietrame
sparso,
materiali
reperibili
in
loco
o
trasportabili.
Assente
all'epoca
e
fino
alla prima
guerra
mondiale l'uso della muratura cementata
nelle
opere
campali,
in
ossequio
al
principio
di
facile
e
veloce
realizzabilità.
 La
tipica
fortificazione
passeggera
è
la trincea, sostanzialmente uno scavo entro il
quale
si
riparano
i
soldati
e
che
costituisce
esso
stesso
un
ostacolo
non
indifferente.
Essa
servì
all'inizio
anche
per
approcciare
le
fortificazioni
permanenti
nemiche
rimanendo
abbastanza
protetti
dall'azione
dei
difensori.
Per
avvicinarsi
alla
fortezza
assediata
in
modo
da
presentare
un
angolo
favorevole
assumeva
un
percorso
complesso
detta
"a
parallele",
poi
vennero
introdotte
delle
traverse
o
un
tracciato
a
dente
di
sega
sempre
per
limitare
l'effetto
di
colpi
che
l'avessero
imboccata
nel
senso
della
lunghezza
(tiro
di
infilata).
Durante
la prima
guerra
mondiale l'uso della trincea era diffuso;
i
sistemi
trincerati
erano
assai
articolati
in
profondità
e
come
complessità,
comprendevano
anche
ricoveri
sotterranei
e bunker in cemento data la staticità
delle
posizioni
e
l'effetto
devastante
delle
moderne
artiglierie.
La
tipica
fortificazione
passeggera
è
la trincea, sostanzialmente uno scavo entro il
quale
si
riparano
i
soldati
e
che
costituisce
esso
stesso
un
ostacolo
non
indifferente.
Essa
servì
all'inizio
anche
per
approcciare
le
fortificazioni
permanenti
nemiche
rimanendo
abbastanza
protetti
dall'azione
dei
difensori.
Per
avvicinarsi
alla
fortezza
assediata
in
modo
da
presentare
un
angolo
favorevole
assumeva
un
percorso
complesso
detta
"a
parallele",
poi
vennero
introdotte
delle
traverse
o
un
tracciato
a
dente
di
sega
sempre
per
limitare
l'effetto
di
colpi
che
l'avessero
imboccata
nel
senso
della
lunghezza
(tiro
di
infilata).
Durante
la prima
guerra
mondiale l'uso della trincea era diffuso;
i
sistemi
trincerati
erano
assai
articolati
in
profondità
e
come
complessità,
comprendevano
anche
ricoveri
sotterranei
e bunker in cemento data la staticità
delle
posizioni
e
l'effetto
devastante
delle
moderne
artiglierie.
Già nella guerra
di
secessione, importanti
lavori
campali
avevano
abbattuto
l'aggressività
delle
rispettive
controparti;
molti fort citati
nelle
cronache
e
nella
memorialistica
in
realtà
erano
dei
poderosi
trinceramenti
estesi
anche
fuori
terra
mediante
possenti
terrapieni
a
protezione
delle
artiglierie
e
dei
fucilieri.
Nel XIX
secolo infatti il confine tecnico fra
opera
permanente
ed
opera
campale
si
fa
sfumato;
il
tipico
forte
dell'epoca
era
di
fatto
un
enorme
terrapieno
poligonale
costituente
il
fronte
rivolto
al
nemico
e
che
solo
su
un
lato,
quello
posteriore,
aveva
dei
bunker
in
muratura,
a
volte
di
mattoni
e
mura
in
pietrame,
quali
ricoveri
a
prova
di
bomba
e
spesso
elevati
di
livello
per
ospitare
postazioni
in casamatta per i cannoni. Agli angoli del poligono
terrapienato,
piccole
casematte
il
cui
tetto
non
superava
il
bordo
del
fossato
difendevano
l'interno
di
quest'ultimo
dagli
assalti
nemici.
Tolte
queste
possenti
parti
murarie,
altre
opere
definite
campali
erano
di
fatto
identiche.
A Peschiera
del
Garda, nel 1866 gli
austriaci
realizzarono
dei
"forti"
che
di
fatto
non
compendiavano
alcuna
parte
architettonica;
questo
perché
il
terrapieno
garantiva
ottima
copertura
alle
sottostanti
strutture
murarie,
ed
era
facile
da
erigere
e
modellare
e
riparare,
fornendo
ciononostante
un'efficienza
tattica
a
volte
superiore
ad
una
complessa
fortificazione
in
pietrame
e
mattoni.
Opere di natura
provvisoria
erano
anche
le batterie, a volte dotate di elementi
architettonici
davvero
minimi
rispetto
ai
lavori
in
terra
e
tuttavia
inserite
nel
dispositivo
organico
di
difesa
permanente.
Si
prevedeva
di
trasportarvi
i
cannoni
al
momento
opportuno,
installati
sul
normale
affusto
ruotato,
al
limite
fissato
a
delle
piattaforme
in
cemento
con
un
sistema
elastico
di
bloccaggio,
mentre
i
cannoni
da
fortezza
avevano
affusti
dedicati
spesso
fissati
definitivamente
alla
struttura.
Le
opere
come
i
forti
e
le
batterie
costituivano
anelli
o
linee
ad
arco
difensive
di
città
o
valichi,
e
si
prevedeva
che
nei
loro
intervalli
sorgessero,
al
momento
opportuno,
opere
campali
anche
imponenti
da
cui
il
nome
di
"campo
trincerato"
dato
alla
fortificazione ottocentesca e del primo Novecento.
In una pagina
dell'Encyclopedia
Britannica del Settecento ci sono dettagliati richiami
all'arte
di
erigere
fortificazioni
campali,
con
disegni
di
palizzate,
terrapieni,
abbattute
di
rami, cavalli
di
frisia, fossati, dove la differenza fra
queste
strutture
e
quelle
permanenti
pare
essere
solo
l'assenza
delle
parti
in
muratura.
In
un
film
statunitense, Ritorno
a
Cold
Mountain, viene ricostruita la scena
dell'attacco
nordista
alle
fortificazioni
campali
durante
l'assedio
di
Petersburg, in Virginia, nel 1864, fortificazioni estese e possenti, in
terra
e
legno,
con
gabbioni
e
fascine
di
protezione.
I
gabbioni
erano
grossi
ed
alti
cesti
da
riempire
di
terra
alla
bisogna.
Si assisterà poi
alla
nascita
del
sacco
di
sabbia,
usato
in
milioni
di
esemplari
fino
a
tutt'oggi.
Riconducibili
a
questa
forma
di
difesa
sono
gli
sbarramenti
e
i
fortini
di
bidoni
colmi
di
terra
o
cemento,
di
sacchi
di
sabbia
o
materiali
edili
di
svariata
natura
(anche barriere
stradali New Jersey), osservabili
nei
filmati
di
cronaca
attuali.
Un esempio di
difesa
campale
nelle
forme
ma
permanente
nella
sostanza
è
il sistema
difensivo
italiano
alla
Frontiera
Nord
verso
la
Svizzera, che si stende al confine
settentrionale
di Valle
d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Il sistema comprende una fitta rete
di
viabilità
(strade,
mulattiere
e
sentieri)
e
complessi
tratti
di
trinceramenti
con
ricoveri,
postazioni
per
fucilieri
e
per
mitragliatrici,
oltre
a
numerosi
appostamenti
d'artiglieria;
le
opere
possono
essere
semplicemente
scavate
nel
terreno
morbido,
o
realizzati
in
calcestruzzo,
o
con
l'apporto
elementi
prefabbricati
in
cemento
o
acciaio,
o,
infine,
scavate
più
o
meno
profondamente
nella
roccia
con
massicce
integrazioni
in
calcestruzzo
o
calcestruzzo
armato.
Vi
sono
quindi
alcune
parti
che,
realizzate
con
tecniche
non
durevoli,
sono
state
gradualmente
cancellate
dal
tempo
-
spesso
individuabili
solo
da
un
occhio
veramente
esperto
-
unite
ad
altre
realizzate
in
maniera
tanto
solida
da
permanere
tutt'oggi
conservate
in
modo
quasi
perfetto.
Il
sistema,
costituito
prevalentemente
da
opere
"leggere",
doveva
compensare
la
relativa
scarsezza
di
massicce
fortificazioni
permanenti
su
quel
tratto
di
confine;
fanno
eccezione
i
tre
forti
valtellinesi
(il Forte
al
Montecchio
Nord
di
Colico, il Forte ai Canali di Tirano e il
Forte
al
Dossaccio
di
Oga,
presso
Bormio),
oltre
alle
grandi
opere
in
caverna
dell'Alto
Varesotto
(le
batterie
alla
Canonica
di
Bedero,
a
Vallalta
del
San
Martino,
al
Piambello,
al
Monte
Orsa)
e
quella
dell'Alto
Lario
(Loco
Tocco).

Castelli
e
fortezze
di
pianura
Diversamente
dalla
forticazioni
costruite
su
speroni
rocciosi
collinari,
nelle
aree
di
in
pianura
o
di
fondovalle
i
siti
di
costruzione
venivano
scelti
vicino
a
fiumi,
isole,
laghi
o
paludi,
che
potevano
compensare
lo
svantaggio
difensivo
della
bassa
altitudine.
Laddove
tali
ostacoli
naturali
non
esistevano,
venivano
creati
fossati
asciutti
o
con
rivi
d'acqua,
bastioni,
palizzate
e
facciate
continue.
In
modo
particolare,
fossati
e
torri
fortificate
permettevano
di
rendere
il
livello
della
costruzione
sufficientemente
alto
da
diventare
una
valida
difesa
contro
i
nemici.
I castelli di
pianura
slavi e sassoni dell'Alto Medioevo
erano
spesso
caratterizzati
da
un
fossato
stretto
e
profondo
e
da
bastioni
di
terra
alti
e
ripidi.
Tali
costruzioni
erano
diffuse
nei Paesi
Bassi, nella pianura
della
Germania
settentrionale, dove è stato stimato che circa il 34% dei castelli possa essere
contestualizzato
in
tale
tipologia.
Il Wasserburg e
il Wasserschloß (lett.
"castelli
di
acqua"
e
"fortezza
di
acqua")
era
una
tipologia
di
castello
di
pianura
edificato
su
una
pianta
quadrangolare,
protetta
da
uno
o
più
fossati
d'acqua
e
con
un
ponte
levatoio
presidiato
dal
mastio.
Ne sono
esempi:
in Germania: Hainewalde, il castello
di
Mespelbrunn, di Schwerin e di Burg
Vischering;
in Austria: il castello di Heinfeld;
in Belgio: il castello
di
Beersel;
in Danimarca: il castello
di
Egeskov;
nel Basso
Reno francese: i castelli di Asswiller e Diemeringen,
di
Lorentzen,
Niederstinzel,
Sarre-Union,
Scharrachbergheim
e
Sarrewerden.
Inoltre, nell'Alto
Reno francese: i castelli di Courtavon, Meauce e Château
d'Olhain;
in Lituania: il castello
di
Trakai;
nei Paesi
Bassi: Muiderslot, Huis
Bergh;
nel Regno
Unito: il Castello
di
Bodiam e di Caerphilly;
in Polonia: il castello
di
Malbork.
Castelli di acqua
in
zone
di
pianura
erano
anche
quelli
di Die
Pfalz, di Sully-sur-Loire, e, in Scozia, quelli
di
Caerlaverock
e
Eilean
Donan.

Pag.
2

Fonte: