|
Nel IV
secolo a.C. i Persiani controllavano un ampio territorio comprendente
Mesopotamia, Egitto, Asia Minore e parte dell'India. Il re, non potendo
governare da solo questo vasto Impero, affidava quindi le varie
provincie a dei governatori locali (i Satrapi), che godevano di molta
autonomia.
Fra il 377 ed il 353 a.C. la Caria fu governata da Mausolo, il quale
spostò la capitale ad Alicarnasso. Egli concepì anche un grande
monumento: il Mausoleo di Alicarnasso. Il monumento fu realizzato da
architetti e scultori di grande fama, con lo scopo di accogliere i resti
mortali di Mausolo e consorte, e innalzarlo così dopo la morte a un
livello divino. Nell'opera, riconducibile alla millenaria tradizione
orientale dei sepolcri colossali, le credenze orientali e il gusto
barbaro si accostano alla più recente arte greca, preannunciando l'arte
ellenistica.
Il termine mausoleo con il quale
si intende la tomba a carattere monumentale, discende dalla tomba di
Mausolo, satrapo della Caria, ad Alicarnasso. Secondo gli antichi autori
è ad Artemisia che si deve la costruzione del Mausoleo dedicato al
fratello-sposo Mausolo, ed è per questo che sovente se ne è fatta
risalire la datazione al biennio intercorso tra la morte di lui e quella
di lei, cioè al 353-351 a.C.
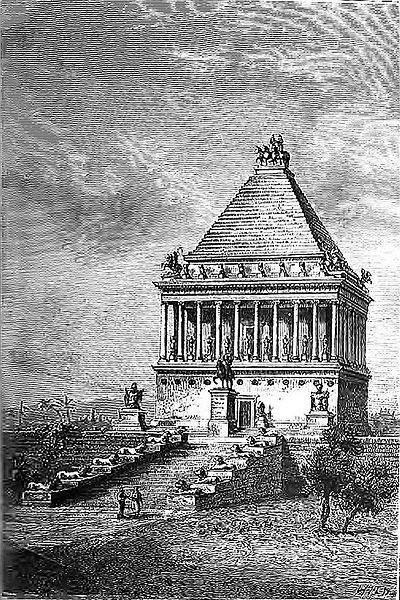 Mausolo sposò la sorella, Artemisia. Divenuto potente,
progettò una tomba per sé e per la sua sposa. Essa però non doveva
essere del tipo tradizionale. Mausolo voleva realizzare un monumento
spettacolare, che avrebbe ricordato al mondo intero la sua ricchezza ed
il suo potere per molto tempo dopo la sua morte. Mausolo morì prima che
la tomba fosse ultimata, ma la vedova diresse i lavori di costruzione
fino alla conclusione dell'opera avvenuta intorno al 350 a.C. Il
monumento fu chiamato mausoleo, dal nome del re, e questo termine é in
uso ancora oggi per indicare un sepolcro monumentale destinato ad una
persona illustre. Mausolo sposò la sorella, Artemisia. Divenuto potente,
progettò una tomba per sé e per la sua sposa. Essa però non doveva
essere del tipo tradizionale. Mausolo voleva realizzare un monumento
spettacolare, che avrebbe ricordato al mondo intero la sua ricchezza ed
il suo potere per molto tempo dopo la sua morte. Mausolo morì prima che
la tomba fosse ultimata, ma la vedova diresse i lavori di costruzione
fino alla conclusione dell'opera avvenuta intorno al 350 a.C. Il
monumento fu chiamato mausoleo, dal nome del re, e questo termine é in
uso ancora oggi per indicare un sepolcro monumentale destinato ad una
persona illustre.
Le ceneri della coppia reale furono raccolte in urne d'oro
e poste in una camera sepolcrale alla base della costruzione, a guardia
della quale, stava una fila di leoni di pietra. Sopra il massiccio
basamento in pietra, poggiava una struttura che ricordava un tempio
greco, con colonne e statue attorno. Alla sommità dell'edificio si
trovava una piramide a gradini coronata a 43 metri dal suolo, da una
scultura raffigurante un carro trainato da cavalli, a bordo del quale
dovevano stare le statue del re e della regina.
La bellezza
dell'architettura della tomba, unitamente alla decorazione scultorea, la
fecero qualificare fra Le sette meraviglie del mondo antico. Donde si
passò a denominare col nome di mausoleo qualsiasi tomba monumentale
(mausoleo di Augusto, mausoleo di Adriano).
Ma il mausoleo fu un tipo architettonico essenzialmente classico: non
sarebbe esatto denominare
mausoleo edifici sorti dopo la fine del paganesimo.
Il
Mausoleo era di pianta rettangolare, con lati a livello del suolo
probabilmente di 120 e 100 piedi , che sommati danno il perimetro di 440
piedi indicato da Plinio. L’altezza era di 140 piedi e risultava da
tre elementi principali: un basamento elevato, che Plinio definisce
semplicemente «la parte inferiore», di forse 60 piedi d’altezza;
sopra questo basamento un colonnato, probabilmente di trentasei colonne
disposte a 11 x 9 (cioè undici colonne su ciascuno dei lati lunghi e
nove sui lati corti, contando per due le colonne d’angolo). Sopra
queste colonne, che dagli scavi risultano essere state di ordine ionico,
si stendeva un tetto a forma di piramide con ventiquattro gradini che
salivano, riducendosi in larghezza, a una piattaforma sormontata da una
quadriga. I 25 cubiti, cioè 37 piedi e mezzo (11,50 metri circa) di cui
parla Plinio valgono, a quanto pare, per una parte dell’edificio, e
con ogni verosimiglianza si riferiscono all’altezza del colonnato,
dalla base della colonna al cornicione. Se così è, allora il resto
dell’altezza complessiva apparteneva, forse per 22 piedi e mezzo
(circa 7 metri) alla piramide, e 20 (circa 6,50 metri] alla quadriga e
al piedestallo su cui questa poggiava.
La
ricostruzione di Krischen fu, fra le molte, la più semplice ed
attendibile. Essa si accorda con le misure delle fondamenta e con quelle
di parti architettoniche rinvenute dall'archeologo inglese Newton
negli scavi del 1856.
Vanno
altresì ricordati numerosi frammenti di fregio, rappresentante la
Amazzonomachia; sembra che questi rilievi ornassero l'esterno della
cella e che, secondo la tradizione tramandataci da Plinio, fossero stati
affidati ai maestri maggiori del tempo. A Scopas il
lato orientale, a Leocore il lato opposto, e gli altri due a Briosside e
Timoteo. La facciata e l'intero complesso dell'edificio erano opera di
due architetti: Potino e Pitide.
Pare
che il Mausoleo sia rimasto in piedi discretamente intatto fino al XIII
secolo d.C., quando la parte superiore, compresi il tetto e il
colonnato, crollarono probabilmente a causa di un terremoto. Tuttavia la
distruzione totale non si verificò fino agli ultimi anni del XV secolo.
Nel 1494 i Cavalieri di San Giovanni decisero di fortificare il loro
castello di Bodrum, costruito nel 1402, e si servirono dei resti del
Mausoleo come comoda fonte di pietra già squadrata.
Lunghi tratti delle
mura del castello sono costruiti con i blocchi di pietra verde vulcanica
che avevano costituito il nucleo centrale del Mausoleo, blocchi di circa
90 centimetri
di lato e uno spessore di 30 centimetri, con chiare tracce delle grappe che li avevano tenuti uniti.
I blocchi
di marmo di cui il Mausoleo era rivestito e i bassorilievi o le statue
marmoree furono per lo più frantumati e arsi per ricavarne calcina. La
recente indagine svolta da Anthony Luttrell dimostra che l’opera di
distruzione continuò per ben ventotto anni, fino al 1522, quando ormai
quasi ogni blocco era stato tolto dal Mausoleo, fino al livello più
basso delle fondamenta, e la cripta sotterranea contenente il sepolcro
era stata scoperchiata e saccheggiata.
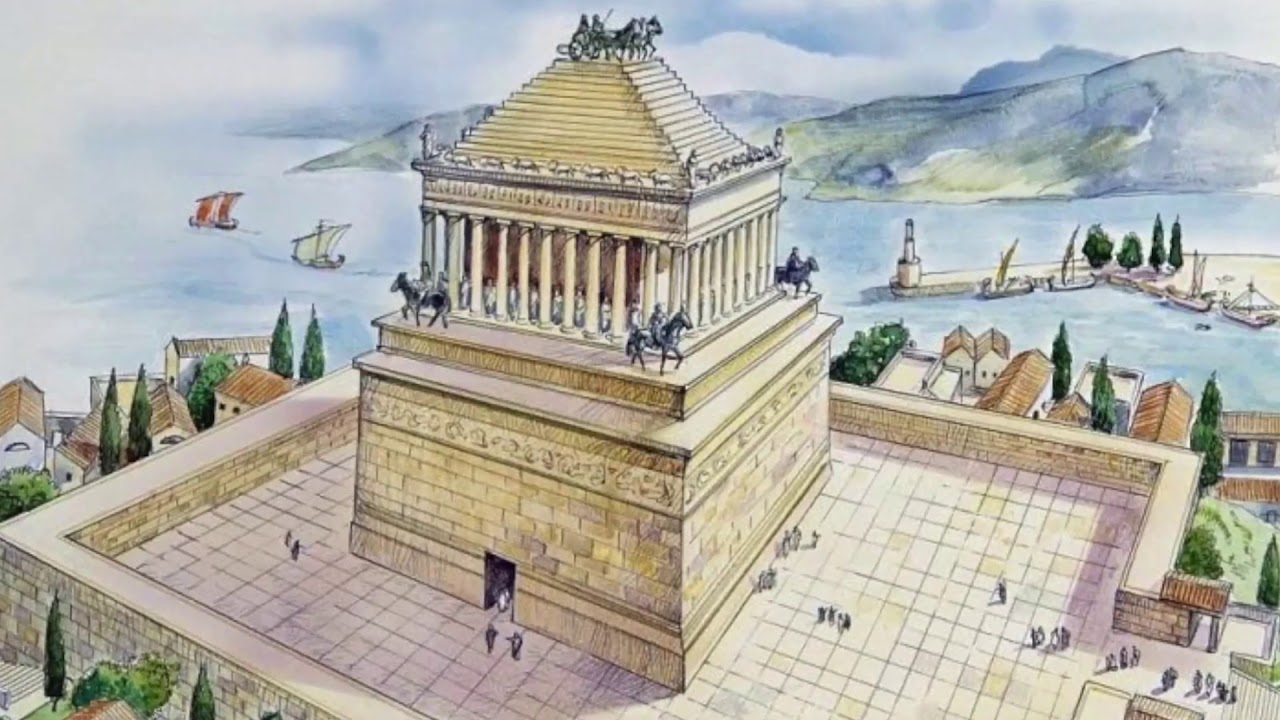
Per
quanto strana possa apparire questa storia, essa è stata confermata
almeno in parte dai reperti dei recenti scavi di Jeppesen.
Nelle
vicinanze della cripta furono trovati frammenti del coperchio a doppio
spiovente; sembra che si sia trattato effettivamente di un sarcofago di
alabastro bianco, mentre i numerosi lustrini d’oro di cui parla
Guichard appartenevano con ogni verosimiglianza al sudario funebre. Dal
che appare che il sepolcro di Mausolo era molto simile a quello
recentemente trovato intatto a Vergina in Macedonia e assegnato a
Filippo II il Macedone, morto nel 336 a.C. Le ossa e le ceneri del
corpo cremato di Mausolo sarebbero state avvolte in un drappo ricamato
d’oro e collocate forse in una teca pure d’oro, a sua volta
collocata dentro il sarcofago di alabastro.
Che
ci sia stata veramente una stanza così ricca sopra la cripta, quale si
trova nella descrizione di Guichard, è molto meno sicuro. Non sono
state identificate tracce di quella ricca decorazione; può darsi che i
particolari architettonici e la decorazione scolpita, in origine all'esterno della tomba, siano stati per errore trasferiti
all’interno della stanza nel resoconto dei fatti.
Benché
i Cavalieri Ospitalieri abbiano arrecato enormi danni al Mausoleo, essi
non distrussero tutte le pietre scolpite che vi trovarono. Tra il 1505 e
il 1507, circa una dozzina delle lastre che formano il fregio della
battaglia tra i Greci e le Amazzoni colpirono l’occhio di uno dei loro
comandanti e furono inserite per ornamento nelle mura del castello; così
si conservarono. Tra queste lastre si trovava un blocco unitario
appartenente al secondo fregio, con la battaglia dei Lapiti e dei
Centauri. Pure a quel tempo furono inserite nel castello le parti
anteriori di quattro statue di leoni eretti e di un leopardo che fugge
da un gruppo di cacciatori. Queste sculture vennero portate più tardi
al British Museum, i fregi nel 1846, i leoni e il leopardo nel 1857.
Con
l’aiuto della descrizione di Alicarnasso fatta da Vitruvio, fra
tentativi ed errori, la squadra di Newton riuscì a localizzare il sito
del Mausoleo. Superando molte difficoltà, l’archeologo acquistò le
dimore turche sorte in quella zona, e il giorno di capodanno del 1857
diede inizio agli scavi. Ma il suo entusiasmo doveva ben presto mutarsi
in disappunto, quando si rese conto dell’estensione del disastro
perpetrato dai Cavalieri e del saccheggio quasi totale che il Mausoleo
aveva subito. Non rimaneva che la traccia rettangolare delle fondamenta
segnata sulla pietra tenera, con qualche blocco di basalto del nucleo
centrale ancora nel luogo d’origine. Inoltre,
Newton riportò in Inghilterra quante più pietre poté della struttura
architettonica, quelle che oggi sono allineate in un deposito del
British Museum. Sono pezzi di vitale testimonianza per una ricostruzione
dell’edificio, ancor oggi studiati e in attesa di essere resi noti.
Tra questi, vi sono molti gradini del tetto a piramide, ivi compreso un
gradino angolare quasi completo.
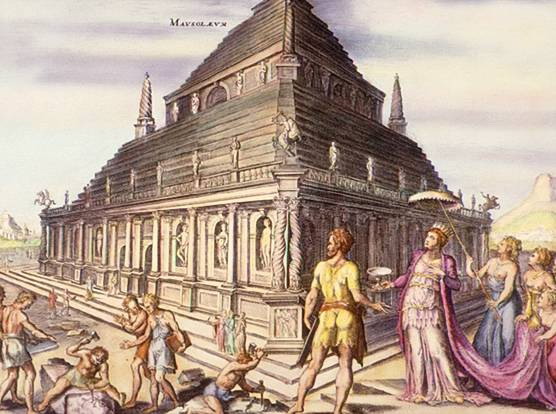 La
camera mortuaria non occupa un punto centrale nella pianta
dell’edificio, ma è spostata piuttosto verso l’angolo
nordoccidentale. Può darsi che ciò sia stato fatto con lo scopo di
sviare eventuali saccheggiatori di tombe, ma più probabilmente fu
collocata in quel punto nel ricordo di una tomba più antica, forse
quella di Artemisia I di Alicarnasso, che combatté contro i Greci a
Salamina nel 480 a. C. a fianco del re persiano Serse. Mausolo avrebbe
così inteso sottolineare un vincolo dinastico che, quanto a sangue,
forse non era affatto saldo. Certamente altre tombe importanti
esistevano in quel sito prima del Mausoleo, come dimostra la scala
vicina all’angolo di sudovest, intagliata nelle fondamenta del
Mausoleo. La
camera mortuaria non occupa un punto centrale nella pianta
dell’edificio, ma è spostata piuttosto verso l’angolo
nordoccidentale. Può darsi che ciò sia stato fatto con lo scopo di
sviare eventuali saccheggiatori di tombe, ma più probabilmente fu
collocata in quel punto nel ricordo di una tomba più antica, forse
quella di Artemisia I di Alicarnasso, che combatté contro i Greci a
Salamina nel 480 a. C. a fianco del re persiano Serse. Mausolo avrebbe
così inteso sottolineare un vincolo dinastico che, quanto a sangue,
forse non era affatto saldo. Certamente altre tombe importanti
esistevano in quel sito prima del Mausoleo, come dimostra la scala
vicina all’angolo di sudovest, intagliata nelle fondamenta del
Mausoleo.
L’ampia
scalinata nella roccia sul lato ovest del Quadrangolo conduce
all’ingresso della camera mortuaria, evidentemente destinata alla
sepoltura di Mausolo. L’enorme masso di basalto che bloccava
l’entrata alla tomba esiste ancora. Davanti a questa pietra, ai piedi
della gradinata, c’era un gran mucchio di pietre e si tratta della
solida protezione di un deposito di cibo rituale, ammassato
presumibilmente subito dopo la discesa nella tomba delle spoglie di
Mausolo. Le offerte consistevano in intere carcasse di agnello o in
pezzi accuratamente macellati di pecora o di capra, di vitello o di bue,
qualche pollo, qualche piccione, un’oca e una notevole quantità di
uova. Una tale offerta di cibo per lo spirito del defunto è più affine
alle pratiche funerarie del Vicino Oriente anziché a quelle greche.
Importantissime fra le statue che non hanno collocazione tutt’attorno
sono le colossali immagini, cosiddette, di Mausolo e Artemisia, le
meglio conservate di una cospicua serie che, a quanto pare, avrebbe
rappresentato la dinastia regnante di Caria e i suoi antenati. Esse
vengono molto ragionevolmente collocate in posizione eminente fra le
colonne del peristilio, sebbene, ripetiamo, non esista prova che fossero
situate proprio lì, né, qualora lo fossero, che poggiavano su
piedistalli o meno.
Le
altre statue a tutto tondo appartengono per lo più a gruppi di
ornamento laterale, collocate su zoccoli ristretti contro il muro del
basamento, come le sculture di un frontone. I soggetti rappresentati
comprendono cacce d’animali su scala colossale e scene di offerte e
sacrifici di pari dimensione, nonché una battaglia fra Greci e
Persiani, con guerrieri a grandezza naturale, alcuni a cavallo. Vi sono
inoltre numerose figure semplicemente in piedi, probabilmente ritratti
maschili e femminili, di dimensione intermedia (cosiddetta eroica), e
collocati qui a livello intermedio tra i due gruppi di figure in
movimento. Le sculture del basamento ebbero a soffrire danni gravissimi
per mano dei Cavalieri e non ne sono rimasti che frammenti, benché
assai numerosi.

|