|
Cogne
è un comune
italiano situato
nella parte
meridionale
della regione,
al cospetto del massiccio
del Gran
Paradiso che
dà il nome
all'omonimo Parco
nazionale.
All'altezza
capoluogo
(Veulla), si
diramano cinque
valli: verso
sud, la Valnontey,
che porta alle
pendici del Gran
Paradiso;
verso
nord, il vallone
di Grauson;
verso
sud-est, il vallone
dell'Urtier e
la Valeille;
verso
est, il vallone
di Gimillan.
Al
centro del
territorio
comunale e ai
margini
dell'abitato di
Veulla si trova
l'ampia distesa
detta Prati
di Sant'Orso, insigniti
del
riconoscimento
"Meraviglia
d'Italia" I
prati ospitano
la bataille
de reines, e sulla zona vige
il divieto di
edificare
secondo lo
statuto
comunale.
La paleofrana di
Champlong, nella
località
omonima, ricorda
la presenza di
un'antica morena glaciale.
A seguito dello
smottamento del
terreno il letto
del torrente
Urtier si è
spostato, i
vulcanelli di
fango
testimoniano la
presenza di
acqua
sotterranea
sotto pressione.
Un pannello
informativo è
stato posto sul
ciglio della
strada per
Lillaz.
La
popolazione di
Cogne ha origini
dalle valli
arpitane
piemontesi.
In epoche
passate le
relazioni
economiche,
commerciali e le
vie di
comunicazione
non erano
dirette verso la
Valle d'Aosta,
ma verso le
suddette valli,
raggiunte
passando per mulattiere e
colli di alta
montagna come il colle
del Rancio o
il colle
dell'Arietta.
Fin
dal Medioevo la
località fu
nota per il
giacimento di magnetite,
concesso in
sfruttamento ai
valligiani dai
signori locali.
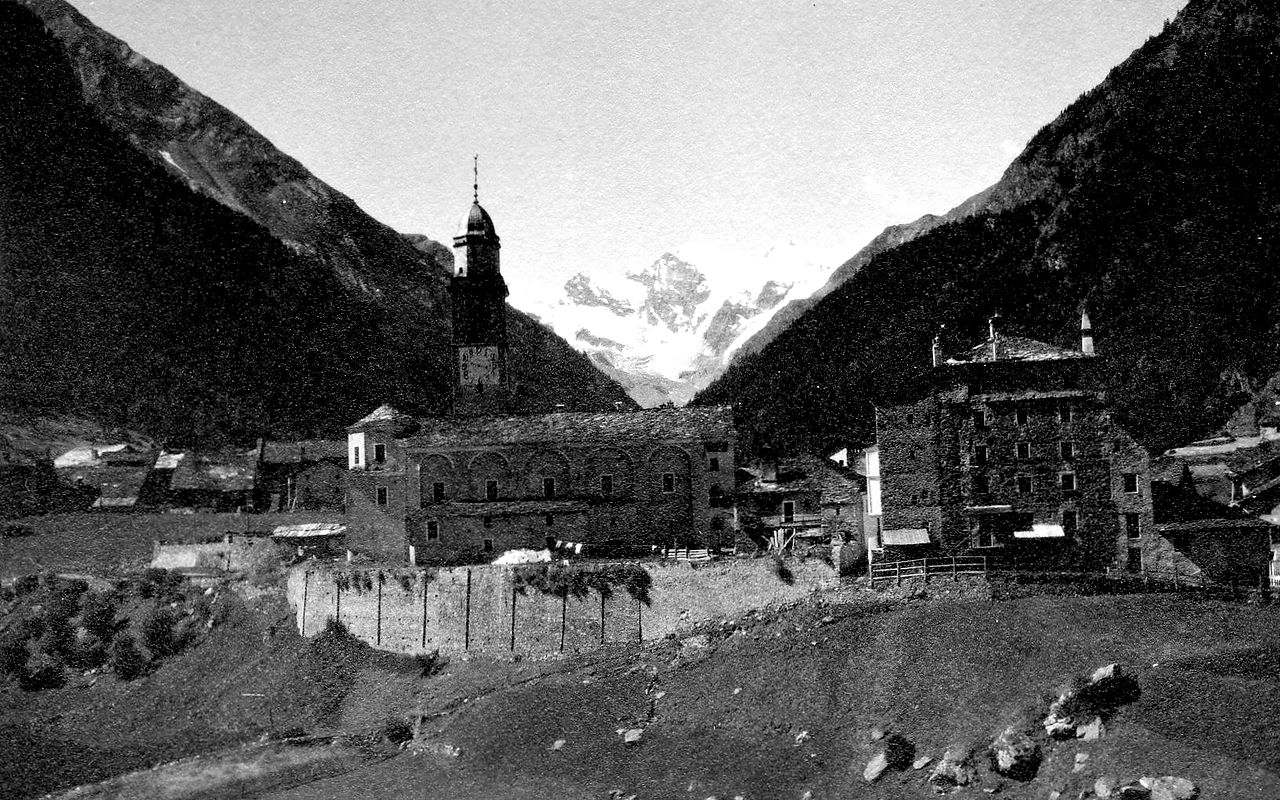
Nel
1191 il conte
di Savoia, Aosta e Moriana Tommaso
I concesse
al vescovo
di Aosta di
costruirsi un castello
a Cogne,
di cui era
signore spirituale e temporale:
«Pactum insuper
fuit ut ipse
episcopus si
voluerit in
valle de Conia
castrum erigere
valeat…». Il
castello fu
probabilmente
terminato nel
1202, quando
venne inaugurata
la chiesa
parrocchiale.
Nel 1865 il Corpo
reale del Genio
civile di Torino in val
di Cogne realizzò
una strada per
unire Cogne con Aosta,
e ben presto il ponte
di Chevril diventò
il simbolo del
collegamento con
il fondovalle.
Nel
corso della
guerra gli
abitanti vennero
esentati dal
prestare
servizio
militare per
permettere la
continuità
dell'attività
della miniera di
ferro. Dal 7
luglio al 2
novembre 1944,
complice
l'isolamento
della vallata e
il ritiro del
presidio tedesco
ad Aosta
ottenuto da Franz
Elter direttore della miniera, il paese divenne una repubblica partigiana
con un sindaco
eletto,
Francesco David,
dotata di una
propria radio
libera e un
giornale,
formato da un
unico foglio,
intitolato prima Il
Garibaldino e
quindi Patriota,
diretto da Giulio
Einaudi arrivato
a Cogne dalla
Svizzera. Negli
ultimi giorni
della repubblica
dalla Francia vi
arrivò anche Sandro
Pertini.
La repubblica
terminò il 2
novembre dopo un
attacco tedesco,
con l'appoggio
di carri armati,
al quale le
brigate
partigiane non
poterono
opporsi.
Fino
agli anni
Settanta del
secolo scorso,
Cogne è stato
un importante
centro minerario
per l'estrazione
del minerale di
ferro, i cui
filoni minerari
principali erano
sfruttati nelle
miniere di
Colonna, Licony
e Larsinaz. Il
minerale
estratto
(principalmente magnetite)
veniva poi
inviato all'acciaieria
Cogne di Aosta per
la lavorazione
utilizzando una
ferrovia a
scartamento
ridotto. La
miniera venne
definitivamente
chiusa nel 1979.
Tra
gli eventi
recenti più
catastrofici che
hanno colpito il
paese si
ricordano
l'alluvione del
1993 e quella
del 15 ottobre
2000: in
quell'occasione
caddero oltre
400 mm di
pioggia in due
giorni
provocando
esondazioni e
frane.
 Chiesa
parrocchiale di
Sant'Orso Chiesa
parrocchiale di
Sant'Orso
La
parrocchia è
posta sotto la
protezione di
Sant’ Orso,
sacerdote
valdostano
vissuto tra il
VII e l’VIII
secolo che,
secondo la
tradizione
popolare avrebbe
bonificato la
località,
originariamente
inospitale. Un
ruolo importante
in questo senso
potrebbero aver
avuto,
piuttosto, i
canonici della
collegiata
aostana di
Sant’Orso,
alle cui
dipendenze la
parrocchia
figura già nel
1184. I canonici
detennero la
parrocchia fino
al 1820, anno in
cui ogni diritto
passò al
vescovo.
Nel
1642
l’edificio
assunse
l’aspetto
attuale, in
seguito a lavori
di ampliamento.
Il campanile fu
costruito nel
1840, dopo che
il vecchio fu
abbattuto per
problemi di
altezza e di
stabilità.
La
chiesa è a
pianta regolare.
L’interno, ad
una sola navata,
ridecorato dal
pittore Pirlato
nel 1960,
conserva
preziosi altari
settecenteschi
in legno
scolpito e
dorato, a
colonne tortili.
Una leggenda attribuisce
alla volontà
divina la
scelta del luogo
sul quale venne
edificata la chiesa di
Cogne. Prima che
fosse costruita,
gli abitanti,
per assistere
alla messa domenicale,
dovevano
percorrere un
lungo cammino
per arrivare
alla cappella
del Crêt. In
inverno il
sentiero era
ancora più
disagevole a
causa del
ghiaccio,
così gli
abitanti,
stanchi della
situazione,
decisero di
costruire una
chiesa a
Cogne.
Il
luogo scelto per
tale costruzione
era Lisardey, frazione che
si trovava sulla
riva destra del torrente.
Successe un
fatto strano
quando sul posto
vennero portate
delle reliquie:
queste
scomparvero e
furono ritrovate
sulla riva
opposta del
torrente.
Nonostante
molti tentativi
di riportarle al
luogo prefissato
esse tornavano
sempre al di là
del fiume. Gli
abitanti di
Cogne,
comprendendo di
aver assistito
ad una
manifestazione
della volontà
divina,
ubicarono la
chiesa nel luogo indicato
dal Signore.
Architetture
civili
Casa
Savin, a
Desot-Veulla
Casa
dell'orologio
(Maison
de l'horloge)
o Casa Grappein
La
fontana in ferro,
realizzata con
il ferro della
miniera per
volere del
sindaco César-Emmanuel
Grappein, oggi
si trova di
fronte ai Prati
di Sant'Orso, in
origine situata
di fronte a casa
Grappein.
I
casolari di
Valmiana, in
Valnontey,
architettura
tradizionale
alpina in pietra
e legno
Miniere
di Cogne

La
prima notizia
documentata
dell'attività
mineraria di
Cogne si trova
in un atto del
1433 del vescovo
di Aosta Oger
Moriset. Le
miniere
rimangono di
proprietà del Vescovi
di Aosta fino
almeno al 1641,
quando i
Cogneins, a
causa di una
crisi economica
abbattutasi
sulla valle,
iniziano a
rivendicarne i
diritti. Il 26
ottobre 1679 il
vescovo
Antoine-Philibert
Bailly vende al
Comune tutte le
miniere.
Tuttavia, fino
al 1800, queste
rimangono
pressoché
inattive per
mancanza di
fondi. La
rinascita si
deve all'opera
di César-Emmanuel
Grappein,
sindaco di
Cogne, il quale,
conscio che il
maggior onere
era il trasporto
del materiale ad
Aosta, decide di
costruire la
prima strada
carrozzabile da
Cogne a Vieyes,
terminata nel
1824.
Le prime
estrazioni si
effettuano a
cielo aperto, a
circa 2.500 m s.l.m.,
nella località
Licony,
ai piedi del mont
Créyaz.
Dopo
vari
esperimenti, più
o meno riusciti,
di gestione
comune delle
miniere, lo
sfruttamento del
minerale si
arresta, e
l'estrazione
cade in una
profonda crisi,
dovuta alla
mancanza di
capitali, ma
soprattutto alle
tecniche
arcaiche di
estrazione e di
trasporto del
materiale. Tra
alti e bassi la
miniera resta
pressoché in
uno stato di
abbandono fino
al 1903, quando,
venduta ad una
società
italo-belga,
inizia lo
sfruttamento a
livello
industriale.
Vengono allora
costruiti una
teleferica ed il
complesso di
Colonna.
Nel
1916 la miniera
viene venduta
alla società Gio.
Ansaldo, ma già nel 1927 viene comprata dal governo fascista. Il lavoro continua a
pieno ritmo per
molti anni,
anche dopo il
periodo bellico,
tanto che nel
1964 occupa
ancora 741
dipendenti; nel
1968-69 inizia
però la crisi,
in gran parte
dovuta alle
pressioni
sindacali, che
hanno portato ad
un'uscita dal
mercato della
seppur ottima
magnetite, poiché
il costo di
estrazione, in
gran parte
determinato dal
costo della
manodopera, era
diventato tale
da proporre il
prodotto a dei
prezzi che,
inevitabilmente,
le leggi della
concorrenza
ponevano fuori
trattativa. La
miniera, seppure
non esaurita, è
chiusa
definitivamente
nel marzo del
1979.
Nel
1957 la funivia
addetta al
trasporto degli
operai verso la
miniera crolla,
causando la
morte di 1
persona e il
ferimento di
altri 11 operai.
La
miniera è
rimasta proprietà
di Fintecna fino al 2014 che ha ceduto, dopo 111 anni, nuovamente le concessioni
al Comune di
Cogne.
Al
centro
espositivo
Alpinart, presso
il Villaggio
Minatori di
Cogne, ha sede
la mostra
permanente sulle
miniere "La
miniera di
Cogne",
gestito dalla Fondation
Grand-Paradis.

Castello
reale
Il Castello
reale di Cogne si
trova al centro
del borgo di Cogne,
in Valle
d'Aosta, a fianco della chiesa di Sant'Orso. Si tratta di un'antica residenza reale
riconosciuta monumento
nazionale italiano.
Ristrutturato,
è di proprietà
di privati e non
è visitabile.
Il
castello reale
di Cogne ha
subito vari
rimaneggiamenti
nel corso dei
secoli. Si
presenta come un
tozzo edificio
di cinque piani
a base
quadrangolare,
che rivela il
passato di
casa-torre
medievale.
Nel
1191 il conte
di Savoia, Aosta e Moriana Tommaso
I concede
al vescovo
di Aosta di costruirsi un castello a Cogne,
di cui è
signore
spirituale:
«Pactum
insuper fuit ut
ipse episcopus
si voluerit in
valle de Conia
castrum erigere
valeat...»
 Il
castello è
probabilmente
terminato nel
1202, quando
viene inaugurata
la chiesa
parrocchiale, ma
le prime notizie
certe della sua
esistenza
risalgono ad una
carta de 1245 in
cui si parla
della «turris
domini episcopî». Durante il Medioevo il castellano del vescovo amministra la contea di
Cogne e risiede
nella torre. In
seguito, il
castello ospita
anche una
guarnigione. Nel
Quattrocento è
qui che si
amministra la
politica locale
e si tengono le
udienze generali. Il
castello è
probabilmente
terminato nel
1202, quando
viene inaugurata
la chiesa
parrocchiale, ma
le prime notizie
certe della sua
esistenza
risalgono ad una
carta de 1245 in
cui si parla
della «turris
domini episcopî». Durante il Medioevo il castellano del vescovo amministra la contea di
Cogne e risiede
nella torre. In
seguito, il
castello ospita
anche una
guarnigione. Nel
Quattrocento è
qui che si
amministra la
politica locale
e si tengono le
udienze generali.
A
lungo in stato
di abbandono, è
solo nel 1844
che il parroco
Pierre
Balthazard
Chamonin ne
avvia il
restauro, quando
la parrocchia di
Cogne ne entra
in possesso al
posto di André
Jourdain,
vescovo di
Aosta. Tuttavia,
le leggi
Siccardi del 1850 aboliscono i privilegi goduti fino ad allora dal clero
cattolico e la
parrocchia si
trova
espropriata del
bene nel 1867.
Il
castello di
Cogne è messo
all'asta nel
1873, ed è
aggiudicato ad
un
rappresentante
reale. Vittorio
Emanuele II,
soprannominato le
roi chasseur,
ne fa una
palazzina di
caccia per
rendersi nella
Riserva reale,
ossia in quei
territori che
saranno poi
all'origine del Parco
nazionale del
Gran Paradiso.
Il suo successore Vittorio
Emanuele III,
non altrettanto
interessato agli
stambecchi,
lascia cadere in
disuso il
castello reale,
finché nel 1915
esso è rilevato
da privati.
In
epoca
contemporanea,
il castello
reale di Cogne
diventa un
albergo e,
successivamente,
le suore
di San Giuseppe vi
tengono una
colonia estiva.
Oggi è privato
ed occupato da
appartamenti.
Una
lapide sulla
facciata lo
ricorda come monumento
nazionale
italiano.
Casaforte
Villette
La casaforte
Villette è una casaforte medievale
valdostana, per
secoli di
proprietà vescovile,
che sorge a Cogne in località Laydetré, non lontano dal capoluogo Veulla, lungo la
strada che porta
alla Valnontey.
Ristrutturata,
è di proprietà
di privati e non
è visitabile.
La
casaforte venne
costruita nel XIII
secolo «per marcare la giurisdizione dei vescovi su questa Valle» e per
volere di
Humbert de
Villette
(1266-1271),
membro della
famiglia dei
Chevron-Villette
che aveva i
propri interessi
in Tarantasia nominato vescovo
di Aosta nel 1266. Di conseguenza, Humbert de Villette avrebbe dato disposizioni di costruire
la casaforte
negli ultimi
anni della sua
vita, come
suggerisce lo
storico Jean-Baptiste
de Tillier indicando
come possibile
data di
edificazione il
1270, o come ipotizza Bruno Orlandoni, lasciando il dubbio se l'edificazione ex
novo sia
attribuibile o
meno al
neo-vescovo, in
una data
compresa tra il
1266 e la data
di morte.
Successivamente
restò in mano
al vescovado,
come
testimoniano i
documenti e
alcuni episodi
significativi:
nel 1363, per
una rivolta
popolare, vi si
rifugiò il
castellano del
vescovo,
minacciato dai cogneins. Un incendio la distrusse nel 1531 e a ottobre dello stesso anno
l'allora vescovo
di Aosta Pietro
Gazino (Pierre
Gazin) (1528
- 1556) radunò
i parrocchiani
per procedere
con la
ricostruzione: i
documenti
riportano che
ogni famiglia di
Cogne avrebbe
lavorato per una
giornata di corvée e
prestato i
materiali
necessari, dal legname,
alla pietra,
dalle lose alla calce,
mentre il
vescovo avrebbe
provveduto a
retribuire i
muratori e alla
cottura della
calce.
Di
fatto, riporta
il de Tillier, i
vescovi nella
giurisdizione di
Cogne ebbero a
lungo il
privilegio di
non dipendere da
alcuno (se
non da Dio),
ossia di godere
dell'autonomia
decisionale di
cui godevano
principi e re, privilegio che mantennero fino al maggio del 1605, quando il Senato di
Savoia riconsegnò
la sovranità
suprema a Carlo
Emanuele duca
di Savoia e ai suoi successori alla corona. Si trattò di una riconsegna,
infatti: i diplomi
d'infeudazione di Carlo
V datati
1º maggio 1521
e 10 dicembre
1547 e quello di Ferdinando
I datato
6 marzo 1562
affidavano il
vicariato
perpetuo e senza
restrizioni del
territorio
locale parte del Sacro
Romano Impero alla Real
Casa di Savoia,
sottomettendo i
prelati di fatto
al vassallaggio.
Nei
secoli seguenti
la casaforte
Villette andò
in rovina, e fu
in questo stato
che la trovò lo
storico Jean
Baptiste
de Tillier negli anni
trenta del Settecento.
Restaurata
nel 1873, la
casaforte
Villette venne
trasformata in
ospizio per i
poveri.
Nei
primi decenni
del Novecento
vennero portati
avanti i lavori
per la
costruzione di
villa
Giacosa-Malvezzi.
Fin
dall'origine la
casaforte
Villette era
composta di due
edifici, una
torre e un
casaforte.
La
casaforte
originaria andò
distrutta
nell'incendio
del 1531 e venne
per questo
ricostruita: gli
edifici attuali,
seppur
trasformati,
hanno per base
le rovine della
casaforte
seicentesca,
pesantemente
rimaneggiati nel
1873.
In
particolare, il
fabbricato con
funzione
residenziale è
stato
trasformato a
inizio Novecento
nella villa
Giacosa-Malvezzi,
mentre la torre
vera e propria
nella seconda
metà
dell'Ottocento
è stata
incorporata in
un ospizio per i
poveri. Quest'ultima, per l'aspetto massiccio, è stata comparata da Bruno
Orlandoni alla domus
episcopalis del Castello
di Issogne,
alla Torre
Colin di Villeneuve e castello
di La Mothe di
Arvier.

Casaforte
di Tarambel
La casaforte
di Tarambel,
localmente
conosciuta anche
come torre
dei Mogni,
in patois
valdostano Tor
de Mougne,
è un rudere
medievale che si
trova tra le
frazioni di Épinel
e di Crétaz,
nel comune
valdostano di Cogne.
La
struttura venne
edificata, nei
pressi di un
crocevia
frequentato nel 1198 dai
nobili di Chésallet che
la cedettero nel
secolo
successivo al
vescovo-conte insieme a tutti i loro beni; egli infeudò poi i terreni ai Moni (o Mogny)
di Épinel,
fedeli al
prelato di Aosta.
Secondo
un'ipotesi nel
1291 Teobaldo de
Casaleto la
cedette insieme
ad altri beni al
vescovo Nicola
Bersatori.
La
storia della
casaforte di
Tarambel è
strettamente
intrecciata con
quella della
comunità
locale: vicino
alla casaforte
sorse il
villaggio di
Tarambel,
probabilmente
costituito da
due abitati
distinti (Mogni
e Croix), che divenne il centro amministrativo di Épinel, tanto da avere diritto ad
eleggere i
propri
rappresentanti
tra quelli della
comunità di
Cogne. Il
villaggio fu
abbandonato nel
corso del XVI
secolo,
probabilmente a
causa
dell'eccessiva
siccità della
zona, e gli
abitanti si
trasferirono così
nel villaggio di
Épinel,
facendolo
crescere.
La
casaforte
conserva
l'impianto
compatto e a
pianta
rettangolare
originario, ma
è ormai ridotto
a rudere e privo
sia del tetto
che dei piani,
un tempo
sorretti da
travi in legno
di cui resta
testimonianza
nei fori delle
mura portanti.
Sulle
mura, inoltre,
si conservano le feritoie e
le aperture
della colombaia.
L'accesso
alla casaforte
è rialzato,
com'è
frequentemente
rilevato nelle
architetture
militari
medievali
valdostane.

Aree
naturali
Parco
nazionale del
Gran Paradiso
Giardino
alpino Paradisia
Vallone
di Grauson, sito
di interesse
comunitario
Vallone
dell'Urtier,
sito di
interesse
comunitario
Stazione
di Astragalus
alopecurus,
sito di
interesse
comunitario
Musei
Mèison
di pitz:
Mostra
permanente del
pizzo al tombolo
- I merletti di
Cogne (Les
dentelles),
in via César
Grappein, di
fronte alla
chiesa
parrocchiale;
Atelier
d'arts et métiers;
Museo
minerario
regionale,
al Villaggio
minatori;
Museo
etnografico Maison
de Cogne Gérard
Dayné,
a Sonveulla, che
ospita anche uno
spazio di coworking;
Centro
visitatori del
Parco nazionale
del Gran
Paradiso.

Cogne
è un'importante
località
turistica, sia
estiva che
invernale, e uno
dei centri
mondiali dello sci
di fondo.
Determinante
attrattiva
turistica è il Parco
Nazionale del
Gran Paradiso,
primo parco
nazionale
italiano che
tutela una
notevole
biodiversità
sia floristica
che faunistica.
Dal
1º gennaio 2011
Cogne è entrata
a far parte
dell'Associazione Perle
delle Alpi per
l'offerta turistica
sostenibile e la mobilità
dolce.
È la seconda
località alpina
valdostana a
rientrare nei
criteri dopo Chamois.
Cogne
è nota anche
per i suoi pizzi a
fuselli
artigianali
lavorati dalle
donne al tombolo e
detti les dentelles de
Cogne;
questa attività
è praticata a
Cogne fin dal
XVI secolo e fa
parte della
tradizione che
ancora oggi
viene portata
avanti dalla
cooperativa
"Les
Dentellieres de
Cogne".
Ai pizzi di
Cogne è
dedicata
l'esposizione
permanente della Mèison
di pitz. I
pizzi così
realizzati
vengono
utilizzati per
impreziosire
svariati
oggetti, quali
tovaglie,
lenzuoli e i
tipici costumi
della valle.








Fonte
|