|
Gressoney-Saint-Jean,
elegante località
turistica a 1385
metri di
altitudine, è
situata in un
contesto
scenografico
particolarmente
interessante per
la vista offerta
sul ghiacciaio
del Lyskamm e
sull’imponente
massiccio del Monte
Rosa.
Si
trova nella valle
del Lys (o
valle di
Gressoney) a
1.385 m
s.l.m. ai
piedi del Monte
Rosa. A est
confina con il
Piemonte nel
territorio di
Alagna Valsesia,
a ovest con la Val
d'Ayas. Dal
capoluogo Obre
Platz chiude
la visuale della
valle il Monte
Rosa con il ghiacciaio
del Lys (1078
ettari, il più
esteso del
versante
italiano del
gruppo e il
secondo della
Valle d'Aosta) e
con le cime del Castore (4226 m),
dei Lyskamm (Occidentale,
4481 m e Orientale,
4527 m) e
della Piramide
Vincent (4215 m).
Nel territorio
comunale è
ubicata la stazione
meteorologica di
Gressoney-Saint-Jean.
La
punta più alta
del massiccio si
trova invece più
distante, a
cavallo tra Macugnaga e Zermatt (Svizzera).
Il versante del Monte
Rosa di
Gressoney,
condivide le
caratteristiche
morfologiche del
confinante
versante
valdostano di Champoluc:
forme ampie,
grandi
ghiacciai, ampi
pianori in
quota, tutti
elementi molto
distanti dal pur
confinante e
vicino versante
Piemontese la
cosiddetta parete
valsesiana del
Monte Rosa. Qui
le forme si
fanno molto più
aspre e
grandiose: ai
grandi ghiacciai
si sostituiscono
pareti
strapiombanti e
versanti a
picco.
La
storia di
Gressoney è
strettamente
legata alla comunità
Walser,
una popolazione
di origine
germanica giunta
in questa zona
più di otto
secoli or sono
attraverso il
Colle del
Teodulo. Il
patrimonio
tradizionale,
mantenuto vivo
dal Centro
Culturale Walser
e dal gruppo
folkloristico,
si riflette
ancora oggi
nell'architettura
originale con
i tipici stadel,
nella lingua
parlata, il Titsch,
e nel prezioso costume
femminile,
indossato anche
dalla Regina
Margherita di
Savoia,
che trascorreva
a Gressoney le
sue vacanze
estive. La prima
sovrana
d’Italia,
grande amante
della montagna,
diede un grande
impulso allo
sviluppo di
questi luoghi,
che divennero
meta di molti
turisti.

CASTEL
SAVOIA - Realizzato per
volere della Regina
Margherita di
Savoia, che soggiornava a Gressoney ospite dei baroni Beck Peccoz già dal
1889, Castel
Savoia
sorge ai piedi
del Colle della
Ranzola nella
località
denominata
“Belvedere”,
in ragione della
splendida vista
che da lì
domina tutta la
vallata fino al ghiacciaio
del Lyskamm.
La posa della prima pietra
dell’edificio
avvenne il 24
agosto 1899 alla
presenza di re
Umberto I il
quale,
assassinato a
Monza un anno
dopo, non
avrebbe visto la
conclusione dei
lavori,
protrattisi fino
al 1904. La
dimora ospitò
la Regina
durante i suoi
soggiorni estivi
fino al 1925, un
anno prima della
sua morte, che
avvenne a
Bordighera il 4
gennaio 1926.
Dopo
l’acquisto nel
1936 da parte
dell’industriale
milanese
Moretti, il
castello divenne
proprietà della
Regione Autonoma
Valle d’Aosta
nel 1981.
Costituito da un
nucleo centrale
di forma grosso
modo
rettangolare,
cui si
affiancano
cinque torrette
cuspidate, una
diversa
dall’altra, il
castello fu
progettato
dall’architetto
Emilio Stramucci
(ideatore delle
decorazioni
neobarocche per
il Palazzo Reale
di Torino e il
Quirinale di
Roma) in stile
medioevale, descritto come
“stile
lombardo del
secolo XV”,
assai in uso
nella Francia e
nella Savoia,
regione
d’origine dei
sovrani
regnanti.
L’esterno è
rivestito in
pietra da taglio
grigia
proveniente
dalle cave di
Chiappey a
Gressoney, di
Gaby e di Vert
(Donnas).
Le pitture
ornamentali furono realizzate
dal giovane
pittore e
restauratore
Carlo Cussetti,
in seguito
attivo
nell’ala nuova
del Palazzo
Reale di Torino.
I soffitti
a cassettoni, le
boiseries e gli
arredi di
ispirazione
medievale sono invece opera
dell’intagliatore
torinese Michele
Dellera,
fornitore della
Real Casa.
Il castello si articola su tre piani:
il pianterreno
con i locali da
giorno, il piano
nobile con gli
appartamenti
reali ed il
secondo piano
(non
visitabile),
riservato ai
gentiluomini di
corte; i
sotterranei
ospitano le
cantine. Tutti
autentici gli
arredi esposti
nel castello,
così come le
tappezzerie che
ornano le
pareti, in
tessuto di lino
e seta, decorate
ad effetto chiné.
 Pianterreno: gli ospiti accedono ad un vasto atrio
a colonne. Si
visita quindi la
sala da pranzo,
dalla ricca
decorazione
dipinta sulle
pareti, sul
camino e sul
soffitto e
rivestita da una
boiserie con
intagli a
pergamena in
stile neogotico.
Il percorso si
sviluppa poi
attraverso la
veranda
semicircolare
che si affaccia
sulla valle e
prosegue verso
la sala da
gioco, con il
biliardo
originale ed i
salottini di
soggiorno. Pianterreno: gli ospiti accedono ad un vasto atrio
a colonne. Si
visita quindi la
sala da pranzo,
dalla ricca
decorazione
dipinta sulle
pareti, sul
camino e sul
soffitto e
rivestita da una
boiserie con
intagli a
pergamena in
stile neogotico.
Il percorso si
sviluppa poi
attraverso la
veranda
semicircolare
che si affaccia
sulla valle e
prosegue verso
la sala da
gioco, con il
biliardo
originale ed i
salottini di
soggiorno.
Piano
nobile: un elegante e
maestoso scalone
in legno di
rovere
intagliato con
grifoni ed
aquile conduce
agli
appartamenti
reali, preceduti
da un atrio sul
cui soffitto si
legge
l’iscrizione
augurale “Hic
manebimus
optime”. Il
percorso di
visita raggiunge
invece il primo
piano attraverso
la scala a
chiocciola
ricavata
all’interno
della torre di
guardia.
Nella stanza
riservata al
padre spirituale
che seguiva i
reali nelle
villeggiature a
Gressoney, sono
esposte diverse
fotografie che
ritraggono la
Regina ed il suo
entourage
durante i
momenti di svago
in montagna. Si
procede in
seguito con gli
appartamenti
destinati a Re
Umberto I, in
cui si ammirano
altre curiose
foto d’epoca.
L’appartamento
della Regina
occupa la
posizione più
felice ed è
riccamente
arredato con
mobili nello
stile eclettico
a lei caro,
provenienti in
parte dalla
Villa
Margherita, la
dimora che
accolse la
Sovrana in paese
negli anni
precedenti la
costruzione del
Castello;
accanto alla
camera è
possibile
osservare la
stanza da bagno,
mentre sul lato
opposto, nella
torre
settentrionale,
si apre un
grazioso
boudoir, con
finti drappi
dipinti alle
pareti che
richiamano la
decorazione
della sala
baronale del
castello di
Issogne, e
finestre che
permettono di
contemplare il
magnifico
panorama sul
Monte Rosa e
sull’intera
vallata. La
stanza attigua a
quella della
Regina, infine,
è dedicata al
principe
ereditario
Umberto II.
La
meridiana,
realizzata in
facciata nel
1922, reca le
parole augurali
già riportate
su un orologio
solare di Cogne
del 1915: “Sit
patriae aurea
quaevis” -
“Ogni ora sia
d’oro per la
patria”.
L’augurio,
purtroppo, non
sarebbe stato
realizzato dagli
avvenimenti
drammatici
avvenuti in
Italia proprio
in quell’anno
Le
cucine,
collocate in un
fabbricato poco
distante dal
castello, sono
collegate alla
sala da pranzo
da una Decauville sotterranea.
Il
giardino
botanico,
inaugurato nel
1990 nel parco
ai piedi del
maniero, è
costituito da
aiuole rocciose
con specie
botaniche
tipiche
dell’ambiente
alpino.
Altre
dipendenze del
castello sono
la Villa Belvedere, in origine adibita a foresteria e
gendarmeria
reale, e la
casetta nota
come Romitaggio
Carducci, dedicata al
poeta che della
Regina fu devoto
ammiratore e
cantore.
CHIESA
DI SAN GIOVANNI
BATTISTA - La chiesa
di Gressoney-Saint-Jean,
dedicata
a San
Giovanni
Battista, si
trova sulla
piazza centrale
del capoluogo,
denominata Òbre
Platz.
Il
documento più
antico che
accerta la
presenza di una
chiesa sul
territorio di
Gressoney risale
al 1380, ma la
prima chiesa,
secondo la
tradizione,
sorgeva a Gover,
contro la
montagna, e fu
distrutta da una
frana.
L'edificio
risale al 1515 e
costituisce la
prima presenza
religiosa
documentata di
Gressoney. È
ubicato nel
centro del
paese, sulla
piazza
denominata
in Greschòneytitsch "Òbre
Platz", e
fu costruito su
un terreno
donato dalla
famiglia
Battiany.
Della
chiesa
originaria ci
rimane solo una
parte della
facciata con il
portale tardo
gotico in pietra
lavorata sul
quale, in alto,
si trova
un'iscrizione
gotica scolpita
su pietra :
«HOC OPUS FECIT
MAGISTER ANTHON
GOYET DE ISSIMA
ET CHRISTIANUS
F. US EIUS. A.
D. MDXV» che ci
racconta che
l'impresario che
la costruì fu
Antoine Goyet
di Issime,
lo stesso che
qualche anno
prima costruì
la chiesa
di Fontainemore.
Nel 1731 la
chiesa fu
ingrandita su
terreno donato
anche questa
volta dalla
famiglia
Battiany
(Jean-Joseph
Battiany).
Furono
realizzate le
due ali laterali
e fu
sopraelevata.

La
facciata
principale della
chiesa è
caratterizzata
dall'ampio tetto
a due spioventi
che la protegge
interamente. Si
dice che
anticamente
fosse tutta
dipinta come
quella di Perloz
e Issime, ma non
se ne hanno
testimonianze
certe. Oltre
alle tre porte
di accesso si
trovano nella
parte superiore
numerose
finestre di
varie forme che
permettono alla
luce di
penetrare
all'interno e un
cornicione
dipinto che
sottolinea la
copertura. A
destra della
porta
principale, nel
1928 fu
collocato il
busto
della regina
Margherita, in
memoria del
fatto che
durante i suoi
36 anni di
villeggiatura a
Gressoney la
stessa soleva
recarsi qui a
messa ogni
domenica
percorrendo a
piedi il
sentiero che
oggi si chiama
“passeggiata
della Regina”.
L'interno
si presenta
grandioso ed
elegante. Alla
navata
principale si
affiancano le
due navate
laterali
separate con
colonne
monolitiche in
granito. Il
soffitti sono a
volta a vela.
Nel 1818 fu
rialzata la
volta del
presbiterio e
costruita una
seconda
sacrestia al di
sopra di quella
primitiva.
Datano
probabilmente di
quegli anni i
dipinti dei
soffitti e delle
pareti del
pittore
eporediese
Giovanni
Stornone. I
dipinti assumono
in pieno la
tradizione della
pittura sacra
come si era
andata
codificando
dalla fine del
Cinquecento che
recepiva le
indicazione
della Chiesa
dopo
il Concilio
tridentino. I
dipinti infatti
consentono una
lettura semplice
ed immediata dei
fatti narrati e
sono impostati
in modo decoroso
ed equilibrato.
Le tonalità
delicate e la
leggerezza delle
stesure rendono
gradevoli questi
inserimenti nel
contesto.
Il
pittore Nino
Pirlato chiamato
a restaurare i
dipinti
nell'anno 1955
modificò le
originarie
decorazioni in
stile classico
delle lesene
(cornici
geometriche e
foglie d'acanto)
e dei cornicioni
introducendo
ornamenti con
motivi di
conchiglie in
stile
neobarocco, e
sostituì il
grande dipinto
di San Giovanni
(seicentesco)
che medita nel
deserto sopra
l'altare e i due
medaglioni
laterali con
quelli ancora
visibili oggi.
L'altare
maggiore in
marmo a diversi
colori proviene
dall'antica
chiesa di San
Francesco di
Ivrea che fu
soppressa dalle
leggi
napoleoniche nel
1812. Dei
gressonari della
famiglia De La
Pierre
l'acquistarono
per farne dono
alla loro chiesa
nel 1818. Sopra
l'altare,
durante i
periodi
liturgici di San
Giovanni e di
Natale vengono
poste quattro
statue
settecentesche
raffiguranti
Maria, San
Giuseppe,
Elisabetta e
Zaccaria. Sopra
lìaltare si
trova una grande
tela
raffigurante San
Giovanni
Battista che
medita nel
deserto e i due
medaglioni
laterali (questi
dipinti furono
sostituiti con
altri analoghi
durante
l'intervento di
Pirlato. La
Parrocchia
possiede anche
una reliquia di
San Giovanni
portata qui
dalla Germania nel
primo ottocento
da un altro
parrocchiano.
Dopo
il Concilio
Vaticano
II e la
necessità di
ristrutturare
alcune parti del
presbiterio per
far fronte alle
nuove
indicazioni
liturgiche fu
soppressa la
balaustra in
marmo che
separava il
presbiterio dal
resto della
chiesa con parte
delle colonnine
della stessa fu
realizzato
l'altare al
centro del coro.
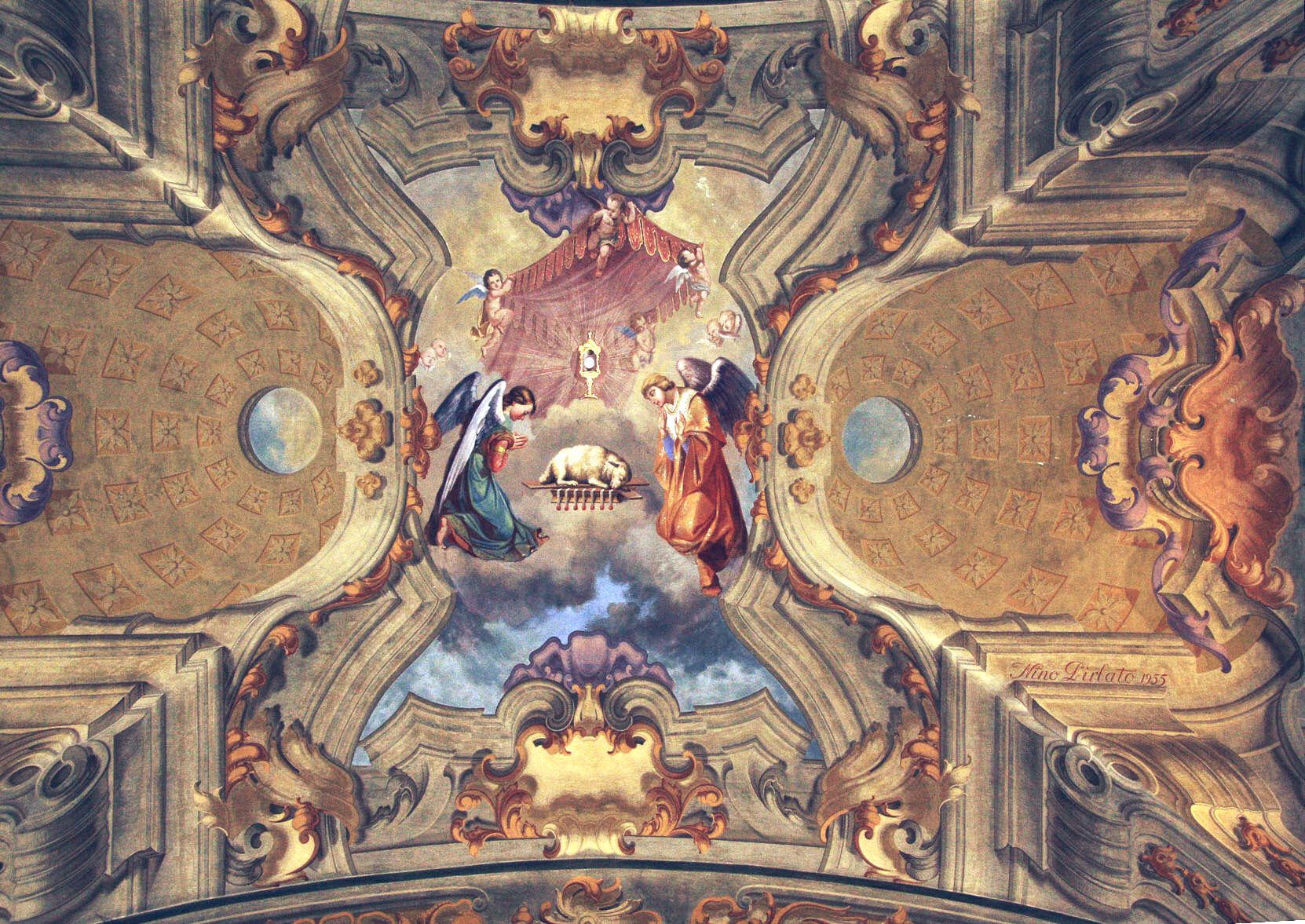
Vi
sono altri
quattro altari
laterali:
notevole per la
composizione
plastica quello
del S. Rosario,
in legno
intagliato e in
gran parte
dorato, con la
statua della
Madonna al
centro che reca
la data del 1662
circondata da 14
cornici
contenenti le
raffigurazioni
dei misteri del
Rosario. Il
mistero
dell'Annunciazione
è raffigurato
in proporzioni
più grandi in
alto. Le altre
due statue che
raffigurano S.
Domenico e Santa
Caterina sono
recenti e
realizzate dallo
scultore
valdostano Siro
Viérin perché
le originarie
sono state
rubate nel 1975.
Anche
gli altri altari
risalgono al
settecento e
costituiscono
dei pregevoli
esempi di
scultura lignea
policroma.
Quello nella
navata destra è
dedicato a San
Sebastiano, e ai
lati
troviamo San
Grato e San
Lorenzo Martire,
mentre in alto
c'è San
Giuseppe col bambino.
Nella
navata di
sinistra si
trovano invece
gli altari
dedicati a Sant'Antonio
con San
Grato e San
Pantaleone, e
quello dedicato
a Santa Caterina
tra Sant'Anna e
San Giuseppe.
Caratteristici
i banchi in
legno di larice
settecenteschi
con le testate
scolpite che
richiamano
motivi bavaresi.
In quel tempo
la Baviera era
luogo terminale
dei commerci
attuati dai
Gressonari e
alcuni rami di
famiglie vi
presero anche la
residenza.
Il
campanile,
costituito da
una torre in
pietra a vista,
con semplici
feritoie fino
alla cella
campanaria con
bifore con archi
a pieno centro.
Esso seguì
l'evoluzione
della chiesa:
poiché
l'intervento di
ampliamento del
settecento gli
fece perdere le
primitive
proporzioni, si
provvide nel
1771 alla sua
sopraelevazione
(dieci metri),
nel 1870 furono
stanziati dei
fondi dal comune
per l'acquisto
di alcune
campane e
dell'orologio,
quindi fu
ulteriormente
innalzato nel
1903 quando fu
mutata anche la
parte terminale
originariamente
in stile
lombardo e fu
sostituita da
una cuspide
piramidale
ricoperta in
rame sormontata
da una croce e
un gallo. Questo
intervento
contribuì ad
aumentare la sua
slanciatezza.
 Nel
1866 vi si
trovava ancora
una campana del
1554 rinomata
oltre che per la
sua veneranda
età anche per
il suo timbro
musicale che fu
poi rifusa.
Attualmente
nella cella
campanaria si
trovano 7
campane tutte
distese, due
delle quali
regalate dalla
famiglia Beck
Peccoz nel 1914,
fuse da Paccard
a Ginevra,
e due comperate
nel 2005 per
completare il
concerto di
campane che
adesso possono
suonare in fa
diesis. Nel
1866 vi si
trovava ancora
una campana del
1554 rinomata
oltre che per la
sua veneranda
età anche per
il suo timbro
musicale che fu
poi rifusa.
Attualmente
nella cella
campanaria si
trovano 7
campane tutte
distese, due
delle quali
regalate dalla
famiglia Beck
Peccoz nel 1914,
fuse da Paccard
a Ginevra,
e due comperate
nel 2005 per
completare il
concerto di
campane che
adesso possono
suonare in fa
diesis.
Nella
cantoria si
trova un organo,
un Vegezzi
Bossi, che è
stato donato
dalla regina
Margherita nel
1895. I Vegezzi
Bossi
appartengono a
una grande
famiglia di
organari che
risale al 1550.
All'inizio
della navata
sinistra, nel
1983 è stato
allestito un
piccolo museo
nella nicchia
dove era situato
l'antico
battistero. Esso
concilia la
protezione
museale delle
opere d'arte
sacra con la
funzione
devozionale
delle stesse.
Antiche sculture
lignee sono
ancora in grado
di comunicare
una severa
religiosità nel
pianto
silenzioso della
Madonna
addolorata
seduta con il
corpo del Cristo
morto sulle
ginocchia o nel
composto dolore
del Cristo di
questo
crocifisso che
potrebbe datare
addirittura del
XIII secolo. La
statua della
Madonna con il
bambino era
situata
nell'oratorio
del villaggio di
Valdobbia, dove
fu rubata nel
1960 e in
seguito
ritrovata e
collocata nella
chiesa. Data del
XIV secolo.
Si
possono inoltre
ammirare i
virtuosismi dei
maestri
argentieri
impegnati nella
realizzazione di
preziosi
reliquiari,
calici, pissidi,
ostensori, croci
astili tutti
antichi e alcuni
di provenienza
tedesca. Tra
tutti, il pezzo
più prezioso
consiste nella
croce astile di
scuola
fiorentina
di Lorenzo
Ghiberti risalente
al XVI sec.
Di
particolare
pregio artistico
e interesse
storico sono le
opere donate da
Jean-Nicolas
Vincent e dai
suoi eredi
riguardanti la
famosa
collezione di
vetrate
medievali
tedesche e
svizzere
possedute e
raccolte dallo
stesso Jean
Nicolas Vincent
tra la Svizzera,
l'Italia e la
Germania nel
corso del XIX
secolo.
Antistante
la chiesa si
trova il
sagrato,
suggestiva
piazzetta
delimitata da un
porticato dietro
al quale si
snodano le
edicole della
via Crucis
costruito nel
1626. Al centro
si trova la
croce in pietra
dell'antico
cimitero (eretta
nel 1735 e
consacrata
durante la
missione del
1777).
Infatti,
secondo l'uso
antico, il
cimitero stava
proprio in
questo luogo,
come lo
dimostrano le
lapidi in pietra
dissepolte,
molte delle
quali del XVII
secolo. Le
cappelle delle
stazioni
(in Greschòneytitsch, d'Gheimnisse)
erano state
dipinte dal
famoso pittore
gressonaro
Curta, ma tali
pitture sono
andate perse.
Possiamo
ammirare per
esempio la
pietra tombale
datata 1629 in
cui è scolpito
il
“Chremer-Zeiche”,
cioè
l'"emblema
dei
mercanti",
al centro il
simbolo di
Mercurio,
considerato
nella remota
antichità il
protettore dei
mercanti, ai
lati le foglie
di quercia,
mentre al centro
l'agnello è il
simbolo di San
Giovanni
protettore della
parrocchia. In
quei tempi vi
era anche
l'abitudine di
seppellire i
morti sotto il
pavimento stesso
della chiesa
come si è
potuto
constatare anche
da recenti
lavori di
sostituzione del
pavimento in
legno quando si
ritrovarono
parecchi
scheletri.
Nei
primi anni
dell'800 si
ampliò il
cimitero sul
lato est e sud
della chiesa,
dove ancor ora
si trovano le
lapidi più
antiche e belle.
L'ultimo
ampliamento
avvenne nel 1877
con l'acquisto
del terreno a
nord della
chiesa
parrocchiale,
terreno che
apparteneva a
Johann Jacob
Bonda. Il comune
fece fronte alle
spese
dell'acquisto e
dei lavori di
sistemazione e
di recinzione
con una
sottoscrizione
fra tutti gli
abitanti di
Saint-Jean. I
171 posti del
nuovo cimitero
furono assegnati
alle famiglie
per estrazione a
sorte, in data
14 novembre
1886.
Contemporaneamente
venne steso un
regolamento
d'uso, in parte
ancora in uso.

VILLAGGIO
WALSER DI
ALPENZU - Posizionato
su una
panoramica
balconata
naturale, il
villaggio di
Alpenzu
racchiude in sé
le peculiarità
dell'architettura
Walser, tra cui
spiccano gli stadel,
edifici rurali
che poggiano su
colonne a forma
di fungo. Degni
di nota sono
anche i villaggi
di Noversch ed
Ecko.
L’itinerario
consiste in una
piacevole
passeggiata in
destra
orografica della
valle di
Gressoney, ora
nel bosco, ora
sui pascoli, che
tocca i villaggi
di Alpenzù
piccolo e Alpenzù
grande, dove
l’architettura
Walser è
rimasta
mirabilmente
conservata. A
fare da sfondo
il grandioso
spettacolo del
massiccio del
Monte Rosa. I
due villaggi si
trovano sul
percorso del
Grande Sentiero
dei Walser,
l’itinerario
percorso dalle
popolazioni
d’oltralpe
che, a partire
dal XII secolo,
migrarono verso
la Valle
d’Aosta
attraverso le
montagne.
ALPENFAUNAMUSEUM
BECK-PECCOZ - Il
museo ospita una
ricca collezione
di trofei di
caccia, armi
antiche,
preziosi cimeli
di famiglia e
pubblicazioni
inerenti la
fauna e la flora
alpina.

Gressoney-La-Trinité è
l’ultimo
centro abitato
alla testata
della valle
percorsa dal
torrente Lys,
situato a 1627
metri di
altitudine in
una vasta conca
dominata dal
ghiacciaio del
Lyskamm della catena del Monte
Rosa.
Nel Medioevo
questa località
appartenne ai
vescovi di Sion
e fu popolata da
pastori
precedentemente
transitati in
territorio
vallese, a cui
devono il loro
nome: i Walser,
una popolazione
di origine
germanica giunta
in questa zona
più di otto
secoli or sono
attraverso il
Colle del
Teodulo. La loro
cultura si
riflette ancora
oggi nelle
usanze, nell’architettura
tradizionale con
i tipici stadel, nella lingua parlata, il Titsch,
e nel prezioso costume
femminile,
simbolo della
tradizione
Walser e
indossato dalle
donne di
Gressoney nelle
occasioni
importanti,
famoso per la
sua bellezza ed
eleganza.
ECOMUSEO
WALSER - Il
museo propone un
viaggio alla
scoperta del
Walser,
attraverso la
visita di tre
strutture:
un’antica casa
rurale del 1700,
la casa museo
con mostre
permanenti e la
Baita di Binò
Alpelté, un
piccolo alpeggio
costruito al
riparo di un
masso naturale
che funge da
tetto.
La
visita
all’ecomuseo
attraversa tre
strutture che
offrono
l’opportunità
di un viaggio
alla scoperta
della cultura
walser:
Casa
Rurale -
Puròhus -
Antica casa
rurale del 1700
che ripropone
l’autentica
atmosfera di una
tipica
abitazione
walser con il
suo
“Wohngade”,
la
stalla-abitazione.
Il Wohngade, un
tempo cuore
pulsante
dell’attività
lavorativa,
comprende una
parte adibita a
ricovero degli
animali ed una
riservata
all’abitazione
umana, separate
tra loro da una
divisoria in
legno. La
coabitazione era
finalizzata allo
sfruttamento del
calore animale.
Visitabile anche
la bella cantina
a volta e il
fienile con gli
attrezzi da
lavoro.
Casa
Museo -
Pòtzschhus
- Negli ambienti
di questo
“stadel”,
nome dialettale
della tipica
casa walser,
sono allestite
mostre
permanenti
dedicate al
territorio.
Nella sala del
Monte Rosa, si
raccontano
l’evoluzione
dei ghiacciai
nel tempo, la
storia della
conquista delle
cime e dei suoi
protagonisti,
l’evoluzione
tecnica
alpinistica, la
storia dei
rifugi e
l’affascinante
impresa della
posa del
“Cristo delle
Vette”, la
grande statua in
bronzo posta sul
ghiacciaio del
Rosa a 4170
metri. Vi è poi
una sezione
dedicata alla
storia e alla
funzione dei due
laboratori
scientifici
“Istituto
Angelo Mosso”
e “Regina
Margherita”
(quest’ultimo
allestito
nell’omonimo
rifugio, il più
alto d’Europa,
a 4554 metri),
sedi dei primi
studi degli
effetti
dell’altitudine
sull’uomo.
Un'area è
dedicata anche
alla Krämertal -
La Valle dei
Mercanti Walser.
Presso la sala
al primo piano,
sede anche
dell'Office Régional
du Tourisme, si
può ammirare
un’esposizione
sulla storia del
costume locale,
famoso per la
sua bellezza ed
eleganza.
 Baita
di Binò
Alpelté -
Si tratta della
terza struttura
dell’Ecomuseo,
costituita da
una casetta sita
in località Binò
e destinata un
tempo, da giugno
alla fine di
settembre, allo
sfruttamento dei
pascoli situati
nelle vicinanze
del capoluogo.
L’edificio è
formato da due
fabbricati
contigui,
costruiti al
riparo di un
unico masso
naturale, la
“balma”, che
funge da tetto e
li protegge
dalla caduta di
valanghe e di
pietre, a cui la
zona è esposta
durante
l’inverno e la
primavera. Lo
spazio più
ampio veniva
utilizzato per
il ricovero
notturno di una
ventina di capi,
tra bovine
adulte da
mungitura e
vitelli, mentre
l’altro era
adibito alla
lavorazione del
latte. Baita
di Binò
Alpelté -
Si tratta della
terza struttura
dell’Ecomuseo,
costituita da
una casetta sita
in località Binò
e destinata un
tempo, da giugno
alla fine di
settembre, allo
sfruttamento dei
pascoli situati
nelle vicinanze
del capoluogo.
L’edificio è
formato da due
fabbricati
contigui,
costruiti al
riparo di un
unico masso
naturale, la
“balma”, che
funge da tetto e
li protegge
dalla caduta di
valanghe e di
pietre, a cui la
zona è esposta
durante
l’inverno e la
primavera. Lo
spazio più
ampio veniva
utilizzato per
il ricovero
notturno di una
ventina di capi,
tra bovine
adulte da
mungitura e
vitelli, mentre
l’altro era
adibito alla
lavorazione del
latte.
La
Baita è aperta
solo nel periodo
estivo secondo
disponibilità
ma raggiungibile
anche in
autonomia
seguendo il
sentiero n. 15.
CHIESA
PARROCCHIALE
DELLA SANTISSIMA
TRINITA' - La
chiesa fu
costruita nel
1671 sulle
fondamenta di un
preesistente
edificio del XV
secolo. Degni di
nota l’altare
maggiore ligneo
in stile barocco
e il cimitero
adiacente alla
parrocchia con
le sue antiche
lapidi in
pietra,
fatte a mano da
scultori locali.
Fin
dalla sua
fondazione,
avvenuta nel
1702, la chiesa
è intitolata
alla Santissima
Trinità, ma ha
per patrono San
Francesco
Saverio, non
potendosi
attribuire il
titolo patronale
delle Tre Divine
Persone.
Elementi
interessanti:
-
l’altar
maggiore,
coevo alla
chiesa, in stile
barocco con
qualche
reminiscenza
rinascimentale.
Realizzato in
legno dorato e
dipinto, intorno
alla metà
dell’800 è
scampato ad un
incendio
-
il tabernacolo a
ruota del
1704
-
la lampada
ornamentale in
rame argentato e
dorato,
risalente al
1695.
Nel
1975 la chiesa
ha subito un
furto di gravi
proporzioni;
alcune opere
rubate sono
state
rimpiazzate da
statue
realizzate dallo
scultore Siro Viérin,
mentre altri
lavori
provengono dalle
cappelle locali,
come le due
statue collocate
sull’altare di
San Giuseppe,
originariamente
site nella
cappella di
Tschaval.
La
torre
campanaria,
contemporanea
alla chiesa,
s’innalza per
circa 30 metri.
La cuspide
risale al 1819 e
presenta una
particolare
forma a cipolla,
sormontata da
una boccia in
rame e da una
croce; la
struttura è in
legno ricoperto
da ferro
zincato.
Inizialmente era
dotata di tre
campane, a cui
ne furono
aggiunte altre
tre nel 1933.
L’intero
concerto
campanario,
rinnovato ed
inaugurato nel
1992, con le sue
dodici campane
risulta essere
il più completo
di Piemonte e
Valle d’Aosta.
Nella piazza
della Chiesa è
esposta la più
antica campana
di sicura
datazione
dell’antico
concerto.
Adiacente alla
Chiesa, il cimitero è degno di nota per l’antichità e la qualità delle lapidi di
pietra, fatte a
mano, opera di
scultori e
scalpellini del
posto, ma
soprattutto per
la bella croce
in pietra che vi
campeggia, fatta
erigere dal
reverendo
parroco
Valentino L. De
La Pierre nel
1722.
CAPPELLE
- Il
territorio di
Gressoney-La-Trinité
ospita numerose
cappelle,
testimonianza
dell'importanza
della religione nella
vita
tradizionale
delle comunità
alpine, tra cui
quella di Oagre, dedicata alla Madonna delle Nevi.

Fonte
|