|
Bisignano è
posta a 350 metri sul livello del mare sulle ultime propaggini collinose della Sila greca,
a dominio della valle del Crati. Sede vescovile dall'VIII secolo, vanta i
ruderi di un castello bizantino-normanno e la cattedrale, risalente al XIII
secolo ma quasi interamente rifatta.
Non
si conoscono con esattezza quali furono gli albori della città; alcuni storici
antichi, e tra questi il Barrio, raccontano che il fondatore fu un tale Bescio,
il quale condusse Aschenez,
pronipote di Noè,
fino in Calabria,
dandole il nome di Bescia, che i Greci e
i Romani cambiarono
in Besidia. Altri storici, invece, fanno risalire le origini agli Ausoni.
Certamente nel IV secolo a.C. Bisignano era una delle principali città della Confederatio
Bruttiorum.
I
numerosi ritrovamenti testimoniano comunque le antichissime e importanti origini
della Città, in periodi storici che risalgono al XV e XIV secolo a.C. I siti
archeologici di Bisignano nelle località di Mastro D'Alfio e di Comò
custodiscono, sepolte, le vestigia della Bruzia Besidiae. In particolare, nella
zona di Mastro D'Alfio, affiora, dal cumulo di terra che lo ricopre, un forno di
età greca a due bocche e nella medesima zona furono ritrovate le grandi giare
del IV secolo
a.C. custodite nel Museo della Sibaritide. Notizie della città sono
già note intorno al 205
a.C., quando alleata di Annibale, nella battaglia di Campovile, sconfisse
i Romani.
Per
carenza di documentazione sono altrettanto ignote sono le origini di Bisignano
sede vescovile. Secondo l'arcidiocesi Cosenza-Bisignano, è attendibile
l'ipotesi che stabilisce che la diocesi di Bisignano sia stata istituita a
cavallo dei secoli VII e VIII, subentrando a quella di Thurii, di cui noi si
hanno più notizie dal 680. Il primo vescovo che risulta da un documento
ufficiale del 743 è Auderamus, il quale partecipa al sinodo convocato a Roma da papa
Zaccaria nel 745. Niceforo
II Foca, imperatore bizantino, nel 963 riconquisto la Calabria scacciando
i Longobardi dalla
valle del Crati imponendo il rito Bizantino anche alla Diocesi di Bisignano. Ma
già nel 983, papa
Benedetto VII la assegna alla metropolia di Salerno, come risulta
dalle bolle papali del 986 e del 1058. La posizione però è contraddittoria
fino all'XI secolo in quanto per le fonti greche Bisignano dipende da Reggio
Calabria, mentre per quelle latine da Salerno.
Secondo
l'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, Bisignano era il confine tra il dominio
longobardo e quello bizantino e quindi, molto probabilmente, non era soggetta a
nessuna di esse. Dopo il concordato
di Melfi, periodo normanno, la diocesi di Bisignano è ricordata nel Liber
Censum della Chiesa di Roma come "Domini Papae", ovvero era
soggetta direttamente alla Sede Apostolica. Notizie più precise circa i confini
e i possedimenti della Diocesi si hanno dal momento in cui fu redatta, da parte
del vescovo Ruffino, la Platea, dalla lettura della quale emerge la presenza in
Bisignano di monasteri Basiliani e latini, chiese parrocchiali, rurali e luoghi
culturali, menzionati successivamente in numerosi documenti ecclesiastici i
quali dimostrano un'intensa e continua vita religiosa. Nel 1806 furono
espropriate le terre ecclesiastiche in Bisignano e nel 1809 furono soppressi i
Monasteri dei Domenicani, dei Cappuccini, dei Conventuali, dei Paolotti, dei
Riformati e il Terz'Ordine dei Santa Maria delle Grazie. Nel 1818 la Diocesi di
Bisignano è stata unita a quella di San Marco Argentano e nel 1979 è stata
definitivamente unita all'arcidiocesi di Cosenza.

Durante
la dominazione longobarda (568-774),
venne nominato Anderamo vescovo di Bisignano.
Il
cronista Colaniello Pacca annota che nel 1026 Bisignano fu assediata, presa,
profanata e saccheggiata dai Saraceni che venivano dalla vicina Sicilia.
La
città era Comune nel 1061 guidata
"dai consigli" di Pietro De Turra (fatto prigioniero da Roberto
Guiscardo per ottenere la resa della città).
Nel
1056 Bisignano, Cosenza e quasi tutta la Calabria Citra furono costrette a
pagare un tributo e prestare servigio ai Normanni grazie ad un'astuzia di
Roberto D'Altavilla, detto, dopo questo episodio, il Guiscardo. Sotto le mura di
Bisignano Roberto D'Altavilla chiama a colloquio Pietro Turra, ricchissimo
signore di quella città, per risolvere alcune questioni sorte tra i Bisignanesi
e i Normanni che vivevano nella vicina San Marco. Mentre i due signori
discorrevano sotto gli occhi dei Bisignanesi da un lato e i Normanni dall'altro,
Roberto, con un movimento repentino, afferra Pietro, di forme smisurate, a metà
del corpo e se lo mette in spalla correndo verso i suoi uomini. I Bisignanesi,
colti di sorpresa corrono verso Roberto D'Altavilla per liberare Pietro Turra
arrivando ad azzuffarsi con i Normanni, e mentre questi si azzuffano, Pietro
invano si sforza, con i piedi e con le mani, di divincolarsi. Roberto lo
attanaglia sempre più, ora rotolandosi sul terreno, ora spingendolo alla
meglio, ora trascinandolo, riesce a farlo prigioniero. Pietro Turra ottenne la
libertà solo dopo aver pagato un riscatto di 20.000 scudi.
Bisignano
fu dominio dei Normanni e
nel 1400 feudo dei Ruffo di Catanzaro.
Nel 1461 con
Luca Sanseverino, figlio di Antonio Duca di San Marco, ha inizio la dinastia dei
Principi di Bisignano e la città diviene capoluogo del principato fino ai primi
del XIX secolo oltre
che protagonista delle alterne vicende legate alla fortuna militare e politica
del casato dei Sanseverino.
Nel 1508 furono
gli Aloise a regnare su Bisignano dopo una battaglia contro i Sanseverino e
proprio quest'ultimi vennero spodestati sia da San Marco che da Bisignano; il
regno degli Aloise durò 21 anni, a capo del regno ci fu Francesco Aloise, nel 1529 i
Sanseverino si ripresero Bisignano e San Marco, gli Aloise riuscirono a fuggire
e si recarono verso Catanzaro.
 La
città di Bisignano fu governata da una florida aristocrazia facente parte di un
Seggio o Sedile chiuso, cioè del quale si poteva entrare a fa parte solo con il
consenso unanime di tutti gli altri componenti del Seggio stesso. Tale Seggio
era preesistente all'infeudamento alla Famiglia Sanseverino, poiché risalente
al 4 gennaio 1339, con privilegio di Re Roberto d'Angiò confermato da Giovanna
I e da Ladislao. La
città di Bisignano fu governata da una florida aristocrazia facente parte di un
Seggio o Sedile chiuso, cioè del quale si poteva entrare a fa parte solo con il
consenso unanime di tutti gli altri componenti del Seggio stesso. Tale Seggio
era preesistente all'infeudamento alla Famiglia Sanseverino, poiché risalente
al 4 gennaio 1339, con privilegio di Re Roberto d'Angiò confermato da Giovanna
I e da Ladislao.
Nell'atto
di ricostituzione dei capitoli del Seggio del 2 aprile 1645 per Notaio Giovan
Tommaso Oliverio (n. 215, Vol. 13, fol. 10, conservato presso l'Archivio di
Stato di Cosenza) sono presenti i rappresentanti delle seguenti famiglie, alcune
ancora esistenti: Acervo, Alitto, Aloise (o Loise), Caro Caruso, Catapani,
Cosentini, Fasanella, Fede, Ferraro, Gaeta, Gioppa, Granata, Herrico, Laymo,
Loe, Longo, Luzzi, Maldotto (o Maddotti), Pisa, Rende, Ripulo, Rodà, Rosa,
Rossi, Russo, Solima, Trentacapilli, Valle, Ventre, Zazzo. Con atto del 27
aprile 1672 per Notar Muzio Verderame (n. 254, Vol. 8, fol. 7, presso l'Archivio
di Stato di Cosenza), si aggiunsero le famiglie Rogliano e Boscarelli.
Infine,
con atto del 14 gennaio 1721 per Notar Marzio Castagnaro (n. 107, presso
l'Archivio di stato di Cosenza) venne ammessa al Sedile di Nobiltà la famiglia
Gallo. Il Governo da parte del Seggio dei Nobili cessò con la legge napoleonica
di eversione della feudalità, il 2 agosto 1806. Delle predette famiglie
risultano tuttora sicuramente esistenti le seguenti: Loise, Fasanella e di
Fasanella d'Amore, Rende (anche detta Rende Altomonte) e Rende Granata, Solima,
Trentacapilli, Boscarelli.
I
rovinosi terremoti ed
in particolare quello del 1887 portarono
alla distruzione di gran parte del cospicuo patrimonio monumentale della città.
La diocesi di Bisignano vanta tradizioni storiche millenarie: fu eretta
probabilmente tra il VII e
l'VIII secolo.
Nel X secolo apparteneva
alla provincia
ecclesiastica dell'arcidiocesi
di Reggio Calabria e adottava il rito
bizantino. Nel XIII
secolo la diocesi, ben definita nei suoi confini, vantava una
numerosa presenza di chiese e conventi. Nel 1818 la
diocesi fu unita a quella di San
Marco Argentano, mentre dal 1979 è
stata unita a quella di Cosenza. Il patrimonio artistico e culturale di
Bisignano è particolarmente interessante ed è concentrato nel centro storico,
tra i quartieri di: Piazza, Piano, Giudecca, San Simone, Santa Croce, San
Zaccaria, San Pietro e Cittadella.
Visitare
il borgo
Bisignano
ha una storia ricchissima e secolare, che si snoda sinuosa tra l'intrico di
vicoletti, archi e scalinate che si snodano nel centro storico, facendo da
scenari agli splendidi palazzi patrizi e alle numerose chiese, traccia
indelebile di una cultura antichissima. Gli otto quartieri che la compongono
sono ricchi di numerose botteghe artigiane sempre aperte e in attività, che
testimoniano la grande operosità del borgo e l'indubbio valore artistico della
produzione artigianale locale. Bisignano ha dato i natali ad una delle più
grandi famiglie di liutai del mondo, i De Bonis, e ospita attualmente i
laboratori dei discendenti diretti della famiglia oltre che altre botteghe
ispirate alla produzione di strumenti a corda rinomati a livello internazionale.
Nella città di
Bisignano sono presenti più di 15 Chiese: la chiesa concattedrale, il santuario
di Sant'Umile, la chiesa di San Domenico, la chiesa di San Francesco, la chiesa
dell'Immacolata, la chiesa di Santa Maria del Popolo, la chiesa di Santo
Stefano, la chiesa dei Cappuccini, la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli,
la chiesa di San Pietro, la chiesa di Santa Maria de Justitieris, la chiesa di
Sant'Andrea, la chiesa di San Bartolomeo, la chiesa della Pietà detta della
Conicella, nonché una seconda omonima chiesa dedicata alla pietà e una recente
chiesa dedicata a san Tommaso apostolo.
Santuario
di Sant'Umile

Il santuario di
Sant'Umile, conosciuto come “Convento la Riforma”, fu
fondato tra il 1219 e il 1222 (1221 e 1264 secondo altre fonti) da Pietro
Cathin, inviato in Calabria da San Francesco d’Assisi a diffondere l’Ordine
Francescano: il convento porta il titolo di San Francesco
Stimmatizzato o San Francesco alla Verna.
La tradizione
vuole che nei primi anni abbiano dimorato in questo convento due tra i SS. VII
Martiri calabresi che danno il nome anche alla Provincia dei Frati Minori di
Calabria.
Nella metà del
'400 vi dimorano i Minori Osservanti che lasceranno il posto ai Minori Riformati
verso alla fine del '500.
Dopo la
soppressione degli ordini religiosi da parte dello Stato Italiano, avvenuta
nella seconda metà del XIX secolo, il convento ebbe un periodo di abbandono che
durò fino a quasi il dopoguerra, quando i Frati Minori ricominciarono, con
grandi sacrifici, a restaurarlo. In questi ultimi anni è stato ulteriormente
restaurato, riportandolo all’antico splendore.
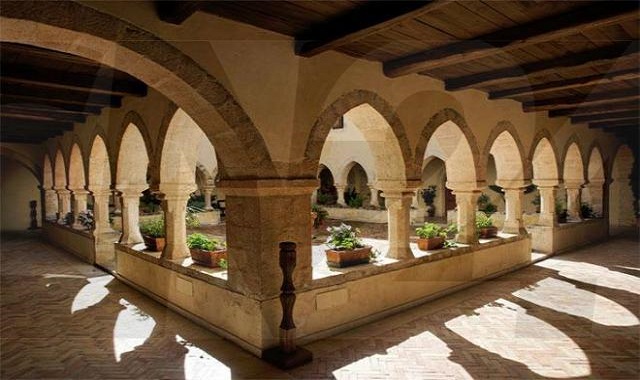 Il
portale, che risale al XV secolo è sormontato dallo stemma dei Principi
Sanseverino e dal monogramma cristologico di San Bernardino
da Siena, conduce nella navata centrale la quale culmina nell'abside, su
cui è posta la scultura lignea di Gesù Crocefisso, opera di frate Umile
da Petralia e risalente al 1637 (anno della morte di sant'Umile).
All'interno del convento si trova una scultura marmorea raffigurante la Madonna
delle Grazie, attribuita alla scuola di Antonello
Gagini (1537), e un dipinto su tela raffigurante il Martirio di
san Daniele
Fasanella a Ceuta,
opera di un ignoto pittore napoletano della scuola di Luca
Giordano. Il
portale, che risale al XV secolo è sormontato dallo stemma dei Principi
Sanseverino e dal monogramma cristologico di San Bernardino
da Siena, conduce nella navata centrale la quale culmina nell'abside, su
cui è posta la scultura lignea di Gesù Crocefisso, opera di frate Umile
da Petralia e risalente al 1637 (anno della morte di sant'Umile).
All'interno del convento si trova una scultura marmorea raffigurante la Madonna
delle Grazie, attribuita alla scuola di Antonello
Gagini (1537), e un dipinto su tela raffigurante il Martirio di
san Daniele
Fasanella a Ceuta,
opera di un ignoto pittore napoletano della scuola di Luca
Giordano.
Naturalmente è
possibile visitare la cella di sant'Umile
da Bisignano, che oltre a custodire varie reliquie del santo, conserva un
dipinto del XVIII secolo, a lui dedicato.
La cappella
dedicata a sant'Umile risale all'anno della sua beatificazione, 1882, anno cui
è databile anche la prima statua lignea del santo. Dalla chiesa si accede al
chiostro duecentesco. Su una colonnina vi è incisa la data di fondazione del
convento (1222).
Oltre al santuario è
possibile visitare il museo, la biblioteca e la cella di Frate Umile da
Bisignano (1582-1637), che oltre a custodire le reliquie del Santo, conserva un
dipinto su tela a lui stesso dedicato, della seconda metà del XVIII secolo.
L’attuale
cappella dedicata a Sant'Umile da Bisignano risale alla data della sua
beatificazione, 1882, anno cui è databile anche la prima statua lignea del
Santo.
Concattedrale
di Santa Maria Assunta (Duomo)

La concattedrale
di Santa Maria Assunta è il principale luogo di culto della città.
La cattedrale
è intitolata a santa Maria Assunta e presenta forme architettoniche tipiche del
periodo normanno. Sulla facciata è inserito un portale a sesto acuto in pietra,
eseguito da maestranze del vicino monastero cistercense della Sambucina. I
molti terremoti hanno danneggiato la cattedrale che, prima dei rifacimenti,
presentava una facciata con tre porte che immettevano nelle navate interne,
sullo stesso stile della cattedrale di Cosenza.
L'interno è in
tre navate terminanti con tre absidi. La navata centrale presenta decorazioni a
tempera raffiguranti scene della vita della Madonna e di Cristo, eseguiti negli
anni trenta dal pittore Emilio Iusi da Rose. Sull'abside centrale,
originariamente affrescata con scene dell'Assunzione di Maria, è stato
aggiunto, durante l'episcopato del vescovo Rinaldi (1956-1977), un mosaico
raffigurante l'Immacolata Concezione. Al culmine dell'abside laterale destra
troviamo la cappella del Santissimo Sacramento all'interno della quale, sono
presenti in bassorilievi, figure tratte della Disputa del Sacramento di Raffaello,
riproduzione attribuita allo stesso Iusi.
Sull'altare
maggiore, fatto costruire dal vescovo Pompilio Berlingieri, vi erano dei
marmi policromi, che sono stati trafugati. Il pulpito marmoreo, commissionato
dal vescovo Antonio Pistocchi, risale alla seconda metà dell'Ottocento, mentre
il fonte battesimale, posto all'ingresso, nella navata laterale destra, risale
all'XI-XIII secolo. Esso è costituito da una grande conca in pietra poggiata su
due capitelli, parti dell'antica cattedrale normanna.

All'interno è
conservata la statua di santa Lucia con alcuni ex-voto in argento, cui
segue, nella navata destra, la Madonna dei Sette Veli. Nella navata laterale
sinistra sono visibili la statua del Sacro Cuore di Gesù, un crocifisso ligneo,
la statua della Madonna delle Grazie, quella di san Vincenzo De Paoli e,
nell'abside di sinistra, la statua dell'Addolorata.
La biblioteca
Fu costruita dal vescovo Bonaventura
Sculco nel 1765,
in cui fece confluire parte del patrimonio librario di famiglia, ammontante a
circa 2.000 volumi. A ricordo della sua fondazione, fu posta una lapide
realizzata da Giuseppe Galzerano di Catanzaro, attualmente posta all'ingresso
dell'ex seminario diocesano di Bisignano. Conserva tuttora alcune antiche
pergamene in carta pecora e numerosissimi processetti matrimoniali risalenti
all'epoca in cui Bisignano era diocesi autonoma.
Madonna dei
Sette Veli - Luigi Falcone, nel libro La pietà popolare in Italia,
racconta che a Bisignano la Vergine è venerata sotto i due titoli della Madonna
dei sette veli e dell'Addolorata, il cui culto è stato
importato da Foggia, dal monsignor Vincenzo Ricotta, vescovo di Bisignano dal
1896 al 1909. Il primo titolo si spiega col fatto che, secondo la leggenda, dei
veli avvolgevano il quadro quando fu ritrovato in un canneto, nello stesso luogo
dove, poi, fu edificata Foggia. Questo quadro è la copia di quello che si
conserva nella cattedrale
di Foggia.
Santa
Maria di Costantinopoli

L'antica
chiesetta di S. Maria di Costantinopoli, detta anche "‘A
Marunnella", si chiama così perché si riteneva che la primitiva immagine
venisse da Costantinopoli. Nel documento redatto dal vescovo Ruffino, la Platea,
nel XIII secolo, risulta essere stata Posita intus civitatem Bisiniani, loco ubi
dicitur li pignatari.
Tale
costruzione presenta nel registro inferiore della facciata il motivo della
successione di tre arcate: quelle laterali sono cieche, mentre quella centrale
è "sfondata" dall'apertura rettangolare del portone d'ingresso.
Questo piano visuale principale è sormontato, nel registro superiore, dalla
cornice dentellata, cui si sovrappone il timpano, sulla sommità, caratterizzato
da una serie di nove arcatelle cieche, di altezza variabile digradante, che
richiamano le tre arcate maggiori sottostanti.
I due
cantonali, ben rilevati e sagomati, trasmettono un'immagine di forza e
delimitano i margini della visione frontale, nel suo complesso di estrema
semplicità e linearità.
Chiesa
di San Domenico

La
Chiesa di San Domenico fu
eretta, insieme al convento dei domenicani nel 1475 e fino alla soppressione
degli ordini monastici, imposta dal governo francese nel 1807, fu parte
integrante del monastero.
 L’impianto
originario fu completamente distrutto durante dal terremoto del 1887 e
l'attuale chiesa fu ricostruita tra il 1910 e il 1962. L’impianto
originario fu completamente distrutto durante dal terremoto del 1887 e
l'attuale chiesa fu ricostruita tra il 1910 e il 1962.
L’attuale
facciata è in stile gotico-romanico ed è stata realizzata su tre livelli: nel
primo livello è presente un grande portale con arco a sesto acuto affiancato da
due nicchie, sempre ad arco a sesto acuto, e quattro lesene di ordine tuscanico;
il secondo livello presenta nella parte centrale un’interessante bifora, ai
lati sono presenti quattro false colonne che racchiudono due nicchie laterali
simili a quelle del livello precedente, ma meno elaborate; nel terzo livello è
presente il timpano, nella parte centrale, e il campanile, sul lato destro.
Chiesa
di San Francesco da Paola
La
chiesa di san Francesco da Paola in Bisignano venne probabilmente fondata nei
primi anni del 1500 da Berardino I Sanseverino, terzo principe di Bisignano,
nei pressi di un antico oratorio che sorgeva nella contrada santa Maria di
Coraca. Lo stesso principe conobbe personalmente san Francesco in Francia,
alla corte di Luigi XII.
I
rapporti fra san Francesco e i Sanseverino erano intensi già da molti anni:
il principe di Bisignano e sua moglie erano stati nominati dal santo quali
Procuratori Generali dell'Ordine dei Minimi nel 1482, per aver favorito la
diffusione dei Paolotti nei loro feudi contribuendo alle spese per la
costruzione di chiese e conventi. Con questa nomina san Francesco volle
renderli partecipi dell'indulgenza plenaria da ottenersi una volta l'anno,
concessa dai Papa all'Ordine dei Minimi. La chiesa venne distrutta una prima
volta dal terremoto nel 1638, ricostruita nel 1669 e subì altri rifacimenti
dopo ì terremoti dei secoli successivi. Del convento annesso alla chiesa si
sa che venne ricostruito in stile tardo-barocco nel XVII secolo. Ad oggi sono
visibili sul retro della chiesa i resti del chiostro in stile
romanico-rinascimentale con al centro il pozzo.
Il
portale, finemente lavorato, è realizzato in pietra, su cui è presente la
scritta in latino: Portam hanc fieri fecit Scipio Longo.
All'interno
della chiesa, nella terza cappella a sinistra, è custodita l'immagine di
santa Maria di Coraca, realizzata in pietra tufacea e risalente al XV secolo.
Secondo le fonti proviene da un antico oratorio appartenente ai Sanseverino e
fino al 1630 ne è documentata la collocazione sull'altare maggiore.
Probabilmente venne spostata nella posizione attuale agli inizi del '900.
Sulla sua origine non si hanno notizie certe: pare che sia stata rinvenuta in
una grotta eremitica nei pressi della chiesa e che abbia dato il nome prima
alla contrada e poi al convento dei Minimi. La grotta viene citata in modo
piuttosto vago dalle fonti, che riferiscono che si trova nella vallata
sottostante la chiesa e accennano alla presenza di una croce greca incisa
sulla parete.
L'immagine,
che rappresenta la Madonna intenta ad allattare il Bambino, misura 50x20 cm e
viene considerata di stile bizantineggiante. Essa è inserita in una
composizione pittorica risalente al XVIII secolo e funge da pala d'altare
nella cappella che era dei principi Sanseverino. L'altare in pietra della
cappella, già gravemente danneggiato, è endato distrutto negli anni '80 del
secolo scorso.

Quella
che attualmente è detta chiesa di san Francesco da Paola, un tempo era
intitolata a santa Maria di Loreto e rappresentava uno dei tre conventi della
Provincia di Calabria intitolati alla vergine. La chiesa e il convento sorsero
nei pressi di un antico oratorio dedicato a santa Maria di Coraca, di proprietà
dei Sanseverino, fuori dal borgo di Piano. Impropriamente una relazione del
1650 intitola la chiesa a santa Maria di Coraca riportando quanto detto da
mons. Perbenedetti nella visita apostolica del 1630.
Probabilmente
solo il convento era intitolato a santa Maria di Coraca mentre la chiesa era
intitolata a santa Maria di Loreto, ma poiché O ill'altare maggiore era posto
l'affresco quattrocentesco della Madonna di Coraca si diede un titolo
improprio alla chiesa. Inoltre, mons. Perbenedetti visitò gli altari della
chiesa: l'altare maggiore risulta esser posto al cospetto della porta
maggiore, sul quale è collocata l'icona raffigurante la vergine di Coraca e
antecedente alla costruzione della chiesa. È la stessa che attualmente si
venera sul terzo altare a sinistra. Gli altri quattro altari erano intitolati
a san Francesco da Paola, a santa Maria del Monte Carmelo, a santa Maria degli
Angeli e al Santissimo Crocefisso.
Ora,
però, è difficile stabilire quale fosse l'esatta ubicazione degli altari
ricordati rispetto alla planimetria della chiesa quale oggi appare. Mons.
Perbenedetti ci informa ancora che attraverso il coro monastico si accedeva
alla sagrestia nella quale erano posti due altari in legno. Nel medesimo
ambiente fu sepolto il corpo di Pietrantonio Sanseverino, IV Principe di
Bisignano, morto a Parigi nel 1559 e ricondotto nella sua Bisignano per
rispettare le sue volontà. Secondo la descrizione del 1650 la chiesa risulta
finita, mentre nel convento si dovevano terminare due dormitori e
un'infermeria.

Tra
i diversi dipinti che si possono ammirare nella chiesa di san Francesco,
troviamo, sul primo altare a destra una tela raffigurante L'Immacolata, san
Vito e santa Lucia. Probabilmente questa è un'opera di Giovanni Pellicori. La
tela sembra avvicinarsi allo stile del dipinto presente sul secondo altare a
destra, sempre attribuibile a Pellicori: si tratta della rappresentazione de
La Madonna della Neve, san Francesco di Sales e san Nicola da Longobardi
(1786).
Secondo
quanto narrato da vari autori cristiani, un ricco patrizio che viveva a Roma,
durante la notte del 4 agosto 352 d.C. avrebbe visto in sogno la Vergine Maria
che chiedeva di costruire una basilica nel luogo dove il mattino seguente
avesse trovato della neve fresca. Costui, la mattina seguente, corse da papa
Liberio per raccontargli quanto visto e il pontefice confessò di aver avuto
la stessa visione. Il prodigio nel frattempo si era avverato e per ordine di
Liberio si fece tracciare la pianta di una grandiosa basilica esattamente dove
cadde la neve di agosto. Sempre secondo la storia, la basilica sarebbe stata
finanziata dal patrizio stesso e prese il nome di Basilica di Santa Maria
della Neve. La sua memoria liturgica cade il 5 agosto. La figura di san Nicola
è stata dipinta in epoca successiva all'esecuzione dell'opera (sicuramente
settecentesca) e sovrapposta ad una originaria figura che pare debba
identificarsi con san Carlo Borromeo, in coppia, nell'iconografia di quegli
anni, con san Francesco di Sales.
Nel
1862 è stata realizzata la tela raffigurante il beato Gaspare de Bono, minimo
spagnolo che prega dinanzi al Crocifisso. Si attribuisce la paternità di
quest'opera a Raffaele Barone, attivo a Castrovillari dal 1827 ai 1861.
Possiamo ammirare questa tela nel primo altare a sinistra.
Il
quadro del secondo altare a sinistra, invece, raffigura san Michele Arcangelo
che schiaccia i demoni; infatti, l'arcangelo Michele è ricordato per aver
difeso la fede in Dio contro le orde di Satana. Questa tela è opera di
Francesco Bruno di Cosenza ed è datata 1759.

A
seguito del terremoto del 3 dicembre 1887 anche la chiesa di san Francesco subì
dei danni: la cupola ellittica cadde durante la seconda scossa, ma il tetto
resistette.
In
questa triste occasione, ancora una volta, il popolo bisignanese mantenne viva
la fede verso il suo santo patrono e fu proprio dopo questo episodio che la
statua lignea del santo venne spostata dalla nicchia laterale dove si trovava
(quella che adesso è dedicata all'Immacolata) all'altare maggiore.
I
25 morti durante il terremoto del 3 dicembre furono I primi a essere
seppelliti nel cimitero di Bisignano, che era in costruzione nell'orto dei
padri Cappuccini, i quali avevano lasciato la città da pochi mesi. Per far
fronte all'emergenza, un decretato impediva che i seppellimenti potessero
avvenire nelle chiese di Bisignano. Nonostante l'ordinanza, non mancarono
resistenze classificate dalle cronache dell'epoca come episodi di fanatismo
religioso. Si racconta, infatti, che l'allora parroco don Giacomo Capocasale,
non curandosi delle disposizioni date, fece correre voci che avesse avuta una
visione del santo con le ginocchia nere dalle preghiere, fatte per implorare
le grazie divine in Bisignano, e invitò i fedeli ad accorrere in chiesa per
il giorno di venerdì 6 gennaio 1888 a recitare le litanie e incitare allo
sgombero delle macerie. Lo stesso sacerdote, si sacconta, pare abbia cercato
di indurre al seppellimento dei cadaveri nella fossa posta nel piazzale delta
chiesa di san Francesco anziché nel cimitero comunale.
San
Francesco da Paola fu scelto protettore della città già nel furioso terremoto
del 14 luglio 1767 insieme a s. Giuseppe, s. Domenico, s. Antonio da Padova e s.
Filippo Neri. È rimasto patrono della città fino al 13 maggio 2015 quando
l'arcivescovo Salvatore Nunnari ha dichiarato sant'Umile patrono di Bisignano.

L'attuale
statua lignea di san Francesco, posta sopra l'altare maggiore della chiesa,
venne fatta realizzare dal Seggio dì Nobiltà di Bisignano. Il 28 settembre
1788, infatti, come risulta dai verbali, veniva stabilito di fare costruire una
nuova statua del protettore san Francesco, in ottimo legno e più leggera di
quella esistente per facilitarne il trasporto in processione. Quella che noi
oggi conosciamo, dunque, non è la stessa statua cui faceva riferimento mons.
Perbenedetti nella sua relazione del 1630.
Il
bastone d'argento che adorna la statua nelle solennità, fu fatto fondere a
Napoli da Pasquale Barone. Questi, per devozione, fece dono al santo del bastone
per avergli salvato la vita a causa di una ferita alla mano sinistra, riportata
anni prima in un duello. La memoria locale tramanda che il gentiluomo fu
coinvolto nello scontro per conquistare la mano di un'avvenente fanciulla
partenopea.


La
navata unica della chiesa paolotta di Bisignano, 27x10 metri circa, è
delimitata e conclusa, in altezza, dal controsoffitto ligneo a cassettoni (o
lacunari). Di esso si ha già traccia nei primi decenni del XVII secolo, come
emerge dalla relazione della visita apostolica alla Diocesi di Bisignano del
vescovo Perbenedetti nel 1630.
Al
centro del manufatto ligneo, ad interruzione delia fitta sequenza delle cavità
dei cassettoni, è stata successivamente inserita la tavola con l'immagine
dell'iconografia classica di san Francesco da Paola, con il saio marrone scuro
simile a san Francesco d'Assisi, barba corta e un bastone alla cui estremità è
un cartiglio con la scritta Charitas, datata 1719. Questa datazione sarebbe
coerente con l'ipotesi di successivi interventi di restauro e completamento,
eseguiti tra la fine del 1600 e la prima metà del 1700, da cui deriverebbero le
forme di matrice barocca attuali, nella ridondanza di stucchi e decorazioni a
corredo degli altari e dei paramenti murari e nella stessa copertura
cassettonata dell'aula sacra. Le forme geometriche di riferimento, per la base
delle cavità dei 98 cassettoni di cui si compone il soffitto della chiesa, sono
il rettangolo e il rombo, quest'ultimo a correre lungo tutto il perimetro del
soffitto, incorniciandolo e sottolineando la ricchezza dei motivi formali
decorativi che ne completano la manifattura.
Il
soffitto ligneo cassettonato, fortemente degradato e compromesso nella sua
integrità materiale, è stato oggetto di importanti interventi di restauro
negli anni '80 e restituito al nostro sguardo nel 1990, in occasione della
celebrazione del 475° anniversario della fondazione della chiesa e del convento
dei Minimi di Bisignano.

-
Chiesa dell'Immacolata
-
Chiesa di Santa Maria del Popolo
-
Chiesa di Santo Stefano, la chiesa dei Cappuccini, la chiesa di San Pietro
-
Chiesa di Santa Maria de Justitieris
-
Chiesa di Sant'Andrea
-
Chiesa di San Bartolomeo
-
Chiesa della Pietà detta della Conicella
Numerosi
sono i palazzi nobiliari di grande interesse storico-architettonico che
arricchiscono i quartieri del centro storico. Passeggiare lungo le vie del paese
è un meraviglioso tuffo nel passato, a contatto diretto con un mondo carico di
cultura e tradizione, passato indenne dal trascorrere del tempo per mostrarsi
agli occhi meravigliati dei visitatori.
Attività
artigianali
Fra le attività
artigianali che un tempo erano svolte nella città e che in qualche modo sono
sopravvissute all'evoluzione tecnologica, sono degne di nota le arti della liuteria,
le lavorazioni del ferro e
quelle della ceramica e
delle terrecotte.
Nel settore
degli strumenti musicali merita una citazione particolare la "chitarra
battente", di origini antichissime, che è considerato lo strumento
caratteristico calabrese.
Tradizioni
e folclore
Nonostante la
soppressione del convento dei Minimi, ad opera dei Francesi (1809), a Bisignano,
il culto e la devozione a san Francesco
di Paola si sono mantenuti vivi. Il santo è festeggiato non solo il 2
aprile, ma anche il 14
luglio, per ricordare la protezione accordata agli abitanti in occasione
del terremoto del 1767.
In caso di
prolungata siccità o di poggia torrenziale, è invocato dai membri delle
confraternite del Rosario e dell'Immacolata Concezione con la pia pratica del trivulu ("lamento").
Trattasi di una pratica penitenziale, analoga a quella dei flagellanti, che dura
tre giorni. Durante il "trivulu" la statua di San Francesco
di Paola viene prelevata dalla chiesa di appartenenza e portata presso la
cattedrale, dove viene tenuta in ostaggio finché non si ottiene la pioggia.

Fonte:
|