|
Paola è
il più grande centro del Tirreno
Cosentino, nota per essere la Città di San
Francesco: Santo
della Cristianità, Patrono della Calabria e della Gente di Mare.
È una nota
meta turistico-balneare, visitata annualmente da migliaia di turisti che
scelgono Paola per le sue spiagge e
per il suo patrimonio storico-architettonico-religioso, come: il Santuario
di San Francesco, la Chiesa
del SS. Rosario, la Chiesa
di Montevergine, la Chiesa
Ipogea di Sotterra, l'Arco di San Francesco, la Torre
del Castello, la Fontana
Monumentale "dei Pisciarieddi", la Fontana
Monumentale dei Sette Canali, la Badia, il Duomo
(Chiesa della SS. Annunziata), la Chiesa
di San Michele Arcangelo e molti altri.
Dal 2021 Paola
è la Città dell'Olivo
Bianco.
STORIA
- La documentazione sull'origine del nome
dell'odierna città di Paola è piuttosto scarna e compare sul finire dell'XI
secolo, quando viene menzionato il tenimentum Paulae all'interno dei
possedimenti del notabile normanno Roberto Bohon di Fuscaldo.
A partire dalla
metà del XVI secolo, numerosi eruditi hanno tentato di risalire all'origine del
nome della città. Fra
questi, il primo fu il sacerdote Gabriele Barrio il quale, sulla scorta
dell'opera dello storiografo Stefano Bizantino (che riprendeva, a sua volta,
Ecateo di Mileto), identificò, per assonanza con il moderno toponimo, l'antico
insediamento enotrio di Patycos con la città di Paola.
- Con la
conquista romana della Calabria,
un console romano di nome Lucio
Emilio Paolo stabilì la propria residenza nella città calabrese.
Da qui deriverebbe il nome Paola.
- Nella lingua
latina la parola Pabula vuol dire terra da pascolo. Da alcuni
documenti importanti si è appreso che Paola era un casale di Fuscaldo,
amministrato dai marchesi Spinelli
di Fuscaldo. Il suo territorio, ricco di vegetazione, era usato
soprattutto per il pascolo degli animali.
Tra queste
ipotesi la più accreditata dagli storici è proprio quest'ultima, che a
differenza delle altre due è avvalorata da testimonianze storiche.

Tra il IV e il
III secolo a.C., il territorio di Paola ricadeva, con buona probabilità, nel
comprensorio rurale dell'oppidum brettio di Clampetia, che recenti
studi hanno identificato con il centro storico dell'attuale comune di San
Lucido. Qui, infatti, nel corso dei lavori per il rifacimento della
pavimentazione della Chiesa dedicata a S. Giovanni Battista alla fine degli anni
'80, furono scoperti i resti di un abitato ellenistico composto da alcuni vani
abitativi con funzioni produttive, tra cui spiccavano numerosi pesi da telaio e
i resti di una fornace per la produzione di manufatti ceramici databili al
medesimo periodo. Sulla base degli studi condotti nel territorio di San Lucido,
anche quello di Paola doveva essere costellato di piccole fattorie produttive
legate alla coltivazione dell'olivo e della vite, favorite dalle condizioni
geomorfologiche. Deboli tracce di questa presenza sono attestate dal
rinvenimento di ossa e frammenti ceramici recuperati durante scavi archeologici
condotti nel cortile del complesso monastico di Badia Luta, in occasione dei
lavori di restauro occorsi alla fine degli anni '90.
Successivamente Clampetia,
insieme ad altri centri bretti della regione, prese parte al secondo conflitto
romano-cartaginese, venendo infine conquistata negli ultimi anni dello stesso
conflitto. La vittoria di Roma sui cartaginesi segnò la fine dell'indipendenza
politica dei populi indigeni della Calabria e la scomparsa delle
fattorie.
L'influenza
romana avviò presto un imponente processo di ristrutturazione agricola delle
campagne calabresi e nuove coloniae furono fondate per controllare i
nuovi territori assoggettati. Sui fertili terrazzi costieri di tutta la regione
furono edificate numerose villae, dotate di ricche residenze con bagni o
terme (pars urbana) per il dominus e la sua familia, di alloggi
per i dipendenti e gli schiavi (pars rustica ed ergastula), di
impianti per la trasformazione e grandi magazzini lo stoccaggio delle derrate
agricole (pars fructuaria e horrea).
Una di queste
grandi villae è stata scoperta nei primi anni '80 in contrada Cutura,
alla periferia nord di Paola. L'edificio, ancora oggi parzialmente conservato e
quasi del tutto inesplorato, occupa la sommità di un terrazzo costiero che si
eleva alcune decine di metri sul livello del mare. Le strutture della villa poggiano
su un'imponente sostruzione in muratura realizzata per regolarizzare il pendio
naturale del medesimo terrazzo (basis villae), con la pars urbana affacciata
sul mare e il cui paramento esterno era intramezzato da una serie di nicchie che
dovevano ospitare un ciclo di statue, rendendo il complesso ancora più
maestoso. La pars urbana contemplava anche un bagno (balneum) o un impianto
termale privato, a giudicare dalle numerose suspensurae rinvenute nel
sito.
Sul versante
interno del terrazzo costiero, verso le colline circostanti, si trovava
probabilmente la pars fructuaria della villa, con impianti per la
lavorazione delle olive e dell'uva, come documentato dai numerosi frammenti di
macine in pietra vulcanica e un frammento di pressa litica per la pigiatura
rinvenuti, nonché le numerose anfore da trasporto prodotte in loco ed emerse da
piccoli saggi di scavo effettuati nel 2002 dalla Soprintendenza Archeologica
della Calabria.
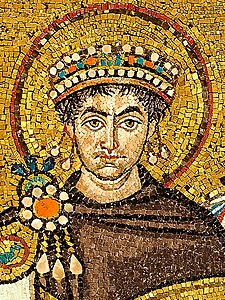 Nel 395 con
la morte dell'imperatore Teodosio ci
fu la scissione dell'Impero
romano, che fu diviso in due, Impero
romano d'Occidente e Impero
romano d'Oriente. Il primo fu affidato al figlio minore di Teodosio, Onorio;
il secondo al figlio maggiore dell'imperatore, Arcadio.
L'impero bizantino comprendeva parte dell'Italia
centrale, l'Italia
meridionale e l'Asia
minore, quindi anche il territorio di Paola diventò possedimento
bizantino, questo determinò anche il passaggio di queste zone al culto
ortodosso. Nel 395 con
la morte dell'imperatore Teodosio ci
fu la scissione dell'Impero
romano, che fu diviso in due, Impero
romano d'Occidente e Impero
romano d'Oriente. Il primo fu affidato al figlio minore di Teodosio, Onorio;
il secondo al figlio maggiore dell'imperatore, Arcadio.
L'impero bizantino comprendeva parte dell'Italia
centrale, l'Italia
meridionale e l'Asia
minore, quindi anche il territorio di Paola diventò possedimento
bizantino, questo determinò anche il passaggio di queste zone al culto
ortodosso.
Il regno di Giustiniano fu
segnato da una continua lotta per il predominio sul territorio italiano contro
gli Ostrogoti prima
e i Longobardi poi. Nel 536 i possedimenti bizantini erano ridotti all'Esarcato
d'Italia, alla Repubblica
di Venezia, al Ducato
di Napoli, alla Sardegna e
alla Corsica,
alla Sicilia e
al Ducato di
Calabria. Nei secoli successivi i bizantini si trovarono a fronteggiare
le invasioni di Arabi e Saraceni,
a seguito di queste invasioni la Sicilia cadde in mano araba e il Ducato di
Calabria fu costantemente flagellato dagli islamici. Proprio in questo periodo
la Calabria divenne l'angolo preferito del crescente monachesimo italo-greco, i
monaci, in seguito alla conquista araba della Sicilia, si trovarono costretti a
vivere in continuo pericolo, così la abbandonarono per stabilirsi in Calabria,
soprattutto lungo il versante tirrenico.
Nel territorio
di Paola monaci di S.
Basilio, in particolare dell'Ordine
Basiliano di San Giosafat fondarono due monasteri, uno nella località Badia,
consacrato a S. Maria della valle di Giosafat e delle Fosse, l'altro sul
versante nord del territorio, consacrato a S. Michele Arcangelo. Da
un'analisi architettonica, storica e rituale possiamo capire che siamo di fronte
ad un tipo di monastero denominato Laura. Questi centri religiosi avevano
una funzione di controllo sulla popolazione in collaborazione con il feudatario
locale, il potere religioso ed il potere costituito collaboravano per ottenere
il rispetto e la devozione che pretendevano dai cittadini per lo sviluppo della
società dell'epoca. Nell'anno 1110 la moglie del feudatario di Fuscaldo Roberto
de Bubum fece una donazione scritta ai monaci del monastero di S.Maria delle
Fosse. Grazie a questa donazione i monaci ottennero in concessione il
possedimento dove avrebbero poi eretto il monastero, un antico mulino ad acqua,
del bestiame e dei contadini per la lavorazione della terra. Con questa
donazione Sica (vedova di Roberto di Bubum) tentò di favorire l'opera dei
religiosi verso la popolazione, ottenendo, anche, l'obbedienza di questi.
Intorno all'anno
1000 d.C. a bordo dei possenti drakkar arrivarono
in Italia i Normanni,
un popolo di guerrieri provenienti dalla Scandinavia.

Essi erano
guidati da Guglielmo
d’Altavilla, detto braccio di ferro e da suo fratello Drogone.
In breve tempo questi condottieri tolsero ai bizantini il dominio dell'Italia
meridionale, iniziando dalla Sicilia. Nel 1050 arrivò
in Calabria Roberto
d’Altavilla, detto il guiscardo, raggiunto nel 1057 da
suo fratello Ruggiero.
I due iniziarono ad assediare le principali città della Calabria, trovando
dapprima l'opposizione del papato.
Nella battaglia
di Civitate l'esercito di volontari guidato da Leone
IX subì una disfatta totale e lo stesso pontefice fu catturato dai
Normanni. Con l'arrivo degli scandinavi tutte le diocesi ortodosse furono
convertite in diocesi cattoliche, così Papa
Niccolò II decise di stringere un'alleanza con i nuovi padroni del
meridione e nel 1059 a Melfi investì
solennemente Roberto il Guiscardo del titolo di ‘'Duca di Puglia, Calabria e
Sicilia'’. La città di Paola deve ai Normanni la costruzione del ‘'Castello
di Paola'’ intorno all'anno 1110
d.C. Questa roccaforte fu eretta usando malta e arenaria, in una
posizione strategica che sovrastava la città e aveva lo scopo di difendere
monaci e abitanti dai soldati che passavano attraverso il territorio paolano.
Durante il
regno di Federico
II di Svevia la Calabria raggiunse uno dei suoi momenti di maggiore
prosperità. Il sovrano aveva la sua residenza a Melfi,
in Basilicata. Egli fece costruire il castello e il Duomo
di Cosenza e la fortezza di Rocca
Imperiale sullo Ionio.
I calabresi rimasero sempre fedeli agli Svevi,
anche dopo la morte di Corradino
di Svevia ucciso per ordine di Carlo
I D'Angiò, che prese il potere a Napoli.
Anche Paola beneficiò di questo periodo prosperoso. La cittadina iniziò
progressivamente ad ingrandirsi fino a che, quando la Calabria passò dal
dominio Svevo a
quello Angioino divenne
feudo, e fu affidato alla famiglia Ruffo.
Nel 1418 Polissena
Ruffo sposò il duca
di Milano Francesco
Sforza, portando anche in dote il territorio Paolano. Polissena morì
avvelenata da uno degli zii nel 1420 senza
dare eredi al duca di Milano, Paola e gli altri paesi che aveva portato in dote
tornarono quindi alla sua famiglia. Il feudo di Paola fu portato nuovamente in
dote da Covella,
sorella minore di Polissena, quando sposò Giovanni Antonio Marzano. Dalla loro
unione nacque Marino
Marzano, che fu spogliato del feudo per aver congiurato contro il Re di
Napoli Ferrante
d'Aragona.
 Con
l'arrivo degli Aragonesi Paola
raggiunse lo status di Città,
fu proclamata tale da Ferdinando
II di Aragona. Durante lo sbarco, avvenuto nel 1283,
gli abitanti della contrada Fosse, per evitare di essere coinvolti negli
scontri, si trincerarono nelle zone limitrofe al Castello di Paola,
scombussolando gli equilibri che ruotavano intorno all'antica abbazia della loro
contrada. Il monastero andò incontro quindi ad un inevitabile declino,
nonostante il prodigarsi degli ultimi abitanti e dei monaci. Con
l'arrivo degli Aragonesi Paola
raggiunse lo status di Città,
fu proclamata tale da Ferdinando
II di Aragona. Durante lo sbarco, avvenuto nel 1283,
gli abitanti della contrada Fosse, per evitare di essere coinvolti negli
scontri, si trincerarono nelle zone limitrofe al Castello di Paola,
scombussolando gli equilibri che ruotavano intorno all'antica abbazia della loro
contrada. Il monastero andò incontro quindi ad un inevitabile declino,
nonostante il prodigarsi degli ultimi abitanti e dei monaci.
Il 2 luglio 1555 la
città fu assediata dai Turchi, comandati da Dragut
Rais, il quale, dopo averla saccheggiata e incendiata, assalì il
Convento dei Frati
minimi fondato da San
Francesco e lo depredò. Ripresasi, la città continuò a vivere
come gli altri paesi della Calabria, ma andava sempre più ingrandendosi,
crescendo anche in importanza.
Il 18 ottobre
del 1806,
Paola subì l'occupazione da parte dei Francesi. Essi incendiarono e
saccheggiarono il Santuario
di San Francesco, che restò deserto. In seguito ad una legge emanata da Gioacchino
Murat nel 1809,
iniziò la soppressione di tutti gli ordini religiosi del regno
di Napoli, compreso il protocenobio dei Minimi di Paola, nonostante la
sua importanza, i conventi furono tutti convertiti ad altro uso, spesso
militare, le chiese passarono al clero diocesano e
tutti i beni clericali confiscati.
Dopo il Congresso
di Vienna (1815), Ferdinando
IV di Borbone fu restaurato sul trono di Napoli. L'anno successivo i
due regni di Napoli e Sicilia furono uniti nel nuovo Regno
delle Due Sicilie. Nel 1844 il
re Ferdinando II e
la sua consorte Maria
Teresa d'Asburgo visitarono Paola per voto. In seguito il re tornò il 29
ottobre 1852 accompagnato
dal principe ereditario, Francesco.
Durante
il risorgimento,
Paola partecipò al movimento di Garibaldi. L'eroe
dei due mondi, tuttavia, non passo dalla città, a differenza dei suoi Garibaldini.
Essi furono persino aiutati dal Comune quando le truppe comandate da Nino
Bixio e Giacomo
Medici s'imbarcarono per raggiungere Garibaldi a Napoli. Prima della
costruzione della Ferrovia
Paola-Cosenza nel 1910,
il porto di Paola era molto trafficato, i piroscafi provenienti da Napoli e Messina erano
carichi di merci e viaggiatori e il commercio fiorente. Vi nacque l'ultimo
segretario del Partito Fascista, Carlo Scorza.
Monumenti
e luoghi d'interesse
La
cittadina è una delle mete del turismo religioso
in Calabria.
Fra i principali luoghi di interesse si segnalano il Santuario
di San Francesco, la Badia, la chiesa cosiddetta di Sotterra (nella località
omonima — già Gaudimare — con dipinti di cui quelli più antichi sono
variamente datati ai secoli altomedievali), rovine romane, Palazzo Scorza,
il castello di Paola.
Il
27 marzo si celebra la nascita di san
Francesco di Paola, mentre il 2 aprile (festa canonica del Santo di Paola) la
morte. I solenni festeggiamenti in onore di san Francesco si tengono dal 1° al
4 maggio, con diverse processioni a terra e a mare del "busto" del
Santo e del mantello. La tradizione vuole che un barcaiolo si rifiutò
di traghettare san Francesco dalla costa calabra a Messina ed il Santo
attraversò lo stretto con il proprio mantello. San Francesco è stato
proclamato oltre che patrono della Calabria anche patrono della gente di mare.
Il 4 maggio 2008 si sono conclusi i festeggiamenti per il V centenario
della morte di san Francesco.
In
merito agli elementi di pregio storico-religioso e culturale occorre ricordare
che il secolo XVI fu senz’altro il periodo d’oro per Paola, grazie
specialmente a san Francesco, i cui fedeli provenienti da ogni parte della
Calabria. Per questo motivo si ebbe un incremento urbanistico notevole per quei
tempi. La città espandendosi venne abbellita nei palazzi, nelle strade e nelle
fontane. In poco meno di un secolo si delineò una febbrile attività edilizia
ed artistica.

Oltre
al Santuario di San Francesco di Paola, le chiese e i conventi presenti a Paola
sono comunque numerosi.
Cattedrale
della SS. Annunziata
 Nel
centro storico di Paola, al culmine di una scalinata, vi è la chiesa matrice
dell’Annunziata, considerata il Duomo della città del Cosentino. Nel
centro storico di Paola, al culmine di una scalinata, vi è la chiesa matrice
dell’Annunziata, considerata il Duomo della città del Cosentino.
L’edificio
fu costruito in epoca normanna, come dimostrano alcuni fregi più antichi, ma
l’impianto della struttura fu completamente ricostruito nel Quattrocento in
stile gotico: gli affreschi più antichi risalgono proprio al XIV e XV secolo e
sono stati oggetto di un recente restauro che ha permesso di riportarli alla
luce.
Diversi
furono i rimaneggiamenti, il più importante dei quali nel Settecento che conferì
alla Chiesa un aspetto baroccheggiante. Tale caratteristica è visibile già
nelle decorazioni della facciata in tufo locale, che presenta due volute oggi
purtroppo non ammirabili pienamente per via dello stipite della cappella del
Purgatorio e della copertura dell’antistante pronao.
L’interno,
a tre navate, è molto più ricco. Le arcate che le suddividono sono sorrette da
pilastri in tufo in stili diversi secondo i canoni più puri dell’architettura
gotica, a cui rimandano anche le finestre ogivali in stile pre-rinascimentale.
Il bell’altare maggiore è sormontato da una pala raffigurante
l’Annunciazione della Vergine in olio su tavola ed impreziosita da una cornice
in legno dorato che pare sia opera del Santafede, artista calabrese del
Seicento.
Sono
molte altre le opere pittoriche presenti nella chiesa e risalenti ai secoli XV e
XVIII, attribuite ad artisti come Francesco Curia, Giuseppe Pascaletti o Dirck
Hendricksz. Pregevole anche il coro in legno, finemente intagliato con fregi
barocchi da artigiani fuscaldesi a fine Settecento.
Nell’adiacente
Cappella della Confraternita del Suffragio troverete, tra le altre cose,una
scultura dell’Ecce Homo ed una tela di Maria del Suffragio. A destra, invece,
troverete il battistero in legno con base in pietra lavorata al cui interno è
custodito il fonte battesimale anch’esso in pietra decorata e con croci
gemmate.
Chiesa
di Sotterra
La Chiesa
di Sotterra è una
chiesa interrata o ipogea (da qui il nome di Sotterra),
cui si accede grazie ad una scala che parte dal portico della
sovrastante la Chiesa del Carmine.
Poche
sono le notizie certe riguardo all'origine e ai motivi della scomparsa della
chiesa, la datazione e gli autori degli affreschi,
o il significato di alcuni elementi strutturali. Il rinvenimento della chiesa
risale al 1874, grazie a Giovanni Battista Moscato da San Lucido, che
ne diede notizia nel 1889, ma soltanto dal 1926 in poi appaiono
le prime descrizioni dettagliate. La prima esplorazione scientifica fu eseguita
da Claudio Ricca della Soprintendenza del Bruzio e della Lucania nel 1925.
Le
origini della chiesa restano tuttavia sconosciute. La sua architettura ricorda
una primitiva basilica paleocristiana di epoca romana, intorno al IV
secolo, grazie anche alla presenza di cocci di antiche tegole di età
imperiale tardo-romana e reperti fittili di epoca precedente alla costruzione
bizantina, ma l'ipotesi viene generalmente scartata, poiché i reperti
potrebbero essere preesistenti alla costruzione della chiesa. Altri ipotizzano
che la basilica sia stata edificata prima della diffusione del monachesimo bizantino
in Calabria, o da monaci profughi dopo il 750, dopo le persecuzioni
iconoclastiche di Costantinopoli e dell'Oriente. Ancora, si pensa
all'ambito longobardo, permeato ancora dalla cultura bizantina, sotto il dominio
dei Longobardi di Benevento, tra il VIII e il IX
secolo, ma l'affermazione del dominio bizantino su tutta la Calabria farebbe
posticipare la fondazione della chiesa al IX-X secolo.

La
combinazione di due eventi storici colloca la datazione più probabile tra i
secoli IX e X:
il ripristino del dominio di Bisanzio su tutta la Calabria e la conquista
araba della Sicilia, che favorì l'insediamento sulle coste tirreniche calabresi
di molti monaci italo-greci o di origine bizantina. Una lapide che era stata
collocata sopra il portale della Chiesa del Carmine afferma che la chiesa fosse
sotterrata a causa delle incursioni islamiche:
- Sacram
hanc aedem
- Virgini
Beatissimae de Carmelo
- quam
- etiam
venerabantur olim
- a
tetra Mahometismi incursione vexati
- hic
sub terra Prisci
- dicatam
- huius
Page aedificavere
- anno
MMCCCLXXXII
- Agricolae
pii
"Nell'anno
1882 i pii agricoltori di questa contrada edificarono questo santuario alla
Beatissima Vergine del Carmelo che anche gli antichi una volta veneravano qui,
sotto terra, oppressi dalla incursione del Maomettismo".
La
datazione tra il IX e il X secolo è favorita sia dai dati storici che dalla
datazione degli affreschi più antichi, quelli dell'abside,
non anteriore al IX secolo. Le osservazioni di Francesco Russo confermano
la collocazione della chiesa in epoca bizantina, mentre secondo Gregorio E.
Rubino la chiesa presenta soltanto tracce bizantine. Alfonso Frangipane cataloga
la chiesa di origine basiliana, ma ricostruita.
Il profilo storico e l'accurata ispezione strutturale dell'impianto rivelano che
originariamente la chiesa fu costruita fuori terra e solo successivamente
interrata a causa dell'abbandono dell'uomo e di frane e inondazioni del vicino
torrente Palumbo, probabilmente agli inizi del XVII secolo, come sostiene
anche Francesco Russo.
 Architettura
- La
chiesa presenta una pianta ad aula leggermente asimmetrica composta da vano
presbiteriale ed endonartece,
con disposizione nord-sud. La lunghezza è di circa 16,30 m, dalla parete
dell'abside semicircolare a sud fino all'ultima campata a nord,
mentre la larghezza della navata è di 4,60 m e quella del presbiterio di
4,70 m. Quest'ultimo è sopraelevato di circa 20 cm rispetto alla navata; la sua
profondità è di 3,02 m mentre quella dell'abside è di 1,62 m. Nelle pareti
laterali, due mezze nicchie servivano forse per collocarvi delle icone. Il
centro del presbiterio ospitava originariamente un altare, che fu
trasferito nel fondo dell'abside. L'altarino a sinistra serviva per la
preparazione del pane e del vino per la celebrazione della messa; manca sul
lato opposto l'altarino del diaconicon,
destinato alla conservazione delle sacre suppellettili. A destra della porta
d'ingresso si trova una grande conca forse anticamente destinata al rito del battesimo per
immersione. Architettura
- La
chiesa presenta una pianta ad aula leggermente asimmetrica composta da vano
presbiteriale ed endonartece,
con disposizione nord-sud. La lunghezza è di circa 16,30 m, dalla parete
dell'abside semicircolare a sud fino all'ultima campata a nord,
mentre la larghezza della navata è di 4,60 m e quella del presbiterio di
4,70 m. Quest'ultimo è sopraelevato di circa 20 cm rispetto alla navata; la sua
profondità è di 3,02 m mentre quella dell'abside è di 1,62 m. Nelle pareti
laterali, due mezze nicchie servivano forse per collocarvi delle icone. Il
centro del presbiterio ospitava originariamente un altare, che fu
trasferito nel fondo dell'abside. L'altarino a sinistra serviva per la
preparazione del pane e del vino per la celebrazione della messa; manca sul
lato opposto l'altarino del diaconicon,
destinato alla conservazione delle sacre suppellettili. A destra della porta
d'ingresso si trova una grande conca forse anticamente destinata al rito del battesimo per
immersione.
La navata è
divisa in quattro campate da tre archi:
-
la prima campata si trova in corrispondenza del vano presbiteriale ed è a botte
lunettata, con al centro un lucernario di
forma quadrata;
-
la seconda campata si conclude con una volta
a crociera;
-
la terza campata, grazie a un grosso arco strutturale, sostiene la chiesa
superiore; la volta corrispondente
è a botte liscia;
-
la quarta ed ultima campata termina con un ultimo arco, tamponato dalla muratura
adiacente all'odierna scala d'accesso a quello che per Isnardi è un ipogeo e
per il Frangipane è una cripta.
Concentrati
soprattutto nella parete dell'ogiva dell'abside
e sulla parete frontale del presbiterio, si trovano molteplici fori circolari di
diverse dimensioni. Varie sono le ipotesi sull'utilizzo degli elementi fittili
nell'architettura medievale:
-
alleggerire il peso delle volte;
-
favorire la ventilazione e impedire l'umidità;
-
migliorare l'acustica: ad esempio i vasi acustici sono costituiti da piccole anfore o
piccole brocche integre murate nelle pareti, in ceramica costituita da
un impasto rosso mattone;
-
sostenere le lampade votive.
Nulla
esclude la coesistenza di usi diversi degli elementi fittili.

Gli
affreschi costituiscono l'elemento più pregiato della Chiesa di Sotterra, ma
ancora si discute sulla loro datazione e fattura. Occupano l'abside e il
presbiterio, ma non la navata.
Originariamente,
gli affreschi dell'abside erano due: il primo nella volta, separato dal secondo
nel cilindro da una fascia policroma a
motivi geometrici.
Il
primo si trova in pessimo stato conservativo, a causa di pesanti infiltrazioni
d'acqua: sono appena visibili alcune tracce di un Cristo seduto
in trono circondato da due Angeli.
Il
secondo si trova in un miglior stato conservativo; si trova al di sotto della
fascia policroma sopracitata e al di sopra di un'altra fascia dai motivi fitomorfi,
sovrastante l'altare in pietra. L'affresco rappresenta l'Ascensione di Cristo tra
terra e cielo. La cornice al di sotto del Cristo è interrotta dal suo piede,
motivo tipico dell'iconografia medioevale: Cristo asceso in corpo, anima e
divinità ma ancora prossimo alla terra (con il piede). Inoltre nell'affresco
compaiono la Madonna, al centro, circondata da, per alcuni, Santi e Sante,
per altri, come il Verduci, sei Apostoli per lato, per esprimere il
concetto della totalità della Chiesa (alcuni identificano San Pietro e San
Paolo, rispettivamente a destra e a sinistra di Maria). Le figure sono allineate
frontalmente, ieratiche, a rappresentare astrazione dal mondo ed elevata
spiritualità; alcune hanno tratti ben visibili, altre hanno contorni sfumati,
il capo circondato da un'aureola e sono vestite di abiti solenni. Hanno il
dito alzato, a indicare il trono di Cristo, e le palme delle mani rivolte verso
l'alto in segno di pace. I volti sono scarni, com'è tipico della pittura
bizantina. La posizione dei Santi al di sotto della Majestas Domini rappresenterebbe
i piedi del Signore, perciò si può pensare che tali affreschi siano la
traduzione pittorica dello scritto di San Paolo:
"La Chiesa è il corpo di Cristo: noi siamo le Sue mani, la Sua bocca e i
Suoi piedi in questo mondo".
 Gli
affreschi del presbiterio sono divisi spazialmente e iconograficamente in due
gruppi, distinti tra secondo ciclo e terzo ciclo di affreschi. Gli
affreschi del presbiterio sono divisi spazialmente e iconograficamente in due
gruppi, distinti tra secondo ciclo e terzo ciclo di affreschi.
Il
secondo ciclo è costituito da due affreschi ai lati dell'abside, sulla parete
di fondo del presbiterio, e rappresentano il momento dell'Annunciazione.
A
sinistra è raffigurato l'Arcangelo
Gabriele, che annuncia il concepimento verginale a Maria: ha le braccia
incrociate sul petto, le mani aperte e dispiega ali dal fine piumaggio, che
interrompono la cornice dalle decorazioni geometriche. La sua figura contrasta
con lo sfondo dai motivi cosmateschi: è raffigurata in modo dinamico, il
capo rotato verso la Madonna, ed è vestita di abiti dalle linee eleganti e
flessuose lievemente rigonfiati, quasi mossi da una brezza. La sua veste è
elegante e sobria, bordata da una stola, quasi a delinearne il ruolo
sacerdotale, caratterizzata da croci patenti. Delle perline abbelliscono
capelli, scollo della veste e bordo delle maniche.
A
destra, è raffigurata la Madonna. Anche la Vergine emerge dal fondo cosmatesco:
è in posizione eretta, con il capo leggermente chino in avanti e rivolto
dolcemente verso l'Angelo; la mano destra è sul cuore mentre la sinistra
sorregge un libro. I tratti del volto ricordano il modello femminile greco;
vicino all'orecchio destro è presente una colomba stilizzata,
raffigurazione della Parola di Dio e dell'Annunciazione ma anche
simbolo della divina concezione attraverso l'orecchio (Atanasio in Egitto,
IV sec.: "Venite e vedete l'opera meravigliosa: la donna concepisce
nell'udito dei suoi orecchi"). La sua veste è ondulata, ornata da tre
stelle a otto punte in campo rosso - una sul copricapo, le altre due sulle
spalle -, simbolo della maternità divina; un orlo decorato impreziosisce il
bordo del corpetto e delle maniche, mentre il mantello blu è impreziosito lungo
l'orlo da una perlinatura a rilievo, simile a quella dell'Angelo. Un'analisi a raggi
UV conferma che entrambi gli affreschi dell'Annunciazione costituiscono un
unico ciclo pittorico con quelli dell'abside, poiché condividono un substrato
pittorico simile; l'Arcangelo e la Vergine sarebbero stati ridipinti
successivamente.
Il
terzo ciclo è caratterizzato dalla rappresentazione di due figure sacre
realizzate sulla parete laterale sinistra del presbiterio, sopra l'altare delle
offerte.
A
sinistra è raffigurata la Vergine Maria col Bambino, chiamata anche Madonna del
melograno, frutto raffigurato sul petto del Bambino, simbolo della benedizione
di Dio e, nell'Antico
Testamento, di buone condizioni di vita, in quanto uno dei più copiosi frutti
della Terra promessa. La sua rappresentazione è frequente nell'iconografia
cristiana, soprattutto nei secoli XV e XVI: le intense sfumature
di rosso rappresentano la passione di Cristo. Il modello teologico greco
della Madonna del melograno è però arricchito dalla presenza di un elemento
tipico del culto latino:
sull'angolo inferiore destro dell'affresco è raffigurato un orante a mani
giunte. La Madonna allatta il figlio (motivo della Madonna galactotrofusa,
diffuso nelle immagini bizantine), atto ricco di amore e spiritualità, col capo
inclinato verso il Bambino Gesù, e l'indice e il medio della mano sinistra a
favorire la fuoriuscita del latte, in modo premuroso, riducendo la fatica al
figlio. Il Bambino, a sua volta, asseconda il gesto materno con la mano
sinistra, possibile rappresentazione del sostegno di Cristo alla Chiesa che si
adopera per e si nutre di Cristo, in un circolo virtuoso tipico della teologia greca
che lega l'umano al divino. La rigidità del Bambino e lo sguardo inespressivo
ancora una volta riconducono all'arte bizantina.
A
destra si trova la figura di un Santo, molto probabilmente Sant'Antonio
Abate, racchiuso insieme alla Vergine e al Bambino in una sobria cornice rosso
porpora. Il Santo emerge in posizione eretta da uno sfondo dello stesso colore
della cornice, con il capo canuto circondato da un'aureola, ai cui lati restano
la lettera s a sinistra e la scritta ius a
destra, che guidano all'identificazione del Santo, cioè S. Antonius.
Le rughe solcano la sua fronte e il volto barbuto appare scavato dalla vita
eremitica e di penitenza. Con la mano sinistra si sorregge a un bastone, mentre
con la destra tiene una campanella, propria della sua iconografia.

La
pavimentazione è stata realizzata nello stesso periodo dell'edificazione della
chiesa. È costituita da tre tipi di mattoni: rettangolari, triangolari e
quadrati, di dimensione e colori vari.
Nella
navata si osserva che la pavimentazione è divisa in due metà longitudinali,
destra e sinistra, da una lunga fila di larghe lastre rettangolari di pietra
grigia, delimitate in quattro zone trasversali da tre strisce di grandi pietre
rettangolari dalle dimensioni più ridotte. Ogni zona, tranne quella dell'endonartece,
è divisa da lastre di mattoni policromi triangolarti e quadrati, tagliati ad
angolo retto e organizzati in modo da formare motivi geometrici.
Nel
presbiterio vi sono file alternate di pietre rettangolari grigie e triangolari
policrome, allineate verticalmente fino all'abside; intorno all'altare non c'è
traccia di pavimento.
È
un pavimento realizzato da materiale povero, ma di sorprendente eleganza
geometrica.
Nella
chiesa di Sotterra si trovano numerosi graffiti medioevali
che hanno prevalentemente "forma e funzione di natura simbolica,
riducendosi a puri e semplici signa",
e stilisticamente quindi si avvicinano ai graffiti preistorici o protostorici. I
contenuti sono devozionali, tipici della "graffitomania del
pellegrino" (croci, colombe, pesci...). È presente il signum
crucis, simbolo per antonomasia del Cristianesimo a partire
dall'Editto di Costantino. Tra i signa ancora visibili ci sono pesci,
colombe, e quella che sembra una galea, in prossimità di una croce di
Gerusalemme, testimonianza forse di un pellegrinaggio in Terra Santa. Ma vi sono
ancora molte altre figure, alcune mai descritte. Si può anche osservare la
raffigurazione di due uccelli riconoscibili dal piumaggio stilizzato, l'uno di
fronte all'altro, forse a significare l'incontro, oppure il candore che si nutre
di amore verso il prossimo e verso Dio, suggerito dall'atto di beccare uno
stesso frutto, o ancora, infine, forse l'interpretazione più appropriata,
simboleggiano la vigilanza di San Matteo e di San Luca.
- Santuario
di San Francesco

Il santuario di San Francesco di Paola sorge nella parte alta e collinare della
cittadina, in una valle costeggiata dal torrente Isca e ricca di vegetazione. È
meta di pellegrinaggio da tutto il sud Italia, specialmente dalla Calabria,
di cui san Francesco è patrono. Custodisce parte delle spoglie del santo (le
restanti si trovano a Tours in Francia).
Davanti
al santuario vi è un ampio piazzale, al limite del quale si erge la
facciata principale del tempio. A destra dell'ingresso principale, vi è un
arco tramite il quale si accede alla parte laterale del santuario, in cui si
trovano l'ampia basilica moderna (inaugurata nel 2000) e la fonte della cucchiarella,
alla quale sogliono bere i pellegrini. Accanto a questa è esposta una bomba
inesplosa, caduta nel torrente accanto al santuario durante un bombardamento
anglo-americano nel mese di agosto del 1943, che non danneggiò il
santuario. Continuando si accede al ponte del Diavolo e ad un sentiero al
termine del quale si trova un luogo che fu rifugio del santo nei suoi anni
giovanili.
Entrando
nel santuario per l'ingresso principale, si accede a due ambienti semi-aperti
iniziali. Nel primo sono conservate diverse lapidi, datate fra il XVI ed
il XX secolo, che ricordano varie ricorrenze ed eventi riguardanti il
santuario, mentre il secondo è il vero pronao della basilica antica: a
destra si trova il portale di accesso alla basilica, a sinistra vi è un
affaccio sul torrente e sull'adiacente convento, ed avanti vi è l'ingresso al
chiostro ed al romitorio del santo e la cella del beato Nicola.
La
basilica antica, in stile romanico, risalente al XVI secolo, è
composta da un'ampia aula principale piuttosto spoglia e da un'unica navata
laterale a destra, lungo la quale si aprono quattro cappellette, che ha il suo
culmine nella sontuosa cappella barocca che custodisce le poche
reliquie di san Francesco pervenute a Paola, fra cui alcuni suoi abiti e
frammenti di ossa.
Nel
chiostro del santuario, chiuso verso l'esterno con vetrate, si trova il roseto
del santo, che costituisce oggi un folto giardino, e ospita lungo le sue pareti
interne affreschi raffiguranti i principali episodi della vita del santo, molti
dei quali legati a leggende. Adiacente ad esso è il romitorio di San Francesco,
un insieme di angusti spazi sotterranei che costituirono il primo nucleo di
cenobio per il santo e per i suoi confratelli. Fra il chiostro e la basilica
antica si erge il campanile del tempio.
 Basilica
nuova
- Davanti
al santuario vi è un ampio piazzale, al limite del quale si erge la facciata
principale del tempio. A destra dell'ingresso principale, vi è un arco tramite
il quale si accede alla parte laterale del santuario, in cui si trovano l'ampia
basilica moderna (inaugurata nel 2000) e la fonte della cucchiarella,
alla quale sogliono bere i pellegrini. Accanto a questa è esposta una bomba
inesplosa, caduta nel torrente accanto al santuario durante un bombardamento
anglo-americano nel mese di agosto del 1943, che non danneggiò il
Santuario. Continuando si accede al ponte del Diavolo e ad un sentiero al
termine del quale si trova un luogo che fu rifugio del Santo nei suoi anni
giovanili. Basilica
nuova
- Davanti
al santuario vi è un ampio piazzale, al limite del quale si erge la facciata
principale del tempio. A destra dell'ingresso principale, vi è un arco tramite
il quale si accede alla parte laterale del santuario, in cui si trovano l'ampia
basilica moderna (inaugurata nel 2000) e la fonte della cucchiarella,
alla quale sogliono bere i pellegrini. Accanto a questa è esposta una bomba
inesplosa, caduta nel torrente accanto al santuario durante un bombardamento
anglo-americano nel mese di agosto del 1943, che non danneggiò il
Santuario. Continuando si accede al ponte del Diavolo e ad un sentiero al
termine del quale si trova un luogo che fu rifugio del Santo nei suoi anni
giovanili.
Entrando
nel santuario per l'ingresso principale, si accede a due ambienti semi-aperti
iniziali. Nel primo sono conservate diverse lapidi, datate fra il XVI ed
il XX secolo, che ricordano varie ricorrenze ed eventi riguardanti il
santuario, mentre il secondo è il vero pronao della basilica antica:
a destra si trova il portale di accesso alla basilica, a sinistra vi è un
affaccio sul torrente e sull'adiacente convento, ed avanti vi è l'ingresso al
chiostro ed al romitorio del Santo e la cella del beato Nicola.
All'interno
della basilica nuova sono presenti un affresco di circa 20 m²,
tre tele ad olio di circa 200
× 250 cm e una
tela di 440
× 214 cm, 4 volte a
vela triangolari di 4
× 3 m e una pala
d'altare di 250
× 150 cm, tutte opere
del pittore neo-manierista Bruno d'Arcevia, che le ha realizzate nel
periodo 1997-1998.






L'organo
a trasmissione elettronica computerizzata via-radio, del nuovo Santuario di
S.Francesco a Paola, è stato costruito dalla ditta Mascioni nel 2004. Il
materiale fonico è inserito all'interno di un'ampia nicchia sopraelevata, con
mostra in più campi, situata nella testata destra dell'aula. Lo strumento è
stato progettato da Franco Nicora e si articola in 44 registri per un
totale di circa 2900 canne;
la sua consolle, mobile indipendente, dispone di 3 tastiere e pedaliera.
Basilica
antica - La
basilica antica, in stile tardo rinascimentale, risalente al XVI secolo, è
composta da un'ampia aula principale piuttosto spoglia e da un'unica navata
laterale a destra, lungo la quale si aprono quattro cappellette, che ha il suo
culmine nella sontuosa cappella barocca che custodisce le poche
reliquie di San Francesco pervenute a Paola, fra cui alcuni suoi abiti,
frammenti di ossa e un dente.
Nel
chiostro del santuario, chiuso verso l'esterno con vetrate, si trova il roseto
del Santo, che costituisce oggi un folto giardino, e ospita lungo le sue pareti
interne affreschi raffiguranti i principali episodi della vita del santo, molti
dei quali legati a leggende. Adiacente ad esso è il romitorio di san Francesco,
un insieme di angusti spazi sotterranei che costituirono il primo nucleo di cenobio per
il santo e per i suoi confratelli. Fra il chiostro e la basilica antica si erge
il campanile del tempio.

CHIESA
DELLA MADONNA DEL CARMINE - La
Chiesa della Madonna del Carmine, situata a Sotterra in località Gaudimare, è una delle parrocchiali del
territorio di Paola.
L'interno
a navata unica, decorato in stile neoclassico, custodisce un pregevole altare
maggiore, dipinti, statue di santi e decorazioni finemente lavorate.
Sovrasta
la nota Chiesa
Ipogea di Sotterra
CHIESA DI
SAN MICHELE - La Chiesa di San
Michele Arcangelo, con la sua caratteristica cupola bizantina, è tra le più
antiche chiese di Paola e del Tirreno
Cosentino.
Fu
probabilmente eretta tra il IX e il X secolo dai monaci basiliani della Laura di
Sant'Angelo su un precedente luogo di culto.
Custodisce
al suo interno, tra le altre cose: un antico Fonte Battesimale in pietra con
incise quattro croci greche con montante; una delle più antiche statue
raffiguranti San
Francesco da Paola; una
grande Icona raffigurante San Michele Arcangelo Psicopompo; un Organo del 1880
donato dagli emigranti paolani nelle Americhe; statue raffiguranti Sant'Anna con
una giovane Maria Vergine, la Madonna con Bambino e San Michele Arcangelo.
CONVENTO
BADIA - Il Monastero Catino di
Santa Maria della Valle Giosafat, più semplicemente noto
come la Badia, è un antico complesso monastico risalente
all’epoca normanna.
Si
trova in località Fosse, nell'area meridionale del territorio paolano.
Fu
eretto dopo il 1110, per volere di Sica, moglie di Roberto di Bubum, Signore
di Fuscaldo,
da alcuni religiosi insediati nell’area.
Nel
settembre del 1190 ospitò il re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, durante
il suo viaggio verso la Terza Crociata.
La
chiesa, architettonicamente molto sobria, evidenzia come elementi d'interesse:
il portale lapideo a sesto acuto e il rosone.
Sono
annessi al complesso monastico, oltre alla chiesa, anche: un muro di cinta,
un'antica torre, posta sul versante occidentale, l'area dell'antico convento.

CONVENTO DI
SANT'AGOSTINO
CHIESA DI
SAN GIACOMO MAGGIORE
CONVENTO DEI
CAPPPUCCINI
CHIESA DI
SAN LEONARDO
CHIESA
DELL'IMMACOLATA
CONVENTO DEI
GESUITI
CHIESA DEL
ROSARIO - La Chiesa del SS.
Rosario, intitolata originariamente a Santa Caterina, si trova nel Centro
Storico di Paola, in
Corso Garibaldi; nei pressi della Fontana
Monumentale dei Sette Canali.
Dal
punto di vista architettonico è tra i monumenti religiosi più interessanti di
Paola e del Medio
Tirreno Cosentino.
L'interno,
a navata unica, custodisce interessanti opere artistiche.
CHIESA DI
SAN FRANCISCHIELLO
CHIESA DI
MONTEVERGINE - Secondo la
narrazione popolare, fu edificata dopo il rinvenimento di un’icona della
Madonna Nera ai piedi della Torre.
Dopo
il ritrovamento, l'icona fu portata presso il convento di Sant’Agostino, ma al
mattino seguente fu nuovamente ritrovata ai piedi della torre, senza che nessuna
l’avesse spostata. A seguito questi segni, ritenuti prodigiosi, il popolo
paolano decise di edificare la chiesa.
La
chiesa, probabilmente, in origine eretta in stile gotico, attualmente presenta
una facciata in stile barocco: opera di allievi di Niccolò Ricciulli da Rogliano.
All’interno,
custodisce: un soffitto realizzato con volta a crociera e costoni in tufo,
appartenenti alla struttura originaria; l'icona della Madonna di Montevergine;
dipinti del '500; un organo ad armadio della metà '700.
CHIESA DELLA
MADONNA DELLE GRAZIE
CHIESA
DELL'ADDOLORATA
CHIESA DI
SANTA MARGHERITA
CHIESA DI
SAN GIUSEPPE
CHIESA DI
SANTA MARIA DI PORTO SALVO
CHIESA DI
SANT'ANNA
Arco
di San Francesco
L’Arco
di San Francesco, detto anche la ‘Maggior Porta’ o ‘Porta di San
Francesco’, rappresenta l’ingresso a Paola, quello storicamente più
importante per la cittadina del Tirreno Cosentino: la Porta sul Mare.
Si
tratta di un interessante arco in tufo finemente lavorato, la più significativa
testimonianza ancora in piedi dell’antica cinta muraria che proteggeva quello
che oggi è il Centro Storico di Paola: chiare indicazioni di questa antica
funzione sono le feritoie per le armi da gittata e quelle da fuoco che nel
Cinquecento, epoca in cui la Porta di San Francesco venne costruita, avevano da
poco fatto la loro comparsa negli scenari bellici.
Su
di essa si possono trovare chiari riferimenti alla storia paolana: non soltanto
il fastigio in marmo bianco sorretto da quattro colonne in cui è esposta la
statua di San Francesco, ma anche lo scudo con lo stemma familiare degli
Spinelli – i Marchesi che, tra le altre cose, diedero una nuova organizzazione
urbanistica alla città – e il pavone, simbolo di Paola. L’ignoto autore di
questa monumentale opera ha inteso dedicarla, a nome di tutta la cittadinanza,
al suo Patriarca San Francesco.

Fontana
dei Sette Canali
La Fontana
detta “dei Sette Canali” è posta a pochi passi dalla Chiesa del Rosario nel
centro storico di Paola e sorge ai piedi di una lunga scalinata. Opera di
artigiani locali, porta la data del 1636.
Si tratta di
una delle fontane più caratteristiche dell’intera Calabria, con effetti
scenografici ed una struttura architettonica davvero notevoli: la sua struttura
ricorda quella di un ventaglio dispiegato, chiara allusione alla coda del
pavone, animale simbolo di Paola.
La fontana si
sviluppa su due bracci, le cui pareti sono decorate con 7 quadri in cui è
ritratto San Francesco nei suoi miracoli più celebri: in corrispondenza di
ognuna di queste immagini vi è una protome in pietra dalla cui bocca sgorga
acqua che viene canalizzata in una grande vasca semicircolare, di fronte alla
quale compare un ottavo quadro del Santo Paolano. Alla sommità di
quest’ultimo si possono notare tre scudi su cui sono riconoscibili, seppur
logorati dal tempo, lo stemma della Famiglia Spinelli in quelli laterali ed un
pavone in quello centrale notevolmente più grande.
Sulla
costruzione della fontana dei Sette Canali non si sa molto: le prime
informazioni scritte risalgono alla metà del Cinquecento, benché in quel caso
i documenti parlino di dodici e non sette canali. Tale circostanza non ha
trovato né conferma né smentita nelle ricerche successive, ma è certo invece
il ruolo di punto di incontro ed aggregazione dei paolani che questa fontana ha
assunto per secoli. La leggenda vuole che sia stato proprio San Francesco, con
un prodigio, a portare l’acqua a questa fonte perché si dissetasse il padre.

Fontana
dei Pisciarieddi
In
Piazza del Popolo a Paola si trova una monumentale fontana nota come dei
Pisciarieddi, uno degli esempi della maestria degli scalpellini paolani.
La
Fontana è costituita da due vasche asimmetriche e da un obelisco zampillante in
pietra arenaria locale, una struttura che richiama alla mente la struttura delle
fontane nell'architettura latina: le due vasche, poste una nell'altra, sono
infatti alimentate da 4 protomi ciascuno e, quando la pressione lo consente, si
creano dei giochi d'acqua molto caratteristici.
Nella
vasca più ampia, che costituisce anche la base della Fontana dei Pisciarieddi,
noterete due sculture raffiguranti la croce, che rimanda sia alla fede cristiana
che allo stemma della Famiglia Spinelli, ed il Pavone, simbolo di Paola.
Fino
a qualche anno fa la fontana era provvista di una balaustra in tufo sulla quale
era incisa la data del 1737: contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questa
non indica la data di costruzione, che sarebbe invece da collocare nel XVI
secolo. Oggi la balaustra è stata dismessa, così come il puttino con il suo
zampillo che era posto alla sommità dell'obelisco.

Torre
della Badia
 Distante
dal centro abitato e posizionato su un'altura il complesso è costituito da un
insieme di fabbricati, alcuni dei quali adibiti ad uso di civile abitazione, con
annessi due strutture architettoniche di rilievo: la torre e la chiesa. Distante
dal centro abitato e posizionato su un'altura il complesso è costituito da un
insieme di fabbricati, alcuni dei quali adibiti ad uso di civile abitazione, con
annessi due strutture architettoniche di rilievo: la torre e la chiesa.
La torre
presenta una pianta quadrata elevata a due piani fuori terra in un primo ordine
a forma di tronco piramidale ed in un secondo prismatico retto visibile nel
prospetto sud; una scala di accesso elicoidale permette l’accesso ai piani
superiori. Nel prospetto est e ovest si riscontrano corpi di fabbrica aggiunti
in epoca successiva.
La chiesa, a
pianta rettangolare ed a navata unica, presenta un abside semicircolare con
copertura semisferica di larghezza inferiore rispetto alla navata. Il tetto, a
due falde, è costituito da capriate Palladiane.
Nelle
fondazioni vi è la presenza di una fossa tombale mentre, sul prospetto ovest ed
Est, vi è un posizionamento asimmetrico dei due contrafforti. Presenta un
portale in tufo lavorato a più livelli.
Castello
normanno-aragonese
La
Torre del Castello sorge su di una struttura rocciosa in declivio sovrastante la
fascia costiera tirrenica, in una delle zone paesisticamente e storicamente fra
le più interessanti della Calabria.
Di
forma cilindrica su bastione quadrilatero, costituiva l'elemento principale di
un sistema collaborante di fortificazioni, di cui le torri costiere
rappresentavano gli estremi puntuali di controllo esterno, garantiti dal
presidio posto a monte e a difesa dell'abitato, destinato anche ad accogliere il
feudatario al quale offriva pertanto residenza ufficiale.
Oscure
sono le origini dell'impianto che, da vaghe e limitate fonti desunte dalla
storiografia locale verrebbero attribuite all'età normanna e successivamente al
periodo svevo. Motivi di natura militare legati al controllo delle vie di
collegamento e necessità difensive ne stimolarono lo sviluppo e
l'accrescimento.

Fonte:
|