Architetture
civili
Le
prime architetture civili risalgono al 1530 quando l'abate commendatario
Salvatore Rota, fece realizzare la prima via selciata (sielica) per
collegare il monastero con i colli e l'acquedotto badiale. Nello stesso
periodo, cominciarono a sorgere i primi edifici amministrativi nel rione Cortiglio,
e si rese necessaria la creazione di una piazza pubblica come luogo sociale e
amministrativo. Le architetture signorili giunsero solo verso la fine del
Seicento, con l'arrivo in paese delle prime famiglie proprietarie terriere.
Queste, realizzarono i loro palazzi dapprima intorno alla piazza comunale, e
in seguito, a causa anche del tessuto urbano che si era conformato, molto
fitto, e dell'esiguità di grandi spazi dove poter edificare, eressero le loro
abitazioni sui colli che sormontavano il centro storico, con edifici
architettonicamente semplici, alla ricerca tuttavia di uno slancio
volumetrico, che ponesse i palazzi al di sopra del tessuto minuto circostante,
in modo da poter esser visibili da più parti del paese.
Il
maggior esempio di slancio volumetrico e la conseguente visibilità
dell'edificio stesso, è il Palazzo Barberio Toscano, eretto allora, fuori dal
centro storico, ma in una posizione dominante il centro stesso, simbolo
dell'influenza che l'allora famiglia Barberio Toscano aveva nella vita
amministrativa del paese.

Fino
al 1700, non esistevano edifici di rilevante dimensione e valore. L'edilizia
urbana era costituita principalmente da edilizia minuta, di case e casette
popolari. Solo a partire dai primi anni del Settecento si cominciarono a
costruire le prime abitazioni di rilievo, di famiglie facoltose o comunque di
un certo rango sociale nella vita pubblica e amministrativa della città, che
possedevano boschi della Sila e allevamenti. I primi palazzi sorsero intorno
alla piazza principale, l'attuale piazza Abate Gioacchino, ed in
seguito lungo le strade principali e le aree marginali del centro storico, ma
su terreni che permettevano la predisposizione di orti ad utilizzo della
famiglia stessa.
Edificare edifici di un certo volume nell'allora tessuto urbanistico, non fu
certamente facile. Poche erano le aree disponibili alcune delle quali
costituite da imponenti massicciate granitiche, o su forti acclività.
I
palazzi vennero edificati in contesti urbani di rilievo, seguendo due
disposizioni:
la
prima comprende i palazzi eretti intorno a Piazza Abate Gioacchino;
la
seconda comprende i palazzi dominanti il centro storico realizzati sul colle
dei rioni Coschino, Catoja e Scigato
I
palazzi storici familiari, sorgono tutti nel cuore del centro storico, ad
eccezione di Palazzo Barberio Toscano, edificato sul colle della Filippa,
nella zona nord del paese e dominante sia il centro storico, che tutti gli
altri palazzi familiari. Le notevoli dimensioni dei palazzi si possono notare
solo nelle vicinanze degli stessi edifici, o in punti panoramici della città,
mentre difficile è ammirarli percorrendo le strade del centro storico. La
difficile reperibilità di grandi aree sulle quali realizzare i palazzi, ha
fatto sì che ai palazzi non potessero essere ad essi annessi piazze o aree
verdi, tranne che per i casi di palazzo Barberio Toscano, palazzo Benincasa e
Palazzo Barberio.
La
carenza di aree verdi o piazze, è stato in parte rimpiazzata dalla
realizzazione di un cortile interno privato o alte mure riparatorie, questi
nei casi di palazzo Lopez, palazzo Nicoletti, palazzo De Luca e palazzo
Barberio Toscano. Di certo, la realizzazione dei palazzi, incastonati nella
trama fitta urbana del centro storico, spesso in zone completamente marginali,
non sono stati concepiti per lasciare al pubblico spazi marginali. Per tutti
questi motivi, l'architettura degli stessi si è spinta in una ricerca
compattezza dei volumi, senza presentare notevoli qualità architettoniche, ma
ricercando uno slancio volumetrico notevole.
Quest'ultima è la principale caratteristica dei palazzi storici, un'impronta
edilizia che certamente nel passato, come in parte anche oggi, riusciva a
rendere visibili e imponenti al resto del paese, i palazzi, e di conseguenza,
le famiglie più prestigiose.

I
primi palazzi signorili furono il
Palazzo
Lopez (di
Piazza Abate Gioacchino) di
fine Settecento, il Palazzo
Nicoletti e
il Palazzo
Romei,
di metà XVIII secolo, che sorgono intorno alla piazza principale del
paese.
Palazzo
Lopez - A
palazzo Lopez è legata la vicenda dei Fratelli
Bandiera. Posto su
via xxv aprile, solennemente bordato, presenta una facciata imponente, che si
slancia in alto al cospetto della stretta strada in cui è ubicato. Il portale
alto, sormontato da un arco a tutto sesto, racchiude un particolare chiave
di volta raffigurante lo stemma dell'antica famiglia dei Lopez.
All'interno ampie scalinate portano fin su al secondo piano. Per accedere al
terzo piano si deve accedere dall'ingresso laterale posto ad ovest, circondato
da una piccola corte triangolare. Il tetto sostenuto da travi in legno,
presenta volte a crociere. Niente di decorativo presentano le sue pareti se
non altro la grande dimensione delle stanze e la particolarità dell'ultimo
piano on le stanze tutte collegate fra di loro.
La
costruzione dell'edificio risale al l'inizio del 1700. La pianta, come si
presenta oggi, è frutto di una serie di aggregazioni di diversi manufatti,
che hanno riportato ad oggi, un edificio asimmetrico. Alcune aggregazioni
possono essere datate nello stesso periodo di edificazione dell'edificio,
mentre altre sono state apportate successivamente. L'edificio è posto su una
leggera salita, e presenta un dislivello fra il lato est e quello ovest, che
molto probabilmente ha influito sul disegno generale della facciata. Il
cortile laterale, cinto da mura con portone in legno, posto all'ingresso che
dà l'accesso al terzo piano, racchiude gli ambienti della zona residenziale.
Naturalmente sia i diversi livelli che le piante degli accorpamenti, sono
collegati attraverso nodi di comunicazione, così come le stalle e le antiche
cucine poste su edifici al di fuori la piccola corte trapezoidale. Altri
ambienti esterni sempre la corte, sono collegati con il vicolo soprano, grazie
ad un vaglio.
L'importanza
dell'edificio non è legata alle caratteristiche architettoniche dello stesso,
quanto ai moti rivoluzionari di metà '800, ed in particolare alla vicenda dei
fratelli veneziani Bandiera.
Per questo fatto storico Palazzo Lopez è spesso citato su libri, riviste,
giornali, e guide turistiche. I Fratelli Bandiera, originari di Venezia che
vennero catturati dalla gendarmeria locale nel 1844. Presso Palazzo Lopez,
infatti, furono deportati Emilio Bandiera e Domenico Moro dopo la loro
cattura, e qui furono tenuti prigionieri per alcuni giorni. Ritrovo di
patrioti liberali con idee mazziniane,
che ben spesso si presentavano accompagnati da belle donne. Il fatto dei
fratelli Bandiera, portò alle cronache di tutt'Italia la cittadina di San
Giovanni in Fiore e Palazzo Lopez, ne fu il simbolo dei moti silani. Il
riferimento ai quei tragici fatti, sono impressi nella lapide realizzata negli
anni '50, posta a fianco l'ingresso principale del palazzo.
 Nell'ultimo
decennio il Palazzo è stato oggetto di gran dibattito politico/cittadino,
quando questo fu ceduto dal comune di San Giovanni in Fiore, a cittadini
privati, i quali vollero realizzarvi un "Bed
and breakfast".
Nell'ultimo
decennio il Palazzo è stato oggetto di gran dibattito politico/cittadino,
quando questo fu ceduto dal comune di San Giovanni in Fiore, a cittadini
privati, i quali vollero realizzarvi un "Bed
and breakfast".
Lo scatenare
delle polemiche fece giungere ad una sorta di compromesso fra i privati che
acquistarono il palazzo, ed il comune: ai primi fu concesso realizzare un
ristorante e un pub, con la promessa di poter adibire il terzo piano a
“Museo delle memorie e del Risorgimento”. Ad oggi nulla si muove in
direzione del museo, mentre già da alcuni anni le attività ricettive sono
state avviate.
In
posizione marginale ma dominante il centro storico, sono Palazzo
Barberio costruito
tra il 1772 ed il 1783 (dichiarata
dal 1995 Dimora Storica vincolata), Palazzo
Benincasa,
databile intorno al 1730, Palazzo
Caligiuri,
della seconda metà del XVIII secolo e Palazzo De Luca,
di inizio Ottocento.
Palazzo
Barberio - Posto alle spalle della Chiesa Madre nel quartiere Coschino,
palazzo Barberio venne realizzato tra il 1772 e il 1783. La
caratteristica principale dell'edificio è quello di poggiarsi in maniera
completamente asimmetrica, sulla stessa particella. Questa particolarità è
data da una nota storica, legata al periodo in cui il palazzo conglomerò a sé
negli anni '70, alcuni fabbricati di edilizia minuta di proprietà della
famiglia, posti dinanzi al palazzo e distrutti da un incendio. Il palazzo, che
fino a quel periodo era edificato solo per metà sulla propria particella,
assunse la forma attuale. Il palazzo, di forma rettangolare, ha la
particolarità di essere a forma di "gradoni" con metà edificio
posto in basso, e la restante metà, in posizione "sopraelevata".
Questa particolarità ha reso l'edificio unico per tipologia costruttiva, con
la formazione di un duplice edificio sovrapposto, con l'ultimo piano dell'area
sopraelevata" si affaccia lungo la falda inclinata dell'area posta
"a valle". L'edificio si presenta a tre piani, con il portale posto
a destra, sormontato da un arco a tutto sesto in granito silano, il
primo piano presenta una fila di tre piccole finestre quadrate munite di
inferriate, il secondo piano una fila di quattro finestre, mentre il terzo
piano una fila di 4 balconcini. In cima al terzo piano, nel sottotetto, vi è
una fila di 4 oculi ovali.
Palazzo
Benincasa - Della famiglia Ernesto Benincasa, il palazzo fu eretto nel
1735. Originariamente la planimetria dell'edificio non era quella attuale, ma
di semplice pianta regolare. L'edificio attuale è il risultato di annessioni
fra l'edificio antico e successivi ampliamenti. I rimaneggiamenti ne hanno un
po' modificato l'architettura delle facciate, specie per quanto riguarda i
cornicioni delle finestre. Questo in quanto, dal secondo dopoguerra, il
palazzo venne donato dalla famiglia, all'istituzione clericale che ne fece un
asilo nido. La conversione tipologica del palazzo, fu succeduta da una serie
di interventi (fortunatamente per la gran parte interni) che ne modificarono
l'aspetto. Nonostante ciò si può ammirare la ricchezza costruttiva, e in
particolare la posizione arroccata lungo il colle di via Florens. Inoltre
questo è uno dei pochi palazzi storici di San Giovanni in Fiore avente
un ampio giardino verde.
Palazzo
De Luca - Il palazzo fu realizzato nella seconda metà XVIII secolo.
La famiglia De Luca, che nella seconda metà del XVII secolo era
dedita principalmente all'allevamento di pascolo bovino e alla pastorizia,
riuscì nel tempo a costituire un ricco patrimonio che le permise di
introdursi nei ceti maggiori della società sangiovannese. Il palazzo, che
sorge lungo via Fratelli Bandiera, sul colle di via Florens, è il risultato
di una composizione volumetrica fatta da tre volumi diversi. Due di questi
volumi di forma rettangolare incastonati fra di essi, hanno composto il
piccolo cortiletto posto davanti all'ingresso. L'assemblaggio fra due edifici
realizzati in epoche diverse è confermata dai materiali (mensole) e finestre
che l'edificio contiene nel proprio interno. Il palazzo è a tre piani. Il
prospetto che da lungo via Fratelli Bandiera, è caratterizzato da uno schema
rigido e preciso di finestre solo al primo piano, e una serie di balconcini al
secondo e al terzo piano, mentre non sono presenti terrazzi come in altri
palazzi.

Palazzo
Caligiuri - l palazzo venne edificato nella seconda metà del XVIII
secolo su “Timpone San Biagio” (un colle della città) dove sorgeva
l'antica chiesa di San Biagio, demolita negli anni 1930. Questo edificio
è stato realizzato lungo un crinale molto scosceso e la sagomatura
dell'edificio segue per gradoni l'orografia del colle, così come è per Palazzo
De Marco. Certamente il colle, "suddiviso" con un altro palazzo
storico, Palazzo Barberio, ha contribuito non poco all'architettura del
palazzo. Vi sono 5 ingressi, posti lungo tutta la facciata, mentre l'ingresso
principale è stato realizzato nel corpo centrale dell'edificio. Nella parte
più in basso l'edificio ospitava quasi sicuramente i depositi, mentre la
parte più in alto, terminante sul colle, è caratterizzata da una duplice e
differente volumetria, rispondente a due distinte altezze dell'edificio. Il
palazzo non presenta particolari ornamenti architettonici mentre segue uno
schema preciso con sole finestre al primo piano e balconcini al secondo.
In
posizione marginale, edificati lungo le arterie principali sono Palazzo
De Marco,
della prima metà del Settecento, sede della Biblioteca comunale, e
Palazzo Oliverio,
di inizio Ottocento.
Rappresenta
un'eccezione
Palazzo
Barberio Toscano,
databile tra il 1735 ed il 1740, fortemente compromesso dalla
frammentazione della proprietà, unico palazzo che può vantare il titolo
nobiliare (baronale) della cittadina florense, edificato su un colle posto al
di sopra di tutto il centro storico, in posizione dominante rispetto anche
agli altri palazzi signorili, come evidenza dell'importanza economica e
politica, che la famiglia Barberio Toscano aveva nel XIX secolo.
Ville
Il
paese è piuttosto carente di aree verdi, non avendo in campo amministrativo,
mai sviluppato una cultura del verde e dell'arredo urbano. Già le famiglie
signorili del 1700 e del 1800 non manifestarono mai la necessità di grandi
giardini da realizzare intorno alle loro abitazioni, anzi i pochi palazzi
storici circondati da verde, utilizzavano queste aree in parte per orto e solo
in minima parte in giardino.
La cultura dell'orto dinanzi casa, fino a metà anni cinquanta sopperiva, così,
alla necessità di aree verdi.
Lo
sviluppo edilizio del dopoguerra, cancellò gli antichi orti e le loro tracce,
senza adeguatamente sostituire questi, con altre aree di verde urbano. Solo
negli anni ottanta vennero mossi in campo amministrativo, i primi interventi
per la realizzazione di alcune aree da destinare a verde pubblico, ma la
carenza nel centro urbano di aree libere sfruttabili a tale scopo, fece
individuare ed emergere soluzioni alternative. Furono realizzati un grande
parco comunale in una zona periferica (quartiere Pirainella),
espropriando ed abbattendo alcune costruzioni esistenti, mentre una
"Villa comunale", fu realizzata alle spalle del palazzo comunale,
trasformando un colle piuttosto acclive, area utilizzata ad orto, in un
giardino attrezzato, formato da una serie di terrazzamenti e a forma di
gradoni.
Sito
archeologico Protocenobio
di Jure Vetere

La Domus di Fiore, nota anche come l'Abbazia di Jure Vetere (o Fiore
Vetere), ovvero come Protomonastero di Jure Vetere, è la prima
fondazione dell'Ordine Florense, edificata dall'abate Gioacchino da
Fiore. L'abbazia, distrutta da un incendio, venne in seguito abbandonata
insieme al sito comprendente altri locali utilizzati dai monaci. Il sito, in
territorio di San Giovanni in Fiore dal quale dista circa 5 km,
è stato localizzato dal Dott. Luigi Biafora (San Giovanni in Fiore) sul
finire degli anni '90 del secolo passato, ed è stato riportato alla luce a
seguito di perlustrazioni avviate nel 1997 e campagne archeologiche effettuata
a fase alterne tra il 2003 e il 2005.
Nella
località di “Iure Vetere” Gioacchino, fondò quella che sarà la sua
prima Abbazia. Cominciata nel 1189 e terminata in data antecedente al 21
ottobre 1194. L'Abbazia di “Iure Vetere” era ubicata in un luogo perfetto
secondo Gioacchino, ove regnasse la pace e la tranquillità, e dove si potesse
rigenerare la spiritualità perduta. Assieme al monastero vennero realizzate
anche delle dipendenze ad utilizzo dei monaci alla quale vennero affidate
terre per la coltivazione e il pascolo. La realizzazione del nuovo monastero
non fu semplice, soprattutto "perché
si dovettero combattere le controversie con i monaci Basiliani del vicino Monastero
dei Tre Fanciulli, in quanto questi ultimi si servivano delle terre donate
all'abate, per farvi pascolare i loro greggi".
Cominciate
a realizzare le prime fondamenta, Gioacchino nel 1198 si recò a Palermo
presso la corte di Costanza, vedova da poco del re Enrico VI, che in
precedenza aveva concesso all'abate, il diritto di utilizzo e di pascolo delle
terre della Sila, per cercare conferma di protezione e donazione da parte del
regno. L'approvazione di Costanza, ufficializzò la realizzazione
dell'Abbazia. Gioacchino non vide mai completarsi definitivamente la sua
opera. L'Abate, infatti non aveva fatto i conti con le difficili condizioni
climatiche del luogo prescelto, che in concomitanza dei continui viaggi che
intraprendeva in Sicilia e nel resto della Calabria, alla ricerca di consensi
per il suo operato e per diffondere il suo pensiero, gli costarono gravi
malanni, l'ultimo dei quali, nel 1202, fu letale. Morì infatti il 30 marzo
del 1202 a Pietrafitta, dopo aver ricevuto la visita degli abati cistercensi
di Corazzo, della Sambucina e dello Spirito Santo di Palermo, e qui vi fu
seppellito.
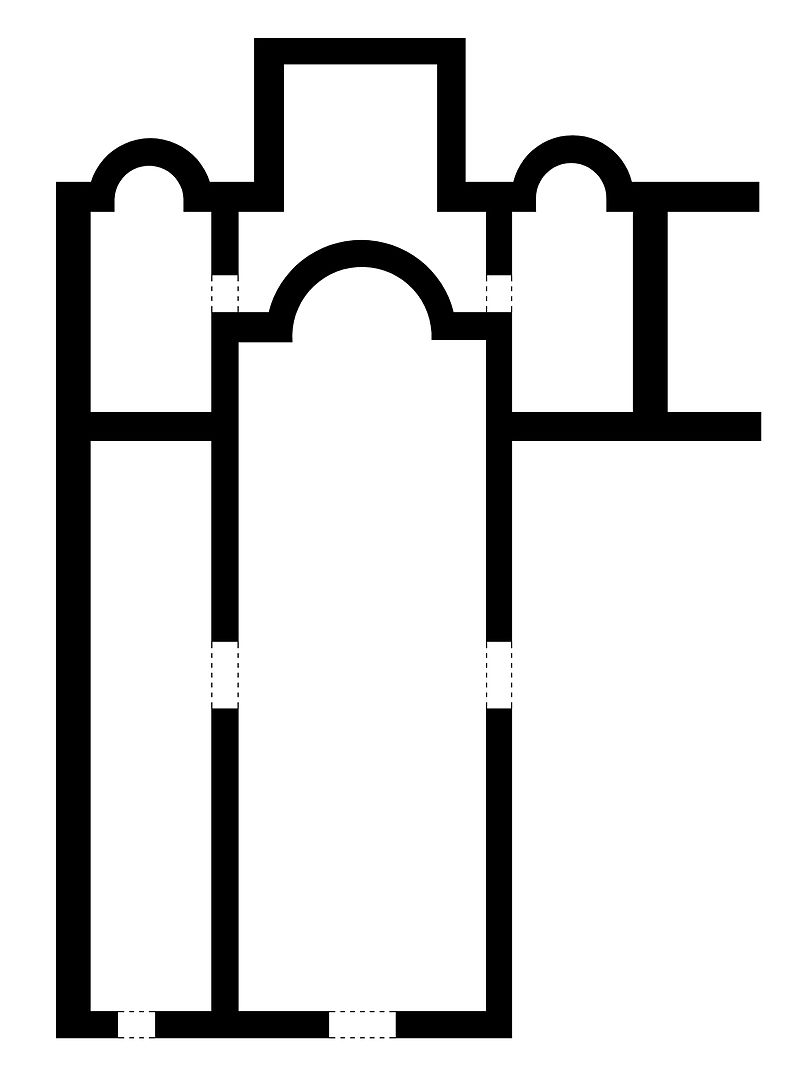 A
sostituire Gioacchino a capo del monastero, fu Matteo, suo seguace, che ben
presto si ritrovò a dover affrontare numerosi problemi. Nonostante tutto, i
monaci con grossi sacrifici, riuscivano a mantenere intatto sia il canone di
vita, sia il luogo silano. Il periodo più difficile per i Florensi,
avvenne nell'anno 1214, quando a fine estate, un vasto incendio devastò il
protocenobio di Iure Vetere, e tutti i suoi edifici contigui. Quest'incendio
difatti, sancì la chiusura del monastero di Iure Vetere, il luogo scelto da
Gioacchino nel 1189, poiché da qui a breve i monaci florensi, prenderanno una
scelta radicale. Nonostante l'acquisizione di un vasto territorio donato da
Enrico VI, e quindi aver acquistato in maniera indiretta prestigio e potere,
le condizioni climatiche del luogo apparivano troppo difficili cosicché i
monaci decisero di abbandonando per sempre il vecchio protocenobio.
A
sostituire Gioacchino a capo del monastero, fu Matteo, suo seguace, che ben
presto si ritrovò a dover affrontare numerosi problemi. Nonostante tutto, i
monaci con grossi sacrifici, riuscivano a mantenere intatto sia il canone di
vita, sia il luogo silano. Il periodo più difficile per i Florensi,
avvenne nell'anno 1214, quando a fine estate, un vasto incendio devastò il
protocenobio di Iure Vetere, e tutti i suoi edifici contigui. Quest'incendio
difatti, sancì la chiusura del monastero di Iure Vetere, il luogo scelto da
Gioacchino nel 1189, poiché da qui a breve i monaci florensi, prenderanno una
scelta radicale. Nonostante l'acquisizione di un vasto territorio donato da
Enrico VI, e quindi aver acquistato in maniera indiretta prestigio e potere,
le condizioni climatiche del luogo apparivano troppo difficili cosicché i
monaci decisero di abbandonando per sempre il vecchio protocenobio.
Dopo
esser stato abbandonato, il proto monastero di Jure Vetere venne per secoli
dimenticato. Le sue testimonianze erano lasciate solo a racconti, divenuti con
il tempo quasi leggendari, mentre le sue tracce erano completamente scomparse.
Nel 1997 cominciò a ricercarlo l'arch. Pasquale Lopetrone, ma la sua
localizzazione era già avvenuta ad opera del dottor Biafora e della moglie
Nicoletta Magnaghi, proprietari del terreno in cui furono rinvenuti i resti
dell'edificio religioso. Successivamente vennero compiuti i primi accertamenti
del caso e fu trasmessa segnalazione alle autorità competenti. Dopo la
localizzazione, il Comitato Nazionale per i festeggiamenti dell'8º centenario
della morte dell'Abate Gioacchino da Fiore, nel 2001, attivò una campagna
archeologica, diretta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Calabria, condotta dal gruppo di ricerche dell'IBAM di Potenza, in
collaborazione col Comune di S. Giovanni in Fiore e del Centro
Internazionale di Studi Gioachimiti coi tecnici della Scuola di
Specializzazione in Archeologia di Matera (Università degli Studi della
Basilicata) i resti della prima fondazione furono riportati alla luce, e con
essi anche alcuni primi e rurali insediamenti.
Gli
scavi proseguirono con altre 4 campagne, ma non vennero terminati, poiché i
fondi utilizzati per questi scavi, finirono ben presto. Il luogo archeologico
è stato in parte abbandonato, e recintato solo nel 2009 onde evitare che
pascoli e bestiame presenti in zona, potessero accedervi e recarvi qualche
danno. I resti solo in parti ricoperti mentre altri sono esposti alle
intemperie del luogo. Sulla scoperta archeologica, è stato redatto ed edito
un volume apposito, voluto dal Comitato Nazionale per i festeggiamenti dell'8º
centenario della morte dell'Abate Gioacchino da Fiore, con il patrocinio del
Ministero per i Beni Culturali.
Arco
normanno
L'Arco
normanno del 1200 è,
insieme all'Abbazia Florense, il simbolo della cittadina. L'Arco normanno si
trova nelle vicinanze dell'Abbazia forense. Non esistono notizie certe in
merito di questo singolare monumento. Si suppone, secondo recenti studi, che
l'arco facesse parte di una serie di diversi archi realizzati lungo le mura
che cingevano il complesso abbaziale e alcuni edifici utilizzati dai
religiosi. Le percezioni di tali supposizioni si poggiano sul ritrovamento di
resti di alcuni “ammorsamenti” nei muri vicini all'arco medievale.
L'arco
normanno si presenta a forma di sesto ogivale, e sicuramente risale
all'epoca in cui il borgo monastico era sotto la dominazione normanna,
nel XII secolo. Le mura e soprattutto gli archi, erano stati fatti
erigere intorno al borgo monastico, e oltre a fungere da porte d'accesso di
protezione, avevano certamente anche la funzione di confini urbano
extraterritoriale, oltrepassando i quali si era immuni da ogni pena inflitta
dalla Corte Giudiziaria Normanna.

Monumento
ai caduti di Monongah
Il Monumento
ai caduti di Monongah è l'ultimo monumento, ad oggi, eretto nel
comune di San Giovanni in Fiore. Fatto costruire da maestri scalpellini
locali, sotto proposta e direzione della Regione Calabria, per commemorare il
centenario della tragedia,
il monumento fu poi consegnato alla città di San Giovanni in Fiore, quale
paese calabrese con la maggior perdita di cittadini subita nella sciagura del
6 dicembre del 1907.
Molti
dei 956 morti nella più grave sciagura mineraria mai accaduta negli Stati
Uniti d'America (Monongah, Virginia Occidentale, 6 dicembre 1907)
erano infatti emigranti provenienti da San Giovanni in Fiore, oltre che da
altre cittadine della Calabria, dell'Abruzzo e del Molise.
Il monumento è stato visitato dal governatore del Virginia Occidentale,
Joe Manchin III, nel 2004 che vi ha deposto una corona di fiori.

Ponte
della Cona
Il
Comune di San Giovanni in Fiore, vista la sua natura montana è attraversato
da numerosi ponti, la stragrande maggioranza, di piccole dimensioni, alcuni
dei quali, realizzati nei pressi della città vecchia sono esteticamente
gradevoli e di pregevole fattura. L'unico ponte che però merita essere
menzionato per pregio, caratteristiche storiche e naturali, è il “Ponte
della Cona”. Realizzato sul finire del Settecento, è una strutta a due
arcate con le due volte a pietra incastrate fra di loro e “saldate” da un
leggero strato di malta a base di calce.
Un
tempo unico accesso tra il centro urbano e le prime strade di collegamento fra
gli altri paesi, il ponte della Cona fu poi soppiantato dalla edificazione di
nuovi passaggi viari e relativi ponti. Si ricorda nella storia, poiché da
questo passaggio transitarono i Fratelli Bandiera dopo la loro
cattura.
Cippo
della Stragola
Sul
luogo della cattura dei Fratelli
Bandiera, nel 1909 venne innalzato un cippo in granito silano, comunemente
chiamato Cippo della Stragola, commemorativo delle eroiche gesta
dei fratelli veneziani. Il cippo si trova in località “Stragola” a circa
10 km dal centro abitato della cittadina.
Il
monumento, realizzato completamente con granito silano, fu eretto da
parte della cooperativa "Fratelli Bandiera", per conto della
famiglia Lopez, la famiglia che ospitò due dei rivoltosi catturati nel 1844.
Con l'erezione del cippo, la famiglie intese mettere a tacere, le polemiche
che incalzavano dall'Unità d'Italia, e che puntualmente venivano fomentate da
politici del luogo.


Tradizioni
e folclore
San
Giovanni in Fiore è un paese nel quale è profondamente radicata la cultura
religiosa.
-
nel
mese di febbraio viene festeggiato il carnevale con delle particolari
rappresentazioni musicali dette “Frassie”
che riproducono sotto forma satirica un quadro degli avvenimenti più
eclatanti del paese;
-
nei
mesi estivi si susseguono festività religiose: Madonna della Sanità, San
Francesco di Paola, Corpus
Domini, Sant'Antonio, San
Giovanni Battista (protettore
della cittadina), Madonna
del Carmine e San
Domenico;
-
in
agosto si allestiscono due fiere: la “Fiera” tradizionale annuale, che
attira visitatori di tutte le zone limitrofe, legata alla ricorrenza delle
festività di San
Giovanni Decollato e
la fiera Florense che si svolge nei vicoli del centro storico;
Durante
le festività natalizie, vengono annoverate le antiche tradizioni:
-
U
zugghi,
un canto popolare augurale che viene cantato davanti agli uscì degli amici e
delle persone care, fino a quando non si è invitati ad entrare, per ricevere
l'offerta (spesso una cena) facendo festa insieme al commensale;
-
e
delle focere, falò rionali che vengono accesi la notte di Natale.
È tradizione a San Giovanni in Fiore e in Sila, accendere la notte santa la focera,
con l'intento di creare quel calore di cui nella leggenda popolare tanto aveva
bisogno Gesù bambino.
Il
costume tradizionale di San Giovanni in Fiore è "ù ritùartu",
indossato dalla donna, che assume il nome di "pacchiana".
"U rituarto" e la "Pacchiana", sono stati oggetto di studi
e di interesse da parte di antropologi ed etimologi.
Non vi è un abito maschile locale, ma indumenti tipici come il manto (mantello)
e le calandrelle (tipici calzari).
Pag.
2 
Fonte: