Abbazia
Florense
L'Abbazia
Florense è uno dei
più grandi edifici religiosi della Calabria e,
grazie all'imponenza dell'intero complesso badiale è considerato, insieme al santuario
di San Francesco di Paola,
il più importante edificio religioso della provincia di Cosenza. Fa parte
dell'arcidiocesi
di Cosenza-Bisignano.
Fu il primo edificio di San Giovanni in Fiore, decretando così la nascita del
borgo.
Le
origini dell'Abbazia Florense racchiudono una storia ricca di avvenimenti e
coincidenze, che hanno portato con un lungo cammino alla realizzazione del
complesso monastico. La principale delle cause, è sicuramente la ricerca di
una nuova ”fonte di spiritualità” da parte del fondatore del monastero, Gioacchino
da Fiore. Il futuro
abate viaggiò da giovane, per alcune abbazie, venendo a contatto con vari
ordini monastici, tra cui quello cistercense.
Da giovane, infatti, fu prima accolto presso l'Abbazia
di Santa Maria della Sambucina nei
pressi di Celico;
in seguito soggiornò nel monastero
di Corazzo,
divenendone priore e poi abate. Recatosi nel 1183 presso l'abbazia
di Casamari, nel
Lazio, con l'intento di far accorpare il cenobio di Corazzo all'Ordine
Cistercense, Gioacchino affinò la propria spiritualità, scorgendo un bisogno
di meditazione fino ad allora mai capitatogli. Fu così che insieme a un
compagno decise, fra la Pasqua del 1186 e il febbraio del 1188 di salire sulla Sila alla
ricerca di un luogo per abitare. Si fermarono dapprima presso la località di
Pietra Lata, ma il luogo non piacque all'abate, che decise di proseguire il
cammino e risalire ancora i monti della Sila. Superato il fiume Lese,
i due giunsero presso una radura sul versante orientale della Sila, presso una
vasta foresta di boschi, nella valle del fiume
Arvo. La località
sembrò perfetta a Gioacchino, che decise di stabilirvisi e di edificarvi il
monastero, dedicandolo a San
Giovanni Evangelista.
Nella
località di “Iure Vetere” Gioacchino, fondò quella che sarà la sua
prima abbazia. Cominciata nel 1189 e terminata nel 1198, l'abbazia di “Iure
Vetere” era ubicata in un luogo perfetto secondo Gioacchino, ove regnasse la
pace e la tranquillità, e dove si potesse rigenerare la spiritualità
perduta. Assieme al monastero vennero realizzate anche alcune dipendenze a
utilizzo dei monaci, a cui vennero affidate terre per la coltivazione e il
pascolo. La realizzazione del nuovo monastero non fu semplice, soprattutto
“perché si dovettero combattere le controversie con i monaci Basiliani del
vicino Monastero
dei Tre Fanciulli, in
quanto questi ultimi si servivano delle terre donate all'abate, per farvi
pascolare i loro greggi”. Nel
1214 un vasto incendio devastò il protocenobio di Iure Vetere e tutti i suoi
edifici contigui. Le condizioni climatiche del luogo incisero molto sulla
scelta dei monaci florensi, che decisero di abbandonare per sempre il vecchio
protocenobio.
Il
sito della prima fondazione florense venne ritrovato nel 2001, attraverso una
campagna archeologica diretta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Calabria e condotta dal gruppo di ricerche dell'IBAM di Potenza.

Dopo
l'incendio di “Iure Vetere”, i monaci florensi vennero aiutati da alcuni
loro benefattori, tra i quali il conte Stefano di Crotone, che trovò loro una
prima sistemazione nelle sue proprietà presso Cerenzia.
I monaci cominciarono subito a porsi il problema se restaurare il vecchio
monastero e restare sul luogo scelto da Gioacchino o fondarne uno nuovo. La
seconda opzione era quella più gradita ai monaci e dall'abate Matteo, anche
perché Iure Vetere era una zona ove vivere era difficile, sferzata quasi
tutto l'anno da un vento gelido e da un clima rigido, e dove in inverno la
temperatura scende costantemente sotto lo zero. Si decise quindi trasferire la
nuova abbazia in un nuovo sito. Al nuovo progetto venne incontro l'imperatrice Costanza
d'Aragona, che donò
all'ordine gioachimita altri beni demaniali, per ripagare i monaci dei danni
subiti con l'incendio, e invocò l'aiuto di feudatari ed ecclesiastici,
affinché si potesse sopperire ai bisogni degli stessi monaci.
Le
donazioni arrivarono da più parti e i monaci poterono finalmente dedicarsi
all'impiego per la costruzione della nuova chiesa. La prima scelta riguardava
il sito del nuovo monastero. Papa
Innocenzo III, conscio
del clima della Sila e delle difficoltà di viverci, consigliò ai monaci di
discendere l'altipiano alla ricerca di aree più miti. I monaci comunque non
vollero abbandonare le foreste silane, decidendo di scendere solo di qualche
centinaio di metri dal luogo di Iure Vetere.
Nel 1215 venne scelto un costone roccioso nella valle del fiume Neto,
vicino alla confluenza con il fiume
Arvo. Il luogo apparve
subito più ameno del precedente, con maggiori possibilità di costruire il
monastero e vivervi serenamente. Il clima era di fatto più mite, e a valle
del costone fino al fiume vi erano terreni adatti sia al pascolo sia alla
coltivazione. Per dare continuità al primo messaggio gioachimita, l'abate
Matteo e i monaci florensi decisero di nominare la località scelta Fiore o
“Fiore Nuovo”.
 Negli
anni 2007-2008 l'ala est e il chiostro sono stati oggetto di ricerche e scavi
archeologici diretti della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria. Nel corso di tali ricerche è
stata individuata l'officina vetraria dell'abbazia,
operante sul finire del XII secolo, dove sono state prodotte le vetrate
policrome ritrovate in tracce nel corso degli scavi. Altra scoperta è la
messa in luce dei piedritti di un portale monumentale, con fosso-trabocchetto
interno, che consentiva l'accesso all'ala est per chi proveniva dalla valle
sottostante.
Negli
anni 2007-2008 l'ala est e il chiostro sono stati oggetto di ricerche e scavi
archeologici diretti della Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria. Nel corso di tali ricerche è
stata individuata l'officina vetraria dell'abbazia,
operante sul finire del XII secolo, dove sono state prodotte le vetrate
policrome ritrovate in tracce nel corso degli scavi. Altra scoperta è la
messa in luce dei piedritti di un portale monumentale, con fosso-trabocchetto
interno, che consentiva l'accesso all'ala est per chi proveniva dalla valle
sottostante.
Intorno
al 1230 l'Abbazia Florense venne terminata. L'opera apparve subito imponente,
in un luogo quasi sperduto e difficile come quello silano.
Nel corso del tempo infatti, ha subito numerosi rimaneggiamenti e modifiche,
spesso seguendo le tendenze architettoniche dei vari periodi, ma perdendo in
questo modo l'originaria struttura architettonica. La prima impronta
architettonica che si nota dell'Abbazia Florense, è certamente di marca romanica.
L'impianto del complesso badiale, è di forma quadrata e vede al centro un
grande chiostro ad archi ogivali. La pianta dell'edificio ecclesiastico è
invece a croce
latina, con l'abside
di forma rettangolare orientata verso oriente.
Fra
gli ultimi stili architettonici del quale si ha testimonianza, prima
dell'ultimo restauro del 1989, vi è lo stile barocco.
Questo importante e poderoso cambiamento all'interno dell'abbazia coinvolse
l'intero patrimonio religioso di San Giovanni in Fiore. Dal 1600 in poi,
praticamente tutti gli edifici di culto posti nell'abitato cittadino hanno
subito interventi che ne hanno cambiato gli interni, adattandoli allo stile
barocco: in quel periodo l'intera collettività silana viveva un momento di
profuso sviluppo economico. Lo stile barocco è poi passato indenne negli
ultimi secoli, giungendo a noi così come praticamente si presentava più di
quattro secoli fa.
Dopo
il restauro del 1989, l'interno dell'Abbazia era irriconoscibile: tutti gli
altari e gli stucchi barocchi erano stati rimossi; al loro posto si vedeva un
muro di colore giallo. Successivamente, negli interni fu rimossa la tinta
gialla e fu così lasciato il muro a vista. L'edificio è segnalato nei
"Monumenti Vivi - Siti importanti per la Fauna", il primo in
Calabria, in quanto ospita da tempo diversi uccelli selvatici nidificanti e
per questo luogo importante per la biodiversità da tutelare.
ARCHITETTURA
- L'ingresso
dell'Abbazia è mutato nella sua quasi millenaria vita. Dell'ingresso
originale rimane solo il portone mentre è andato perduto il nartece e la
facciata ha più volte mutato d'aspetto.
 La
facciata dell'abbazia si presenta oggi molto semplice e snella, con la cuspide
che forma una capanna. Non ci sono decorazioni imponenti, tranne il portone.
Lavorato è, invece, il foro sopra il portone che presenta un anello interno e
uno esterno più sporgente in pietra lavorata.
La
facciata dell'abbazia si presenta oggi molto semplice e snella, con la cuspide
che forma una capanna. Non ci sono decorazioni imponenti, tranne il portone.
Lavorato è, invece, il foro sopra il portone che presenta un anello interno e
uno esterno più sporgente in pietra lavorata.
Il
portale è stato realizzato in pietra calcarea finemente lavorata e
costituisce l'unico tratto distintivo di tutta la facciata.
L'ingresso
è più elevato del piano della navata, infatti bisogna scendere alcuni
gradini per accedervi. Le decorazioni poste sul portale presentano dei fregi
di foglie dentellate sormontati da una fascia classica, che separa il portone
dalla parte più alta. La parte superiore è composta da una serie di archi
ogivali che formano quattro cornici. Lavorati sono anche i capitelli e le
colonne ai lati dell'ingresso. Il portone dell'ingresso è di legno ed è
recente, sostituito nel restauro del 1989. Termina in alto con l'intersezione
degli archi e cerca di riprendere la semplicità del portone precedente al
restauro.
L'ingresso
principale del monastero ha ospitato in passato anche il nartece.
Oggi gli unici segni rimasti del porticato coperto sono appena visibili, e
tali segni si possono notare solo attraverso delle sporgenze dalla muratura
sul lato destro del portone e da una fila ben delineata al di sopra dello
stesso portone, dalla quale partiva la copertura. Il nartece abbaziale era
probabilmente formato da un porticato costituito da tre arcate per lato.
Con molta probabilità, anche il nartece fu andato distrutto da un incendio,
come si vede ancora oggi dall'annerimento della facciata dell'abbazia, che ne
distrusse completamente la copertura, mentre le mura restanti furono
successivamente smontate e recuperate per essere riutilizzate nella
costruzione delle imponenti sovrastrutture barocche del XVIII secolo.
L'abside
è forse l'elemento di maggiore pregio di tutta l'abbazia. Si rifà
all'architettura tardo romanica del periodo e presenta una finestra circolare
esalobata, al centro di un triangolo ai cui vertici vi sono tre piccole
finestre circolari quadrilobate. Sotto questi quattro elementi circolari si
trovano tre ampie monofore, che nella dimensione del complesso disegno, non
superano i lati delle piccole finestre circolari. Secondo alcuni studiosi, il
disegno dell'abside si rifà ad alcune chiese francesi di stile romanico. Gli
elementi utilizzati appartengono chiaramente al periodo romanico: infatti
quest'abside è molto simile alla famosa Abbazia
di Casamari, nel
Lazio, costruita nello stesso periodo dell'Abbazia Florense. Altri studiosi
sostengono che la disposizione delle finestre circolari seguirebbero
l'espressione e il pensiero gioachimita della Santissima Trinità, ma tale
accostamento è privo di elementi significativi, e pertanto non viene né
citato né rappresentato nelle tavole del Liber Figurarum.
Il
campanile, posto a lato dell'abside nella parte più elevata del tetto della
stessa, ha forma di parallelepipedo regolare. Presenta una sommità più
lavorata, con quattro archi a tutto sesto realizzati lungo i lati della parte
più elevata del campanile, mentre il tetto, regolare, funge da grande
capitello. Nel campanile sono presenti due campane:
-
La
I, chiamata "Campana Tambati" in onore di un abate, è stata fusa in
una data imprecisata e rifusa in seguito a un danno per caduta, come scritto
sulla campana, nel 1774;
-
La
II, chiamata "Campana dell'abate Nicola", è stata fusa tra il 1200
e il 1400.

L'interno
modificato con l'ultimo restauro del 1989 si presenta oggi in stile
romanico a pietra
nuda, come lo era originariamente. Sulle pareti dell'interno non sono presenti
sculture, fregi, decorazioni, dipinti, statue, guglie, e qualsiasi altra forma
decorativa, affinché
«…non
vi fosse nulla che ostentasse superbia, vanità o potesse corrompere la
povertà, custode di virtù»
("Regola
Florense").
Dalla
pianta a croce, si possono notare una grande navata centrale e due navatelle
laterali, ottenendo in questo modo, tre luoghi separati. Le navate laterali si
collegano alla navata laterale da ingressi posti nei pressi dell'altare.
Dalla
cappella di sinistra è possibile accedere alla cripta.
La
navata centrale dà subito l'impressione dell'imponenza dell'abbazia. Dalla
soglia del portale si scendono alcuni gradini rilevando che la soglia del
pavimento si trova sotto il piano esterno di 90 cm. Il pavimento,
restaurato negli anni
1980 non era come
lo si trova allo stato attuale. Molto probabilmente era vario, con soglie
differenti che delimitavano differenti ambienti nella stessa navate. Le pareti
alte e verticali, rendono immediatamente l'ampiezza e la profondità
dell'edificio. Le pareti, ritornate allo stato attuale dopo il grandioso
restauro degli anni ottanta, si presentano spoglie, quasi stanche,
rimaneggiate in molte parti a causa del continuo rinnovamento e cambiamento di
stili che l'abbazia ha avuto nei secoli.
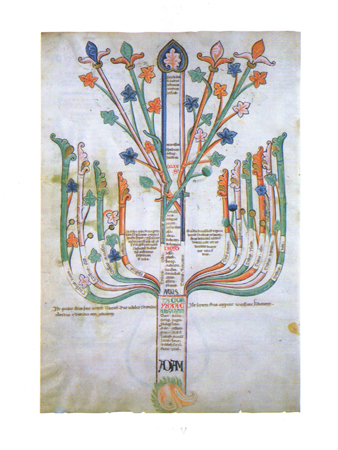 In
alto sono presenti quattro monofore per lato. Queste sono state riaperte dopo
che vennero chiuse e sostituite dalle finestre barocche più grandi, a forma
di rettangolo con gli angoli smussati. Le finestre barocche vennero chiuse
nell'ultimo restauro perché non conformi con l'aspetto originario
dell'edificio. Ai lati delle pareti vi sono quattro porte. Tre di queste sono
murate e un tempo collegavano la navata centrale a locali non più esistenti o
per lo meno completamente diversi da come si presenta oggi il complesso
badiale. Solo una porta è ancora oggi “attiva”, la prima porta a sinistra
dopo l'ingresso, che collega la navata centrale alla navatella laterale. In
fondo alla navata centrale si staglia l'altare in stile barocco, e ben è
visibile l'abside in fondo, con le caratteristiche finestre circolari.
Sopra l'altare in prossimità dell'abside è possibile scorgere dalla navata
centrale i matronei (o
cori notturni).
In
alto sono presenti quattro monofore per lato. Queste sono state riaperte dopo
che vennero chiuse e sostituite dalle finestre barocche più grandi, a forma
di rettangolo con gli angoli smussati. Le finestre barocche vennero chiuse
nell'ultimo restauro perché non conformi con l'aspetto originario
dell'edificio. Ai lati delle pareti vi sono quattro porte. Tre di queste sono
murate e un tempo collegavano la navata centrale a locali non più esistenti o
per lo meno completamente diversi da come si presenta oggi il complesso
badiale. Solo una porta è ancora oggi “attiva”, la prima porta a sinistra
dopo l'ingresso, che collega la navata centrale alla navatella laterale. In
fondo alla navata centrale si staglia l'altare in stile barocco, e ben è
visibile l'abside in fondo, con le caratteristiche finestre circolari.
Sopra l'altare in prossimità dell'abside è possibile scorgere dalla navata
centrale i matronei (o
cori notturni).
La
navatella laterale, dalla quale si può accedere sia da una porta laterale che
si affaccia sulla piazzetta antistante il portale dell'abbazia, sia da una
porticina che la collega alla navata centrale, è stata rimaneggiata e
modificata più volte nel corso dei secoli. In alcune foto dell'epoca appare
diroccata con alberi e piante nel proprio interno, segno di una profonda
incuria. Dopo l'ultimo restauro, è stata riaperta al pubblico e oggi ospita
la mostra permanente delle tavole del "Liber Figurarum", le opere
artistiche di Gioacchino da Fiore, che racchiudono il pensiero e l'immaginario
gioachimita.
L'altare
in stile barocco è un'opera del maestro di arte lignea Giovanbattista
Altomare, originario di Rogliano.
Realizzato nel periodo del barocchi mento dell'abbazia, l'altare è datato
1740, data incisa dal maestro sull'opera realizzata. L'altare, che poggia su
una base rialzata, presenta elementi riccamente decorati, intagli preziosi nel
legno che sono stati poi dorati dal maestro. Gli elementi utilizzati con più
frequenza sono la foglia dorata e teste di putti. È un vivido esempio di arte
barocca che partendo dal basso, con la mensa eucaristica posta sui gradini,
presenta una base a forma di parallelepipedo imponente con al centro il
tabernacolo, mentre salendo fino in cima, lo stile rigoglioso delle foglie,
racchiude la nicchia contenente la statua del patrono della città, ossia san
Giovanni Battista.
Dietro
l'altare sta il coro ligneo, opera di autore sconosciuto. Il coro è
intagliato in legno di noce, finemente lavorato. Era utilizzato un tempo dai
religiosi che risiedevano nel monastero e che in questa parte dell'edificio si
dedicavano ai canti liturgici.
Sala
esposizioni delle tavole del Liber Figurarum - Posta
presso la navatella laterale dell'Abbazia Florense, il cui accesso è sito di
fianco il portale dell'abbazia, quest'esposizione permanente raccoglie le
litografie delle Tavole del Liber
Figurarum, opera
figurativa di Gioacchino da Fiore, considerata «la più bella ed importante
raccolta di teologia figurale e simbolica del Medio Evo».
Le tavole figurative, oggetto ancora oggi di studi da parte di enti,
fondazioni e università, e che per il loro simbolismo sono considerate
gioielli d'arte di inestimabile valore,
queste riproducono, attraverso l'arte del disegno, tutto il pensiero
gioachimita, pensiero studiato in tutto il mondo. La sala esposizioni,
è gestita dal Centro Studi Gioachimiti.
Chiesa
dell'Annunziata
La chiesa
dell'Annunziata è una piccola chiesa di San
Giovanni in Fiore realizzata nel 1653.
La
chiesa deve la propria nascita grazie alla “Confraternita
dell'Annunziata”, confraternita composta da muratori, scalpellini e
carpentieri. Edificio dalla modestissime dimensione ma di grande pregio
storico, poiché in passato era contigua alla chiesa
di Santa Maria delle Grazie (San Giovanni in Fiore), creando un
complesso monumentale di due chiese differenti per dimensioni fra di loro,
simili però nel contesto architettonico. È rimasta aperta fino agli anni
'70, e dopo di allora è rimasta quasi sempre chiusa, tranne in occasione del
recente restauro del coro ligneo (mai esposto), e in occasione di
un'importante fiera provinciale.
 Il
piccolo edificio sacro è noto anche perché al proprio interno, e più
precisamente nel pavimento della chiesa, sono custodite le spoglie di Giuseppe
Miller e Francesco Tesei, due patrioti italiani facenti
parte del gruppo della spedizione dei Fratelli
Bandiera, caduti durante il conflitto a fuoco che si tenne tra il
gruppo dei rivoltosi e la guardia urbana di san Giovanni in Fiore.
Il
piccolo edificio sacro è noto anche perché al proprio interno, e più
precisamente nel pavimento della chiesa, sono custodite le spoglie di Giuseppe
Miller e Francesco Tesei, due patrioti italiani facenti
parte del gruppo della spedizione dei Fratelli
Bandiera, caduti durante il conflitto a fuoco che si tenne tra il
gruppo dei rivoltosi e la guardia urbana di san Giovanni in Fiore.
Attaccata
un tempo alla Chiesa madre di Santa Maria delle Grazie, la piccola chiesa
dell'Annunziata fu costruita e modificata seguendo gli stessi stili
architettonici di quest'ultima. Non ci sono precise notizie sul perché sia
stata eretta realizzando parte dell'abside e fissandolo con il campanile della
Chiesa madre. Probabilmente vi era un passaggio comunicante fra le due chiese,
che in questo modo apparivano come un complesso monumentale rilevante. Intorno
al 1930 fu abbattuta la parete che collegava le due chiese in modo da poter
creare un secondo accesso alla piazza antistante la Chiesa madre.
La
facciata ripropone il tema seguito per la Chiesa madre. Il portale è ad arco
a tutto sesto, con colonne semplici, realizzato con pietra del luogo.
Al di sopra del portale vi è un'ampia finestra ad arco
ribassato. L'interno è barocco,
di modeste dimensioni e con una pavimentazione risalente alla metà del 1800.
Vi è un coro ligneo barocco, realizzato nel 1760, intagliato e decorato da
artigiani calabresi, e recentemente restaurato. Vi era in passato un'altra
opera di rilievo, un gruppo ligneo raffigurante l'annunciazione a Maria
Vergine, ma nel 1970, fu trasferito nella vicina Chiesa madre. Anche il
campanile richiama lo stile architettonico della Chiesa madre, ed è
considerato uno dei migliori esempi meglio conservate, degli artigiani
scalpellini del luogo.
La
chiesetta ha avuto da sempre la sua storia concatenata con la Chiesa madre, e
il muro che collegava le due chiese ne era l'emblema più evidente. Non si può
parlare della chiesa dell'Annunziata tralasciando la storia della Chiesa
madre.
La
chiesetta ha subito profondi interventi che ne hanno cambiato l'aspetto, anche
se la pianta originaria e il campanile sono rimasti praticamente esenti da
tali interventi. Nel 1930 la demolizione del muro che la collegava con la
Chiesa madre è stato il più importante. La facciata e il campanile vennero
restaurati negli anni ‘70 in concomitanza con i lavori di restauro per gli
stessi elementi della Chiesa madre, mentre sono rimansti immutati gli interni
barocchi.
Dopo il restauro fu chiusa al pubblico. Aperta negli ultimi anni solo per
asportare e far restaurare il coro ligneo barocco da un'équipe di
restauratori dell'Università di Pisa, la chiesa anche dopo il restauro del
coro ligneo continua a rimanere chiusa e non è programmata una sua imminente
riapertura al pubblico. La chiesa si raggiunge percorrendo le scale che dalla
piazza antistante la Chiesa madre di Santa Maria delle Grazie porta all'abbazia
Florense.
Convento
dei Padri Cappuccini
Il convento
dei Padri Cappuccini è il terzo edificio religioso edificato per ordine
cronologico, dopo l'abbazia
Florense e la chiesa
madre.
La storia dei
Cappuccini e il loro arrivo nella terra di San Giovanni in Fiore, risale al
1500. Nel casale florense, infatti, la famiglia francescana vi aveva da tempo
una casetta che utilizzava come ospizio, dimora d'appoggio per le lunghe
attraversate che i frati intendevano fare risalendo i monti della Sila, sia
dal lato occidentale di Cosenza che
da quello orientale di Crotone e
del marchesato crotonese. L'ospizio era utilizzato anche per i frati che
praticavano la pastorizia, e che secondo pratica della transumanza,
passavano il periodo estivo sui monti silani.
L'apertura di
un convento in quel periodo, non era nei programmi della provincia monastica
di Cosenza, sia in quanto la realizzazione di altri conventi erano stati
programmati nelle città di Amantea, Strongoli, Piane
Crati e Castiglione
Cosentino e necessitavano di ultimazione dei lavori e
completamento delle strutture principali, sia perché la struttura esistente
dell'ospizio, riusciva a soddisfare le esigenze dei frati silani. Nel 1614,
Francesco Maria di Majo, notaio cosentino di ricca famiglia, fece dono alla
provincia monastica, di un pezzo di terra posto su un colle che dominava
l'allora piccolo centro urbano di San Giovanni in Fiore e il complesso
monastico florense.
Per i motivi
già citati, i lavori di realizzazione del convento non iniziarono
immediatamente, ma ci vollero ben 25 anni prima che la provincia monastica
decidesse l'inizio dei lavori. Nel 1636 si iniziò alla deforestazione
dell'area e allo sbancamento del colle, e dopo 3 anni, cominciarono i lavori
di edificazione del convento, che verrà ultimato tra il 1648 e il 1649.
Il convento
non ebbe vita facile nel corso dei suoi anni. Subì infatti, una serie di
soppressioni la prima delle quali nel 1811 in base ad alcune disposizioni
legislative murattiane. Occupato dai monaci elemosinieri, subì un ulteriore
soppressione nel 1866 e accorpato al comune di San Giovanni in Fiore. Passò
in mano a D. Saveria Lopez che lo tenne in custodia cercando nel frattempo di
farvi ritornare i frati Cappuccini, cosa che avvenne solo mezzo secolo dopo,
ed esattamente nel 1923. All'ultima ripresa delle attività pastorali dei
frati, come segno di riconoscenza il comune concesse al convento l'orto
circostante.

La prima
edificazione prevedeva una pianta a forma di quadrilatero, uno stile
architettonico comune a tutti i conventi dei Cappuccini in Calabria. Al centro
di questo quadrilatero vi è il chiostro con pozzo per l'acqua, mentre la
chiesa, allora realizzata ad unica navata, sorse in direzione est-ovest, con
la facciata rivolta ad oriente.
L'ingresso
principale del convento è posto sulla sinistra della navata, con un lungo
corridoio perimetrale coperto per evitare le intemperie invernali. Vi è un
altro ingresso posteriore, che si raggiunge attraversando l' “orto” del
convento.
Il corridoio
alla quale si accede dall'ingresso del convento, dà accesso ai locali della
sagrestia posti dietro l'altare, mentre per accedere al convento, realizzato a
due piani, si deve salire una scala interna (un tempo in legno) posta sul lato
occidentale basso, del chiostro.
 L'attuale
sagrestia, che prima era posta negli odierni uffici del convento, un tempo era
utilizzata come coro, luogo di canto dei frati, prima che questo venne
spostato e realizzato sopra il portale centrale della chiesa attuale.
L'attuale
sagrestia, che prima era posta negli odierni uffici del convento, un tempo era
utilizzata come coro, luogo di canto dei frati, prima che questo venne
spostato e realizzato sopra il portale centrale della chiesa attuale.
Il piano
terra ospitava i locali della foresteria, dei laboratori, della legnaia, i
ripostigli e le dispense, la cantina, e il refettorio con annessa cucina. La
sala mensa, oggi saletta multifunzione, ospita una grande tela de “L'ultima
cena”, opera di metà secolo scorso. Il piano superiore è cinto da
un loggiato realizzato con arcate edificate sul chiostro del piano inferiore,
ed ospita i locali del dormitorio e delle celle dei frati. Dal secondo piano
si accede al nuovo coro realizzato nel primo decennio del secolo scorso, dai
maestri falegnami probabilmente della famiglia degli “ottavi”. Al secondo
piano vi è una sala adibita a cappella per i frati malati che non potevano
assistere direttamente alla messa, altre sale per uso comune, e una ricca
biblioteca ove intraprendere ed approfondire gli studi di teologia, storia,
filosofia, greco e latino.
La navata
centrale ospita un altare ligneo in stile barocco riccamente decorato, con
presenza di numerosi intagli e motivi floreali, opera probabilmente di maesti
ebanisti roglianesi.
Il ciborio intarsiato
è un'opera che si fa risalire a frate Felice Maria da San Giovanni in Fiore.
Sulla parete ai lati dell'altare sono presenti due piccole nicchie contenenti
due piccole statue raffiguranti Santa
Veronica Giuliani e la Beata
Maria Maddalena Martinengo. Al centro dell'altare vi è una grande tela
raffigurante la "Vergine in gloria tra i cieli", ossia Santa Maria
delle Grazie, opera del 1797 dell'artista calabrese Cristoforo
Santanna, che ha affrescato anche la volta della navata centrale con
una raffigurazione della "Madonna con il Bambino Gesù".
La navata
laterale ospita anch'essa un altare ligneo in stile barocco, finemente
lavorato, risalente al '700. L'altare con colore in legno naturale, risale con
molta probabilità agli stessi artisti roglianesi autori dell'altare della
navata centrale, è presenta decorazioni floreali, mentre al proprio interno
custodisce la statua di Sant'Antonio anch'essa
lignea risalente alla stessa epoca dell'altare. Sul lato destro della
navata vi è un grande dipinto olio su tela raffigurante il Beato
Angelo d'Acri, opera di un certo F. Fontana del 1925, mentre su un
rosone della volta si può ammirare un affresco con Sant'Antonio, opera di Francesco
Giordano da Policastro del 1761.
Il convento
sorse al centro di una grande area (un ettaro circa), che doveva essere
utilizzata ad orto per la produzione delle derrate alimentari ad uso e consumo
del convento. Il lato nord dell'area, fu spianato e reso pianeggiante, mentre
il lato meridionale, scosceso, fu interessato da lavori di terrazzamento.
L'area, era attraversata dall'acquedotto badiale (acquaro), opera dei monaci
florensi di ben 400 anni prima, e grazie ad una serie di diramazioni, fu
possibile utilizzare l'acquedotto per scopi idrici e per i servizi igienici,
mentre per l'acqua potabile si fece riferimento al pozzo creato al centro del
chiostro. L'orto era attraversato da un sentiero che collegava il convento ad
una strada pubblica, probabilmente la sielica, la prima strada pubblica
realizzata in paese. Alla coltivazione dell'orto provvedevano solo i frati più
esperti, mentre i chierici avevano solo il compito di aiutanti.
 Con
la riapertura, il convento subì una progressiva ma vigorosa crescita numerica
dei frati. Tale crescita costrinse ad effettuare numerose e continui
interventi edilizi su tutta la struttura, per migliorare sia lo stato del
vecchio edificio, sia con lo scopo di ampliare il complesso monastico, poiché
le strutture esistenti si presentavano completamente inadeguate alle esigenze
della oramai numerosa comunità francescana.
Con
la riapertura, il convento subì una progressiva ma vigorosa crescita numerica
dei frati. Tale crescita costrinse ad effettuare numerose e continui
interventi edilizi su tutta la struttura, per migliorare sia lo stato del
vecchio edificio, sia con lo scopo di ampliare il complesso monastico, poiché
le strutture esistenti si presentavano completamente inadeguate alle esigenze
della oramai numerosa comunità francescana.
Nel 1960 si
cominciò a discutere dell'ammodernamento della struttura convittuale e
dell'ampliamento del convento. La commissione edilizia-economica provinciale
decise di effettuare interventi consistenti sul convento di San Giovanni in
Fiore, in quanto la struttura si presentava "quasi decadente" con
necessità di restauri immediati. Nel frattempo si optò per un progetto
complessivo che prevedeva anche l'ampliamento della struttura attraverso il
prolungamento dell'ala meridionale dalle parti del sagrato.
La nuova
struttura venne ultimata tra il 1973 e il 1974, una struttura moderna che
modificò l'assetto complessivo del convento. La nuova ala infatti, poteva
ospitare le nuove celle per i frati con nuovi e moderni servizi igienici. Ciò
permise di poter metter mano alla vecchia struttura, con risultati che però,
compromisero l'originale struttura. Vennero infatti eseguite alcune opere di
demolizione di un muro che non si ritenne portante, ma nel prosieguo dei
lavori, la demolizione portò al crollo di una consistente parte della
muratura interna, con il rischio anche per alcuni oparai che finirono sotto le
macerie, fortunatamente senza subire conseguenze.
Il crollo
modificò sostanzialmente il progetto iniziale, facendo optare per un completo
rifacimento dell'interno della struttura, utilizzando incautamente materiali
estranei all'originale muratura, e sopraelevando ed alterando in maniera
consistente il chiostro.
Nel 1989 avviene l'ultima consistente ristrutturazione del complesso
conventuale, attraverso l'utilizzo dei fondi previsti dal Piano del
Sottoprogramma dei Beni Culturali - triennio 1989-1991. Gli interventi furono
concentrati nella rimozione di alcune coperture di tutta la struttura, del
cambio di porte ed infissi, ma l'intervento più importante venne effettuato
sulla chiesa, che venne stonacata, riportando alla luce le vecchie murature in
pietra perimetrali.
La chiesa
conserva 14 quadretti dipinti olio su tela, raffiguranti la via
crucis, opera firmata dall'artista Francesco
Giordano da Policastro e risalente al 1745.
Nella sagrestia vi
si trova un armadio del 1762 finemente lavorato ed ancora in utilizzo da parte
dei frati, opera di intagliatori esporti del luogo. Sempre in sagrestia si
trova un crocifisso in legno risalente ad epoca di dominazione spagnola, fatta
restaurare di recente ed esposta in occasione della Pasqua. Il convento nel
1742 ospitò per alcuni giorni un "capitolo provinciale" al quale
partecipò anche il Beato Angelo d'Acri, che nell'occasione portò in
processione un crocifisso che piantò in una roccia di granito nelle
vicinanze. La croce oggi si trova eretta su una collona, nel sagrato dal
convento. Una statua dell'Immacolata è custodita all'interno della chiesa,
statua realizzata alla fine del '600.

Altri
edifici religiosi
Chiesa
del Madonna del Carmelo - La Chiesa della Madonna del Carmelo (o del Carmine),
di semplice stile barocco, è posta nel versante sud del centro abitato, nel
rione Costa. Fu costruita dopo il 1790, per volere degli abitanti del
quartiere, che molto numerosi in quel periodo, pretesero la realizzazione di
un edificio di culto nella loro rione. Con molta probabilità i lavori hanno
avuto inizio nella seconda metà dell'Ottocento.
Chiesa
dell'Ecce Homo - La Chiesa
dell'Ecce Homo (o santuario dell'Ecce Homo) si trova nel
quartiere periferico di "Palla Palla". Realizzata nel 1700 quando il
quartiere era una frazione del comune di San Giovanni in Fiore, distante da
questo alcuni chilometri. Nel mese di giugno la chiesa e la zona circostante
è animata dalla festa dell'Ecce Homo, che richiama, oltre ai cittadini
sangiovannesi, anche popolazioni dei comuni limitrofi.
Chiesa
di San Francesco di Paola - La Chiesa di San Francesco di Paola (o Chiesa
del Crocefisso) sorge in posizione extraurbana nella parte più meridionale
del centro storico, lungo la strada che porta in località Iunture.
Costruita nel 1774, si conserva integra nelle forme originarie. L'interno
della chiesa è stato trasformato da un restaurato effettuato nel 1974 che ha,
comunque, mantenuto, senza alterarla eccessivamente, la tipologia della chiesa
ad unica navata. Conserva un prezioso altare ligneo.
Chiesa
di Santa Maria delle Grazie - La Chiesa di Santa Maria delle Grazie (o Chiesa
Matrice) è stata edificata intorno al 1530 dall'Abate Commendatario Salvatore
Rota. Inizialmente era ad una sola navata. Completamente demolita, venne
riedificata a tre navate nel 1770 per opera dell'Abate Commendatario Giacomo
Filomarino. Presenta un prospetto con tre portali in pietra arenaria decorati
a motivi ornamentali seicenteschi. Il portale maggiore è riccamente decorato
con motivi di ispirazione classica.
 Chiesa
di Santa Maria della Sanità - La Chiesa di Santa Maria della Sanità
(meglio conosciuta come Chiesa della Cona) fu edificata nel 1600, in uno
dei quartieri più antichi della città, oggi parte integrante del centro
storico. È di dimensioni ridotte suddivisa in tre navate.
Chiesa
di Santa Maria della Sanità - La Chiesa di Santa Maria della Sanità
(meglio conosciuta come Chiesa della Cona) fu edificata nel 1600, in uno
dei quartieri più antichi della città, oggi parte integrante del centro
storico. È di dimensioni ridotte suddivisa in tre navate.
Nel
1700 fu modificata architettonicamente con vistosi elementi barocchi, e
conserva ancora oggi un pregevole portale sobriamente decorato. Conserva
preziosi affreschi di artisti calabresi e napoletani dell'epoca.
Chiesa
di Santa Lucia - La Chiesa di Santa Lucia è stata edificata tra la
seconda metà degli anni settanta e i primi anni ottanta, dando vita ad una
nuova parrocchia assorbendo quella di San Francesco e dell'omonima chiesa.
Il
quartiere sorto intorno alla chiesa ha poi assunto lo stesso nome
dell'edificio di culto. La chiesa attuale è opera di un lungo restauro e
rifacimento della chiesa negli anni novanta.
Chiesa
di San Domenico - La Chiesa di San Domenico è stata edificata negli anni
ottanta nel quartiere dell'Olivaro, un quartiere periferico distante un paio
di chilometri dal centro urbano. L'edificio, oltre alla funzione religiosa, ha
assunto negli anni anche ruolo di centro di aggregazione sociale, ospitando al
proprio interno un oratorio ed una casa di riposo.
Chiesa
dello Spirito Santo - Ultima chiesa, per ordine cronologico, consacrata
nel centro urbano. È posta nel quartiere della "Pirainella", il
quartiere più a nord della città. Utilizza parte del vecchio capanno della
"Scuola Tappeti", in disuso dagli anni ottanta. La chiesa è stata
consacrata nel 2008.
Cappella
di San Giovanni Battista - La Cappella di San Giovanni Battista è una
piccola cappella posta in cima al quartiere del "Bacile", la
parte più alte di Monte Difesa, sopra il vecchio serbatoio del Bacile
realizzato nei primi anni del secolo scorso.
Altri
elementi religiosi
Le
croci di inizio Novecento - Nel 1912, in occasione di una “Missione di
evangelizzazione”, furono realizzate due croci, poste successivamente, in
due zone del paese, all'estremità del centro urbano. La prima croce, fu
innalzata accanto alla Chiesa
del Carmelo, chiamata “Croce della Costa”, mentre la seconda croce
venne posta sul colle Difesa, chiamata appunto “Croce della Difesa”. Le
croci sono costituite da assi in ferro, e poggiano su una base in granito
silano.
Al
centro delle croci è stato riprodotto un cuore crociato, simbolo della “Congregazione
dei Passionisti”. Ai lati della croce, in posizione obliqua vi sono
una lancia, simbolo del ferimento al costato di Gesù in croce, ed una canna
come quella utilizzata per abbeverare il Signore, durante l'agonia della
crocifissione. La base in granito silano, di forma quadrangolare, ospita
alcune incisioni fatte su tavole in marmo, ognuno delle quali riportano la
data dell'avvenimento, il maestro che ha eseguito l'opera, e alcune
esortazioni cristiane come ”Soffri e Taci” e ”Ama e
spera”. Oltre alle due croci, ve ne è un'altra, distante un centinaio di
metri dalla “Croce della Difesa” fatta realizzare alcuni decenni dopo,
sempre in ferro battuto, con elementi in legno, meno pregiata delle
altre.
L'innalzamento
delle due Croci, è legato ad un fatto increscioso della storia della comunità
silana, che venne riportato su un verbale della “Curia provinciale dei Padri
Passionisti del Santo Costato di Gesù”. Quando i missionari giunsero in
paese, la sera, dopo le laute celebrazioni eucaristiche, con seguente
processione per le vie cittadine, sia le croci che i padri vennero presi beffa
da un gruppo di anarchici probabilmente ubriachi. Il giorno susseguente,
saputo dell'accaduto, per poco non si rischiò il linciaggio dei facenti parte
al gruppo degli anarchici da parte di migliaia di fedeli, rischiando anche
tentativi di impiccare incendi alle abitazioni degli anarchici. Il tutto venne
portato alla calma il giorno successivo, quando i padri missionari, fecero due
comunioni generali, una per gli uomini e l'altra per le donne, terminate con
la benedizione delle croci e il perdono degli “attentatori”. Per questo le
croci, ancora oggi, sono simbolo del perdono religioso.
L'edicola
dell'Ecce Homo - Posta nel vecchio quartiere del "Petraro",
quest'edicola racchiude un'immagine dell'Ecce Homo. Al suo fianco vi è una
fontana, ed il luogo era un punto di sosta per i viaggiatori che si
apprestavano a scendere in paese e per i contadini che lavoravano le terre
delle zone tra "Meterire" e i "Pardici".

Pag.
1 
 Pag.
3
Pag.
3