|
Il
paese, che sorge su una collina a circa 380 metri s.l.m. (Municipio posto a 423
metri s.l.m.), si affaccia sulla piana di
Lamezia e il Mar
Tirreno, al centro del golfo
di Sant'Eufemia, sulla Costa
dei Feaci. Il territorio comunale degrada
dolcemente da est verso ovest, dalle falde delle Preserre catanzaresi
occidentali (Monte Contessa,
metri 881 s.l.m.) al litorale pianeggiante.
Offre
paesaggi e caratteristiche ambientali variegate: boschi di faggi, lecci, querce
e abeti sono presenti in alta collina. In località Vrisi si può ammirare il
Gigante Buono, un platano
orientale millenario
monumentale (Platano
orientale di Vrisi), tra i
più grandi d'Europa, mentre il pioppo nero più grande d'Italia si trova poco
più a valle, proprio all'ingresso del borgo. Per questo motivo Curinga è
conosciuta anche come "il paese dei due giganti".
Il
litorale è caratterizzato da cinque km di spiaggia libera con un ampio arenile
in sabbia silicea e dune marine che ospitano colonie di piante psammofile e una
folta macchia mediterranea con mirti e ginepri. L'intera area è stata
riconosciuta come sito di interesse comunitario. Seguendo la linea costiera, una
folta pineta ricopre tutto il litorale comunale fino a Torre Mezza Praja (Ruaddu) dove
lascia spazio a eucalipti ed a una zona umida anch'essa riconosciuta sito di
interesse comunitario. Alle spalle della pineta costiera si estende una fertile
pianura ricca di agrumeti e uliveti che interessa metà della superficie
comunale. Ai piedi delle colline si trova un'antica ed enorme duna fossile
importante testimonianza del neolitico. Il panorama collinare è caratterizzato
quasi interamente da ulivi secolari e vigneti.
L'intero
territorio è percorso da est a ovest dal torrente Turrina (Mucato / Nocato) che
sfocia nel golfo di Sant'Eufemia dopo aver attraversato la valle sottostante il
borgo e la piana. Altri corsi d'acqua presenti sono il torrente Le Grazie, il
Randace, Samboni, Tre Carlini. Curinga è ricchissima di acqua, numerose sono le
falde acquifere sotterranee e le sorgenti. Il clima è quello tipico delle
regioni mediterranee con temperature miti anche in inverno.

Curinga
ha una storia plurimillenaria. L'intero territorio comunale è infatti
ricchissimo di testimonianze storico-archeologiche.
Grazie
alle ricognizioni condotte tra il 1974 ed il 1977 da Albert J. Ammerman vengono
individuati sulla grande duna fossile (Rina) in località Prato
S. Irene i resti di alcuni abitati del periodo neolitico (databile tra la fine
del settimo e
gli inizi del terzo
millennio a. C.). Si
tratta di circa 40 capanne a pianta rettangolare, dotate di focolari. Le
abitazioni hanno pareti in incannucciata ricoperta d'argilla, con struttura
lignea formata da paletti. Basamento di pietra, struttura portante in legno,
pareti in graticcio intonacato. Il tetto, sorretto da un palo centrale o da pali
perimetrali, era di paglia o di canne, rivestito di argilla. Nei pressi sono
stati trovati materiali in ossidiana e ceramica.
Nel 1992 l’area è stata oggetto di scavo da parte della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Calabria e sulla duna venivano individuati i buchi
dei pali di un insediamento di capanne preistoriche oltre che un focolare
circolare, resti di intonaco di strutture abitative, di strumenti litici, per la
quasi totalità in ossidiana proveniente da Lipari, ceramiche con decorazioni impresse, accette levigate e fusaiole.
Riconducibile alla cultura di stentinello, individuata da Paolo
Orsi nel 1890 e cronologicamente riferibile ad una fase evoluta del
Neolitico antico, questa comunità era dedita allo sfruttamento delle risorse
agricole e allo smistamento dell’ossidiana delle Isole
Eolie verso le regioni adriatiche. Più di recente, un laboratorio di
archeologia sperimentale, supportata da analisi archeometriche eseguite presso i
laboratori dell’Università
della Calabria, è stato
sviluppato da Rocco Purri. Attraverso un approfondito studio dei materiali
originali che caratterizzano la ceramica stentinelliana di Curinga sono state
ripercorse tutte le fasi del processo di produzione: dall’approvvigionamento
della materia prima, alla realizzazione delle forme, alla loro decorazione fino
alla loro cottura. I reperti originali recuperati nella zona sono conservati
presso il Museo
Archeologico Lametino e
il Museo
Pigorini di Roma.
L'intero
territorio curinghese fa parte del regno mitologico che Omero nell'Odissea descrisse come "Terra
dei Feaci" .
Proprio
sull'estesa e sabbiosa spiaggia curinghese Ulisse approda e incontra Nausicaa. Questa lo condurrà a Scheria, da suo padre, il re Alcinoo che lo aiuterà in seguito a ritornare a Itaca.
 Furono
probabilmente questi racconti a spingere i primi coloni greci a stabilirsi
nell'area. È ragionevole ritenere che nel periodo magno-greco il litorale
curinghese fornì un comodo e utile approdo marittimo tra gli imbocchi e quindi
le vie di comunicazione verso l'interno, dell'Amato e dell'Angitola a
metà strada tra le città greche di Hipponion (Vibo
Valentia) e Temesa (Nocera T.). ll tempio di Castore
e Polluce (di cui
si conservano, all'interno del giardino di villa Cefaly, due delle quattro
colonne rinvenute), eretto dai navigatori achei che
occuparono quest'area, e successivamente inglobato dai Romani nella costruzione
delle Terme, fornisce un indizio sull'ubicazione della città greca perduta di Terina. Questa tesi tuttavia necessiterebbe di studi e campagne di scavo
approfondite e al momento non ci sono certezze sull'entità dell'insediamento
ellenico in zona, nonostante la chiara nomenclatura che individua nell'area
luoghi come Lacconia (Laconia), Calavrici (Kalavryta),
Malia (Amalias), ed ancora Argò, Argadi, Aglioca, Chinea, Moddoni, Palandara
ecc. Furono
probabilmente questi racconti a spingere i primi coloni greci a stabilirsi
nell'area. È ragionevole ritenere che nel periodo magno-greco il litorale
curinghese fornì un comodo e utile approdo marittimo tra gli imbocchi e quindi
le vie di comunicazione verso l'interno, dell'Amato e dell'Angitola a
metà strada tra le città greche di Hipponion (Vibo
Valentia) e Temesa (Nocera T.). ll tempio di Castore
e Polluce (di cui
si conservano, all'interno del giardino di villa Cefaly, due delle quattro
colonne rinvenute), eretto dai navigatori achei che
occuparono quest'area, e successivamente inglobato dai Romani nella costruzione
delle Terme, fornisce un indizio sull'ubicazione della città greca perduta di Terina. Questa tesi tuttavia necessiterebbe di studi e campagne di scavo
approfondite e al momento non ci sono certezze sull'entità dell'insediamento
ellenico in zona, nonostante la chiara nomenclatura che individua nell'area
luoghi come Lacconia (Laconia), Calavrici (Kalavryta),
Malia (Amalias), ed ancora Argò, Argadi, Aglioca, Chinea, Moddoni, Palandara
ecc.
In
contrada Prato Sant'Irene e nelle adiacenze del torrente Tre Calrini è stata
scoperta una necropoli con suppellettili tardo elleniche, vestigia di età
classica si riscontrano anche nell'alveo del torrente Turrino.
Nel 1916, durante
operazioni di bonifica del torrente, venne ritrovato accidentalmente un
tesoretto di circa 300 stateri greci arcaici (VI
secolo a.C) in argento e in buono stato di conservazione, subito diviso tra gli operai
e la gente del luogo. L'intervento di Paolo Orsi e della prefettura ne scongiurò
la totale dispersione: 164 monete furono recuperate a Ravenna, 14 a Catanzaro,
11 a Pizzo, 4 a Curinga, mentre il contenitore ceramico e il resto del tesoretto
non furono più ritrovati. Provenienti dalle zecche delle città di Taranto,
Crotone, Metaponto, Sibari, Caulonia, sono attualmente conservate nel Museo
Nazionale della Magna Grecia a
Reggio Calabria.
I
romani, conquistata la Calabria, si insediarono a Curinga, nella zona di
Lacconia su quelle antiche terre che erano state dei coloni greci. Lungo la via
Popilia, che attraversa per intero il territorio comunale da nord a sud, vi
fondarono la Statio di Aque Ange (Anniae)
descritta nella Tavola
Peutingeriana.
In
località Trivio (proprietà Greco) sono leggibili avanzi attribuibili alla Statio Ad
Turres menzionata anch'essa negli itinerari romani. La stazione di posta
romana si trovava probabilmente presso il Fondaco del Fico (attualmente in stato
di rudere), e sopravvisse nelle sue funzioni fino alla meta dell'800. Di
notevole importanza doveva essere l'area, dato che vi sorse una grande villa
rustica con annesso un cospicuo complesso termale, unico in tutto il Sud Italia
a poter essere osservato ancora oggi fin quasi all'altezza della copertura. La
costruzione del complesso termale avviene tra il I ed il II secolo d.C.; esso è
composto da un atrio-ginnasio,
dal frigidarium, da un piccolo tepidarium-spogliatoio,
da due grandi calidaria, da un laconicum e da
alcuni ambienti di servizio con un sistema di copertura a volta a crociera
centrale collegata a due brevi volte a botte impostate su pilastri
quadrangolari, mentre un complesso sistema di canali ne permetteva la
circolazione dell’acqua. Il rinvenimento di una moneta bronzea dioclezianea ne colloca il pieno funzionamento intorno III - IV secolo d.C., in età
imperiale. ll momento della disattivazione del complesso termale avviene tra la
metà del IV e gli inizi del V secolo, quando venne trasformato in chiesa
gotica. Le Terme Romane sono presenti nell'elenco dei monumenti nazionali
italiani e attualmente sono interessate da una nuova campagna di scavi
archeologici.
Con
la caduta dell'Impero Romano, occupata dai Longobardi, distrutta dalle guerre
gotiche e devastata
da eventi naturali, Lacconia conobbe un forte declino, rimanendo spopolata. La
migrazione interna verso aree più salubri e sicure determinava sulle colline la
nascita di Curinga (il primo nucleo è a Calicinò, attuale rione Ospizio). La
piana iniziò a riattivarsi tra la fine del IX e il X secolo, con l'insediamento
di coloni greci, veterani armeni e traci ai quali si aggiungevano fuggiaschi
dalla Sicilia e da Reggio, flagellata dalle incursioni saracene. In questo periodo sono ambientate le vicende di Bernardino De Rubeis
che, a quanto scrive Bartolomeo Romeo, riuscì a riunire un buon gruppo di
uomini armati e a respingere da Lacconia una scorreria saracena. Nella
piana dell’ultimo periodo bizantino sono il monastero di San Nicola di
Calabrice e Santa Maria di Canna, il cenobio di Sant'Andrea a Curinga, mentre a
monte veniva edificato da monaci basiliani il cenobio di Sant'Elia, beneficato e
protetto dal basileus di Costantinopoli.
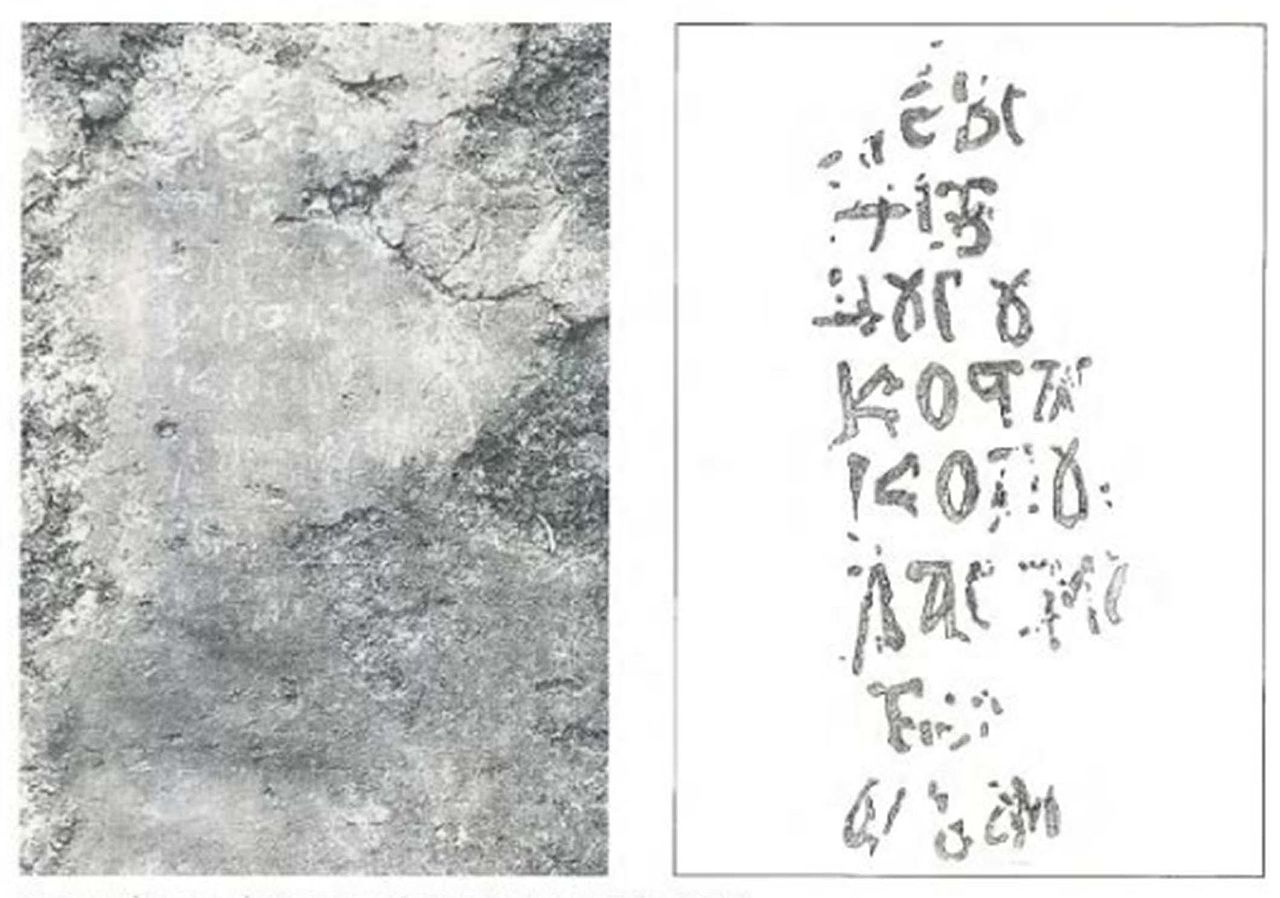
Nel
1057 Roberto
il Guiscardo con i
suoi uomini muove da nord verso Reggio. Arrivato presso il fiume Mucato
(Turrina) nei pressi di Lacconia, si accampa per due giorni per consentire ai
soldati di riposare. Ne approfitta per esplorare il territorio, contattare la
popolazione e tentare accordi con i notabili di Neokastron e Maghida. I due
borghi vengono assoggettati così come il resto della Calabria bizantina. Roberto diviene Duca dei territori conquistati, ma è costretto a cedere
metà della Calabria al fratello Ruggero.
La linea di confine sul Tirreno viene fissata seguendo il corso del torrente
Mucato. A Ruggero spetta il sud mentre Roberto andrà a nord. Il territorio di
Curinga e Lacconia in particolare sono in questo periodo confine amministrativo
tra i due territori normanni. Nel 1062 il Duca Roberto fa pressione su
Antrasillo, signore di Maida, affinché questi ceda il cenobio di Sant'Elia con
le dipendenze e i villani all'abate di S.Eufemia. Nel 1098 il Conte Ruggero, in
marcia verso Salerno, presso Lacconia firma un Diploma che concede beni e
diritti ai basiliani della zona. Sotto il dominio normanno si intensificò
l'attività agraria nella piana: cereali, canna da zucchero, oliveti, vigne ed
orti. Iniziano a comparire anche le prime colture di gelsi con conseguente
produzione tessile.
I terreni sono affidati oltre che ai conventi, alla famiglia
normanna (o nordica) dei Bono, che vantava proprietà tra Lacconia e L'Amato.
L'imperatore Federico
II, abilissimo
falconiere amante della caccia, dichiarò foresta regia (Ascrea) i boschi che
allora si estendevano alle spalle di Lacconia fin oltre L'Amato, mentre in un
privilegio rilasciato nel 1225 ai Cistercensi di Corazzo si parla della florida
tonnara presente tra Rocca Angitola e Lacconia.
La regina Costanza cedette
il feudo a Giacomo figlio di Ruggero di Sanseverino,
che nel 1354 concesse all'ordine dei Celestini il prelievo di ventiquattro
barili di tonno all'anno, privilegio confermato da re Ladislao nel 1404 e da Federico
d'Aragona nel 1488.
La tonnara rimase attiva fino alla fine XVIII secolo.
Con
la caduta di re
Manfredi, gli Angioni si
insediarono nel territorio. Nel 1269 Lacconia venne concessa a Giordano
Sanfelice mentre il cenobio di San Nicola in Calavrici divenne base operativa e
osservatorio di Gillotto Santoliceto nel suo tentativo di impadronirsi di Rocca Nicefora (Rocca Angitola), tentativo riuscito nel 1278. Ai Santoliceto, uomini
di fiducia di Carlo
I, verranno riconosciuti
i diritti su Lacconia, Curinga e Calavrici, oltre che su Maida ed il resto del
feudo. Furono anni bui per la popolazione del luogo, costretta a subire
prepotenze e angherie di ogni genere da parte dei nuovi signori. Durante il
dominio angioino, i monasteri, che tanto si erano adoperati per il rifiorire
della piana, versano in uno stato di abbandono. La popolazione insorge nel 1283
(Guerra
del Vespro), aggravando
ulteriormente la situazione economica, politica, sociale e religiosa già al
collasso a causa del fiscalismo degli Angioini, delle incursioni saracene e
dalle truppe assoldate dalle parti in lizza. Il monastero di San Nicola viene
devastato e, abbandonato dai monaci, non verrà più riedificato. Nel 1331, morta l'ultima dei Santoliceto, la civitas di Lacconia con sede protopapale e
il casale di Curinga passano prima a Goffredo
Marzano e nel 1409
alla potente famiglia Caracciolo.
Nel
1459 le truppe di Ferdinando
I scacciano gli
Angioini dal feudo, requisendo tutte le proprietà dei Caracciolo. Passate al
figlio Federico,
questi concede numerosi benefici e franchigie e gli abitanti del luogo,
diversamente dal resto della Calabria, godono di diritti e grazie. Vengono
promossi lavori di bonifica e incrementate le colture di gelso con la
costruzione di grandi trappeti per la lavorazione dello zucchero. Curinga è
sede di abili artigiani del vetro: "in un luogo vicino, Coriga, si
solevano in questi anni passati fare bellissimi vasi di vetro". Nel 1496, per far fronte all'imminente guerra, Federico dovette cedere il
feudo a Marcantonio Caracciolo. Curinga e Lacconia ritornano sotto il dominio
baronale.

Curinga
e Lacconia vengono unificati nella Contea di Nicastro vedendo un graduale
impoverimento economico. Le frequenti inondazioni a cui è soggetta Lacconia, ne
acuiscono la crisi, rendendo la piana inospitale a causa della malaria che
imperversa. A questa si aggiunge una nuova ondata di scorrerie saracene. Nel
1572 Lacconia subisce un'incursione turca durante la quale alcuni abitanti
vengono rapiti e ridotti in schiavitù. Per contrastare il fenomeno vengono erette e rafforzate le torri
di avvistamento su
tutta la costa e tra queste, la Torre di Mezzapraja già presente in epoca
angioina e la torre e il castrum di Lacconia di epoca normanna-sveva. Anche
Curinga ha il suo castello, adattato, in seguito, in palazzo-residenza dai Loffredo. Nel 1605, Marcantonio Loffredo subentra ai Caracciolo e il feudo diviene Principato. La condizione sociale tuttavia non
cambia e gli ultimi abitanti di Lacconia, ridotta ormai una palude, e
completamente rasa al suolo dal terremoto
del 1638, migrano verso
le colline. Il terremoto del 1659 e quello del 1783, in seguito, danneggeranno
fortemente anche Curinga, divenuta nel frattempo università superando Maida per
numero di abitanti (2500 c.a.). L'ultimo atto di cessione delle terre di Lacconia e Curinga è del
1670: il nuovo signore è Fabrizio Ruffo di Bagnara, prozio del più famoso Cardinale
Ruffo che nel 1799, in marcia verso Napoli per la riconquista del Regno,
trova ospitalità a Lacconia e Curinga. I suoi 4000 uomini, per la maggior parte
galeotti, si lasciarono andare a violenze gratuite e abusi. Ai Ruffo è dovuta
la costruzione del Palatium di Mezzapraja e sempre alla famiglia
Ruffo saranno legate le sorti di Curinga e Lacconia fino alla fine del
feudalesimo.
Caduta
la Repubblica
Napoletana, il principe
ereditiero borbonico transita nel 1806 per il Fondaco del Fico per raggiungere
la Sicilia. Viene inseguito dal generale Reynier che fissa in Maida il quartier
generale dei francesi proprio mentre un'armata inglese approda nel tratto di
costa tra l'Angitola e l'Amato dando così inizio alla Battaglia
di Maida, che vedrà gli
inglesi vincitori, sostenere l'insurrezione calabrese. Il brigante Papasodero,
da una Curinga occupata, con centinaia di uomini armati e insieme al borbonico
Cancellieri tentò più volte di espugnare Maida, dove si erano rifugiati i
benestanti della zona. I tentativi furono tutti respinti e l'ordine ristabilito.
La riorganizzazione napoleonica portò alla soppressione del sistema feudale.
Nel 1783 la baronia di Lacconia, oramai divenuta Acconia o Acquania, scomparve
del tutto e il suo territorio venne assegnato definitivamente alla municipalità
di Curinga.
Tuttavia
le condizioni della popolazione rimangono tragiche, povertà e miseria sono
ovunque e molte volte sfociano in atti di violenza. Nel 1848 le truppe
borboniche si scontrano con i Nazionali e gli insorti calabresi presso Curinga
nella Battaglia delle Grazie. I molti curinghesi guidati da Francescantonio
Bevilacqua insieme ad altri accorsi dai paesi vicini inflissero pesanti perdite
e costrinsero i Regi guidati da Nunziante a
una disastrosa ritirata.
Il
27 e il 28 agosto 1860 Garibaldi è
a Curinga acclamato da una folla piena di speranza. Incontra e dà ordini al
generale Stocco presso il Palazzo dei Bevilacqua. Cinquantacinque curinghesi e molti
altri accorsi dai paesi limitrofi lo seguiranno dando vita alla Seconda
Battaglia delle Grazie.

Svanita
l'illusione unitaria, intuito il tradimento del nuovo re Sabaudo e con il
perdurare della situazione di miseria, Il 6 maggio 1870, Curinga insorge: un
raggruppamento di duecento uomini mossi dagli ideali anarchici di Bakunin proclama il governo provvisorio repubblicano di Curinga. Avanzano
verso Maida seguendo le piste di montagna cambiando però direzione per unirsi
agli altri 100 insorti provenienti da Cortale e diretti a Filadelfia,
dove si concentra il raggruppamento sotto la guida di Ricciotti
Garibaldi. La notizia
dell'insurrezione si diffuse e altri accorsero dalle campagne e dai paesi
limitrofi armati alla men peggio.
Il
7 maggio 1870 viene proclamata la Repubblica Universale di Filadelfia. Segnalata
la comparsa dei moti insurrezionali la Prefettura di Catanzaro invia 122 uomini
di gran lunga meglio organizzati e armati degli insorti. Questi ultimi,
asserragliati nella parte più alta del paese, sperano nella sollevazione
popolare, che tuttavia non avviene con vigore. Gli abitanti, già in condizione
di miseria e impauriti per un ulteriore aggravamento della loro già misera
condizione sociale, non supportano la rivolta che termina il 9 maggio con la
cattura degli ultimi insorti. Ci saranno due morti tra la popolazione e uno tra
i soldati.
Alto
fu il tributo di sangue versato dai curinghesi durante le due guerre mondiali.
Il
Novecento vedrà moltissimi curinghesi cercare fortuna prima oltreoceano e in
seguito nel nord Italia.
Gli
anni Cinquanta videro nel paese un'ulteriore diffusione delle idee socialiste.
Non mancarono episodi di occupazione delle terre da parte di contadini.
Scoprire
il borgo

L'insediamento
principale è il borgo di Curinga che sorge in posizione collinare ed è
capoluogo dell'omonimo comune. Ospita la metà dei residenti. Il pittoresco
centro storico del paese è un intreccio di stradine, scalini, vicoli
caratteristici (carrìari) che attraversano un tessuto urbano
estremamente irregolare fatto di piccole case costruite in pietra e attaccate
tra loro che portano a piazzette dominate quasi sempre da palazzotti gentilizi:
Largo e palazzo Bevilacqua, Piano di Pruscino e palazzo Loffredo (Perugini),
Largo Impietrata (Menzalora) e palazzo Serrao. Altri ancora sono Palazzo Senese,
Palazzo Panzarella, Palazzo Ciliberti (Cuda). È diviso in rioni (rughi), tra
i quali i principali sono Ospizio (Spìzzu), Calvario (Carvàru), San
Giuseppe, Serra di Ciancio,
Notar Cola (Notraccola), Pietrapiana (Petraxhiana).
Il
corso principale del centro storico è Corso Garibaldi e attraversa le tre
piazze di Curinga: Piazza Diaz, Piazza San Francesco, Piazza Immacolata. Tre
sono anche le chiese principali: Il Duomo o Chiesa di Sant'Andrea Apostolo, il
Santuario Maria SS.ma del Carmelo, la Chiesa Maria SS.ma dell'immacolata. Le
ultime due vedono una intensa partecipazione da parte delle relative
confraternite.
Nel
centro storico sono presenti inoltre la Chiesa di San Giuseppe, la Chiesa
dell'Addolorata, la Chiesa di Maria SS.ma del Soccorso, mentre fuori
dall'abitato la Chiesa della Madonna delle Grazie. Il centro storico nel corso
degli anni ha subito un graduale spopolamento dovuto a fenomeni di migrazione
verso paesi quali Stati Uniti, Canada, Argentina, Venezuela, Australia, Francia,
Svizzera, Germania.
Al
centro della piana si trova Acconia,
frazione di Curinga che detiene quasi lo stesso numero di abitanti del paese
capoluogo. Importante e rinomato centro agricolo sviluppatosi sui resti
dell'antica Laconia, risorge proprio come villaggio agricolo in seguito alla
bonifica della piana, conoscendo un forte incremento urbano a partire dagli anni
80. Ha una piazza intitolata a San Giovanni Battista sulla quale si affaccia
l'omonima chiesa. Costruita di recente, non distante dalla piazza è la chiesa
di Santa Maria della Speranza che ospita la vita parrocchiale della comunità.
È sede di una stazione ferroviaria (Stazione
di Curinga).
Poco
distanti da Acconia si trovano le contrade di Ferriolo, Cerzeto, Torrevecchia,
Prato Sant'Irene.
Le
contrade di Trunchi, Ergadi, Calavrici si trovano sul confine sud del comune di
Curinga.
Le
contrade di Agrosini, San Salvatore (Cacci), Zecca, Centone,
Jencarella, Bellifico si trovano in posizione collinare a monte di Curinga. Sono
caratterizzate da piccoli e suggestivi nuclei abitativi che si affacciano sulla
valle sottostante. Vantano una pregevole tradizione agricola ed eccellenti
tipicità culinarie.
Architetture
religiose
 Chiesa
di Sant'Andrea
Apostolo (Chiesa Matrice/Duomo) Chiesa
di Sant'Andrea
Apostolo (Chiesa Matrice/Duomo)
Santuario
di Maria
Santissima del Carmelo
Chiesa dell'Immacolata
Chiesa di San
Giusepp e
Chiesa di Maria
Santissima del Soccorso;
Chiesa dell'Addolorata;
Chiesa
della Madonna
delle Grazie
Chiesa
di San
Giovanni Battista
(Acconia
di Curinga)
Chiesa dell'Annunciazione
(Acconia
di Curinga )
Chiesa
di Santa Maria della Speranza
(Acconia
di Curinga)
Chiesa
"borbonica" di San Giovanni
(Acconia
di Curinga)
Siti
archeologici
Monastero
di Sant'Elia Vecchio, eremo basiliano. Nelle vicinanze esiste un platano
orientale che, secondo gli esperti che lo hanno studiato, avrebbe più di mille
anni
Le
Terme Romane di Curinga, che si trovano in c.da Cerzeto, nei pressi di Acconia
di Curinga
Duna
fossile di Piana di Curinga (Località Prato S. Irene - Rina),
importante testimonianza del neolitico.
Palazzi
Nel
centro storico di Curinga vi sono diversi palazzi storici:
Palazzo
Bevilacqua, ora di proprietà del comune
Palazzo
Perugini (principi Loffredo)
Palazzo Serrao
Palazzo
Ciliberti, vecchia sede del municipio, situato in piazza San Francesco
Palazzo
Senese appartenente ai duchi di San Demetrio
Palazzo
Senese. Di costruzione quattrocentesca, è uno degli edifici di maggior valore
storico del paese.
Villa Maggiore
Perugino
Villa Cefaly -
Pandolphi
(Acconia)
Palazzo Ducale
(Acconia)
Di
notevole bellezza sono pure le numerose case coloniche, ville/casini di campagna
sparse su tutto il territorio comunale. Alcune, recentemente ristrutturate, sono
oggi sede di pregevoli agriturismi e ristoranti. Presenti in Curinga vi sono
anche vari appezzamenti di terreno una volta suffeudi del feudo di Curinga tra
cui località Ciceri appartenente alla famiglia Senese,località Trunchi
appartenente alla famiglia Bardari ed altri .

Architetture
militari
Torre Angioina
di avvistamento
Palazzo -
Fortezza principi Ruffo
Torre Normanno
- Sveva
Fortino Seconda
Guerra Mondiale
Tradizioni
e folclore
 Il
costume tipico veniva indossato dalle donne curinghesi per la prima volta
intorno ai 15 anni e segnava il passaggio dall'adolescenza alla
giovinezza. "Pacchiana" è Il termine con il quale si
definisce la donna che lo indossava, principalmente nei giorni di festa. Si
distingueva a seconda che la donna fosse sposata, vedova o nubile. Il
costume tipico veniva indossato dalle donne curinghesi per la prima volta
intorno ai 15 anni e segnava il passaggio dall'adolescenza alla
giovinezza. "Pacchiana" è Il termine con il quale si
definisce la donna che lo indossava, principalmente nei giorni di festa. Si
distingueva a seconda che la donna fosse sposata, vedova o nubile.
L'abito è
formato principalmente da una sottoveste bianca molto lunga detta
"Cammisa" mentre un corpetto a doppio petto di velluto o raso nero o
rosso senza maniche detto "Bustu" era ricamato a mano
in seta, oro o argento e rigido a tal punto da tenere ben sollevato il seno
femminile.
Dalla scollatura del corpetto fuoriusciva la "Cammisola"
una camicetta bianca a maniche corte e larghe ricamata con fini lavori di alto
artigianato locale.
La gonna, di lana, flanella o cotone, era rossa per le donne
sposate, nera per le vedove e veniva detta "Pannu" mentre
la sopravveste, rimboccata e annodata dietro la schiena, a formare una lunga
coda veniva chiamata "Gunnedda".
Completava il costume
la "Fodalicchia", un pezzo di stoffa, di solito seta nera,
che copriva il davanti e veniva annodata dietro la schiena da due lunghi lacci.
Altri elementi erano il "Pettine" avente lo scopo di
coprire il seno e il "Vancalieddu" lungo copricapo di colore nero o
bianco, che si snodava lungo le spalle dopo aver formato sulla testa stessa una
specie di corona che serviva per agevolare il trasporto dei contenitori per
l'acqua o i cesti con i "panni" da lavare.
L'usanza
dell'utilizzo del costume tipico venne mantenuta nel dopoguerra solo dalle donne
anziane scomparendo del tutto negli anni '70.
Fonte:
|