Capo Colonna - noto
in età coloniale (antica, classica ed ellenistica) come Capo Lacinio e poi promontorium
Lacinium in età romana - è un promontorio sito
otto chilometri a sud di Crotone,
che costituisce la punta più orientale della penisola calabrese e costituisce
il limite meridionale del golfo
di Taranto. La sua importanza risiede nella quantità di elementi
archeologici di diverse epoche che sono legati a questa punta di terra protesa
sullo Ionio.
Il toponimo moderno
è deriva dalla presenza dell'unica colonna rimasta eretta del tempio
di Hera Lacinia: fino al XVI
secolo era chiamato "Capo delle Colonne" perché 2 erano
le colonne rimaste in piedi del santuario di Hera.
Proprio la
caratteristica di luogo facilmente identificabile dal mare rese il capo Lacinio
punto di riferimento per la navigazione e per la definizione di confini. Questo
metodo di indicare i limiti della navigazione e le aree di influenza era
generalizzato e derivava dal tipo di navigazione "sottocosta"
dell'epoca; anche i trattati
fra Roma e Cartagine prendevano un promontorio (capo
Bello) come limite insuperabile dalle navi Romane.
Con la
fondazione di Crotone da
parte di coloni greci nell'VIII
secolo a.C. l'area dell'antico Capo Lacinio, già considerata sacra
dalle popolazioni autoctone, viene ulteriormente nobilitata dalla costruzione
del famoso tempio dedicato a Hera Lacinia, divinità greca, protettrice delle
donne e della fertilità e che viene nella mitologia classica abbinata alla
romana Giunone.
Queste due principali qualità: la facile riconoscibilità dal mare e la
presenza del tempio fecero convergere sul capo Lacinio le pagine della storia.
Un riferimento
alla funzione di "pietra di confine" ci viene fatta da Tito
Livio quando ci informa che le navi romane, per il trattato
stipulato nel 303
a.C. con Taranto non
potevano superare il capo Lacinio. La mancata osservanza di questo trattato
spinse nel 282
a.C. la città greca ad attaccare i romani e successivamente alle guerre
pirriche.
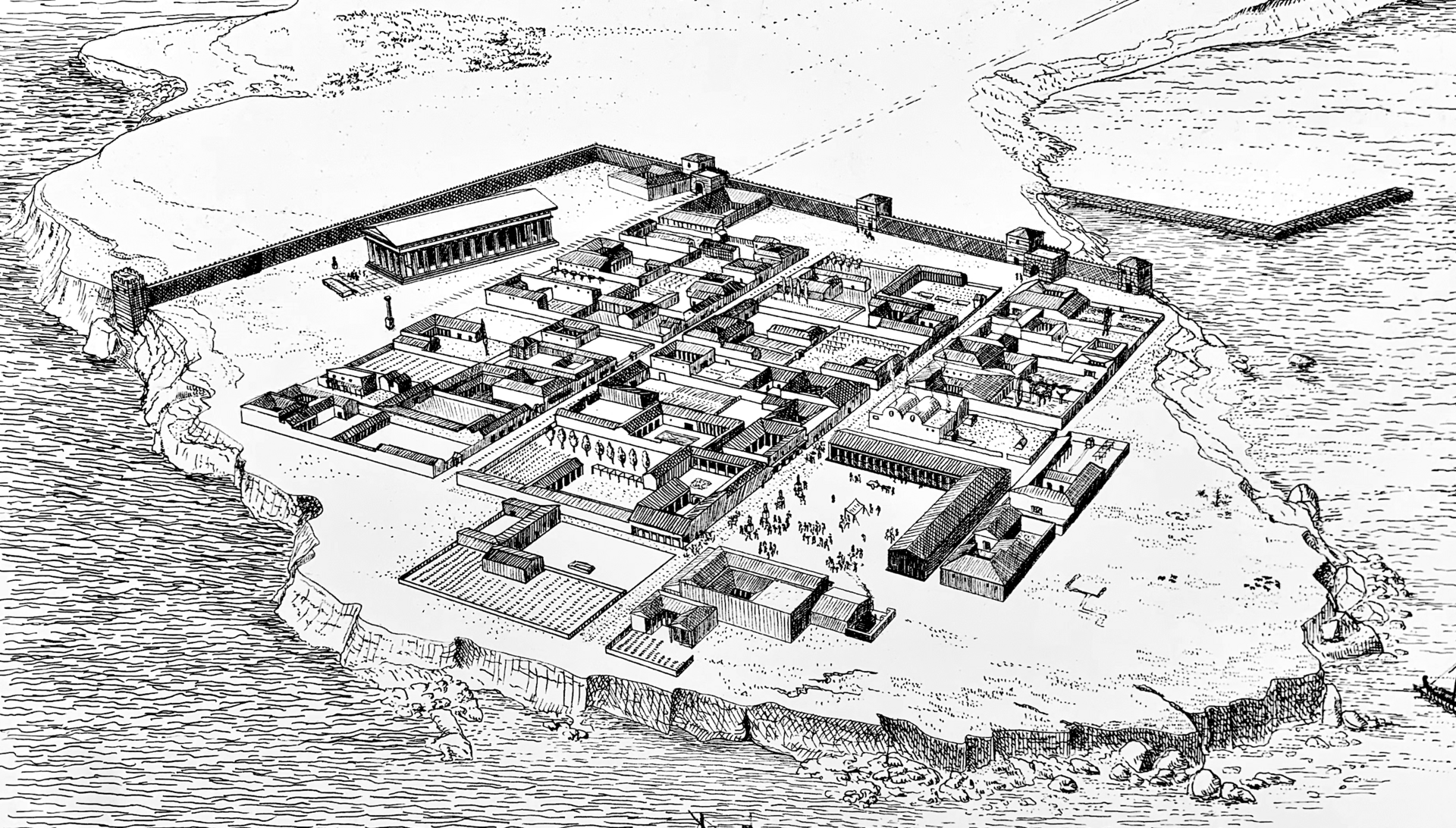
L'area
comprende trenta ettari di terreno adibito a scavi e venti di bosco e macchia
mediterranea. A Capo Colonna sorgeva una tra le aree sacre più importanti
dell'intero bacino Mediterraneo: il santuario dedicato a Hera Lacinia, moglie e
sorella di Zeus, protettrice dei pascoli, delle donne, della fertilità
femminile, della famiglia e del matrimonio.
I
reperti rinvenuti nell'area di scavo sono custoditi, in parte, nel Museo
Archeologico Nazionale di Crotone. In particolare si segnalano i reperti di età
arcaica e il prezioso Tesoro di Hera Lacinia. Del celebre santuario sono esposti
oggetti votivi, frammenti di decorazioni architettoniche in marmo e terracotta,
e frammenti di sculture, tutti risalenti all'età arcaica; il cippo iscritto che
ricorda l'appartenenza del santuario ad Hera Eleytheria; il gruppo scultoreo
d'età romana di Eros e Psyche rinvenuto in mare a Capo Colonna.
Nel
nuovo museo di Capo Colonna, situato all'ingresso del Parco Archeologico, sono
esposti reperti rinvenuti nell'area.
All’interno
del Parco Archeologico si trova la Torre di Capo Nao, tozzo edificio
spagnolo del XVI secolo, che ospita al suo interno l'omonimo antiquarium.
Oltre
a rappresentare un luogo storico dal grande valore artistico e archeologico,
il promontorio di Capo Colonna ospita la piccola e suggestiva chiesa di
rito latino in cui si venera la Madonna di Capo Colonna. Ogni anno la più
grande processione religiosa della Calabria porta migliaia di fedeli
in pellegrinaggio dal Duomo di Crotone alla piccola chiesa all'interno del Parco
archeologico.
Dopo la
conclusione della seconda
guerra punica, i conquistatori romani nel 194
a.C. dedussero a Crotone una colonia marittima ed affidata ai
triumviri Cn. Octavius, L. Aemilius Paulus, C. Laetorius (Livio Libro
XXXIV; 45). Da vari elementi storici che evidenziano l’importanza del Lacinio
per le operazioni militari romane via mare in questa fase storica, dalla
presenza di stratigrafie di età repubblicana-imperiali emerse sul promontorio,
e contemporaneamente per l'assenza di stratigrafie consistenti in età
repubblicana (II e I sec. a.C.) nell’area della città moderna, ha lasciato
ipotizzare che la deduzione della colonia romana di Croto fosse avvenuta
nell’area del Lacinio poco distante del tempio di Hera. A Capocolonna,
infatti, a nord della hiera hodos sono venute alla luce cospicue strutture
databili tra la metà del II sec. a.C. e la prima metà del I sec. d.C. Una
parte notevole dello spazio urbano della colonia sembra essere occupata invece
solo da edifici privati.

Ma
l’insediamento romano presso il Lacinio sembra esaurirsi dopo pochi decenni,
visto che già dalla prima meta del I d.C., in eta augustea, si assiste allo
stanziamento, soprattutto di edifici pubblici, ai piedi della collina del
Castello di Crotone, nell'acropoli della vecchia città greca, anche se
rimangono segni di vitalità del promontorio Lacinio fino al periodo tardo
antico.
Qui infatti si
pone la statio
del cursus pubblicus di Lacenium, riportata nella Tabula
Peutingeriana e con qualche errore di trascrizione (Facenio) anche
in altre fonti
itinerarie.
L’insediamento
di età
repubblicana sul Capo Lacinio occupa tutta l’estremità
settentrionale del promontorio e si compone di insulae quadrangolari
che risparmiavano il settore del Santuario di Hera e le sue immediate
pertinenze. Oltre alle piccole domus vi erano ricche residenze di proprietari più
illustri ed un complesso con destinazione termale, edificato dai duoviri
Lucilius Macer e Annaeus Traso l’80 e il 70 a.C., come attestato da
un'iscrizione su un mosaico decorato con una fascia esterna a meandro.
La fase di
decadenza e il progressivo abbandono dell’abitato del Lacinio inizia
probabilmente dopo l’assedio di Sesto
Pompeo nel 36 a.C., nella cui occasione viene forse costruito il
peribolo in reticolato del promontorio, a scopo difensivo.
Scavi
effettuati tra settembre e dicembre 2014 hanno messo in evidenza la presenza,
sul lato settentrionale e, parzialmente, su quello occidentale del sagrato, dei
resti di un porticato, costruito, presumibilmente, in età augustea, che forse
definiva architettonicamente uno spazio pubblico dall’epoca della fondazione
della colonia romana, le cui dimensioni lasciano supporre che possa riferirsi ad
un edificio pubblico.
In località
Torre Mariedda-Quote Cimino, sono stati ritrovati resti di un considerevole
complesso provvisto di un’imponente fontana monumentale riconducibile al
periodo tra tarda età repubblicana e prima età imperiale (I sec. a.C. e III/IV
sec. d.C.).
Dopo
l’abbandono dell'abitato, il perdurare della devozione nei confronti di Hera
Lacinia è ancora attestato tra il 98 ed il 105 d.C. dall’ara dedicata da Oecius procuratore
imperiale (libertus procurator), in favore di Ulpia Marciana, sorella di
Traiano.
L’occupazione
sul promontorio di Capocolonna non si limita al solo abitato al Capo Lacinio. Le
ricognizioni compiute da Joseph Carter della Università del Texas mostrano che
il retroterra agricolo era occupato da numerose fattorie rurali, presubibilmente
inizialmente si trattava delle terre distribuite ai coloni che arrivarono qui
dopo la deduzione del 194 a.C., ma l'occupazione con queste caratteristiche
prosegue fino all'età tardo-antica ed
anche oltre.
Parco
Archeologico Nazionale

L'area archeologica di Capo Colonna è un sito archeologico statale situato
situato in località Capo
Colonna, vicino a Crotone.
È inclusa nella lista dei monumenti
nazionali.
Gli
elementi archeologici presenti non si limitano al solo più noto Santuario
dorico dedicato ad Hera, di maggiore frequentazione durante l'età classica ed
ellenistica, ma si tratta di un sito con stratificazioni di diverse epoche, da
quella preistorica, con frequentazioni italiche fino alla fondazione della
colonia di Kroton. Numerosi resti risalgono all'età romana: dapprima in età
repubblicana, un decennnio dopo la fine della seconda
guerra punica, qui venne costituito il primo insediamento della colonia
romana di Croto, e poi la statio di Lacenium in età imperiale.
Museo
Archeologico di Capo Colonna
Inaugurato
nel 2002, il museo sorge all'interno del Parco omonimo, su un unico piano.
La struttura è divisa in tre padiglioni espositivi: la Terra, che conserva
reperti emersi durante il periodo della dominazione romana; il Sacro, dedicato
alle testimonianze dell'area sacra del Santaurio ed il Mare, che espone i
ritrovamenti subacquei.
Tra i reperti più pregiati esposti nel Museo si
annoverano un elmo corinzio in bronzo del V secolo, un ceppo d'ancora in pietra
su cui è incisa una dedica di Phayllos, tra i più celebri atleti crotoniati, a
Zeus Meilichios e una piccola scultura in marmo raffigurante Amore e Psiche,
ritrovata nelle acque antistanti la costa crotonese. La struttura è circondata
inoltre dal giardino di Hera, costituito, tra gli atri, da alberi di pero, melo,
giglio, mirto e melograno.
Santuario di Hera Lacinia
Il santuario
di Hera
Lacinia di Capo
Colonna, dipendente dalla città di Crotone antica,
fu uno dei santuari più
importanti della Magna
Grecia dall'età
arcaica fino al IV
secolo a.C., finché cioè fu sede della lega
Italiota prima che si trasferisse a Taranto.
Il
sito del santuario era
in una posizione strategica lungo le rotte costiere che univano Taranto allo stretto
di Messina, su un promontorio chiamato anticamente Lacinion,
che diede anche l'epiteto alla dea venerata, Hera Lacinia.
Il nome odierno invece ricorda le rovine del tempio (con l'ultima
"colonna" in piedi), mentre il nome usato fino all'epoca moderna,
"Capo Nao", altro non è che una contrazione del greco naos, che
significa appunto tempio.
Il
santuario era stato edificato alla fine del VI
secolo a.C. ed era anche chiamato di Hera Eleytheria, come
resta testimoniato da un'iscrizione sul cippo del Lacinion,
al Museo
archeologico nazionale di Crotone.
Tra
il XVI ed
il XIX
secolo fu quasi completamente saccheggiato per
riutilizzare i materiali
da costruzione per importanti opere pubbliche: quali il Castello
di Carlo V e le mura difensive della città, e poi per la costruzione del Porto.
Il
Santuario di Hera Lacinia ruotava intorno al tempio dorico costruito nel V
secolo a.C. sopra un precedente tempio arcaico del VII secolo, come attesta
l’uso difforme di blocchi di reintegro. Oggi del tempio dorico, che aveva il
classico impianto planimetrico a 6×19 colonne, rimane la nota colonna
superstite, posta sopra un poderoso basamento composto da dieci livelli di
blocchi di arenaria.
Delimitato
dall’ampia cortina muraria, di cui oggi restano ben visibili ampi blocchi di
opus reticolatum di epoca romana, rinforzata a Nord e a Sud da due torri
esterne, il Santuario di Hera Lacinia si articola in due aree orientate ad Est
ed attraversate dalla solenne Via Sacra (larga 8,50 m) individuata nel 1987.
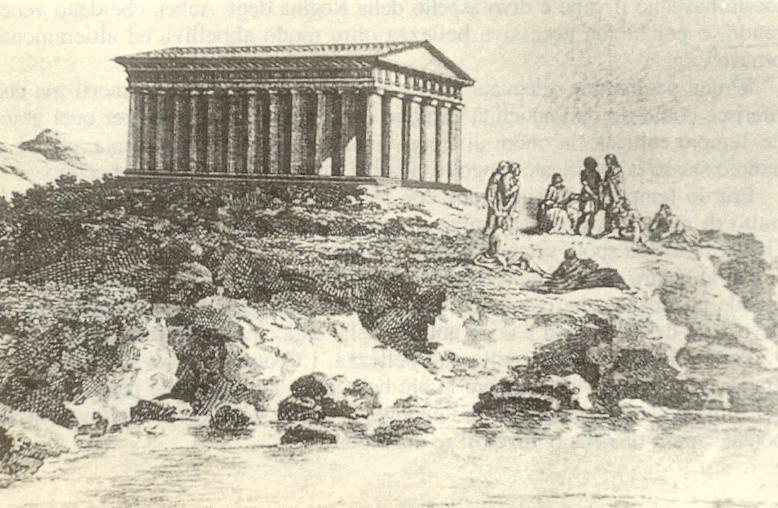
Il
complesso del Santuario era composto da più edifici, dei quali sono oggi
visibili alcuni resti. Il tempio vero e proprio, di ordine
dorico, con sei colonne sulla
facciata (esastilo) e quattordici sui lati lunghi, era proteso verso il mare e
aveva la classica forma dei templi
greci: un imponente complesso di 48 colonne in stile
dorico alte oltre 8 metri e costituite da otto rocchi scanalati.
Il tetto era
di lastre di marmo e tegole in marmo
pario. Nulla si sa delle decorazioni che, però, erano certo
presenti, come si può dedurre dal ritrovamento di una testa femminile in marmo della Grecia e
pochi altri frammenti. La colonna, in stile
dorico, fino al 1638 era
affiancata da un'altra caduta per un terremoto e
poggia sui pochi resti del possente stilobate.
Edificio
H - Lungo il lato a sud della Via Sacra, subito dopo la porta
d’ingresso e della cinta muraria romana (entrando sulla destra) sorge l’hestiatorion (Edificio
H), edificio per banchetti sacri, e che si allinea sull’asse
determinato dal grande tempio dorico.
L’hestiatorion
del Lacinio ha pianta quasi quadrata (26,30 x 29 m) ed è costituito da un
cortile porticato su cui si affacciano 14 vani, anch’essi di pianta quadrata,
di uguali dimensioni (4,74 m x 4,75), disposti simmetricamente in due serie di 5
e 2 ambienti.
La datazione di
questo "Edificio H" viene posta al IV
secolo a.C. quando il tempio già
aveva assunto grande celebrità.
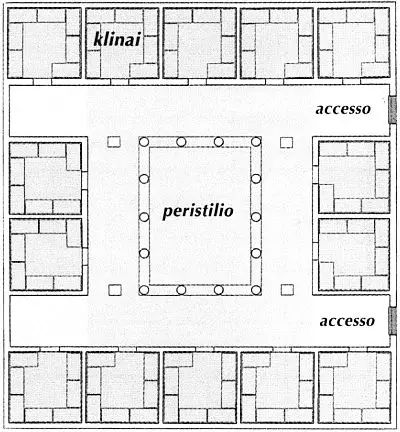 Le
misure degli oikoi sono
funzionali a contenere 7 kline (lettino
usato non solo per il riposo ma anche per consumare i pasti) per
stanza; alla restituzione ipotetica dell’edificio si ricostruiscono
complessivamente 98 klinai.
Le
misure degli oikoi sono
funzionali a contenere 7 kline (lettino
usato non solo per il riposo ma anche per consumare i pasti) per
stanza; alla restituzione ipotetica dell’edificio si ricostruiscono
complessivamente 98 klinai.
Il termine “banchetti
sacri” è da riferirsi al consumo di pasti
rituali collettivi, un aspetto del culto ampiamente praticato in ambiente
greco già dall’età geometrica ed arcaica. “La commensalità rituale
collettiva rappresentava il necessario corollario dell’azione sacrificale ed
era volta a stabilire rapporti, da un lato, tra la comunità umana e il
referente divino, dall’altro, fra gli individui costituenti tale comunità,
configurandosi, pertanto, come una complessa azione cultuale cui era sottesa
un’elaborata operazione politico-sociale”. … “In virtù di tali profonde
implicazioni di natura socio-politica, l’analisi delle strutture che
ospitavano il banchetto sacro, gli hestiatoria appunto, permette di ricostruire
indirettamente i cambiamenti verificatisi nella polis e, parallelamente, la
definizione del paradigma di sviluppo architettonico contribuisce, per
estensione, a tratteggiare la progressiva strutturazione spaziale e monumentale
del santuario greco”.
Già in età
classica il banchetto rituale non è svolto all’aperto, ma è abitualmente
ospitato in edifici noti come hestiatoria, che tra la fine del VI ed il V secolo
si strutturano in numerosi vani destinati ad ospitatare i klinai ed in altri
locali distinti funzionalmente per funzioni accessorie (cucine, magazzini, ecc).
Questo modello degli hestiatioron e delle forme di partecipazione al banchetto
rituale muta in età ellenistica con lo spostamento dei centri del potere, dalle
città-stato ai regni: il nuovo quadro storico, imperniato non più sulle
poleis, ma sulle monarchie, non necessitava più del consolidamento e
dell’affermazione periodica dell’identità cittadina nei santuari,
soprattutto nelle realtà di nuova fondazione.
In ambito
magno-greco la tradizione del consumo di pasti rituali collettivi trova esempi
significativi, sebbene in periodi cronologici differenti, nel santuario
extra-muraneo di Afrodite a Locri (cd. Stoà ad U nell’area di Centocamere,
databile nel VI secolo a.C.) e nel santuario di Hera Lacinia a Capo colonna.
Edificio
K - Lungo il lato nord della Via Sacra si trova il katagogion (Edificio
K), albergo per ospiti privilegiati, dotato di un peristilio con colonne
stuccate e capitelli di ordine dorico della seconda metà del IV secolo a.C.
L’edificio
K (38×34 m.) presenta l’accesso tramite la via sacra sul lato sud, su cui
affacciava con un portico dorico proseguito anche lungo il lato est a forma di
elle. L’accesso avveniva, tramite un corridoio, direttamente nel peristilio su
cui affacciavano su tutti e quattro i lati ambienti uguali (5,10×5,10 m.).
Il
confronto planimetrico più calzante è con il Leonidaion di Olympia utilizzato
come struttura d’albergo, per ospitare le delegazioni giunte per i giochi
olimpici. In analogia con tale confronto l’edificio K viene interpretato come
un Katagogion, utilizzato forse come foresteria dove
potevano trovare alloggio importanti visitatori, mentre i loro accompagnatori si
dovevano accontentare di costruzioni molto meno raffinate e resistenti.
Edificio
B -
A nord del tempio dorico si
trova un altro grande edificio rettangolare (22×9 metri) definito edificio
B, di cui rimangono tracce di fondazioni in calcarenite. Emerso dagli
scavi aperti tra il 1987 ed il 1990 la costruzione è orientata ad Est, in modo
più approssimativo rispetto al grande tempio, con un deciso spostamento
dell’asse verso settentrione. In prossimità del basamento quadrato è stato
rinvenuto un horos,
un cippo di confine arcaico in calcarenite, che doveva delimitare una primitiva
area sacra di grande importanza.
 L’ipotesi
più accreditata per questo edificio è che potrebbe trattarsi del primo luogo
di culto risalente alla prima metà dell’VIII sec. a.C., abbandonato poi nel V
sec. a.C. quando fu costruito il tempio classico.
L’ipotesi
più accreditata per questo edificio è che potrebbe trattarsi del primo luogo
di culto risalente alla prima metà dell’VIII sec. a.C., abbandonato poi nel V
sec. a.C. quando fu costruito il tempio classico.
La
presenza, in fondo alla cella rettangolare, di un basamento in blocchi di
calcare, posizionato asimmetricamente, che fa pensare ad una base per una statua
di culto o una mensa per le offerte; potrebbe perciò trattarsi del più antico
luogo di culto dedicato alla divinità.
Vicino
al cippo è stato trovato il famoso diadema d’oro, datato intorno alla metà
del VI sec. a.C. e che con ogni probabilità doveva incoronare il simulacro dì
Hera. Nei pressi del cippo sono stati ritrovati anche altri importanti oggetti
– tra cui spiccano gli splendidi bronzetti arcaici (Gorgone, Sfinge e Sirena),
prodotti in madrepatria. L’ipotesi più accreditata è perciò che dopo la
fondazione del tempio maggiore (l’edificio A) questo tempio arcaico non venne
demolito, ma riutilizzato come thesauròs, ossia un edificio destinato a
conservarvi le offerte dei cittadini e della comunità urbana.
La
Via Sacra - La strada sacra del santuario è stata scoperta tra il I988 ed
il I989, sul margine settentrionale dell’edificio B. Ne è stato scavato un
tratto lungo m 58 circa e largo m 8,50 circa, con margines realizzati
in blocchi di calcarenite disposti per lungo, e ne sono stati messi sinora in
luce gli strati di abbandono che possono ascriversi al III secolo a.C.
Costituisce l’asse mediano che attraversa longitudinalmente il temenos
collegandolo con il bosco sacro, i punti di approdo e l’altra grande area
sacra nelle “quote Cimino”.
La
forte erosione del margine del promontorio non consente di individuare
l’ultimo tratto della strada che doveva comunque continuare in direzione est e
terminare in una sorta di piazzale nel quale confluivano le processioni
religiose e dove, forse, si trovava l’altare di cui parlano le fonti.
Spicca
la grandiosità delle dimensioni, ma questo era da attendersi se si pensa che
lungo tale maestosa arteria si snodavano le processioni che andavano a
concludersi sulla punta del promontorio.
Si
ritiene che la strada sacra sia sorta nel momento dell’ultima fase di vita
dell’ edificio B, ovvero nel primo venticinquennio del V secolo a.C., allorché
il grande vigore urbanistico che anima la polis, si riflette nel santuario di
Hera con la costruzione del monumentale tempio poco più a Sud dell’edificio
B. È il momento della tryphé crotoniate, conseguente alla vittoria su Sibari e
successivo alla partenza di Pitagora dalla città.
Il
bosco sacro - Da Tito Livio apprendiamo dell’esistenza di un lucus,
termine che in latino individua un “bosco sacro” ed è considerato da alcuni
equivalente al greco àlsos,
di uno selva rigogliosa e di alti abeti. L’esistenza sul promontorio Lacinio
di un bosco di alti abeti, costituito cioè da un’essenza arborea, forse
relitto botanico del manto primigenio di conifere boreali, che doveva.
rappresentare un’ evidente difformità nell’ambito del paesaggio vegetale,
di certo mediterraneo, potrebbe avere stimolato il suo riconoscimento come luogo
sacro già da parte delle comunità indigene.
Torre
di Nao
La torre
di Capo Nao, più semplicemente conosciuta come torre di Nao o torre
Nao, è un monumento risalente
al XVI secolo situato
a Capo Colonna.
Carlo
V iniziò
una vasta ed imponente opera di fortificazione dei litorali calabresi nel XVI
secolo, per potenziare le strutture difensive del Regno
di Napoli. Inizialmente, il progetto iniziato dal viceré don
Pedro di Toledo prevedeva la costruzione di 3 torri,
ovvero la torre di Capo Nao, la torre
di Scifo e la torre
Mariedda. Solo la prima torre venne
però costruita, pare per mano di Fabrizio
Pignatelli, che iniziò la costruzione nel 1550 e
la termino all'incirca nel 1568.
La torre venne
interamente ricoperta di pietra
arenaria, di cui è composto anche tutto il promontorio
Lacinio. La torre resistette alle incursioni saracene e
anche se in seguito, nel 1806,
passò nelle mani dei francesi,
che la inserirono nel loro sistema
doganale. Dopo l'Unità
d'Italia, divenne una sede del comando della Guardia
di finanza, mentre oggi è un piccolo archeologico.
La torre viene
costruita come un elemento di difesa, composta da una base quadrata, un aspetto
tozzo e semplice, ma allo stesso tempo massiccio ed imponente. L'accesso alla
torre è rialzato, e per entrarci bisogna salire tre rampe
di scale, che conducono ad un piccolo ponte
levatoio a scomparsa, azionabile tramite una carrucola dall'interno.
Questi due particolari rendevano la torre quasi impenetrabile ed ancora più
difesa, considerando anche i diversi elementi di offesa di cui questa è dotata,
come diverse archibugiere,
ora trasformate in semplici finestre, e dei piombatoi situati
sulla cima della torre. Solo dopo la recente ristrutturazione,
venne implementata una porta a piano terra, per permettere anche le più
basilari misure
di emergenza.
Dopo una fase
di restauro sia
interno che esterno, la torre è stata adibita ad antiquarium,
ovvero un piccolo museo nel
quale poter osservare ritrovamenti
archeologici subacquei della
zona. Si possono osservare reperti
archeologici Greci e Romani,
con un'età compresa tra il 600
a.C. ed il 200
d.C., tutti rinvenuti nei fondali presso
il promontorio,
ma anche in tutta la riserva
marina, che si estende fino a capo
Rizzuto. Inizialmente, venne adibita alla mostra dei reperti
rinvenuti all'interno dell'area
archeologica adiacente, ma con il passare del tempo e l'aumentare dei
reperti, venne costruito il Museo
archeologico nazionale di Crotone, nel quale vennero trasferiti tutti
i reperti rinvenuti all'interno dell'area
archeologica (anche se alcuni reperti vennero portati al Museo
Archeologico di Reggio Calabria) e lasciò spazio all'esposizione
nella torre di numerose anfore, monete antiche, ceramiche, vasi e marmi.
Salendo inoltre in cima alla torre, si possono osservare a pieno splendore le coste ed
i litorali,
nonché la città di Crotone.

Torre
Scifo
Costruita
nei primi anni del Seicento, la Torre di Scifo, originariamente nominata Torre
di Capo Pellegrino, è il luogo simbolo di uno dei tratti più suggestivi della
costa crotonese, essa rientrava in un disegno di difesa costiera di cui facevano
parte anche la Torre di Capo Nao (la prima costruita) e la Torre Mariedda. Carlo
V iniziò, infatti, una vasta ed imponente opera di fortificazione dei litorali
calabresi nel XVI secolo, per potenziare le strutture difensive del Regno di
Napoli.
La
torre verrà costruita sul capo Pellegrino dal mastro Gio. Bernardino de Sena
nei primi anni del ‘600 e prenderà dapprima il nome di Torre di Capo
Pellegrino e poi di torre di Scifo. Nel 1763 lo stabile passa sotto il controllo
della famiglia Zurlo, che danno un nuovo aspetto all’area. I nuovi padroni in
pochi anni edificheranno il casino, con i magazzini, la chiesa, le caselle ed il
vaccarizzo. Creeranno un grande giardino con alberi da frutto ed un vigneto e
costruiranno due cisterne per raccogliere e conservare la preziosa acqua della
fonte.
Dopo
l’Unità d’Italia la torre di Scifo fu ceduta dal Demanio dello Stato al
marchese Antonio Lucifero, che la trasformò in dimora estiva di soggiorno e
molti terreni di proprietà ecclesiastica della località passarono in proprietà
del barone Luigi Berlingieri che li acquistò dal Demanio. Nel 1938 fu costruita
l’adiacente abitazione del custode. Oggi il fortilizio appare ben conservato e
presenta una pianta di forma quadrata ed è munita di robusti contrafforti e
cordonatura in pietra, è dotato inoltre di una scala esterna e di un piccolo
ponte d’accesso.
Nella
Baia di Scifo è stato ritrovato un relitto di epoca romana che trasportava
delle lastre di marmo provenienti dall’Asia Minore e utensili di diversa
fattura. Il carico si presenta sparso sul fondale, a circa 7/8 metri di
profondità, concentrato in due zone contigue, come se al momento del naufragio
lo scafo si fosse spezzato in due tronconi. Su alcuni blocchi di marmo sono
state identificate alcune iscrizioni di cava riportanti la data del 197 d.C. e
da questo si è ipotizzato un probabile inabissamento della nave attorno ai
primi anni del III secolo. Attualmente è possibile visionare parte del
materiale recuperato presso il museo archeologico di Capocolonna.

SANTUARIO
DELLA MADONNA DI CAPOCOLONNA - Il santuario di Santa Maria di
Capo Colonna si trova vicino all'area
archeologica di Capo Colonna, sul promontorio
Lacinio e custodisce un'icona particolarmente
venerata.
L'edificio
è ubicato nei pressi del tempio dedicato a Hera
Lacinia, del quale oggi rimane un'unica colonna
dorica. La struttura attuale fu eretta dai monaci
basiliani di Salice
Salentino probabilmente fra l'XI e
il XIII secolo e
certamente prima del Cinquecento,
quando la chiesa e l'icona furono descritte nel Libro dei miracoli, un
manoscritto che racconta di un tentativo ottomano di
distruggere o trafugare il quadro che sarebbe avvenuto nel 1519.
La
chiesa fu sottoposta a numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli. Nel Settecento fu
trasformata in romitorio e
nel 1897 assunse l'aspetto attuale per l'ampliamento progettato dal marchese Anselmo
Berlingeri.
L'icona
- L'icona, probabilmente bizantina,
risale al X o
all'XI secolo.
Il dipinto,
che si rifà all'iconografia
di San Luca, sarebbe stato donato al santuario,
secondo la tradizione, da San
Dionigi l'Areopagita[1]. Il quadro subì a sua volta diversi
rimaneggiamenti. Un tempo conservata all'interno della chiesa, l'icona è stata
successivamente trasferita nel Duomo
di Crotone da dove, in occasione della festa della Madonna di Capo
Colonna, viene portata in processione fino al santuario.
La
sacra icona della Madonna di Capo Colonna è l'immagine più rappresentativa
della città di Crotone e il suo culto è ormai da secoli un simbolo per tutti i
crotonesi, anche se non è possibile delinearne un quadro storico preciso. In
merito alla sacra immagine, infatti, i racconti giunti sino a noi non sempre
risultano attendibili e non è possibile rintracciare notizie negli archivi
storici ecclesiastici crotonesi, perché gran parte delle fonti in essi
conservate sono andate distrutte in un incendio che divampò nella basilica e
nell'episcopio cittadino intorno al XVI secolo.
Le
notizie giunte sino a noi sono antichi racconti che intrecciano fonti storiche a
storie leggendarie. Le fonti storiche più attendibili raccontano che già in
tempi antichi, annualmente, i crotoniati facevano pellegrinaggi presso il
promontorio di Capo Lacinio per celebrare e ringraziare Hera, la dea della vita
e della fertilità. Con l'avvento del cristianesimo questo culto pagano venne
sostituito dalla venerazione della Vergine Maria. La tradizione più antica
racconta infatti che la sacra immagine di origine bizantina fu portata sul
promontorio crotonese da San Dionigi, un giudice ateniese che, dopo esser stato
convertito al cristianesimo da San Paolo, giunse a Crotone e ne divenne il primo
vescovo.
Secondo
il racconto il Santo, dopo aver trovato l’immagine, la portò nel tempio di
Hera Lacinia in cui per secoli si era svolto il culto pagano, iniziando i
crotonesi alla venerazione della Sacra Icona. Un'altra versione racconta che il
quadro, proveniente dall'oriente, in origine raffigurava la Vergine a mezzo
busto; fu ritrovato da un artista crotonese il quale, dopo averlo trasportato su
tela, lo completò, ricreando la figura intera della Vergine e abbellendolo
infine con una lamina prima dorata e poi argentea. Nemmeno sull'autore
dell'opera si hanno notizie certe e attendibili.


Un'antica
tradizione racconta che la tela originale sarebbe stata realizzata da San Luca
evangelista, ma questo racconto sarebbe poco attendibile, perché il dipinto
della Vergine di Capo Colonna risalirebbe al X – XI secolo e sarebbe di stile
bizantino, quindi realizzato in tempi successivi. Questa versione potrebbe
essere influenzata dal fatto che San Luca è conosciuto come un abile pittore
che realizzò numerosi dipinti raffiguranti la Vergine Maria. Un altro racconto
attribuisce il dipinto a un altro San Luca detto l’Archimatrite, un abate che
resse uno dei monasteri basiliani presente un tempo a Capo Colonna. Questa
seconda versione sembrerebbe trovare maggiore riscontro perché l’attuale
quadro presenta molti caratteri dello stile bizantino, praticato durante l'epoca
del monachesimo basiliano; elementi caratteristici di questo stile si possono
ritrovare soprattutto nella parte superiore dell'immagine, dove sono raffigurati
la testa della Vergine e il volto del Bambino.
La
parte inferiore del dipinto appare poco nitida e sembra esser stata realizzata
con tecniche diverse rispetto all'originale : il manto della Vergine non è
di stile bizantino e parecchi ritocchi sarebbero riconducibili al XV secolo.
Questi dettagli confermerebbero il fatto che il dipinto attuale sia in realtà
un trasporto dell'immagine originale. Alcuni episodi storici ci fanno capire che
la Sacra Icona era già venerata nel XV secolo. Nel giugno del 1519 i Turchi
giunsero a Capo colonna e dopo aver trovato sul promontorio Lacinio il quadro
della Vergine Maria, appiccarono un incendio e tentarono di bruciare la tela, ma
nonostante il fuoco si fosse protratto per qualche giorno, il dipinto rimase
intatto emanando una grande luce. I turchi stupefatti e spaventati da ciò che
era successo decisero di portar via la tela su una delle loro navi, ma la loro
imbarcazione rimase ferma; decisero quindi di gettare il dipinto in mare e la
barca finalmente si mosse. Qualche giorno dopo il quadro fu ritrovato da Agazio
Lo Morello, un contadino del posto che nascose la tela e solo in punto di morte
confessò il suo segreto.
Nel
1638 i turchi tentarono di assediare Crotone ma il popolo crotonese, per
combattere il nemico, decise di esporre l'immagine della Vergine sulle mura
della città, invocando il suo aiuto e la sua protezione. I turchi, appena
videro l'immagine della Madonna, la riconobbero e spaventati scapparono dalla
città e rinunciarono all'assedio. Nel 1600 venne realizzata una miniatura del
quadro originale, allo scopo di preservare quest'ultimo e per avere una copia
del quadro che fosse maggiormente trasportabile per le vie della città durante
le processioni. Questa riproduzione è conosciuta come "il
quadricello" ed è stata realizzata da alcuni artisti della scuola
napoletana. Negli anni successivi ne fu fatta un'ulteriore copia e quest'ultima
è quella che viene portata annualmente in processione. La tela originale nel
1749, su richiesta di Monsignor Costa, vescovo di Crotone, fu laminata in
argento e nel 1929 anche "il quadricello" venne bordato da una cornice
d’argento. La Sacra Icona è attualmente custodita nella Cattedrale di Crotone
e dal 1988 la Madonna di Capo Colonna è patrona dell’Arcidiocesi di Crotone
– Santa Severina. Alla Vergine vengono attribuiti numerosi miracoli e il
popolo crotonese le è fortemente devoto.
Il
mese di maggio è per i crotonesi interamente dedicato alla festa in onore della
Vergine di Capo Colonna. Ogni sette anni la festa assume un tono solenne perché,
al posto della miniatura moderna, viene portato in processione il quadro
"originale". Il terzo sabato di maggio si compie l'annuale
pellegrinaggio notturno, che vede i fedeli crotonesi accompagnare l'icona della
Vergine dal Duomo al promontorio di Capo Colonna, dove si trova il Santuario a
lei dedicato. Il grande quadro o il quadricello restano nella chiesetta di Capo
Colonna per la sola giornata di domenica, e la stessa sera vengono imbarcati e
trasportati via mare fino al porto di Crotone, dove la sacra immagine viene
accolta dai fedeli che la riaccompagnano al duomo. Durante la festa
"settennale" il rientro non viene effettuato via mare, ma il quadro
della Vergine viene posto su un carro trainato da buoi e percorre la stessa
strada che i fedeli percorrono durante il pellegrinaggio notturno del sabato.

Spiagge
Il
promontorio di Capo Colonna ospita anche alcune delle più belle spiagge di
Crotone, come quella di Punta Scifo, di sabbia rossa finissima e dai
fondali bassi e sabbiosi; quella di Campione, vasta e inserita in un
contesto paesaggistico sublime, ricadente nell'Area marina protetta di
Capo Rizzuto.
Sempre fuori città si trova la Spiaggia dell'Irto, a ridosso del
promontorio di Capo Colonna, molto bella, sabbiosa e poco frequentata. Le
più gettonate sono ovviamente le spiagge cittadine, quelle che dal molo
del Porto Vecchio si allungano in direzione sud costeggiate dal lungomare. A
nord della città invece si distendono le spiagge di Gabella,
caratterizzate da sabbia bianca a granelli, lunghi arenili e fondali alti e
sabbiosi. Questa zona costiera è spesso battuta dal vento di grecale e dalla
tramontana, per questo sono particolarmente frequentate dagli amanti del
kite-surf.