Il
comune di Africo ha la caratteristica di essere diviso in due porzioni a
notevole distanza l'una dall'altra. La prima delle due è una piccola enclave nel
comune di Bianco,
la seconda invece si trova sulle pendici dell'Aspromonte,
ove rimangono i ruderi dei borghi di Africo Vecchio e Casalnuovo.
Il
paese nuovo sorge a pochi metri sul livello del mare, a margine di una piccola
pianura affacciata sul Mar
Ionio, chiusa a sud da Capo
Bruzzano, sulla riva destra della fiumara Laverde,
che proprio qui sfocia a mare. Africo Vecchio invece sorge sul versante sinistro
del vallone
Casalnuovo, nella parte sud-orientale del parco
nazionale dell'Aspromonte; sul versante opposto invece sorge, su una
rupe, Casalnuovo.
 Si
ritiene che il nome del paese di Africo Vecchio derivi dal greco àprichos,
άπριχος, o dal latino apricus.
Si
ritiene che il nome del paese di Africo Vecchio derivi dal greco àprichos,
άπριχος, o dal latino apricus.
È
stata avanzata l'ipotesi che nel luogo siano esistiti insediamenti in epoca
precedente o contemporanea alla colonizzazione magnogreca; esistono comunque
reperti archeologici di epoca bizantina. Probabilmente già nel decimo secolo
erano presenti monaci
basiliani. In epoca normanna, fra i secoli XI e XII, visse San Leo,
il patrono del paese; secondo la tradizione, egli nacque a Bova e prima di
diventare monaco studiò nel convento basiliano della SS. Annunziata di Africo.
Nel
1571 Gabriele Barrio scrive che ad Africo i riti sacri sono celebrati in greco e
che la popolazione adopera il greco anche nei rapporti familiari, assieme al
latino.
Nel
1783 Africo fu seriamente danneggiata da un forte terremoto che causò sei morti
e danni per ottantamila ducati. Alla fine del secolo XVIII aveva circa 800
abitanti e vi si osservava il rito greco. In epoca napoleonica vi si ebbe uno
scontro tra francesi e borbonici, in cui gli abitanti parteggiarono per questi
ultimi. Nell'Ottocento fu attivo nel territorio il brigante Antonio
Zemma.
La
popolazione di Africo e Casalnuovo ammontava in totale a 1726 persone nel 1815;
nel 1861 il solo paese di Africo aveva 1276 abitanti; ne ebbe 1781 nel 1911 e
2489 nel 1951. Altri due sismi colpirono il borgo calabrese nel 1905 e nel 1908.
Le
condizioni sociali ed igieniche di Africo nel periodo
interbellico erano disastrose. Il meridionalista Umberto
Zanotti Bianco, coadiuvato dal giovane Manlio
Rossi Doria, eseguì un'inchiesta
su Africo nella quale riferiva come il paese fosse annidato su case
dirute per il pregresso terremoto, isolato geograficamente, afflitto da tasse
indiscriminate e da malattie, fosse privo di medico, di aule scolastiche (le
lezioni si svolgevano nelle stanza da letto della maestra); gli abitanti si
nutrivano di un immangiabile pane fatto con lenticchie e cicerchie.
Il
20 gennaio 1945 la popolazione di Africo assaltò con armi da fuoco e distrusse
con bombe a mano la locale caserma dei carabinieri, costringendo i tre o quattro
militi presenti a rifugiarsi negli scantinati e liberandoli solo dopo averli
disarmati. In questo periodo si costituirono nel paese la sezione del Partito
socialista, quella del Partito
comunista e la Camera
del lavoro.
Nel
marzo 1948 il settimanale “L'Europeo”
pubblicò un reportage da Africo a firma del giornalista Tommaso Besozzi,
corredato da alcune fotografie di Tino Petrelli; tale reportage (che faceva
parte di un'ampia inchiesta sulle condizioni del Mezzogiorno promossa da Arrigo
Benedetti) mostrava come le condizioni del paese non fossero
sostanzialmente migliorate rispetto a quelle descritte vent'anni prima da
Zanotti Bianco.
Sorto
su di un costone roccioso a destra del torrente Apòscipo, a circa 737 metri sul
livello del mare, Casalnuovo contava, alla fine del secolo XVIII, circa 600
persone (in prevalenza agricoltori e pastori) e faceva parte del feudo dei
Carafa di Roccella. Il santo patrono, diverso da quello degli africesi, era San
Salvatore. Cronache risalenti al diciottesimo secolo fanno cenno ad una comunità
di monaci in Casalnuovo, dapprima professanti il rito greco ma che poi
abbandonarono tale rito. Durante l'Ottocento nel territorio di Casalnuovo furono
attivi i briganti Fortunato Mollica, Vittorio Marrapodi e Bruno Palamara.

Fra
il 14 e il 18 ottobre del 1951 una
violenta alluvione devastò Africo e Casalnuovo, causando tre vittime ad Africo
e sei a Casalnuovo nonché ingenti danni materiali. Su ordine delle autorità i
due paesi semidistrutti furono evacuati; la popolazione fu alloggiata per pochi
giorni nelle scuole elementari di Bova,
per poi, alla fine di ottobre, essere trasferita a Gambarie e
da lì provvisoriamente distribuita in vari altri comuni della provincia (fra i
quali Reggio
Calabria, Bova
Marina e Palmi;
in particolare gli abitanti di Casalnuovo, i quali erano rimasti più a lungo
nel loro abitato originario, dopo l'ordine di sgombero furono provvisoriamente
alloggiati a Bova Marina e a Bova). Più di mille persone furono allocate in
baracche di legno a Reggio
Calabria, in contrada Lazzaretto di Condera, dove in gran parte rimasero
fino ai primi anni sessanta. Tutti i rifugiati ricevettero per qualche tempo un
sussidio.
Non
è chiaro chi sia stato ad avanzare per primo l'idea di trasferire
definitivamente la popolazione dei due paesi in un nuovo centro da costruire in
località La Quercia di Capo Bruzzano, nel territorio del Comune di Bianco;
tale progetto ebbe fin dall'inizio il sostegno del deputato comunista Eugenio
Musolino e di alcune autorità di Africo. Il parroco di Africo, Don
Giovanni Stilo, fu inizialmente contrario, ma in seguito diede anch'egli
la propria adesione. Per risolvere il problema della sussistenza dei profughi
nel nuovo abituro, Musolino proponeva di espropriare il latifondo che
all'epoca esisteva fra Bianco e Brancaleone,
dove sarebbe sorto il nuovo paese, e di distribuirlo alla popolazione che
sarebbe andata ad abitarvi.
La
decisione di trasferire la popolazione di Africo e Casalnuovo nella sua attuale
sede presenta aspetti poco chiari; fin dall'inizio furono formulati seri dubbi
circa l'opportunità di tale progetto; in particolare si opposero l'Associazione
Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno e Umberto
Zanotti Bianco, il quale fece osservare come gli abitanti (in prevalenza
contadini), con il trasferimento, sarebbero stati spossessati della loro terra,
trasferiti in un territorio carente di risorse, e sarebbero state in tal modo
distrutte le basi di una vita comunitaria che gli abitanti si erano
faticosamente costruiti nell'arco di molte generazioni:
«La
burocrazia non ha il diritto di annullare con un tratto di penna questo lavoro
secolare, con lo spedire quelle turbe disgraziate là ove la terra è posseduta
da altri.» (Umberto
Zanotti Bianco).

Zanotti
Bianco, d'accordo con una parte dei rifugiati, proponeva di costruire il nuovo
insediamento in località Carruso, una zona pianeggiante situata nel vecchio
territorio di Africo; tuttavia già nel 1953 cominciarono
ad essere installati, nella suddetta località La Quercia del comune di Bianco,
alcuni prefabbricati donati dalla Croce
Rossa svedese, creando così una sorta di fatto compiuto; a questi
primi insediamenti provvisori fece seguito la costruzione di altri 88
appartamenti nel 1954. Le obiezioni, avanzate da Zanotti Bianco e da una parte
della stessa popolazione di Africo, rimasero così sostanzialmente inascoltate;
nel 1958 Antonio Marando poté scrivere che con la fondazione di Africo Nuovo
era sorto «il primo paese italiano senza territorio».
I
primi abitanti di Africo Nuovo dovettero subito confrontarsi con una realtà
economica assai difficile: la raccolta della legna e delle olive, il lavoro come
affittuari di fondi agricoli o come braccianti nelle coltivazioni di gelsomino,
l'apertura nel paese delle prime botteghe e dei primi negozi, poi il lavoro come
operai presso l'Ente pubblico per la riforestazione, non riuscirono a risolvere
in modo adeguato il problema della sussistenza materiale, cui molti ovviarono
con l'emigrazione, mentre altri si ridussero a vivere di assistenza. Non fu
senza aspre lotte che gli africesi riuscirono ad ottenere servizi essenziali
come la stazione ferroviaria.
Gran
parte della popolazione sfollata da Africo vecchio e Casalnuovo fu a lungo
costretta a vivere in campi profughi; Africo Nuovo iniziò ad esistere solo
all'inizio degli anni '60. Comunque, nel 1962 gran parte dei profughi del
Lazzaretto era andata ad abitare nel nuovo paese; alla metà degli anni '60 data
l'ultimazione di ulteriori 320 alloggi popolari nonché la costituzione ad
Africo Nuovo di un'anagrafe e di un registro di stato civile comuni alle ex
popolazioni di Africo vecchio e di Casalnuovo.
Di
fatto, il comune di Africo Nuovo rimase fino al 1980 privo di delimitazione
territoriale, mentre i suoi abitanti avevano perso la loro antica condizione
sociale (di contadini poveri) senza però averne acquistata una migliore.
Già
nel periodo della costruzione del nuovo abitato, infatti, aveva iniziato a
consolidarsi un'economia di tipo assistenziale, dapprima con il sussidio erogato
ai profughi, poi grazie ai sussidi di disoccupazione; un'altra fonte di
sussistenza era costituita dalle rimesse dei lavoratori africesi emigrati;
l'assistenzialismo migliorò in modo significativo il tenore di vita della
popolazione, ma senza che si realizzasse alcun adeguato sviluppo della
produzione agricola né di quella industriale.
Tale
contesto di persistente precarietà economica condizionò pesantemente tutte le
successive vicende del paese. Vi furono forti tensioni sociali, che si
manifestarono in scioperi, manifestazioni di protesta, blocchi ferroviari, lotte
per la democrazia e per il lavoro che videro il coinvolgimento di una larga
parte della popolazione; a tali istanze le pubbliche autorità spesso faticarono
a dare risposte che non fossero meramente repressive. D'altra parte, l'efficacia
di tali lotte venne spesso pregiudicata da episodi riconducibili all'intervento
della criminalità organizzata. A partire dagli anni Settanta, infatti, si ebbe
in tutta la zona l'ascesa della 'ndrangheta con
modalità particolarmente pervasive e anche violente; negli anni Ottanta il
paese fu teatro di una faida sanguinosa.
Più volte l'amministrazione comunale fu sciolta d'autorità e sostituita da
commissari straordinari; ciò avvenne ancora una volta nel 2014 e
un'altra volta nel 2019.

Le
rovinose alluvioni degli ultimi giorni dell'ottobre 1951 che devastarono quasi
tutto il centro di Africo Vecchio e Casalinuovo furono la causa che costrinsero
gli abitanti, dopo alloggi di fortuna e varie vicissitudini, a fondare un nuovo
paese più vicino al mare. Quello che resta dell'abitato di Casalinuovo è su
una rupe, nei pressi di Africo vecchio, alla destra del torrente Aposcipo. Le
tracce dell'origine greca si conservano tutt'oggi nella parlata, anche se
mischiata con l’idioma locale. Come Africo, anche Casalinuovo fu gravemente
danneggiato dalle alluvioni del ’51. Il nome pare derivi da
"Afrikos", cioè esposto al sole. La spiaggia di Africo è incantevole
ed incontaminata, e vanta una notissima la scogliera.
Oggi
i ruderi dei due paesi di Africo vecchio e Casalnuovo sono meta di turismo. Le
case sono raggruppate tra loro e rimangono in piedi solo le mura e alcuni archi
di imposta delle case borghesi. Gli edifici maggiormente conservati sono la
chiesa di San Nicola in Africo e la chiesa di San Salvatore a Castelnuovo, in
stile rurale ottocentesco; anche la scuola elementare di Africo si conserva con
il cartello in facciata. La caratteristica di alcune abitazioni consiste
nell'avere le fondamenta incastrate nelle rocce della montagna.
Africo
Vecchio - Fondato nel IX secolo a.C. dagli abitanti dell’antica Delia,
colonia locrese situata alla foce della fiumara San Pasquale. Nel corso dei
secoli fu associata al Casale di Bova. Dopo la fine del feudalesimo divenne
comune autonomo, vedendosi assegnata anche la frazione di Casalnuovo. Il
consolidamento del territorio, predisposto dallo stato italiano nel 1930, nulla
potè di fronte alla distruzione posta in essere dall’alluvione del 1951.
Infatti, il 18 ottobre di quell’anno, l’antico sito del borgo venne travolto
da un fiume di detriti di fango; tutto quello che aveva resistito per secoli fu
cancellato dalla forza della natura, non ultimi i numerosi terremoti che hanno
segnato la storia di tutta la Calabria.
Il
governo dell’epoca propose una ricostruzione dell’interno paese sulla costa
a oltre diciotto chilometri di distanza da quella che oggi è chiamata Africo
vecchia. Uno sradicamento doloroso che spostò la maggior parte della comunità
degli africesi nell’attuale sito che prende il nome di Africo nuovo, solo un
numero esiguo di famiglie rifiutò il trasferimento verso la marina, abitando
ancora oggi gli alloggi costruiti in località Campusa.
Ad
Africo vecchio il tempo sembra regolato da leggi diverse da quelle quotidiane, e
tutto appare sospeso in un limbo e sommerso da un mare di luce abbacinante. Un
luogo che ancora oggi, a distanza di quasi settant’anni dalle tristi vicende
che ne fecero teatro di rovina e abbandono, emana un fascino primordiale che si
diffonde nel vento.
Il
paese, al momento del definitivo abbandono, non era ancora raggiunto dalla
strada carrabile ed era collegato con il resto del mondo tramite un semplice
sentiero. Oggi, ad Africo vecchio ci si arriva solo a piedi.
Di
quelle case antiche fatte in pietra sono rimasti solo dei ruderi che si fondono
con la natura circostante. Un paese fantasma immerso nella
vegetazione, che risalendo la montagna lo si incontra per caso.
Nonostante
la lontananza e il percorso impervio, è un luogo molto amato dagli
escursionisti e appassionati di trekking che dopo la fatica, sostano dove un
tempo c’era un paese in movimento.
Del
patrimonio architettonico ancora esistente nel territorio del vecchio abitato si
segnala la chiesa di San Leo, dalle semplici forme architettoniche, ad
un’unica navata con abside semicircolare e campanile sul fronte principale.
Nel campanile sono conservate le due campane di bronzo probabilmente risalenti
all' epoca di costruzione della chiesa. Presenta una cupola con la statua
di marmo del Santo, risalente al 1635, di artigianato locale.
Situata
nella zona di Africo Vecchio, è certamente di matrice bizantina. Distrutta dopo
l'alluvione del 1951 è stata restaurata ma, mentre l'esterno conserva ancora la
foggia originale, l'interno è completamente rifatto. Nel 1972 la chiesa è
diventata meta di pellegrinaggi.

Nel
cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, a 1300 metri di altitudine, si
può ammirare la cascata Palmarello, forse la meno conosciuta tra le
cascate aspromontane a causa delle difficoltà nel percorrere il ripido e
scosceso crinale che consente di raggiungerla, ma non per questo meno
spettacolare. Generata dal torrente Aposcipo, il suo salto unico di circa
70/80 metri è il più alto del parco, osservabile da un terrazzo naturale tra
la fitta vegetazione di roveri e pini larici. L'acqua purissima sgorga
dalla roccia e forma forma un piccolo laghetto ricco di trote. Particolarmente
spettacolare ammirare gli spruzzi creati dall’acqua nei periodi di piena.
Africo
Nuovo - Il paese nasce dallo spostamento di Africo vecchio e della sua
frazione di Casalinuovo. Il nuovo insediamento abitativo venne costruito ex novo
presso “Lacco della quercia” una zona compresa tra Capo Bruzzano e fiumara
La Verde.
Incantevole
ed incontaminata la sua spiaggia, notissima la scogliera e le meravigliose
“vasche” di Africo dove lo Jonio disegna
colori unici in acque cristalline.
La
scogliera di Africo è l’ideale per passare qualche giorno in completo
relax. Vicinissima al promontorio di Capo Bruzzano, di cui ricalca in
parte bellezza e naturalezza, non offre servizi proprio per la sua
conformazione geografica che non rende possibile la costruzione di stabilimenti
balneari e abitazioni.
Lungo
questa parte della Costa dei Gelsomini è stato ritrovato un grande
masso con dei lineamenti di un volto umano perfettamente definiti. Si tratta di
un importante ritrovamento archeologico risalente alla Magna Grecia, come quelli
avvenuti a Riace negli anni ’70. Capo Bruzzano può essere raggiunto
a piedi da Africo Nuovo.
Dalla
spiaggia si gode di una bellissima vista direttamente sull’Aspromonte,
l’acqua del mare è cristallina e la scogliera ha delle forme bizzarre e
fantastiche. La zona circostante è circondata dalla natura incontaminata e si
presta a lunghi periodi di relax. Lungo il litorale si possono raggiungere altre
spiaggette incastonate nella scogliera, altrettanto meravigliose e selvagge

Africo
Vecchio, il paese della “perduta gente”
Esiste
un luogo, in Aspromonte, dove il tempo sembra regolato da leggi diverse da
quelle tradizionali, dove tutto appare sospeso in un limbo, sommerso da un
oceano di fuoco liquido ed abbacinante. Un luogo che ancora oggi, a distanza di
quasi settant’anni dalle vicende funeste che lo videro teatro di rovina e
abbandono, leva un grido sordo, che si disperde nel vento.
Questa
è la sensazione che ho provato camminando tra le rovine di Africo
Vecchio, il nucleo primigenio del nuovo e più noto abitato, sorto nei
pressi di Bianco, situato in uno dei luoghi più isolati dell’Aspromonte.
La
storia di Africo è
fatta di fatica, di sudore, di disgrazie e, infine, di abbandono. Tutti questi
elementi, però, sono permeati dall’atavica fierezza dei suoi abitanti, almeno
finché la diaspora, che per anni Zanotti
Bianco ha preannunciato e tentato di evitare, ha messo la parola
fine a quella realtà. Oggi esiste un’altra Africo, diversa, lontana dai
luoghi ove per secoli si è svolta la vita degli antenati.
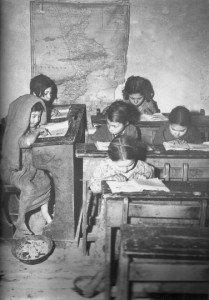 Raggiungere
Africo Vecchio non è semplice, negli ultimi cinque o sei chilometri la strada
è poco più di una mulattiera e l’accesso in auto è precluso a mezzi troppo
sofisticati. Il paese abitato più vicino è Bova
superiore, che a sua volta dista circa quindici chilometri dai ruderi.
Questo isolamento è stato uno dei motivi che ha impedito all’antico abitato
di sopravvivere alle disgrazie ed anche la ragione per la quale, probabilmente,
non si è mai verificato quel ritorno dei primi emigranti che invece è stato
possibile a Roghudi, nella quale si è potuto assistere ad una disperata opera
di ricostruzione da parte degli “Americani”, tornati nel luogo di origine
troppo tardi per poterlo salvare. Ad Africo questo non è successo, le lancette
sembrano essersi fermate nel momento preciso dell'abbandono, come sembra
suggerire una rudimentale meridiana incisa sul muro della scuola elementare ed
ormai priva dello gnomone.
Raggiungere
Africo Vecchio non è semplice, negli ultimi cinque o sei chilometri la strada
è poco più di una mulattiera e l’accesso in auto è precluso a mezzi troppo
sofisticati. Il paese abitato più vicino è Bova
superiore, che a sua volta dista circa quindici chilometri dai ruderi.
Questo isolamento è stato uno dei motivi che ha impedito all’antico abitato
di sopravvivere alle disgrazie ed anche la ragione per la quale, probabilmente,
non si è mai verificato quel ritorno dei primi emigranti che invece è stato
possibile a Roghudi, nella quale si è potuto assistere ad una disperata opera
di ricostruzione da parte degli “Americani”, tornati nel luogo di origine
troppo tardi per poterlo salvare. Ad Africo questo non è successo, le lancette
sembrano essersi fermate nel momento preciso dell'abbandono, come sembra
suggerire una rudimentale meridiana incisa sul muro della scuola elementare ed
ormai priva dello gnomone.
Tre
ore di macchina e quasi ottanta chilometri dividono Palmi da Africo
Vecchio, alla quale giungo, in compagnia dell’amico Giuseppe, verso le
10.30 del mattino. Il caldo è soffocante. Il sole di luglio arde con veemenza e
colpisce i ruderi esposti ed inermi, come a ricordare le contraddizioni insite
nella vita e nella morte del paese. Il nome Africo deriva dal greco apricos o
dal latino apricus,
che starebbe a significare un luogo luminoso ed esposto al sole e che,
tuttavia, è stato cancellato dall’acqua delle alluvioni.
Il
silenzio è interrotto soltanto dal canto delle cicale, che rimbomba tra le mura
delle case sventrate, invase dai rovi e diventate delle stalle per le vacche. In
effetti, scrivevano Francesco Bevilacqua e Alfonso Picone Chiodo, che Africo
è un’enorme e unica stalla dove le vacche allo stato semibrado hanno preso il
possesso.
Ci
addentriamo nel paese lentamente e silenziosamente, timorosi di guastare quella
quiete immobile, seguendo l’unico sentiero percorribile aperto tra i rovi e
che consente di attraversare l’abitato. Superati i primi ruderi giungiamo in
breve al cospetto di quella che, fino al 1948, era stata la scuola
elementare, come testimonia il reportage di Tino
Petrelli, pubblicato su “L’Europeo del 1948. L’immagine più nota
dell’intero reportage, composto da circa quaranta scatti di cui solo cinque
pubblicati, ritrae sei bambine sedute tra i rudimentali banchi di scuola, quasi
tutte scalze che cercano di scaldarsi al calore del braciere. Questa immagine
riassume più di ogni scritto la miseria del paese e la sua voglia di riscatto
che, purtroppo non sarà soddisfatta.
La
scuola costituisce uno straordinario esempio di ingegneria edile. La
collocazione geografica di Africo, infatti, impedisce qualunque espansione
dell’abitato verso monte e che, pertanto, si è sviluppato in lunghezza: il
paese è adagiato sul fianco di una ripida collina che scivola a sud-ovest verso
il torrente Casalnuovo, mentre a nord-est è lambita dalle strette gole
dell’Apòscipo. La singolarità dell’edificio scolastico consiste nel fatto
che esso è realizzato su di un terrapieno, contenuto da un muro di pietra sul
quale corre una scalinata che conduce alla strada principale de paese.
Guardandola da lontano la scuola sembra una fortificazione medioevale più che
un luogo di istruzione. Salendo le scale si raggiunge il piccolo cortile
antistante l’ingresso, che circonda tutto l’edificio e dal quale si gode un
meraviglioso panorama sulla valle del torrente che divide Africo dalle rovine di
Casalnuovo, poste sul versante opposto della montagna.

Sulla
facciata della scuola, posta sopra l’ingresso vi è ancora la scritta “Scuole
Elementari”. Porte e finestre non esistono più ed anche il tetto è
crollato: quello che doveva essere un luogo di riscatto e di speranza, nel quale
le nuove generazioni avrebbero dovuto gettare le basi per il loro futuro, è
rimasto lì, mutilato, memento di
un tentativo di risollevarsi che, purtroppo, non è riuscito. L’edificio
scolastico è contiguo ad uno dei tanti canaloni che attraversano
longitudinalmente il paese e che durante l’inverno si gonfiano d’acqua,
alimentando il torrente a valle. La strada principale, in quel punto, passa
sopra un ponte che scavalca il canalone, che era stato rinforzato con delle
briglie di pietra per contenere la furia dell’acqua. Si può solo lontanamente
immaginare quello che successe durante le piogge che caddero, incessanti, da
domenica 14 a giovedì 18
ottobre del 1951. Nella notte tra il mercoledì e il giovedì il peggio:
fiumi di fango invadono letteralmente il paese, trascinando animali, pietre,
alberi e persone e distruggendo ogni cosa. La montagna si è riversata
sull’abitato come un onda si infrange sugli scogli, ma gli effetti sono più
devastanti. Quello che si mostra ai superstiti alle prime luci dell’alba è lo
spettacolo straziante di un paese ferito a morte.
Proseguiamo
tra le rovine delle case, fino a raggiungere una costruzione di una certa
importanza, di due piani e con le mura portanti ancora in discrete condizioni.
Entriamo a fare delle fotografie. L’intonaco è distrutto e lascia intravedere
parti di mura in pietra. In fondo al corridoio due rampe di scale conducono al
piano superiore. La soletta è intatta ma il tetto è crollato e le stanze di
sopra sono diventate delle verande, popolate da erbacce, travi infracidite e
alberi di fico. Poco più avanti quello che resta del municipio, sulla cui
facciata non rimangono che poche lettere ad indicare che quello era il centro
amministrativo del paese. Camminando sul ciglio delle mura interne ormai
esposte, nell’area che una volta era il terrazzo, si riesce a vedere la
seconda parte del paese, dominata in lieve lontananza dal campanile, sul quale
campeggia ancora una campana di bronzo.
La
piazzetta antistante la Chiesa
di San Salvatore si mostra accogliente anche nella rovina. È
circondata di edifici, ormai diruti, che dovevano conferirle un raro senso di
raccoglimento e dei quali non restano che mura sventrate e pietre sparse sul
selciato. Dentro la Chiesa il pavimento è stato parzialmente ripulito del
calcinaccio caduto dal soffitto e dagli escrementi delle vacche, alle quali
viene ora impedito l’accesso mediante un cancelletto rudimentale posto
all’ingresso.
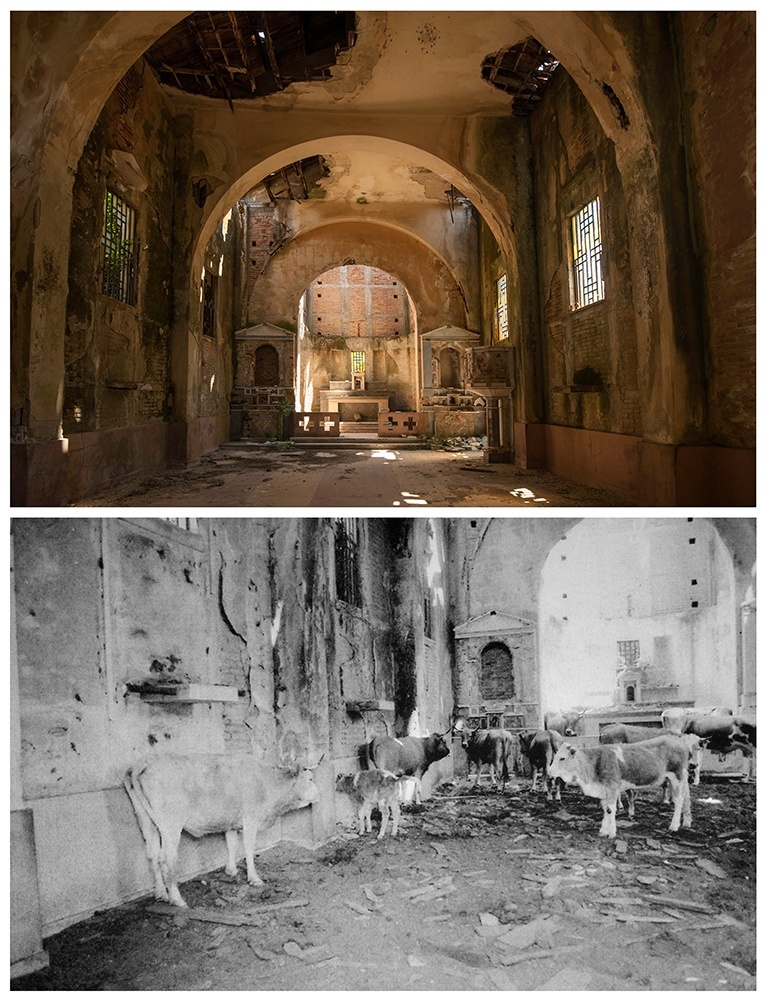
Un
moderno decespugliatore ed alcuni attrezzi segnalano che è in atto una parvenza
di manutenzione; ci sono anche dei pali di legno appena preparati, pronti per
essere conficcati nel terreno. La sensazione è che ci sia in atto qualche
progetto di parziale risistemazione dell’abitato.
La
speranza che tra queste mura possa tornare la vita, anche nella forma del
pellegrinaggio e del turismo culturale, è tuttavia flebile quanto la fiamma di
una candela al vento. Immagino una Africo ripulita, strappata ai rovi ed alla
vegetazione che nei decenni l’hanno fagocitata, resa più facilmente
raggiungibile da vere piste in terra battuta e curata da enti ed associazioni
che hanno davvero a cuore la storia e la memoria della nostra terra, sì da
renderla fruibile alle nuove generazioni che, visitandola, potranno riscoprire
la storia della Calabria.
Sto evidentemente sognando ad occhi aperti. Luoghi come questo suscitano un sano
interesse solo in uno sparuto gruppo di persone, troppo poche per giustificare
l’attivazione della macchina amministrativa, che dovrebbe reperire e stanziare
le somme necessarie al recupero.
Queste
mura non dureranno per sempre, lentamente la montagna si riprenderà ciò che le
era stato tolto e dalle intemperie, mortale stillicidio che, stagione dopo
stagione, eroderà gli ultimi frammenti di questo popolo. Del bellissimo arco in
pietra, ingresso di un edificio del lato est del paese e del quale vi è una
bella fotografia nel già citato libro di Vito
Teti, non rimane che un cumulo di macerie.

Sul
retro della chiesa il sentiero prosegue verso il bosco e raggiunge dopo qualche
chilometro il cimitero di
Africo e, più avanti, la chiesetta intitolata a San
Leo, del quale Africo e Bova si contendono ancora oggi i natali. Nel
cimitero, racconta sempre Teti, fino al 1999 vi erano ancora le ossa dei
defunti. Poi è stato ripulito e le ossa trasferite al cimitero della nuova
Africo. Evidentemente la pulizia non è stata costante, perché noi l’abbiamo
trovato nuovamente invaso dalla vegetazione, al punto che è impossibile
camminare tra le tombe.
La
chiesa, invece, è posta in una larga curva della carrareccia che prosegue in
discesa verso l’Apòscipo:
non ne sono sicuro ma credo che sia una delle chiese più isolate della regione
e, ciononostante, non è mai stata abbandonata. In questo luogo che sembra
dimenticato da Dio ogni anno dal 1972 ritorna la vita, quando a maggio si
svolgono i festeggiamenti
di San Leo e un’Icona
del Santo viene portata in processione fino al paese vecchio. Le
nuove generazioni hanno cercato, nonostante la diaspora e l’abbandono, di
mantenere vive le tradizioni e anche se la festa e la processione hanno
caratteri diversi dal culto originario, sono l’ultimo baluardo di civiltà di
un paese che ha già un piede oltre l’orlo del precipizio. Africo Vecchio è
un paese estinto ma ogni pietra mantiene una fierezza ed una dignità che è
raro incontrare negli insediamenti più moderni. Sta cadendo nel baratro
dell’oblio, trattenuto solo da alcune braccia tese. Mi chiedo quanto potranno
resistere.
Il
problema del recupero di luoghi come Africo Vecchio non è soltanto di natura
amministrativa o politica. Alla base di tutto vi è la pressoché totale assenza
di interesse collettivo verso luoghi come questo, vittime dello scellerato
campanilismo che affligge la nostra provincia. Non siamo abituati allo “sguardo
globale”, al sentirci parte di qualcosa di più ampio e complesso del
ristretto quadro territoriale del comune di appartenenza e, di conseguenza,
tutto ciò che si trova al di fuori di quei confini risulta spesso di scarso
interesse. Anzi, se un’amministrazione più alta di quella comunale dovesse
riuscire ad investire delle risorse in qualche luogo diverso dal nostro, saremo
pronti ad accusarla di averci trascurati, di aver preferito favorire altri che
noi. La Calabria ha molti problemi, non c’è dubbio, ma sono convinto che il
primo passo da fare sia verso la persuasione collettiva, la sensibilizzazione al
patrimonio che si cela tra le pieghe della nostra terra.
Attraverso
la fotografia e la scrittura cerco di dare voce a luoghi come questo,
nell’utopico tentativo di contribuire, sebbene parzialmente, a costruire
quella conoscenza del territorio che è alla base di qualunque sana idea di
sviluppo e di crescita.

Fonte: