|
Il
territorio di Monasterace si eleva dal livello del mare, dove si trova la
frazione Marina, fino a 177 metri s.l.m. Il nucleo urbano principale è posto a
138 metri s.l.m.
Sorge
in corrispondenza della Punta Stilo, una lieve protuberanza costiera limitante a
sud il Golfo di Squillace, che in passato, sulla base di testimonianze
letterarie e di indagini geologiche, era ben più pronunciata; Plinio il Vecchio
parla del Promunturium Cocynthum (come era chiamato in epoca romana) come del
“longissimum Italiae promunturium”, il promontorio più lungo d’Italia.
Inoltre, le indagini di archeologia subacquea hanno rilevato il netto
prolungamento del promontorio in mare in età magnogreca.
 Tuttora,
in presenza di un accentuato bradisismo, in concorso con potenti mareggiate
invernali, la linea costiera varia di anno in anno, allargando o restringendo la
spiaggia, talvolta completamente sommersa in alcuni punti. In tempi più remoti,
al contrario, vi doveva essere una forte contrazione della superficie,
testimoniata dalla presenza di almeno tre aree in cui si rinvengono resti di
conchiglie: la contrada di mezza collina detta Petrusu, verso il confine con la
provincia di Catanzaro; la fiancata meridionale della collina detta Piazzetta;
lungo la strada interna a nord, che porta verso i paesi dell’interno. In
questi due ultimi casi si tratta di veri e propri piccoli giacimenti di fossili. Tuttora,
in presenza di un accentuato bradisismo, in concorso con potenti mareggiate
invernali, la linea costiera varia di anno in anno, allargando o restringendo la
spiaggia, talvolta completamente sommersa in alcuni punti. In tempi più remoti,
al contrario, vi doveva essere una forte contrazione della superficie,
testimoniata dalla presenza di almeno tre aree in cui si rinvengono resti di
conchiglie: la contrada di mezza collina detta Petrusu, verso il confine con la
provincia di Catanzaro; la fiancata meridionale della collina detta Piazzetta;
lungo la strada interna a nord, che porta verso i paesi dell’interno. In
questi due ultimi casi si tratta di veri e propri piccoli giacimenti di fossili.
L’area
comunale è prevalentemente collinare, con ampie zone pianeggianti lungo la
costa e le fiumare che sfociano a mare nei suoi confini.
Risalendo
dalla costa verso l’interno, si hanno, da sud a nord, alcune colline: il
Terzinale (nome poi corrotto in Arsenale nelle carte dell’IGM) o della
Passoliera, dall’edificio che vi sorgeva in cima; una collina senza nome,
sulla cui cima venne costruita una casamatta negli anni della seconda guerra
mondiale; la Piazzetta, possibile acropoli della città magnogreca; una collina
poco elevata in contrada Castellone, importante per il faro che vi sorge, grazie
alla cui costruzione si rinvennero i resti di un tempietto che permisero di
individuare il luogo in cui sorgeva l’antica Kaulonìa.
Tre
sono le fiumare che. da nord a sud, vi sfociano: Fiumarella di Guardavalle, al
confine con questo Comune e con la provincia di Catanzaro; Assi, il cui corso più
regolare in passato forniva l’acqua per il funzionamento del mulino ad acqua
di cui resta ancora l’edificio cadente; Stilaro, al confine con il Comune di
Stilo. Fino alla fine degli anni ’60 del secolo scorso vi erano altri rivi,
tra cui il più rilevante quello di Vidicà (dal Vallone San Bernardo,
che fiancheggia la Piazzetta), ed altri minori, poi prosciugati, interrati o
ricoperti dalle costruzioni.
Fino
al secondo dopoguerra la zona costiera era piuttosto paludosa ed infestata dalla
malaria; fino agli anni ’60 rimasero un piccolo stagno alla foce del Vidicà e
una palude nell’area sud della Marina, dove in seguito sorse la chiesa
parrocchiale di San Giuseppe Artigiano. Vicino a questa, sgorgava una sorgente,
detta Zombaredu, presso la quale si rifornivano gli abitanti fino agli anni
del dopoguerra; vi si trovano anche altre sorgenti anche in aree interne, come
nella contrada Scovara.
Su
una collina a circa 2 chilometri dalla costa sorge il nucleo storico del paese,
Monasterace Superiore, (oggi “nobilitato” da taluni come Monasterace Centro
o Borgo) sormontato da un castello di origini almeno medievali in corso di
restauro al fine di creare spazi per attività sociali.
A
sud si trova l’altipiano della Melìa, dove il comune raggiunse la sua altezza
massima; ad ovest il colle degrada più bruscamente nella contrada semicollinare
di Arsafia; a nord è fiancheggiato dalla fiumara Assi, dalla cui sponda
sinistra comincia la frazione Campo Marzo, un territorio tra il pianeggiante e
il semicollinare, che giunge fino al confine con Guardavalle.
Il
toponimo Monasterace si pensa che derivi dal greco Μοναστηράκι
(Monastiraki), cioè "piccolo monastero".
La
più antica menzione di questo nome si rinviene nella redazione cosiddetta A del
Bios di San Giovanni Therisitìs, riportante la datazione 1217-1218, conservata
a Palermo nella Biblioteca Centrale della Regione Siciliana (vol. gr. II. E.
11), in un testo manoscritto del 1611 proveniente da Stilo. Essendo il santo
monaco vissuto dal 995 circa al 1054 d.C., è altamente probabile che il nome
fosse già presente in tale epoca.
 Si
è certi dell'esistenza di un piccolo monastero di rito orientale dedicato a
Sant’Eufemia, situato nel centro collinare del Comune in quella vallata dello
Stilaro che vide il fiorire del cosiddetto monachesimo
basiliano. Niente ha a che vedere con la molto più tarda chiesetta, di
epoca angioina, di San Marco, i cui resti persistono nei pressi della
spiaggia, in piena area archeologica dell’antica colonia magno-greca di Kaulonìa. Si
è certi dell'esistenza di un piccolo monastero di rito orientale dedicato a
Sant’Eufemia, situato nel centro collinare del Comune in quella vallata dello
Stilaro che vide il fiorire del cosiddetto monachesimo
basiliano. Niente ha a che vedere con la molto più tarda chiesetta, di
epoca angioina, di San Marco, i cui resti persistono nei pressi della
spiaggia, in piena area archeologica dell’antica colonia magno-greca di Kaulonìa.
Del
tutto infondate altre ipotesi sul toponimo, tra cui quella di una presunta
origine normanna Motta Sterace o Monte Storace e simili,
originate dal fraintendimento di M. Sterace/Storace, nome con cui cartografi
inesperti dei luoghi e poi autori poco accurati indicarono il nome del paese.
La
leggenda narra che nell'VIII secolo a.C., Caulone,
figlio dell'amazzone Cleta,
approdò sulle coste antistanti l'odierna Monasterace Marina e qui vi fondò
l'antica Kaulonìa della Magna
Grecia.
Monasterace
marina è il luogo dell'antica città magno-greca di Kaulonìa; tuttavia, non si
può escludere la possibilità che il sito sia già stato popolato da gente
indigena, o addirittura dai bruzi stessi che molto prima del VII
secolo a.C. (data in cui i greci colonizzarono il meridione
d'Italia) risiedevano in Calabria insieme ai lucani, di cui erano schiavi e
successivamente alleati contro le pretese di Roma.
Monasterace
Superiore ha un'origine medievale. Fu popolata dai superstiti di Kaulonia, che
dopo la deportazione di metà della popolazione a Siracusa da parte di Dionigi e
il successivo assoggettamento a Roma, popolarono i colli circostanti per
ripararsi dalle malattie infettive quali malaria e plasmodium che si
diffondevano nelle pianure ormai abbandonate e per sfuggire alle scorrerie di
pirati che approfittando delle distruzioni delle città magnogreche,
saccheggiavano e incendiavano i pochi centri rimasti. In periodo normanno fu un
casale del Kastron di Stilo fino
al 1275,
successivamente passo sotto l'ordine dei templari.
Nel 1347 col
dominio Angioino il feudo di Monasterace viene dato a Nicola Caracciolo,
fratello del feudatario di Gerace.
Nel 1659,
a causa di un terremoto subisce gravi danni, ma non viene riparato secondo il
suo stile originario.
Durante
il periodo della Rivoluzione
francese subisce la confisca dei beni e il Capostipite Diego di
Francia acquista il feudo.
Nel 1807 diventa Università:
una unità giuridica ed amministrativa autonoma. Nel 1811 durante
il Regno delle
due Sicilie diviene comune autonomo ed incluso nel circondariato
di Stilo.
Nel 1816 passa
dalla Calabria
Ulteriore Seconda (Catanzaro) alla Calabria
Ulteriore Prima (Reggio Calabria).
Visitare
il borgo

Dolcemente
adagiata tra le alture della valle dello Stilaro e dell’Allaro e le
acque cristalline del Mar Ionio, la cittadina di Monasterace fa bella
mostra di sé da tempi antichi la cui memoria è rimasta scolpita tra le pietre
del tempio dorico di Apollo sulla spiaggia, nei motivi dei preziosi mosaici
greci qui rinvenuti, nelle tradizioni folkloristiche ancora vissute con
entusiasmo.
Porto
dell’antica Kaulon,
importante città magnogreca le cui rovine continuano a riaffiorare tra le
sabbie dorate e la macchia mediterranea della valle, Monasterace è un
luogo ricco di fascino in cui castelli bizantini, monasteri ortodossi, rovine
greche e tradizioni medievali raccontano la storia di un passato
glorioso che ha impresso la sua memoria nella roccia e nella sabbia, da cui ogni
tanto riemergono tesori inestimabili.
Resti del
tempio dorico di Kaulonìa (Monasterace Marina)
Castello
Medievale (Monasterace Superiore)
- Fu di proprietà dei
principi Caracciolo fino al 1464, poi passò di mano agli Arena Concublet che
dopo pochi anni lo vendettero nel 1478 a Guglielmo Monaco, per passare
successivamente nel 1486 a Silvestro Galeota. Rimase in possesso della
sua famiglia col titolo di principi di Monasterace fino al 1654. In seguito
passò di proprietà diverse volte: prima al maestro di Campo Carlo della Gatta,
a Giacomo Pignatelli, a Barbara Abenante, al marchese Perrelli, ai
Tomacelli, ai Marcucci, al barone Oliva, ed infine nel XX secolo arrivò la
famiglia del barone Scoppa di Francia che nel 1919 lo vendette al
cavalier Giuseppe Sansotta che divise la proprietà in più parti per poi
rivenderle a diverse famiglie, che con ristrutturazioni e rifacimenti motu
propriu ne modificarono l'aspetto senza alcun criterio di restauro, bensì
di vivibilità e praticità.

Ruderi della
chiesetta bizantina intitolata a San Marco
Resti di
ville romane
Chiesa
di Maria SS di Porto salvo, risalente alla fine del Settecento,
appartenente ai marchesi di Francia, di cui rimangono il palazzo nobiliare
omonimo antistante alla suddetta chiesa.
Chiesa
di San Nicola di Bari, risalente alla fine del Seicento (Monasterace
Superiore).
Duomo o
Chiesa Matrice, risalente ai primi dell'settecento (Monasterace
Superiore).
Monumento
del Calvario in pietra antica, via Calvario. (Monasterace Superiore).
Chiesa di
Maria S.S. di Loreto risalente al XII secolo circa, è stata distrutta negli
anni ottanta per far passare una strada e congiungere Monasterace Sup. alla ex
SS 110, dell'antica struttura è rimasto solo l'altare con un affresco sempre
databile al XII secolo, nell'anno 1999 un gruppo di fedeli, a proprie spese ha
eretto un edificio moderno a protezione dello stesso. (Monasterace Superiore).
Torri
antiche, facente parti le mura di cinta. Risalenti ai primi dell'XI
secolo. (Monasterace Superiore).
Piccolo Museo
della civiltà contadina (Monasterace Superiore)
Museo
archeologico di Monasterace - Il museo archeologico di Monasterace o Museo
archeologico dell'Antica Kaulon o MAK è il museo sorto intorno
al parco archeologico "Paolo Orsi", il quale conserva i resti
dell'antica città magnogreca di Kaulon.
Dal dicembre
2014 il Ministero per i beni e le attività culturali lo gestisce
tramite il Polo museale della Calabria, nel dicembre 2019 divenuto Direzione
regionale Musei.
È composto da
7 sale. La prima mostra reperti della fondazione della città di Kaulon tra cui
3 corredi tombali, una incinerazione di località Bavolungi di Stilo e un
corredo tombale di località Franchi di Stilo. Sono presenti anche dei khantaroi di
tipo Itaca, materiale dell'Eubea ed acheo. La seconda espone i corredi
della necropoli dell'area di nord-ovest di Kaulon al di fuori delle mura con
reperti risalenti tra il VI ed il IV secolo A.C. tra cui di attività
produttive. Nella terza sala c'è il materiale trovato nel santuario di Punta
Stilo, tra cui anche la Tabula Cauloniensis in bronzo, il più lungo testo
scritto acheo in Italia risalente al V secolo A.C. Nella quarta sala è
allestita la ricostruzione del recinto e delle terme ellenistiche di
"Casamatta". La quinta sala mostra i reperti dei resti delle case
dell'area San Marco e il mosaico del Drago. La sesta sala è dedicata alla
ricostruzione di una casa di Kaulon ed infine nella settima c'è la
ricostruzione del santuario di Passoliera nonché rocchi di colonne frutto di
rinvenimenti subacquei.

Antichi
resti della città di Kaulonìa (Monasterace Marina) - Caulonia,
o Kaulonìa fu una colonia della Magna
Grecia, i cui resti sorgono
nei pressi di Punta
Stilo. L'area intorno al
sito su cui insisteva la polis viene chiamata dagli archeologi Kauloniatide.
Secondo
la tradizione, il nome della città deriverebbe dal nome del suo fondatore,
Caulon, figlio dell'amazzone Clete. Il mito vuole che, dopo la guerra di Troia,
gli Achei guidati da Tifone di Aegium sbarcarono sulle coste della Calabria e,
con l'aiuto dei Crotoniati, distrussero il regno di Clete. Solo suo figlio
Caulon si sarebbe salvato e avrebbe ricostruito la città. Secondo Strabone, invece, il nome della città
deriverebbe da aulonia, vallonia, cioè valle profonda. Francesco
De Sanctis, lo farebbe derivare piuttosto dalla
parola kaulos, ovvero fusto, tronco.
Circa
le ipotesi riguardanti la sua origine, le fonti riportano due principali
interpretazioni. La prima, sostenuta da Strabone (Geografia, VI, 1, 10) e Pausania
il Periegeta (VI, 3, 12), attribuisce agli Achei il ruolo di fondatori, nella
persona di Tifone di Aegium.
La
seconda ipotesi, propria di autori più moderni, propende invece per l'origine
come colonia di Kroton (l'attuale Crotone). In realtà, non c'è una vera e
propria dicotomia tra le due ipotesi: la ricerca archeologica è infatti
concorde nell'individuare nell'VIII
secolo a.C. il periodo di fondazione di
Kaulonìa, mentre l'influenza crotoniana, corrispondente al periodo di massimo
splendore, è databile al VI
secolo a.C..
La
città era limitata a sud dal fiume Sagra, sulle cui rive nel VI
secolo a.C. si svolse la famosa battaglia
della Sagra, in cui Kaulon, alleata con Kroton, fu
sconfitta dalle poleis di Locri
Epizefiri e Rhegion (l'antica Reggio); la leggenda
vuole che in battaglia fu decisivo il miracoloso intervento dei Dioscuri.
Nel IV
secolo a.C. Kaulonìa fu poi sconfitta dalle forze congiunte dei Lucani e di Dionisio
I di Siracusa, sconfitta che costò nel 389
a.C. la deportazione dei suoi abitanti
a Siracusa e la cessione del territorio a Locri, alleata del tiranno. Ricostruita da Dionisio
il Giovane, Kaulonìa fu in seguito preda di Annibale durante la seconda guerra punica,
finendo poi definitivamente nell'orbita di Roma per opera di Quinto
Fabio Massimo nel 205
a.C.
Strabone ci riferisce che già ai suoi
tempi la città era stata abbandonata a
causa di conflitti con gli abitanti della regione circostante. «Dopo
il fiume Sagra c'è Caulonia, fondata dagli Achei e chiamata dapprima Aulonia,
per la valle che
si trova di fronte ad essa. Ora la
città è abbandonata: i suoi abitanti, infatti, furono cacciati dai barbari in
Sicilia,
dove fondarono un'altra città di Caulonia» (Strabone, Geografia,
V, 1, 10)
Fonti
letterarie attestano che Kaulonìa avesse un porto con doppio approdo situato
alla foce della fiumara d'Assi e che fosse
quindi una città che commerciava in legname. Ricca di materie prime come pietra,
magnesia, sale, oro e piombo, sarebbe stato anche un centro per la produzione di
manufatti in metallo e vasellame.

Il
santuario di Punta Stilo
- Il
santuario è composto da un tempio dorico costruito con arenaria, attorno al quale vi sono degli altari
minori, con cippi e trapezai con offerte di armi di cui ne sono state trovate
oltre 180 tra quelle integre e quelle di cui ne sono rimasti solo frammenti. Le divinità adorate nel santuario
con certezza sono sicuramente Afrodite e Zeus, la tabella bronzea ritrovata e
definita cauloniensis ha scritta una dedica a Zeus in alfabeto
acheo. Il ritrovamento di foglie d'alloro in
bronzo indicano anche di un culto dedicato ad Apollo, tra l'altro rappresentato
nelle monete argenteee incuse di Kaulonìa. Infine sempre nella tabella Cauloniensis
si trovano anche riferimenti ad Artemide, alle Muse e alle Grazie. Nel III secolo A.C. il tempio fu poi
abbandonato e l'area fu riorganizzata per lo scalo marittimo.
La
casamatta
- Nella Casamatta sono state ritrovate diverse
monete dell'epoca nonché tracce di un culto a Demetra.
La
casa del Drago - La
casa del drago è il nome con cui si individuano i resti di una casa in cui è
stato ritrovato un mosaico pavimentale rappresentante un drago marino. Diventato negli ultimi anni poi
simbolo di Kaulonìa stessa. La casa è grande 17x35 metri. recentemente il motivo del
drago è ricomparso in un grande mosaico rinvenuto nel 2012 nell’area
archeologica di Kaulon in condizioni eccelse, che probabilmente era
il pavimento di una vasca termale. Il mosaico - tra i più grandi rinvenuti nel
sud Italia - presenta un motivo di dragoni, delfini e un ippocampo. I
Tempio
sotto al faro
- Sul
colle del Faro
di Punta Stilo Paolo Orsi individuò i resti di un presunto tempio dedicato o a
Poseidone o ad Apollo.
Altre
case - La
Casa del Personaggio Grottesco, Casa
dell'Insula, Casa Guarnaccia, Casa di Clete.
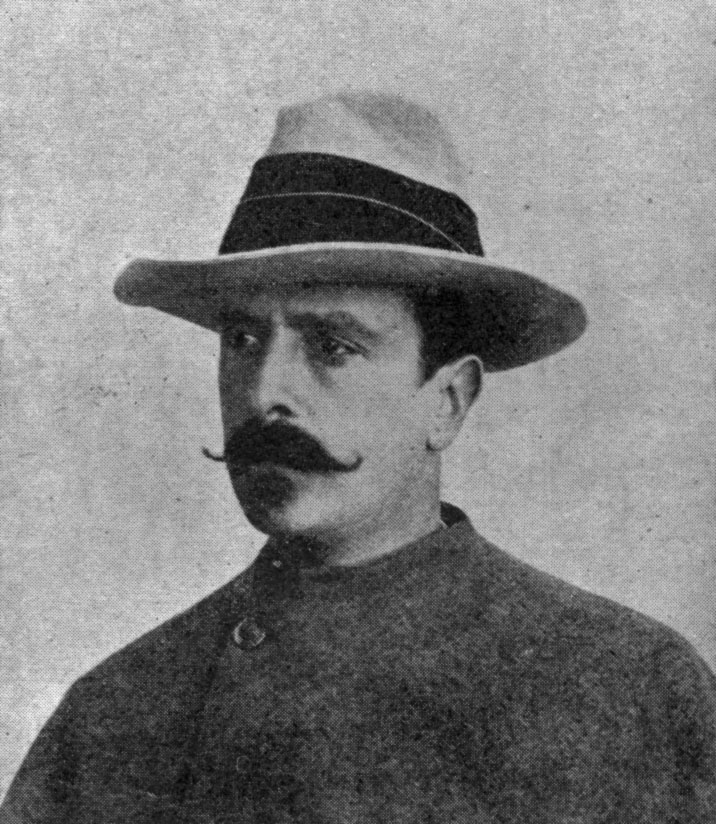 Gli
scavi e i reperti
- Già
dal XVI secolo diversi studiosi tentarono di individuare il sito della città di
Kaulonìa ma solo l'archeologo Paolo
Orsi fu in grado
di identificarne il luogo nel 1891 confermato dai primi scavi effettuati tra il 1911 e il 1913 dall'archeologo Paolo
Orsi, all'epoca Soprintendente ai Beni
Archeologici della Calabria e cofondatore del Museo
della Magna Grecia. Gli
scavi e i reperti
- Già
dal XVI secolo diversi studiosi tentarono di individuare il sito della città di
Kaulonìa ma solo l'archeologo Paolo
Orsi fu in grado
di identificarne il luogo nel 1891 confermato dai primi scavi effettuati tra il 1911 e il 1913 dall'archeologo Paolo
Orsi, all'epoca Soprintendente ai Beni
Archeologici della Calabria e cofondatore del Museo
della Magna Grecia.
Venne
alla luce come la struttura della città prevedesse l'esistenza di un centro
urbano principale, cinto da mura e posto al livello del mare, all'interno del
quale era presente un tempio dorico, di cui ancora oggi sono visibili le
fondamenta. Secondo gli studi effettuati all'epoca, alla costruzione di questo
tempio avrebbero dovuto partecipare maestranze provenienti da Siracusa, data l'alta quantità di quello che
si ritenne essere calcare siceliota.
Si
scoprì inoltre che l'area antistante il tempio, attualmente coperta dal mare,
era pure occupata dal centro abitato, come testimoniato dai reperti ivi
ritrovati, che al tempo stesso attestano la progressiva erosione della costa
nell'area.
Durante
la costruzione del cavalcavia ferroviario nel 1941 furono ritrovate resti di
strutture murarie.
Nuovi
scavi vengono effettuati tra il 1970 ed il 1971 da Elena Tommasello che a sud del
Tempio dorico rinviene 3 guttae.
Gli
scavi condotti dalla Scuola
Normale Superiore e dall'Università
di Pisa a partire dal 1999 e ancora in corso hanno riportato alla luce buona
parte del santuario urbano al quale appartenne il tempio dorico. Molti altri
edifici di grandi e piccole dimensioni sono stati messi in luce o individuati
attraverso lo studio sistematico dei materiali architettonici rinvenuti. E molte
scoperte hanno permesso di comprendere l'articolazione delle fasi di vita del
santuario, a partire dalla sua prima monumentalizzazione nella prima metà del VII
secolo a.C., fino al progressivo declino dei primi
decenni del III
secolo a.C. Ormai superata è l'ipotesi che la
costruzione del tempio dorico si debba a maestranze provenienti da Siracusa: i recenti studi litologici hanno
infatti dimostrato che la pietra utilizzata non è un calcare siceliota, bensì
materiale estratto in loco.
Al
di fuori della cerchia delle mura, e in particolare sul colle Tersinale, era
inoltre sito un altro centro cultuale di grande rilievo, come
desumibile dalle numerose testimonianze ivi raccolte. Da quest'area provengono
alcune favisse ricche di frammenti di terrecotte
architettoniche, in particolare frammenti di cassetta, sime frontonali, sime con gronde a testa di leone,
alcuni acroteri angolari ed uno centrale, tutto
materiale proveniente da tre fasi costruttive diverse di un piccolo tempio.
I
numerosi reperti archeologici provenienti dagli scavi effettuati sul posto sono
per lo più esposti al Museo
nazionale della Magna Grecia di Reggio
Calabria. Di particolare rilievo sono due mosaici di eccezionale fattura, entrambi
raffiguranti un drago, uno dei quali copre un'area di 25 m² ed è quindi
considerato "il più ampio mosaico ellenistico reperibile al Sud". Entrambi i mosaici sono attualmente
esposti presso il Museo di Monasterace.
Il
finanziamento degli interventi conservativi del sito archeologico in generale, e
dei preziosi mosaici del "drago" in particolare, conosce allo stato
attuale numerose difficoltà. Il mosaico è stato recentemente adottato da un
gruppo di studenti della scuola media dell'Istituto comprensivo Amerigo Vespucci
di Vibo
Valentia, i quali hanno raccolto una piccola somma tramite autotassazione.

Gli
scavi dal 2003 a oggi: San Marco nord-est
- L'area
di scavo, denominata saggio SAS II e topograficamente San
Marco nord-est, oggi interessa l'area tra il mar
Ionio a est la ferrovia
Taranto-Reggio Calabria a ovest, la fiumara Assi a nord e
l'area di casamatta a sud.
Grazie
a frammenti di protokotylai e kotylai Aetos 666, si può stabilire una presenza umana nell'area sin
dall'VIII secolo a.C.; dalla fine dell'VIII, o meglio dai primi decenni del VII
secolo, la presenza greca si fa stabile. Di un periodo successivo sono i resti
riconducibili a una casa di benestanti denominata Casa del Personaggio
Grottesco. Nei pressi di essa è stato
individuato una strada in direzione nord-sud larga 6,65 metri. Nel III secolo
a.C., in periodo ellenistico, sono stati rinvenuti i resti di un ampio edificio
in parte ancora sotto l'attuale asse viario della strada
statale 106 a cui quindi non è possibile accedere per definirne completamente il
perimetro. Infine sono stati portati alla luce ciò che rimane di una piccola
necropoli del periodo tardo-antico (VI-VII secolo d.C.).
Campagne
di scavo dal 2001 al 2006
- Dal
2001 al 2006 sono state condotte otto campagne di scavo da M.C. Parra e M.T.
Iannelli. Un'area di ricerca di 56 km² intorno a Kaulon tra i comuni di Monasterace, Stilo, Camini e Guardavalle.
Sono
state scoperte 174 unità topografiche (sedi di manufatti ceramici) e 230
manufatti o aree di dispersione di manufatti a carattere sporadico, che hanno
portato al censimento di 148 siti e 179 testimonianze extra-sito. Questi siti si trovano a Stilo in
località Arito, Bavolungi, Franchi, Furno, Ligghia, Napi, Salti e Troiano.
Insediamenti
di età arcaica
- Sono
stati individuati 7 insediamenti greci di modesta entità di età arcaica,
ubicati tutti alla destra idrogragica dello Stilaro e quasi tutti in posizione
elevati e a 1000 metri di distanza (eccetto quello in località Franchi e quello
in località Serre) ognuno tra di loro interpretabili come fattorie. Il sito di
Franchi (Stilo) differisce per la sua posizione, sicuramente elevata, ma anche
ben difesa naturalmente. Cronologicamente sono esistiti tra il
VII e il VI secolo a.C. e nessuno giunge al periodo ellenistico.
Fa
eccezione, in località Fontanelle (Monasterace), alla sinistra idrografica
dello Stilaro, il rinvenimento di resti di una Villa romana con tracce di
insediamento greco sin dal VI secolo a.C.
Campagne
di scavo dal 2007 al 2009
- Campagna
di scavo 2007: A giugno 2008 viene scoperto un frammento lapideo di una dedica
in lingua
osca scritta in alfabeto
osco-greco del IV-III secolo a.C. per la dea
italica corrispondente a Venere per i latini.
Campagna
di scavo 2008 - Campagna
di scavo di agosto-settembre 2009. Rinvenimento delle testimonianze più antiche
del sito: una protokotyle corinzia, un frammento di coppa
corinzia di tipo Thapsos e il frammento di uno skyphos.

2013
- Il mosaico di 35 metri quadrati e la tabella bronzea in alfabeto acheo
- Il
23 luglio 2013 l'archeologo Francesco Cuteri e
la sua équipe scoprono uno dei mosaici più grandi mai rinvenuti del periodo
ellenistico della fine del IV secolo a.C., che ricopre un'area di circa 35 m².
Il ritrovamento è avvenuto tra le rovine di quella che doveva essere una
struttura termale. Il mosaico si articola ulteriormente in 9 quadrati policromi
e un altro spazio con una rosetta policroma all'ingresso della stanza.
L'8
ottobre 2013 viene annunciata la scoperta nel
santuario urbano di una tabella bronzea del V secolo a.C. con una dedica in
alfabeto
acheo, con stile grafico stoichedón, sviluppata su 18 linee. È il testo
acheo più lungo mai ritrovato nella Magna
Grecia.
2018
- Un nuovo geison
- A
seguito delle mareggiate a cavallo tra il 2013 ed il 2014 viene scoperta l'esistenza di un
nuovo geison che potrebbe testimoniare l'esistenza di un nuovo edificio di
ordine dorico. È scolpito in calcarenite bianca
molto fine, è lungo 88,5 cm, è largo 68,15 cm e alto 47,2 cm. Il mutulo correlato è composto da 3 file di 6 guttae, ed ognuna di esse ha un
diametro di 4,4 cm.
Reperti
numismatici
- Durante
gli scavi a Kaulonìa sono state rinvenute numerose monete in bronzo,
successivamente raccolte nella collezione numismatica di Rodolfo Cimino. Tale
collezione, basata a Monasterace Marina, è composta da 181 reperti fittili e
metallici e di 238 monete di età greca, romana e medievale, materiali che
vennero raccolti a partire dal 1942 da Rocco Giordano, ex
Conservatore Onorario dell'area archeologica di Kaulonìa. Questa collezione era
nota sin dal 1977 alla Soprintendenza Archeologica
della Calabria.
Mostre
a Firenze del 2010 e 2013/14
- Nel 2010 è stata allestita la mostra all'Università
di Firenze Spigolando tra gli archivi, correlata dalla realizzazione del
cortometraggio A scuola di archeologia seguendo le orme di Paolo Orsi a
Caulonia. Da dicembre 2013 a marzo 2014 è
stata allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di Firenze la mostra Kaulonia,
la città dell'amazzone Clete.
Mostra
ad EXPO 2015
- A Expo
2015 nel Padiglione
Italia, dal 14 al 21 agosto 2015, viene
esibita la ricostruzione virtuale stereoscopica dell'andron della
“Casa del Drago” della colonia achea di Kaulon. La mostra virtuale è stata
realizzata dallo spin-off 3DResearch dell'Università
della Calabria.
Alluvione
e messa in sicurezza del sito
- Nel
mese di dicembre del 2013 i resti della casamatta sono
stati rovinati dal maltempo e dal mare mosso, oltre che dalla mancanza di
qualsivoglia protezione del sito archeologico. La Soprintendenza archeologica
calabrese, insieme al comune di Monasterace, fecero una richiesta di
finanziamento del parco per un milione e mezzo di euro, per la quale ancora non
è pervenuta risposta. In ultima istanza, a fronte di tale situazione a rischio,
la provincia
di Reggio Calabria vorrebbe mettere a disposizione
due milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza del parco archeologico. Il 2 febbraio 2014 il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo ha annunciato un finanziamento di 300.000 euro
per la messa in sicurezza de sito archeologico.
Nel 2015 viene costruita la prima difesa per il tempio dorico, mentre nel
settembre 2016 sarebbero dovuti partire i lavori anche per la restante area, ma
ancora non sono stati avviati.

 Folklore
di Monasterace Folklore
di Monasterace
Ricca
del fascino dei luoghi antichi e forte di un passato glorioso che continua a
riaffiorare dalle sabbie, Monasterace si è aperta alla modernità con i recenti
restauri del lungomare - attrezzato per dare una risposta al crescente turismo
balneare - e del castello a lungo deturpato da una secolare tradizione di
passaggi di mano, ma tiene vive le sue tradizioni folkloristiche più
importanti, come la processione di S. Andrea d’Avellino, detta U
territoriu, che si svolge ogni tre anni.
Durante
la processione la varetta con la statua del santo viene portata in trionfo dai
fedeli per tutte le vie del paese.
I
fedeli percorrono col Santo a spalla, a piedi ed a tappe fisse, l'intero
territorio comunale, badando poco ai campi coltivati ed ignorando qualsiasi
barriera, architettonica o naturale che sia.
Altra
importante festa è ‘A cunfrunta di Pasqua, durante la quale i
fedeli rivivono la Passione di Cristo attraverso il ripetersi di
antiche usanze e che vede come protagonista un’emozionante processione durante
la quale la varetta di Cristo e quella della Madonna s’incontrano
tra antichi suoni e canti popolari.
Fonte:
|