|
La
città fu fondata sull'antica Oppidum a
sua volta fondata su un antico insediamento costruito dal popolo dei Mamertini,
spostatosi dalla vicina Mella (III-I sec. a.C.) dove aveva trovato rifugio
unendosi alla popolazione italica del posto e dando alla luce la mitica Mamerto.
Nel 1056 fu
conquistata da Ruggero
il Normanno e divenne
ducato durante la dominazione angioina, fu a lungo contesa tra angioini e
aragonesi.
Il
territorio comunale di Oppido si estende dalle vette dell'Aspromonte e scendendo
lungo la dorsale pre-aspromontana si insinua nel cuore della Piana di Gioia
Tauro e, caratterizzato da formazioni geologiche di varia natura, presenta,
quindi, una fauna e una flora particolarmente diversificata.
Nelle
fascia del territorio che si estende al centro della Piana dominano le
coltivazioni dell'ulivo. Le distese degli alberi di ulivo secolari, che grazie
al clima propizio raggiungono altezza e proporzioni ragguardevoli, unitamente
agli agrumeti sono la prevalente caratteristica paesaggistica nonché una delle
principali risorse economiche.
Le
zone collinari presentano una spiccata eterogeneità. Ai boschi di ulivo si
uniscono i numerosi boschi di castagno, di noce e le pinete che progressivamente
si estendono fino alle zone più alte e la macchia mediterranea, tra i crinali
impervi, cresce rigogliosa. Sotto i mille metri è il leccio a farla da padrone
unitamente ai boschi di quercia. In montagna, poi, le vette sono coperte dai
faggi, dal pino laricio e dall'abete
bianco.
Oltre
alle numerose specie migratrici, nel territorio di Oppido è stanziale la tipica
diversificazione faunistica del versante tirrenico dell'Aspromonte.

Oppido
Mamertina nel corso della sua storia ha avuto differenti nomi:
Mamertion
o Tauriana,
insediamento greco-romano;
Tauroentum
oppidum, I sec d.C.
(con tale nome, probabilmente, Gaio Plinio Secondo definì la città
di Oppido.
Oppidum,
durante epoca tardo-romana;
Oppido o Sant'Agata,
XI sec.;
Oppido, regno
di Napoli;
Oppido
Mamertina, unità d'Italia.
La
città medievale fu fondata, probabilmente nel IX secolo, sull'antica Oppidum a
sua volta fondata su un antico insediamento costruito dal popolo dei Mamertini spostatosi
dalla vicina Mella (III-I secolo a.C.) dove aveva trovato rifugio unendosi alla
popolazione italica del posto e dando alla luce la mitica Mamertion (in latino:
Mamertium).
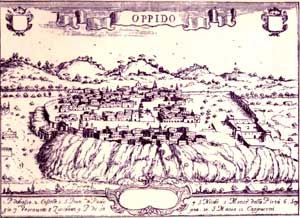 Il
territorio di Oppido ha una stratificazione storico-archeologica di notevole
rilievo.
In località Torre Cillea e Torre Inferrata sono documentate presenze comprese
tra i secoli VII e III
secolo a.C. ricollegabili
ad area di abitato e di necropoli. Sono stati portati alla luce i resti di un
nucleo di genti indigene ellenizzate prima e successivamente di una comunità
brettia. In contrada Mella,
nei pressi della città medievale di Oppido, è stato rinvenuto un insediamento
risalente al III - I
secolo a.C. e reperti
riferibili all'età neolitica e all'età del ferro. Nel cuore dell'Aspromonte,
in località Palazzo, è stata costruita nel IV
secolo a.C. all'estremità
di un lungo serro che domina l'intero territorio di Oppido, una struttura
fortificata che, protetta da un avancorpo, accoglieva una guarnigione in pianta
stabile. La città medievale è
munita di castello e di grandi mura difensive ancora oggi in gran parte
visibili, di un'importante cattedrale, è ricca di palazzi, chiese, conventi,
nel Seminario si insegnavano lettere, filosofia, dogmatica, teologia
morale, sacra
scrittura, canto
gregoriano, storia sacra e
profana, geografia, oratoria, poetica, estetica, storia
della filosofia. Il
territorio di Oppido ha una stratificazione storico-archeologica di notevole
rilievo.
In località Torre Cillea e Torre Inferrata sono documentate presenze comprese
tra i secoli VII e III
secolo a.C. ricollegabili
ad area di abitato e di necropoli. Sono stati portati alla luce i resti di un
nucleo di genti indigene ellenizzate prima e successivamente di una comunità
brettia. In contrada Mella,
nei pressi della città medievale di Oppido, è stato rinvenuto un insediamento
risalente al III - I
secolo a.C. e reperti
riferibili all'età neolitica e all'età del ferro. Nel cuore dell'Aspromonte,
in località Palazzo, è stata costruita nel IV
secolo a.C. all'estremità
di un lungo serro che domina l'intero territorio di Oppido, una struttura
fortificata che, protetta da un avancorpo, accoglieva una guarnigione in pianta
stabile. La città medievale è
munita di castello e di grandi mura difensive ancora oggi in gran parte
visibili, di un'importante cattedrale, è ricca di palazzi, chiese, conventi,
nel Seminario si insegnavano lettere, filosofia, dogmatica, teologia
morale, sacra
scrittura, canto
gregoriano, storia sacra e
profana, geografia, oratoria, poetica, estetica, storia
della filosofia.
Nella
nota contrada Mella, poco
distante da Oppido, insiste un vasto e complesso sito archeologico. Giacciono,
ancora in gran parte sepolti nonostante la massiccia campagna di scavi, i resti
della mitica Mamerto, citata negli scritti di Strabone.
La sua origine è legata alle vicende dei Mamertini (cultori
del dio Marte),
popolo di mercenari provenienti per lo più dalla Campania.
Arrivati in Sicilia,
partendo dalla Sila Tauricana (entroterra sopra Reggio e Locri)
dove si erano stanziati abbandonando il Sannio per
scongiurare una pestilenza, furono assoldati dal tiranno di Siracusa Agatocle.
Alla sua morte si spinsero verso nord fino a Messina conquistandola.
Dopo l'avvio della Prima
guerra punica, del quale
furono i principali responsabili, schiacciati dalla potenza di Roma e Cartagine,
lasciarono l'isola e ritornarono in questo lembo di Calabria dove trovarono
stabile rifugio in un abitato italico fondando così Mamerto. Questo termine però
nel tempo si perse a causa della mescolanza con la cultura e il lessico dei
popoli locali, e visto che l'insediamento dei mamertini avvenne nella Sila
Tauricana da qui il nome Tauriana (la città del monte Taurus). Il legame tra le
città di Tauriana e di Mamertion è insito inequivocabilmente nelle fonti
(Alfio di Messana, Strabone, Catone, Stefano
Bizantino), le due città
sono sorte con ogni evidenza nello stesso territorio, sono cioè la stessa cosa.
Significativi sono i numerosi ritrovamenti di mattonacci e di tegole recanti la
scritta TAYRIANYM e dei bolli statali contraddistinti dall'etnico TAYPIANOYM
comprovanti una piena autonomia politica. Ben presto la città diventa un
importante centro economico e commerciale assumendo un ruolo preminente nello
sfruttamento e nella gestione del potenziale economico dell'alto bacino del
Metauros, usufruendo anche di uno sbocco commerciale sul Tirreno tramite
l'emporio portuale di Taurianum alla foce del fiume.
Il
Parco archeologico di Mella è quindi un sito di grande interesse.
Numerosi sono stati i ritrovamenti sia in termini di rilievi urbanistici (strade
lastricate larghe più di 7 metri, lungo le quali si allineano grandi edifici
civili in un contesto culturale pienamente urbanizzato), sia numismatici:
numerosissime monete appartenenti alle zecche o autorità di Roma, Metaponto,
Bretii, Valentia, Locri
Epizefiri, Rhegion, Cartaginesi in
Italia, Catana, Siracusa e
Mamertini. Queste ultime, in
ragione del 28,35% del totale, in una concentrazione così elevata che non trova
riscontro altrove nell'Italia meridionale. Sono stati ritrovati anche statuette
in bronzo, mattonacci, tegole, testine di terra cotta, macine, collane in
metallo, ceramiche, utensili vari, anfore da trasporto, lucerne, unguentari ecc.
Queste aree archeologiche sono state "visitate" da antichi e moderni
tombaroli, ma ancora solo
una minima parte del vasto sito è stata portata alla luce. Il proseguimento
degli scavi iniziati negli anni ottanta porterà (come sta già portando) a una
ridefinizione della storia della Piana
di Gioia Tauro e di una
parte importante della storia dell'Italia Meridionale, colmando finalmente le
lacune dei testi antichi giunti fino ai nostri giorni.

L'antica
città di Mamerto fu una delle più famigerate repubbliche confederate al popolo
romano. L'etimologia del suo nome "Mamertion" deriva dalla voce osca Mamers,
che significa Marte Dio della guerra. Il valore militare dei Mamertini è
ricordato nella letteratura antica, allorquando, come scrive Plutarco,
si opposero alla marcia su Roma di Pirro schierando
diecimila soldati e dimostrando abile strategia militare. Infatti, seppure
sconfitti, riuscirono a scomporre l'esercito nemico molto più numeroso,
disorientandolo e confondendolo, uccisero due elefanti e lo stesso re dell'Epiro rimase
ferito gravemente sul campo di battaglia.
Posta
a brevissima distanza dal Parco
Archeologico di Mella la città
medievale giace
all'ombra dei taciti ulivi, in una cornice di rara bellezza. Il sito, per la sua
estensione e densità di resti, è particolarmente affascinante e interessante.
La città era protetta da possenti mura e vi si accedeva grazie alle due porte
poste agli estremi del lungo asse principale (ben visibili, tanto le mura quanto
le porte) sul quale si affacciano gli edifici più importanti i cui resti sono
ancora visibili. La città ospitava il Seminario e l'imponente Cattedrale con
l'Episcopio (della Cattedrale persistono oltre le vestigia perimetrali, la
scalinata esterna e interna e il campanile). Dallo stradone principale si
diramavano tortuosamente le vie e viuzze che danno forma al caratteristico
contesto urbano. Ospitava anche, oltre a numerose chiese, il Convento dei Frati
Paolotti e il Convento dei Frati Francescani Osservanti e fuori le mura il
Convento dei Frati Cappuccini e due carceri, uno ecclesiastico e l'altro civile
nel Castello Angioino-Aragonese che, accanto alla porta nord, si innalza
poderoso ancora ben conservato.
La
città fu distrutta dal terremoto del 5 febbraio 1783. Visitandola nella seconda
metà dell'800 Alexandre
Dumas scrisse: «La
città di Oppido ebbe la sorte di tutte le belle donne: oggetto di desiderio
nella loro giovinezza, di disgusto nella loro decrepitezza, d'orrore dopo la
loro morte».
L'abitato
si trova alle falde dell'Aspromonte sul
versante nord-occidentale. Ricostruito, su progetto degli ingegneri napoletani
Antonio Winspeare e Francesco
La Vega, dopo il terremoto
del 1783, presenta un
moderno impianto a scacchiera con ampie vie rettilinee e ortogonali e grandi
piazze. Conserva numerosi
palazzi nobiliari del XIII e XIX
secolo con artistici
portali in granito, tra
questi, Palazzo Migliorini in
stile neoclassico napoletano e Palazzo
Zerbi in stile tardo
barocco. Caratteristiche e pittoresche sono le tortuose vie del centro storico
dei quartieri Tresilico e
Zurgonadio.
Cattedrale
di Santa Maria Assunta

La cattedrale di Santa
Maria Assunta è ubicata nel centro cittadino e prospetta sulla piazza
Duomo. È tra gli edifici sacri più grandi della Calabria e con i
suoi 33 metri primeggia su tutti in altezza. Il campanile (non ancora del
tutto completato), costruito su progetto dell'ingegnere Pasquale Epifanio
auspice il vescovo mons. Domenico Crusco che, nel settembre del 1997,
pose la prima pietra. Il campanile è alto 50,10 metri.
La cattedrale
fu ricostruita su progetto di Ettore Baldanza, in stile neoclassico,
dopo il devastante terremoto del 1908[3]. La parte più antica è la
cappella del Santissimo Sacramento, risalente alla prima metà dell'800,
che resistette integra ai movimenti tellurici del 1894 e del 1908.
Le origini
della cattedrale di Oppido sono, ovviamente, parallele a quelle della diocesi.
Le prime notizie risalgono all'anno 1045, come testimoniano le pergamene
greche tradotte dal Guillou, quando alcuni cittadini fecero donazione di
immobili al vescovo; per cui si presume, evidentemente, che la nascita della
diocesi e quindi della cattedrale sia avvenuta prima di quell'anno.
Ad Avignone,
nell'anno 1351, l'arcivescovo di Reggio Pietro ottenne, da papa
Clemente VI, il permesso di concedere un'indulgenza di quaranta giorni in
occasione di alcune feste, al fine di raccogliere elemosine elargite dai fedeli
ed utili alla ristrutturazione della cattedrale di Oppido all'epoca
consacrata alla "Gran Madre di Dio" (Θεοτόκος) e il
responsabile era il protopapa (molti atti della cattedrale, infatti, sono
sottoscritti da tale Nicola protopapa di Sicilia). Ancora oggi l'arciprete di Santa
Cristina d'Aspromonte, nella stessa diocesi, si fregia del titolo di protopapa,
probabilmente retaggio del periodo bizantino.
 Il
titolo di arciprete della cattedrale, nella persona di tale Girolamo d'Alessio,
emerge con chiarezza nell'anno 1536 e nella scala gerarchica occupava
il quinto posto, come emerge esplicitamente nell'anno 1648. Il vescovo
Andrea Canuto nella relatio nel 1596 dice chiaramente che la cattedrale di
Oppido aveva un suo capitolo e ne faceva parte un arciprete, segnala
poi alla Santa Sede, che la chiesa, di antica costruzione e consacrata a
nuovo culto, era stata, per suo volere, ristrutturata ed abbellita (è
evidente che parlando di nuovo culto nella suddetta relatio ad Limina, il
vescovo Canuto abbia inteso riferirsi all'abolizione del rito greco
avvenuta nel 1482). In una relatio di mons. Montano del 1634 emerge
che, anteriormente a tele anno, all'arciprete veniva affidata anche la cura
della parrocchia di San Nicola de medio, che veniva unita in perpetuo
all'arcipretura. Si spiega così il perché la Cattedrale sin da tempi remoti è
stata sede di una parrocchia e l'arciprete parroco della stessa. Il
titolo di arciprete della cattedrale, nella persona di tale Girolamo d'Alessio,
emerge con chiarezza nell'anno 1536 e nella scala gerarchica occupava
il quinto posto, come emerge esplicitamente nell'anno 1648. Il vescovo
Andrea Canuto nella relatio nel 1596 dice chiaramente che la cattedrale di
Oppido aveva un suo capitolo e ne faceva parte un arciprete, segnala
poi alla Santa Sede, che la chiesa, di antica costruzione e consacrata a
nuovo culto, era stata, per suo volere, ristrutturata ed abbellita (è
evidente che parlando di nuovo culto nella suddetta relatio ad Limina, il
vescovo Canuto abbia inteso riferirsi all'abolizione del rito greco
avvenuta nel 1482). In una relatio di mons. Montano del 1634 emerge
che, anteriormente a tele anno, all'arciprete veniva affidata anche la cura
della parrocchia di San Nicola de medio, che veniva unita in perpetuo
all'arcipretura. Si spiega così il perché la Cattedrale sin da tempi remoti è
stata sede di una parrocchia e l'arciprete parroco della stessa.
Nel 1607 il
vescovo Giulio Ruffo, in una relatio, dichiarava che la sua cattedrale
appariva ampia e bellissima, ma lamentava la penuria di testi sacri, vasi e
suppellettili.
Da alcuni
documenti del 1634 affiora che la Cattedrale era intitolata alla Beata
Vergine Annunziata dall'Angelo; in verità, la cattedrale era ed è intitolata
all'Assunta anche se col tempo quest'ultima aveva perso il fervore popolare a
favore dell'Annunziata attuale Patrona della città di Oppido Mamertina e di
tutta la diocesi.
Nell'anno 1655 da
altra relatio si appura che la cattedrale era stata consacrata poco
tempo prima dal vescovo Montano che l'aveva dotata di campane più grandi e nel 1666,
durante l'episcopato di mons. Parisio, la stessa veniva definita assai
ragguardevole per la sua grandiosità.
Il vescovo Fili
poi, tra la fine del XVII secolo e gli inizi del XVIII,
provvedette ad effettuare ulteriori manutenzioni nella chiesa, anche se da Lui
definita decenter ornata; provvedette infatti ad illeggiadrire le cappelle
dell'Annunciazione e di San Sebastiano con archi di marmo, fece spostare
l'organo in luogo più ampio ed arricchì la porta maggiore con lastre in marmo.
Dispose poi che il Sacro Sinassario venisse spostato nella Cappella
dell'Annunciazione e l'immagine della veneratissima Madonna Annunziata fu
collocata nell'altare maggiore, quest'ultimo impreziosito con 4 grandi colonne
di marmo composte con mosaico, per dare più larga comodità ai numerosi fedeli
che si riunivano in preghiera davanti alla sacra effigie. Arricchì le dotazioni
della cattedrale con 6 candelabri con impressa l'immagine del Crocefisso, le
tavole del Vangelo, dei Giudici e di San Giovanni fuse in argento, 6 calici e 2
lampade anch'esse in argento.
Altri capitoli
si aprirono per la cattedrale negli anni a venire con i vescovi Perrimezzi,
Vita, Mandarani, ognuno dei quali, quasi a non voler essere da meno rispetto al
predecessore, si prodigò per dare il via a nuove opere ed ulteriori manufatti,
fino all'ultimo vescovo della vecchia Oppido mons. Spedaliere, che si disse
morto di crepacuore per la distruzione della città e quindi della cattedrale a
causa del tremendo terremoto del 1783.
Scavi
archeologici - Nel 1996 studiosi dell'Università della
Calabria hanno eseguito degli scavi sul sito dell'antica cattedrale. Tali
scavi hanno permesso di individuare la sua posizione esatta, posizione
confermata dalla pianta prospettica della città realizzata dal Pacichelli.
L'ingresso si trova al di là della strada principale, sulla quale invece
ricadono i ruderi del campanile, e vi si accede per due rampe che portavano ad
un porticato dentro il quale una scalinata introduceva alla chiesa. Sul muro
sottostante ancora oggi è visibile la data 1669, sicuramente quella di un
rifacimento dell'intonaco del manufatto. Entrando a sinistra vi era un grande
fonte battesimale, di cui è rimasta la base. Sul fondo troneggiava l'altare
maggiore, dai cui resti si evince una certa grandiosità. Ai lati sono presenti
i ruderi di due altari, sotto uno dei quali è emersa una lastra con
l'iscrizione a ricordare che durante l'episcopato di Mons. Vita si erano riunite
le spoglie di alcuni canonici prima variamente sistemate. In due sepolcri
sottostanti a quello di sinistra sono stati ritrovati ossa, rosari ed altro
materiale. In alcuni punti della chiesa sono stati ritrovati gradini di marmo e
tratti di pavimento con piastrelle in maiolica.
Nel 2001 un
saggio di scavo in una porzione del presbiterio dell'attuale cattedrale ha
permesso di portare alla luce la suggestiva cripta dove riposano i resti mortali
dei vescovi Francesco Maria Coppola (morto a Oppido nel 1851) e Giuseppe Teta
(morto a Napoli nel 1875).

La
cattedrale della nuova Oppido - Caduta in rovina per il disastroso terremoto del
5 febbraio 1783, e vista l'impossibilità di ricostruirla sullo stesso
sito, Oppido fu riedificata a pochi chilometri, nella località Tuba che è
oggi, insieme a Zurgonadio e Tresilico,
il quartiere più antico della città.
Le funzioni
religiose venivano ufficiate, dal nuovo vescovo di Oppido mons. Tommasini, in
una cattedrale baracca e il primo edificio in muratura con funzione di
cattedrale sorse, per volere dello stesso vescovo, nel luogo dove ora c'è la
chiesa Abbazia.
La prima vera
cattedrale venne innalzata mercé l'impegno profuso dal solerte vescovo Francesco
Maria Coppola, che la consacrò il 23 giugno 1844. I lavori iniziarono per
volere del vescovo nel 1825 e dopo quasi 4 lustri la cattedrale venne
alla luce anche se incompleta e mons. Coppola poté celebrare la prima messa nell'unica
cappella portata a termine.
Negli anni
successivi il tenace vescovo completò e rifinì la cattedrale, come emerge
dalla relatio nel 1851, dove ribadisce le misure della principale
chiesa diocesana (237 palmi di lunghezza interna (circa 62 metri) e 100 palmi di
larghezza interna (circa 26 metri) e divisa in 3 navate. Sotto la grande cupola
si aprivano altre due cappelle, che misuravano entrambe 160 palmi (circa 40
metri) e munite di altare ornato con colonne di marmo. Altre due cappelle erano
poi sistemate ai lati della chiesa. La volta interna era alta 80 palmi (circa 22
metri) e abbellita con tavole di abete, pitture e sacre immagini. Nel
presbiterio vi era il coro in noce con la sedia più alta per il vescovo e non
mancava il trono pontificio. In chiesa si accedeva da una rampa acciottolata e
per un ampio porticato che suppergiù occupava l'area dell'odierno sagrato (per
cui la lunghezza esterna della cattedrale, presumibilmente, era prossima agli 80
metri) e ai lati si elevavano due torri campanarie.
Mons. Coppola
morì nel dicembre 1851.
Il terremoto
del 1894, abbatté le due torri campanarie e provocò seri danni all'intera
struttura, che fu poi consolidata e ristrutturata con lavori che si protrassero
ben oltre il 1900. Nel dicembre del 1908 un terribile sisma abbatté
l'imponente struttura voluta dal Coppola, si salvò soltanto la Cappella del SS.
Sacramento, ancor oggi esistente. Molte parti della chiesa che minacciavano il
crollo furono abbattute dai soldati del genio e in particolare furono rimossi il
portico, la facciata principale, la grande cupola centrale, e l'aula capitolare.
L'attuale
cattedrale sorge sulle rovine della precedente e fu inaugurata nel 1935, alla
cerimonia parteciparono, tra gli altri, l'arcivescovo di Reggio e già arciprete
della cattedrale di Oppido mons. Pujia ed i vescovi di Gerace, mons.
Chiappe, di Tropea, mons. Cribellati e di Mileto, mons. Albéra oltre
naturalmente al vescovo di Oppido mons. Colangelo.

Descrizione
- L'interno, a croce latina, si presenta maestoso, in una soffusa luminosità
non troppo abbagliante come nelle cattedrali barocche, né troppo cupa, come in
quelle gotiche. Presenta un impianto a tre navate divise da imponenti colonne.
Il soffitto della navata centrale è costruito a cassettoni e nel grande rosone
centrale è raffigurata l'Assunzione di Maria in cielo e schiere di angeli
osannanti alla Vergine in altri riquadri.
Al centro del
transetto, intorno alla cupola centrale, si possono ammirare i quattro
evangelisti e, su due pilastri della stessa, i dipinti di San Pietro e San Paolo
che guardano verso la platea, Sant'Agostino e San Basilio rivolti sul
presbiterio. In quest'ultimo sono presenti artistici stalli lavorati in legno
ove sono posti due stemmi, uno di papa Pio XII e l'altro di Nicola
Canino vescovo, la grande mensa interamente lavorata in marmo e nella
profondità del presbiterio l'imponente altare maggiore in marmo policromo.
Dalla balaustra della cantoria si affaccia l'organo con le sue oltre 2.500
canne. Ospita, tra l'altro, una statua della Madonna in marmo del XVI secolo,
opera del Gagini; un'antica statua in
legno di Sant'Anna seduta con la Madonna bambina, autore sconosciuto; nella sua
cappella, abbellita con rosoni, stucchi in oro 23 ct e dipinti che
raffigurano i misteri gaudiosi, è posta la statua in legno della Madonna
Annunziata, opera del 1841, di Arcangelo Testa.
In fondo alla
navata destra è posta l'artistica Cappella del Santissimo Sacramento, di forma
circolare, con una serie di dieci colonne che sorreggono un cornicione ornato
con motivi floreali in gesso decorati in oro 23 carati e rosoni, e la cupola,
anch'essa ornata con festoni in gesso e rosoni, che culmina in un lucernario.
Intorno alla cappella, in apposite nicchie e su basamenti in gesso sono riposte
le statue di San Francesco di Paola, Sant'Antonio da Padova, Santa Margherita
Maria Alacoque, il Cuore Immacolato di Maria, San Pietro e San Giovanni
Evangelista, al centro domina la statua del Cuore di Gesù.
Sulla navata
sinistra è posto un crocefisso del 1807, opera di Francesco De Lorenzo di
Varapodio; un Battistero, finemente scolpito in marmo, del 1860; un sarcofago in
marmo, che custodisce la statua del Cristo morto e sopra di esso la statua
dell'Addolorata, un grande tabernacolo per gli oli santi. La Cappella
dell'Immacolata, dove è posta una statua in legno sopra l'Altare in marmo, La
Cappella Stipo, che ospita un maestoso armadio in legno, interamente scolpito a
mano, ove si custodisce il grandioso Trono della Vergine Annunziata.
La cattedrale
custodisce un Ecce Homo scolpito in legno, posseduto da San Carlo
Borromeo, donato al patrimonio artistico della cattedrale dal vescovo Cesonio
(1609-1629) e le spoglie mortali dei vescovi: Francesco Maria Coppola,
Giuseppe Teta e Santo Bergamo.

Titoli
- Santuario diocesano. Il 15 agosto 2013 monsignor Francesco
Milito vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi ha
conferito alla cattedrale il titolo di Santuario Mariano in onore di
Maria Santissima Annunziata, patrona della città di Oppido Mamertina
e diocesi. Il vescovo ha dedicato una struggente preghiera di
ringraziamento alla Vergine e ha fatto dono di una teca di cristallo contenente
una rosa d'oro e un proiettile disarmato; questo uno stralcio della Sua
invocazione:
«Da oggi, in
questo luogo, di attesa e di ascolto, di preghiera e discernimento, di oasi di
silenzio e di contemplazione, di sguardi amorosi e di messaggi di grazia, con
rinnovato e più intenso trasporto, nell'affidamento più completo, vogliamo
metterci alla Tua scuola perché, guidandoci alla scoperta, progressiva e piena
di stupore, di quel prodigio che è l’uomo, dal primo istante nel grembo della
madre al primo istante nel seno dell'eternità, sviluppiamo un senso profondo e
fattivo di gratitudine, diventandone custodi e difensori. A segno e memoria
deponiamo ai Tuoi piedi, perché ce ne ricordi l’impegno, una rosa d’oro e
un proiettile disattivato. Accanto nella stessa capsula di vetro, ci ricordino
continuamente i due opposti sentimenti, – l'amore e l'odio –, che
attraversano la storia del mondo e dell'uomo pegno e fondamento della sua
salvezza o della sua perdizione.»
Piazza
Duomo - La
cattedrale si affaccia su piazza Duomo, che copre una superficie attuale di
circa 10.000 m². Originariamente si suppone fosse a croce latina,
caratteristica persa agli inizi dell'Ottocento causa la costruzione nel lato
nord-est del grande palazzo voluto dalla famiglia Grillo. Al sagrato della
cattedrale si accede da una grande gradinata sotto la quale è posta una
suggestiva rosa dei venti. Nel lato sud-ovest, collocata al centro di
quattro tigli, fa mostra di sé una caratteristica fontana in ghisa dei primi
del Novecento. Sono presenti 4 grandi aiuole ed i busti del senatore Rocco
De Zerbi e dello scultore Salvatore Albano, quest'ultimo è un suo
autoritratto. La piazza è circondata da palazzi nobiliari sette-ottocenteschi e
dal palazzo Vescovile. Degno di nota è il portale seicentesco di palazzo Princi
proveniente da Oppido Vecchia.
Altre architetture
religiose
Chiesa
dell'Oratorio (o dell'Annunziata)
Chiesa
di San Giuseppe - È ubicata nel centro cittadino in via
Francesco Maria Coppola. È conosciuta anche chiesa della Madonna del Buon
Consiglio.
 La
chiesa è di origini cinquecentesche e sorgeva accanto al convento dei Minimi,
prima che il centro abitato della nuova città, distrutta dal terremoto
del 1783, si espandesse intorno ad essa. La prima ricostruzione avviene
proprio dopo i danni subiti nel 1783. La
chiesa è di origini cinquecentesche e sorgeva accanto al convento dei Minimi,
prima che il centro abitato della nuova città, distrutta dal terremoto
del 1783, si espandesse intorno ad essa. La prima ricostruzione avviene
proprio dopo i danni subiti nel 1783.
L'edificio
attuale è un'ulteriore ricostruzione dopo i gravi danni del terremoto
del 1908. La chiesa viene ricostruita in tutta la parte sommitale della
chiesa, mantenendo originali il portale e parte delle coppie di lesene, gli
altari interni e la porzione inferiore della torre campanaria.
La
chiesa si sviluppa su navata unica
con presbiterio sopraelevato
e grande altare marmoreo. La facciata neoclassica deriva
in gran parte dalla ricostruzione novecentesca, a parte gli elementi originali.
Il campanile, posto a destra della facciata, ha una cella
campanaria con tre originali aperture ellittiche.
L'interno
ospita un'artistica statua di San Giuseppe scolpita in legno dall'artista
oppidese Rocco Morizzi e diverse nicchie laterali riccamente scolpite in marmo,
così come l'altare maggiore posto in fondo al presbiterio ove si accede
attraversando un grande arco sorretto da due colonne in granito. Sopra l'altare
è posto il quadro della Madonna del Buon Consiglio, cinquecentesca.
Entrando subito a destra è posta la nicchia che custodisce la statua della
Madonna del Buon Consiglio, mentre verso il presbiterio sono poste le nicchie
che custodiscono le statue di San Francesco di Paola, pregiata scultura
lignea del 1600, Sant'Antonio da Padova e San Giuseppe. Sulla
sinistra quelle di Santa Lucia, il Sacro Cuore di Gesù e una
tela raffigurante la Sacra Famiglia. Sul soffitto è posto un dipinto di
Domenico Mazzullo che raffigura San Giuseppe conduce un asinello con la
Madonna e il Bambino. Sparse nella chiesa si possono ammirare numerosi capitelli
ed altre sculture in marmo provenienti dalla città medievale.
Nei
sotterranei della chiesa sono presenti le cripte utilizzate per l'essiccazione
dei cadaveri, che venivano posti entro nicchie in posizione seduta e legati con
un particolare sistema di fermi in ferro. Tutte le nicchie erano poi collegate
da canali di scolo dove confluiva il materiale biologico della decomposizione.
Ad essiccazione avvenuta, legati ai fermi in ferro, rimanevano in quella
peculiare posizione gli scheletri dei monaci lì sepolti.
Legata
a questa chiesa nacque, da un'antica devozione della famiglia Germanò, la
Congrega di San Giuseppe, ufficializzata con il Real Decreto del 26 novembre
1846, ma sarà il vescovo mons. Caputo ad assegnare la chiesa come oratorio
della Confraternita e a farne omologare dal re
di Napoli la concessione nel 1854.
Chiesa Maria
SS. Addolorata o del Calvario
Santuario
Maria Santissima delle Grazie - Mons. Raspini vescovo di Oppido il 2 luglio
del 1958 ha elevato la chiesa parrocchiale di Tresilico a Santuario Mariano
in onore di Maria SS. delle Grazie. Il fervente culto alla Vergine dispensatrice
di Grazie è da secoli scandito nella sua stessa storia. Il popolo infatti era
già profondamente legato alla Vergine del Pilar raffigurata in una pregevole
scultura in marmo del '700, ancora oggi conservata nel Santuario.
La prima statua
in legno, ordinata sul modello della Madonna del Pilar, venne portata a
Tresilico nel 1832. Questa statua, che raffigura la Madonna in piedi con Gesù
bambino in braccio, serviva per essere omaggiata in processione e oggi è
conservata ed esposta al pubblico in un vano al piano terra del Palazzo Vorluni
residenza questa della pia Rosa Vorluni alla quale la Madonna sarebbe apparsa
molte volte.
Infatti tra il
1835 ed il 1837 sarebbero successi i fatti miracolosi che il dott. Gaetano
Morizzi ha raccontato nel suo libro "Fiori di Grazie", la Madonna
sarebbe apparsa appunto a Rosa Vorluni e in queste apparizioni avrebbe indicato
alla "Pia devota" e per mezzo di lei, al dottor Morizzi, il modo per
guarire chi a Lei si era rivolto. Il 2 ottobre del 1836 Rosa Vorluni, mentre si
trovava in chiesa, avrebbe avuto l'ennesima apparizione, che portò alla
realizzazione dell'attuale statua venerata nel Santuario.

Chiesa di
San Leone Magno
Chiesa della
Divina Pastora
Chiesa di
San Nicola
Chiesa di
Castellace di sopra
Chiesa
Abbazia - Fin dall'antichità, infatti le prime notizie risalgono al 1596,
la chiesa Abbazia e
la relativa parrocchia detta San Nicola extra moenia fu sempre retta
da un canonico con il titolo di abate.
 Nella
pianta prospettica del Pacichelli la chiesa è disegnata in posizione
centralissima dietro la cattedrale, ciò induce a ipotizzare come la chiesa così
evidenziata non fosse in origine quella di San Nicola extra moenia proprio
perché il termine stesso si riferisce a un edificio sito al di fuori delle mura
della città. Nella
pianta prospettica del Pacichelli la chiesa è disegnata in posizione
centralissima dietro la cattedrale, ciò induce a ipotizzare come la chiesa così
evidenziata non fosse in origine quella di San Nicola extra moenia proprio
perché il termine stesso si riferisce a un edificio sito al di fuori delle mura
della città.
Molto
probabilmente si sarà verificato, per motivi che non conosciamo, qualche evento
che avrà consigliato di trasferire la parrocchia dentro le mura cittadine
mantenendo però il titolo originario. Infatti tra il 1510 ed il 1525 dalle
documentazioni vaticane emerge l'esistenza di una chiesa parrocchiale di Oppido
definita San Nicola del Campo extra moenia o extra muros,
presumibilmente si tratta dalla prima circoscrizione.
Dopo il
disastroso terremoto del 5 febbraio 1783, anche l'Abbazia fu riedificata nella
sede di contrada Tuba e a essa fu assegnata una porzione di territorio. La
relativa parrocchia mantenne il nome di San Nicola extra moenia.
All'interno si
possono ammirare numerosi dipinti di Domenico
Mazzullo, due pregiate statue in marmo del 1500 rappresentanti San
Pietro e San
Paolo poste ai lati dell'altare maggiore. Quest'ultimo è
impreziosito dall'incastro di molti pezzi di altare proveniente da chiese dirute
della città medievale.
La chiesa
ospita le spoglie mortali del vescovo Ignazio
Greco.
Chiesa
dell'Assunta
Chiesa di
Afanto (Località Zervò)
Chiesa di
Quarantano
Cappella
Caia-Musicò
Cappella del
Seminario Vescovile
Episcopio
- Il Palazzo Vescovile, noto anche come Episcopio o Vescovado,
è il palazzo residenziale del vescovo.
L'attuale
edificio, costruito per volere di mons. Nicola
Canino, è situato tra Piazza Duomo e Via Antonio Maria Curcio. Disposto
su due livelli, presenta una forma ad "L". Da un lato è addossato
alla Cattedrale
di Oppido Mamertina e dall'altro al Seminario.
Il
piano alto è interamente adibito a residenza vescovile. Il piano sottostante
ospita il Museo
Diocesano e la Sala vescovile della Comunità. Quest'ultima,
utilizzata originariamente come teatro, nonché come luogo di catechesi, è una
grande sala restaurata nel 2013 per volere del vescovo Francesco
Milito, ed è affrescata con pitture del maestro Diego Grillo
raffiguranti scene del catechismo. Nel soffitto, interamente tinteggiato, è
presente un grande dipinto raffigurante il globo terrestre sul quale è posta la Basilica
di San Pietro e una grande croce, sotto il globo è posta la
Cattedrale, dalla croce e dalla Basilica (Chiesa Universale) si irradia una
fascio di luce verso l'Episcopio di Oppido Mamertina (Chiesa Particolare).
Nell'area
interna del palazzo vi è un giardino alberato ove è presente una suggestiva
riproduzione della grotta di Lourdes.

Seminario
vescovile di Oppido Mamertina - Il Seminario di Oppido
Mamertina fu fondato nel 1701 dal
vescovo Bisanzio Fili, che guidò la Diocesi mamertina dal 1698 al 1707. Dopo il
terremoto del 5 febbraio 1793, il Seminario fu ricostruito per volere del primo
vescovo della nuova Oppido Alessandro
Tommasini (1792-1818).
I
successori di mons. Tommasini si impegnarono strenuamente per rendere il Pio
istituto "lumen doctrinae" e "lumen vitae" secondo le
intenzioni di Mons. Ferdinando Mandalari(1748-1769). Il vescovo Francesco
Maria Coppola introdusse, tra le altre discipline, lo studio della
natura, mons. Michele
Maria Caputo le lingue straniere e mons. Giuseppe Teta la Sacra
Liturgia e la Calligrafia.
Con
mons. Antonio Maria Curcio, al quale è intitolata la via antistante, il
Seminario oppidese si dotò di un Osservatorio Meteorologico e di un Gabinetto
di Fisica. Sotto la reggenza del Vescovo Antonio Galati, a conferma e
riconoscimento dell'importante opera di formazione dei seminaristi (la diocesi
di Oppido Mamertina è da secoli prolifica di vocazioni sacerdotali) e a
suggello del prestigio che il Seminario raggiunse siccome fucina di cultura
scientifica e umanistica per tutta la Piana
di Gioia Tauro, agli inizi del novecento si fregiò della visita del
Cardinale di Milano Alfredo
Ildefonso Schuster, oggi Beato.
Mons. Nicola
Canino (1937-1951) si prodigò ad ingrandire ed abbellire
l'edificio. Costruì un'ampia ala portando la capacità recettiva della
struttura ad oltre sessanta seminaristi, fece edificare un grande salone dove
egli stesso amava fare catechesi a
giovani ed adulti, arricchì il Seminario, la Cappella ed il salone
dell'Episcopio di pregiati affreschi realizzati dal pittore di Pizzo Diego
Grillo. Nel giardino interno dell'Episcopio fece costruire una suggestiva
riproduzione della grotta della Madonna
di Lourdes.
Nel
2014, per volere di mons. Francesco
Milito il salone dell'Episcopio è stato ristrutturato ed ha assunto
il titolo di Sala Vescovile della Comunità.
Oggi
il Seminario, oltre a protrarre la sua opera di formazione dei futuri sacerdoti,
ospita anche il Liceo Classico "San Paolo" fondato nel 1990 da
mons. Benigno
Luigi Papa e divenuto "paritario" nell'anno 2001. La
storia di questa scuola idealmente si riallaccia con quella del Seminario
Vescovile e dell'attigua Biblioteca Diocesana che fu fondata nel 1633 dal
vescovo Giovanni Battista Montano ed è la prima Biblioteca pubblica della
Piana.

Convento dei
Domenicani (ruderi Messignadi)
Calvarietto
Maria Santissima Annunziata (Oppido Vecchia)
Convento dei
Frati Francescani o Paolotti o Minori o Osservanti e dei Frati Zoccolanti
(ruderi Oppido Vecchia).
Architetture
civili
Palazzo
Ioculano, Palazzo Grillo, Palazzo Malarbì, Palazzo Migliorini, Palazzo Grillo
(Palazzaccio), Palazzo Lucisano, Palazzo Zerbi, Palazzo Germanò, Palazzo
Spinelli, Palazzo Cananzi, Palazzo Vorluni, Villa Ferraris in stile liberty,
Palazzo Episcopale.
Castello
Il castello di
Oppido Mamertina fu costruito a cavallo tra il X e XI secolo; si presenta
oggi di matrice aragonese, ma sotto la bardatura si intravede in uno dei
torrioni, a causa di uno squarcio formatosi qualche decennio addietro, una
massiccia costruzione cilindrica, indicativa della precedente fattura bizantina
o normanna. La sua funzione era, evidentemente, residenziale e difensiva.
  Resistette,
nel 1056, all'assedio che il primo Ruggero
I d'Altavilla pose col suo esercito e più tardi fu la
residenza della sorella del secondo Ruggero, feudataria del tempo. Nella seconda
metà XV secolo era controllato dagli aragonesi che
si sostituirono al dominio angioino. Resistette,
nel 1056, all'assedio che il primo Ruggero
I d'Altavilla pose col suo esercito e più tardi fu la
residenza della sorella del secondo Ruggero, feudataria del tempo. Nella seconda
metà XV secolo era controllato dagli aragonesi che
si sostituirono al dominio angioino.
I bastioni
scarpati presentano un motivo decorativo ad archetti su mensole tra due codoni,
molto simile a quello del Castello
di Reggio Calabria. Una parte dei sotterranei fungevano da carcere
civile; fu abbandonato dopo il terremoto
del 1783.

Siti
archeologici
Necropoli pre-ellenica,
necropoli protostorica, Parco Archeologico di Mella (antica Mamerto) sec. III-I
a. C., resti di antico abitato ellenistico, vestigia greche e romane, località
Palazzo III a.C., Oppido
Vecchia (città medievale).
Frazione
di Piminoro
La località di
Piminoro sorge a 719 metri sul livello del mare e rappresenta una delle frazioni
più suggestive del comune di Oppido. Il nome del sito ha origini greche e
significa “Monte dei pastori”. Dall’alto di questo promontorio si può
godere di un panorama incantevole a perdita d’occhio su tutto il
territorio della Piana di Gioia Tauro, dal mar Tirreno fin su al
cuore dell’Aspromonte. Il villaggio, nel quale oggi risiedono solo un paio di
centinaia di abitanti, è una diretta filiazione dell’emigrazione interna
dalle Serre del vibonese agli inizi dell’800.
L’insediamento,
infatti, deve la sua origine all’opera del vescovo di Oppido Alessandro
Tomassini che, nel 1792, diede avvio alla costruzione di una sede estiva
per i seminaristi. Completata l’edificazione del seminario estivo, il vescovo
reclutò un gruppo di carbonai serresi che con le loro famiglie
formarono il primo nucleo di abitanti del piccolo borgo. Il secondo sabato di
luglio si festeggia fra le stradine di Piminoro “La Divina Pastora”, il cui
culto proveniente dalla Spagna è molto sentito e vissuto con grande
partecipazione e sentimento religioso anche da molti fedeli dei centri vicini.
Al termine della novena che precede il giorno della festa, il simulacro
della madonna, una statua lignea, viene poi portato in processione a
partire dalla chiesa per arrivare nel luogo dove un tempo c'era l'antica
parrocchia, distrutta dall'alluvione del 1951.

Tradizioni
e folclore
Sono numerose
le tradizioni di Oppido Mamertina, soprattutto legate a festeggiamenti
religiosi. La più importante di esse è la festa di Maria Santissima
Annunziata, patrona della città e della diocesi
di Oppido Mamertina-Palmi, celebrata due volte l'anno con solenne
processione della statua della Vergine per le vie del paese.
La Festa più
sentita dalla comunità è quella di Maria Santissima Annunziata. La statua
della Madonna Annunziata, custodita nella cattedrale, è un'opera lignea
realizzata nel 1841 dallo scultore napoletano Arcangelo Testa. Il canonico
Pignataro, nel suo studio su "Il culto di Maria SS. Annunziata in
Oppido di Calabria", fa risalire il culto dell'Annunziata al periodo in cui
nella diocesi si praticava il rito bizantino. All'epoca si venerava nel borgo
un'icona bizantina miracolosa della Madonna Annunziata, opera attribuita a
un pittore di Costantinopoli di nome Luca e realizzata nel XII secolo, oggi
andata perduta.

Fonte:
|