|
Scilla è situata sull'omonima punta, che sorge a
nord-est del capoluogo:
il Promontorio Scillèo, proteso sullo Stretto
di Messina, che anticamente veniva infatti denominato Stretto di
Scilla.
Il toponimo Skýla (dal greco
Σκύλα "cagna") richiama un misterioso mostro
che sarebbe il responsabile di tempeste scatenatesi sul mare che determinarono
la fine di molti naufraghi. Descritta da Strabone come
uno scoglio simile a un'isola,
Scilla mantiene tutt'ora i tratti di questo paesaggio. I suoi pochi abitanti
furono degli abili navigatori e conoscitori delle rotte, notizia questa
confermata da San
Girolamo.
È una storia
piena di passione, amori non corrisposti, feroci vendette e un drammatico
epilogo, quella che narra delle gesta mitologiche di dei e mortali nello
specchio d'acqua che separa Reggio da Messina. È la storia di Scilla,
ninfa dalla bellezza sconvolgente, trasformata dalla maga Circe nell’orrendo
mostro che da secoli secondo la leggenda funesta le acque dello Stretto insieme
a Cariddi, devastante creatura marina creata da Zeus capace di
ingoiare e rigettare l'acqua del mare per tre volte al giorno causando mortali
vortici.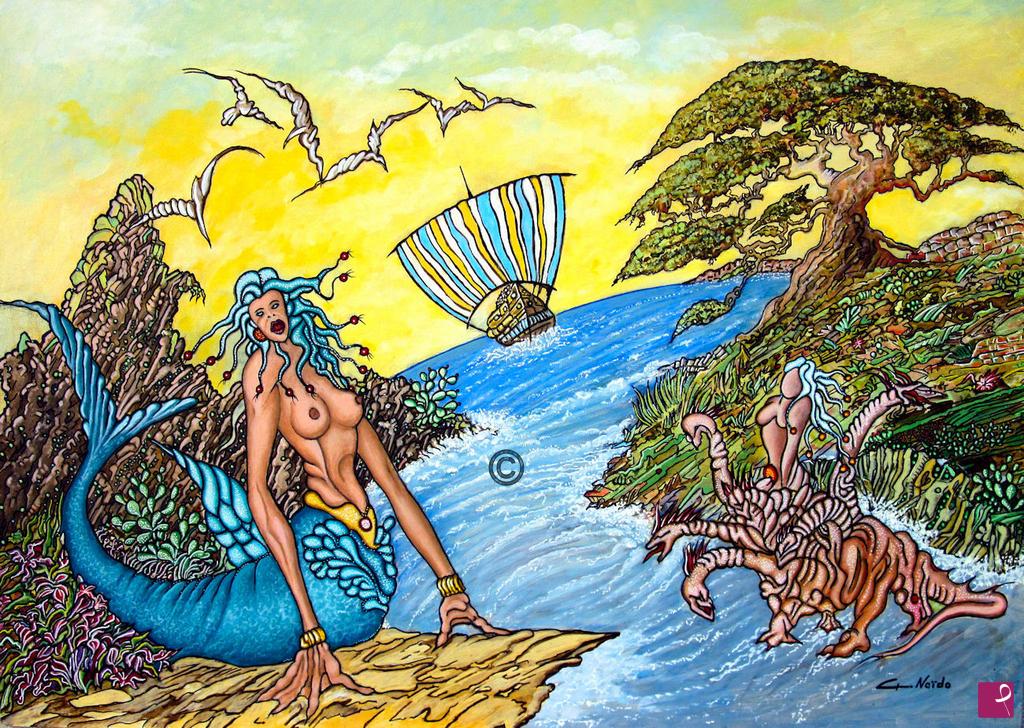
È la gelosia
di Circe all’origine del terribile sortilegio che dà vita ad uno di miti che
più alimentano il fascino e il mistero dello Stretto. Vicino agli scogli di Zancle,
su cui amava riposarsi e trascorrere le sue giornate, Scilla incontra
Glauco, pescatore della Beozia, trasformato in una divinità marina per aver
mangiato l'erba che ridava vita ai suoi pesci e poi istruito all'arte della
profezia da Oceano e Teti.
La visione di
questo essere, metà uomo e metà pesce, terrorizza la ninfa al punto da farla
scappare via. Glauco, abbandonato al suo destino, prova inutilmente a
trattenerla urlandole il suo amore e narrandole la sua drammatica storia,
scolpita e tramandata a noi oggi da Ovidio nelle Metamorfosi (“Non
sono un mostro né una bestia feroce, o vergine, ma un dio dell’acqua […],
prima però ero un mortale, ma a dire il vero il profondo mare era già il mio
mondo”).
In preda alla
disperazione, Glauco si rivolge alla maga Circe, dea figlia di Elio e della
ninfa Perseide, famosa per i suoi incantesimi in grado di cambiare le sembianze
degli uomini, nel tentativo di ricondurre a sé l'amata Scilla. Ma l’unico
risultato che Glauco ottiene è quello di scatenare la gelosia della maga che
prova subito ad allontanare Scilla dal dio marino sfoderando anche le armi della
seduzione nei suoi confronti. Rifiutata da Glauco, Circe riversa la sua
furia vendicativa su Scilla trasformandola con un ferale sortilegio in un
feroce mostro munito di sei teste di cane latranti, terrore di navigatori e
marinai di ogni epoca. Da quel momento, secondo la leggenda, Scilla si rifugia
in preda alla disperazione e alla rabbia in una grotta sotto la Rocca dove sorge
il Castello e
che esiste ancora oggi, in prossimità di alcuni scogli a pochi chilometri da
Cariddi che abita la sponda Sicula. Esseri condannati a vivere in eterno l’uno
di fronte all’altro, entrambi presenza costante e inesorabile nel cuore del
Mediterraneo.
Non tutti sanno
che fino al XVIII secolo sotto la rocca di Scilla era presente una
formazione di scogli molto particolare, essi davano l’impressione di una
creatura mostruosa che usciva dalla grotta. Al tempo dei greci, le
mareggiate erano frequenti e le imbarcazioni che passavano per lo Stretto venivano
spinte dal mare contro la rocca. Con il mare in burrasca e gli scogli che
dilaniavano le imbarcazioni causando la morte di molti, nacque il mito del
mostro di Scilla.
Sulla sponda
sicula, invece, erano le correnti marine a generare dei vortici, che si
verificano ancora oggi ma di intensità minore, che spesso inghiottivano le
imbarcazioni che vi passavano vicino. Anche qui si pensò ad un mostro, Cariddi,
che risucchiava l’acqua del mare e la rigettava creando enormi vortici.

In mancanza di
precedenti testimonianze attendibili circa le epoche più remote, si è propensi
a far risalire la prima fortificazione di Scilla agli inizi del V secolo
a.C., allorquando durante la tirannide di Anassilao la città di
Reggio raggiunse una notevole importanza, che le permise di ostacolare per oltre
due secoli l'ascesa di potenze rivali.
Strabone
racconta che nel 493 a.C. il tiranno di Reggio, Anassila il
giovane, per porre fine alle reiterate razzie perpetrate dai pirati tirreni a
danno dei commerci aperti dalla città con le colonie tirreniche, avesse mosso
contro di loro con un forte esercito, sconfiggendo e scacciando i pirati da
queste terre. Per i Tirreni gli innumerevoli scogli e l'alta rocca
caratterizzanti la costa scillese costituivano un rifugio naturale ideale, luogo
inaccessibile da cui dirigere redditizie scorrerie lungo le coste, nascondiglio
sicuro per il bottino e baluardo di difesa contro eventuali controffensive
nemiche.
Presumibilmente
sorsero quindi contrasti e lotte tra i primi marinai e pescatori che avevano
occupato la zona e i pirati Tirreni, alla cui bellicosità forse si deve
attribuire la causa dell'arretramento dal mare dei pescatori, ostacolati dai
pirati nella pratica su cui basavano il proprio sostentamento. Ciò spiegherebbe
il trasferimento di residenza verso la zona alta di Scilla - l'attuale quartiere
di San Giorgio - attuato da queste genti marinare, che si trasformano in
agricoltori e cacciatori e mantengono poi attive le nuove pratiche fino all'età
moderna.
Espertissimi
nella navigazione, i Tirreni avevano dominato a lungo da incontrastati padroni
le rotte del Mediterraneo, esercitando il proprio predominio soprattutto
nello Stretto, grazie al presidio posto sulla rupe scillese, all'imboccatura del
canale, presumibilmente fortificato. Più tardi però questi vennero sconfitti
dai reggini, vittoria questa che segna un momento significativo nella storia di
Scilla, considerata da Anassila un importante avamposto di controllo sulle rotte
marittime. Mentre si assicura il dominio sul territorio circostante inglobando
una nuova sezione del Chersoneso reggino, al tempo stesso Anassila ha cura
di realizzare una stazione delle navi a Capo Pacì, ordinando la
costruzione di un porto dotato di un agguerrito presidio militare.
L'opera di
fortificazione dell'alto scoglio fu portata a termine dai successivi tiranni
reggini, spesso impegnati in scontri con i pirati che combattono avvalendosi del
porto fortificato appositamente costruito nella piccola borgata
di Monacena (ossia, nascondiglio isolato , una zona anticamente
riparata da alcune caverne poi distrutte), verso Capo Pacì, in un luogo
inaccessibile dal lato opposto allo scoglio. Baluardo della sicurezza dei
reggini, la fortificazione di Scilla dotata di approdo è di fondamentale
importanza agli effetti del felice esito della guerra contro la pirateria,
consentendo ai tiranni di Reggio di opporre per lungo tempo una valida
resistenza contro gli attacchi di nuovi nemici e contro i continui tentativi di
rivalsa dei Tirreni sconfitti.
Agli inizi
del III secolo a.C., dopo la presa di Reggio ad opera del tiranno
di Siracusa Dionisio I, che nel 386 a.C. aveva distrutto la
flotta navale della città di stanza a Lipari e nel porto di Scilla, I
pirati tirreni tornarono ad essere audaci e si reinsediarono sul promontorio
scillese, dove ripresero a dedicarsi alla pirateria avvalendosi del preesistente
porto fortificato fino a quando, nel 344 a.C., il prode Timoleonte di
Corinto riuscì a sconfiggerli definitivamente.

Per quanto
riguarda la successiva storia della fortificazione dell'imponente scoglio di
Scilla, si ha testimonianza di come essa coincida con la storia delle vicende
che hanno caratterizzato il reggino all'indomani della tirannide siracusana.
In tarda età
magnogreca lo scoglio scillese è una fortezza, conosciuta come Oppidum
Scyllaeum, successivamente potenziata nelle sue strutture militari durante
l'età romana, allorquando porto ed oppidum costituiscono un
funzionale ed efficiente sistema di difesa per i nuovi dominatori del
Mediterraneo.
Alla fine
del II secolo a.C., durante le guerre condotte dai Romani contro
i Tarantini sostenuti da Pirro, e in particolare durante
la prima e la seconda guerra punica, i Cartaginesi che
avevano stretto alleanza con i Bruzi e circolavano liberamente lungo
le coste reggine, furono fermati nella loro ascesa proprio grazie alla strenua
resistenza opposta loro dalla fortificata città di Scilla, alleata di Roma.
L'importanza
della Scilla latina cominciò a decadere all'indomani della conquista romana
delle terre siciliane quando, dopo Reggio e Siracusa, Messina assurse al ruolo
di nuovo caposaldo per il controllo dello Stretto.
Pur tuttavia
Scilla, posta all'imbocco settentrionale del canale, continuò a costituire
un'importante tappa d'approdo lungo la costa tirrenica continentale, tant'è che
nel 73 a.C., durante la guerra condotta dai romani contro gli schiavi, la
cittadina sembra essere stata prescelta da Spartaco, a capo dei ribelli,
per accamparsi in attesa di poter attraversare lo Stretto.
 La
fuga in Sicilia, progettata dagli schiavi ribelli con il ricorso a zattere
costruite col legno di castagno estratto dai boschi scillesi, non ebbe
tuttavia alcun esito a causa della presenza lungo lo Stretto delle minacciose
navi pompeiane. La
fuga in Sicilia, progettata dagli schiavi ribelli con il ricorso a zattere
costruite col legno di castagno estratto dai boschi scillesi, non ebbe
tuttavia alcun esito a causa della presenza lungo lo Stretto delle minacciose
navi pompeiane.
Successivamente
il tratto di mare antistante la cittadina fu teatro degli avvenimenti che
segnarono l'ultimo scontro tra Pompeo e l'annata dei Triumviri,
conclusosi nel 42 a.C. con la disfatta del primo.
In quel
frangente il porto di Scilla offrì opportuno rifugio alle navi
di Ottaviano pressate dalla flotta di Pompeo, allorquando il futuro
Augusto, nel tentativo di rimandare lo scontro finale ad un momento a lui più
propizio, colse l'importanza strategica di Scilla e, una volta liberatosi
definitivamente dei rivali, decretò l'ulteriore fortificazione del suo porto.
Dopo Ottaviano
non sembra che la fortificazione scillese abbia conosciuto nuovi
rimaneggiamenti, sebbene la cittadina continui a detenere l'importante ruolo di
centro marittimo locale, come testimonia san Gerolamo quando,
approdato nel 385 a Scilla durante il suo viaggio
verso Gerusalemme, ci ha lasciato testimonianza nel III libro delle sue
opere, circa la grande esperienza dei marinai scillesi, capaci di fornirgli
consigli assai utili per il buon proseguimento della navigazione.
Lo stato di
abbandono in cui sembra trovarsi la fortezza di Scilla in tarda età romana,
presumibilmente, dipende dal localizzarsi la stessa al di fuori degli itinerari
terrestri percorsi dai barbari, durante le loro invasioni nel sud della
penisola.
Costoro,
infatti, nel loro "calare" a sud, utilizzano i tracciati viari romani
rimasti agibili in quell'epoca di decadenza. Scilla, che non era allacciata
alla via Popilia, unica strada consolare esistente lungo la costa
tirrenica, rimane dunque estranea ai fatti essenziali del tempo.
Difatti la Via
Consolare Popilia, nel tratto più meridionale del suo percorso non bordeggiava
la costa, bensì risaliva verso l'interno passando per Solano e, superate
le Grotte di Tremusa, raggiungeva la statio ai Piani della Melia,
dirigendosi poi verso Cannitello, «ad Fretum», senza ripiegare verso
Scilla.
Ai
primi monaci basiliani gli storici attribuiscono la fondazione
del Monastero e della chiesa di San Pancrazio, tra l'VIII e
il IX secolo d.C., fortificati per volontà della
stessa Bisanzio, che aveva affidato ai Padri il compito di difesa delle
coste dello Stretto.
Il terremoto
del 1783 rappresenta uno spartiacque importante nella storia di Scilla per
la particolare violenza con la quale si abbatté sulla cittadina e anche perché
rappresentò la fine di uno sviluppo economico che Scilla ebbe lungo tutto il
settecento. Il successivo terremoto del 1908 costò a Scilla ed anche a Messina
migliaia di morti. Gli scillesi per sfuggire ai violenti movimenti tellurici
dopo il crollo delle loro abitazioni si riversarono sulla spiaggia pensando di
essere al sicuro ma un violento maremoto si abbatté sulla spiaggia
travolgendoli e finendo così di decimare la popolazione. In tempi più recenti,
parallelamente alla emigrazione verso il Nord Italia, tipica della zona, vi fu
un certo fermento culturale.
Luoghi
d'interesse

Il borgo di
Scilla si trova all'ingresso settentrionale dello Stretto di Messina, in una
posizione che Alexandre Dumas, in visita qui nell'autunno 1835, descrisse con
queste parole: "Costruita su un'altura, discende come un lungo nastro sul
versante orientale della montagna, poi girandosi a guisa di S viene a
distendersi lungo il mare".
La rupe di cui
parla il mito esiste davvero. E' occupata dal castello Ruffo (XVI secolo), sorto
al posto di una vecchia roccaforte medievale in un punto in cui è probabile che
ci fosse una fortificazione precedente, risalente addirittura all'epoca della
Magna Grecia: un avanposto difensivo dell'antica Rhegion contro gli
attacchi dei pirati provenienti dal Tirreno.
Il promontorio
divide i due vecchi borghi di pescatori di Marina Grande e Chianalea. Su una
terrazza del castello, un piccolo faro gestito dalla Marina Militare guida i
naviganti attraverso lo Stretto, riscattando Scilla dal terrore che incuteva
nell'antichità e dalla sua fama sinistra di punto pericoloso per le secche e
per le forti correnti, soprattutto durante le mareggiate.
 Quartiere
San Giorgio Quartiere
San Giorgio
Il centro storico di Scilla è denominato "San
Giorgio", e si sviluppa intorno alla Piazza San Rocco, nella quale hanno
sede, fra l'altro, la chiesa di San
Rocco, patrono di Scilla, e il palazzo comunale. La Piazza San Rocco è
costituita da un vasto terrazzamento costruito su un costone di roccia, e si
affaccia a strapiombo sul panorama dello Stretto di Messina. Lo sguardo
abbraccia Punta Pacì (che delimita l'estremità meridionale dell'area di
Scilla), la Sicilia (in particolare Ganzirri e, nelle giornate terse, Capo
Milazzo), in lontananza alcune delle Isole Eolie (Lipari, Panarea e Stromboli),
e il Castello Ruffo.
Il centro storico comprende l'antico abitato di Bastìa,
contraddistinto dalle basse casette affacciate sui caratteristici vicoli. Alcuni
elementi architettonici dello stile locale originario restano visibili nelle
costruzioni oggi esistenti, fra i quali il caratteristico arco ribassato e la
tipica finestrella di forma circolare.
Quartiere
Jecari
Si tratta dell'espansione più recente del centro
abitato, si è formata circa trent'anni fa ed è costituita prevalentemente da
cooperative, inoltre vi si trova il Campo sportivo comunale. Il quartiere è
separato dal centro storico da una piccola zona disabitata e dal cimitero. Zona
un tempo ricca di vigneti, in tempi recenti vi sono stati costruiti molti
condomini.
Quartiere
Chianalea (Borgo)
Il
più antico borgo di Scilla è Chianalea e deriva il suo nome da “piano della
galea”, ma è chiamato anche Acquagrande o Canalea, perché le piccole case
che sorgono direttamente sugli scogli sono separate le une dalle altre da
piccole viuzze, simili a canali, che scendono direttamente nel mare Tirreno.
Chianalea
è il vecchio borgo di pescatori, non imbalsamato a scopo turistico ma che
ancora vive dell’attività antica della pesca. Passeggiando tra le sue
suggestive viuzze è facile incontrare pescatori che, sotto casa, costruiscono
le reti per la pesca, apportano piccole riparazioni alle barche o si preparano a
partire per affrontare una nuova giornata in mare.
Le
onde del Tirreno penetrano sin quasi dentro le abitazioni che sono continuamente
sottoposte alla forza d’urto delle acque; di notte il silenzio amplifica il
suggestivo rumore dei “colpi” di mare che costituisce il sottofondo musicale
della vita a Chianalea. Si dice che qui le case sono barche e le barche sono
case.
Un
tempo questo era il quartier generale di una delle marinerie più attve del
Mediterraneo, con imercanti scillesi che arrivavano fino a Venezia a bordo delle
loro feluche.Sui fondali rocciosi davanti allac osta, tra i 50 e i 100 metri di
profondità, è stata scoperta lapiù grande foresta del mondo di corallo nero,
una delle specie di corallo più rare.
Sullo
“Scaro Alaggio”, dove i pescatori ancorano le proprie barche per ripararle
dalle onde, si impone per armonia architettonica il palazzo Scategna, con il suo
doppio ordine di balconi in pietra squadrata disposti su tre piani. Vicino si
trova villa Zagari, un edificio del 1933 in stile eclettico. Le antiche fontane,
sparse qua e là, le piazze e le chiese, ognuna con la propria storia, gli
scogli e le rocce che si frantumano nel mare, offrono un paesaggio naturale di
grande bellezza, vigilato dall’austero castello dei Ruffo, sulla rocca che è
la stessa del mostro omerico. Costruito a scopo militare, l’imponente edificio
è stato riadattato ad uso residenziale dal conte Paolo Ruffo che nel 1532
subentrò nel feudo di Scilla ai precedenti signori. Dal castello si gode un
meraviglioso panorama che comprende le isole Eolie e la costa siciliana.
Chianalea è inserito nella
lista de I
borghi più belli d'Italia ed
è stato segnalato dalla CNN come
uno dei 20 paesi più belli d'Italia.

Quartiere
Marina Grande
Il
quartiere è anche noto come Scilla Marina, Marina di Scilla, Lido
di Scilla, Spiaggia delle Sirene o, più semplicemente, Spiaggia
di Scilla. Delimitata, a
sud e a nord, da due imponenti costoni di roccia (probabilmente granito),
costituisce come una sorta di insenatura.
Il
più imponente dei citati costoni (noto come la Rocca) è situato a nord ed
ospita in cima l'antica fortezza nota come Castello
Ruffo. Ad est della grande roccia, collegata al Castello da una stradina
e protesa verso il centro della città, sorge la chiesa arcipretale di Maria SS.
Immacolata, titolare dell'omonima parrocchia arcipretale
che comprende tutte e sette le chiese di Scilla e la chiesa della frazione Favazzina.
Il castello
Ruffo di Scilla, talvolta noto anche come castello Ruffo di Calabria,
è un'antica fortificazione situata
sul promontorio
scillèo, proteso sullo stretto
di Messina. Il castello costituisce il genius
loci della cittadina di Scilla,
circa 20 km a nord di Reggio
Calabria, e sicuramente uno degli elementi più caratteristici e tipici
del paesaggio dello Stretto e del circondario reggino.
L'edificio
presenta una pianta irregolare con parti databili a diverse epoche ma che nel
complesso conservano tutt'oggi la configurazione abbastanza omogenea di una
fortezza dotata di cortine, torrioni e feritoie.
L'ingresso
è preceduto dal ponte che conduce all'edificio il cui ambiente principale è
caratterizzato dal portale di pietra costruito con arco
a sesto acuto, su cui campeggiano lo stemma nobiliare dei Ruffo e
la lapide che celebra il restauro del castello eseguito nel XVI
secolo.
Superato
l'androne a volta ribassata si apre un cortile, e da qui, percorrendo il grande
scalone, si giunge all'ingresso della residenza. Questa è dotata di ampi
saloni, essendo stata di proprietà di una delle più ricche e importanti casate
del regno di
Napoli.
Data
la posizione dominante del castello sullo Stretto
di Messina, nel 1913 venne
costruito un faro per fornire un riferimento alle navi che attraversavano lo
stretto. Il faro di Scilla, una piccola torre bianca con la base nera, è
tuttora attivo ed è gestito dalla Marina
Militare.
La
prima fortificazione della rupe di Scilla risale all'inizio del V
secolo a.C. quando, durante la tirannide di Anassila, città di
Reggio assurse a una notevole importanza, tale da permetterle di ostacolare per
oltre due secoli l'ascesa di potenze rivali. Infatti, nel 493
a.C., il tiranno di Reggio, Anassila
il giovane, per porre fine alle incursioni dei pirati etruschi che lì
avevano una sicura base per le loro scorrerie, dopo averli sconfitti col
dispiego di un notevole esercito, fece iniziare l'opera di fortificazione
dell'alta rocca. Questa divenne per Anassilao un importante avamposto di
controllo sulle rotte marittime.
L'opera
di fortificazione dell'alto scoglio fu portata a termine dai successivi tiranni
reggini, spesso impegnati in scontri con i pirati combattuti avvalendosi del
porto fortificato appositamente costruito nella zona circostante, verso Punta
Pacì, in un luogo inaccessibile dal lato opposto allo scoglio.
Baluardo
della sicurezza dei reggini, dotata di approdo, la fortificazione di Scilla è
di fondamentale importanza agli effetti del felice esito della guerra contro la
pirateria, consentendo ai tiranni di Reggio di opporre per lungo tempo una
valida resistenza contro gli attacchi di nuovi nemici e contro i continui
tentativi di rivalsa dei Tirreni sconfitti.
Il
dominio reggino sul luogo fu interrotto per soli cinquant'anni da Dionisio,
tiranno di Siracusa,
che, nel 390 a.C.,
assoggettò la rocca dopo un lungo assedio.
Nel
cinquantennio che intercorse tra le distruzioni operate da Dionisio e il
riacquisto dell'indipendenza favorita da Timoleonte
di Corinto, che abbatté il potere tirannico di Siracusa (340
a.C.), i Tirreni rioccuparono la rocca. Tornata la normalità, Scilla
rientrò nell'orbita di Reggio.
La
rupe pian piano divenne una vera fortezza, tanto che nel III
secolo a.C. la fortificazione dei reggini, alleati dei romani,
resistette validamente ai Punici alleati
dei Bruzi.
Successivamente Ottaviano,
una volta disfattosi del rivale Pompeo,
avendo compreso l'importanza strategica della rupe di Scilla che gli aveva
offerto opportuno rifugio, decretò che venisse maggiormente fortificata.
Alcuni
scavi hanno portato alla luce strutture murarie del monastero
basiliano di San
Pancrazio, edificato verso la metà del IX
secolo come difesa dalle incursioni saracene.
Nel 1060,
con l'assedio di Reggio da parte dei normanni Ruggero e Roberto
il Guiscardo, anche il castello di Scilla resistette a lungo e si arrese
solo per fame. Roberto il Guiscardo quindi attestò sulla rocca un presidio
militare.
Nel 1255,
per ordine di Manfredi, Pietro
Ruffo fortificò ulteriormente le rocca assegnandovi un presidio,
mentre nel XIII
secolo il castello fu ulteriormente fortificato da Carlo
I d'Angiò.
Nel 1469 Re Ferdinando
I di Napoli concesse il castello a Gutierre
De Nava, un cavaliere castigliano vicino alla corte aragonese e
originario della Germania (dal
quale discendono i De Nava di Reggio),
che fece eseguire nuovi interventi di ampliamento e di restauro.
Nel 1543 il
castello venne acquistato da Paolo
Ruffo che decise di restaurarne il palazzo baronale poiché nel 1578 la
famiglia Ruffo ottenne il titolo di principe.
Il
forte terremoto
del 1783, che danneggiò tutta l'area dello stretto e parte della
Calabria meridionale, non risparmiò il castello di Scilla che però, divenuto
proprietà demaniale dello Stato nel 1808,
fu restaurato nel 1810.
Il
terribile sisma
del 1908 distrusse gran parte dell'antica struttura del castello,
mentre nel 1913 la
parte più superiore venne chiusa per ospitare il faro.
Poi durante il periodo
fascista alcuni ambienti vennero divisi in appartamenti destinati a
impiegati e funzionari pubblici, uso che contribuì al danneggiamento di ciò
che rimaneva della struttura.
Nell'ultimo
trentennio il castello è stato utilizzato come ostello della gioventù, ma
oggi, dopo un nuovo restauro, è stato destinato a diventare un centro
culturale: ospita infatti il Centro regionale per il recupero dei centri
storici calabresi ed è sede di mostre e convegni.

Sull'altro
complesso roccioso, porta della città per chi proviene da Reggio o
dalla limitrofa Villa
San Giovanni utilizzando la SS18,
è posto un terrazzino, noto come Belvedere Morselli, che offre una
magnifica panoramica sullo Stretto e
sulla città. Il belvedere ospita un monumento allo scrittore Ercole
Luigi Morselli, innamorato delle suggestioni mitologiche di Marina Grande
di Scilla, cantate da Omero circa
duemila e settecento anni fa.
Lo
spazio fra le due rocce, circa un chilometro, è occupato dal lungomare Cristoforo
Colombo e dalla spiaggia che, costituita da ghiaietta molto
fine, è stata probabilmente ampliata dallo scarico dei materiali risultanti
dalla costruzione del tratto dell'autostrada
A3 Salerno-Reggio
Calabria.
All'estremo
settentrionale del lungomare, proprio ai piedi della grande roccia, è posta la chiesa
dello Spirito
Santo, in stile tardobarocco, risalente al 1752.
Scampata ai terremoti del 1783 e
del 1908,
nonché a numerose mareggiate, come quella del capodanno 1979-'80,
fra le più violente degli ultimi decenni, la chiesa ospita anche un antico
quadro (olio su tavola) ed una statua di San
Francesco da Paola, venerato come patrono del quartiere.
Dalla
primavera del 2007 la
chiesa, sotto l'egida del Ministero
per i beni e le attività culturali per il suo valore
storico-architettonico di rilevanza nazionale, è stata interessata per oltre un
anno da lavori di restauro, supervisionati dalla competente Sovrintendenza, che
ne hanno riguardato la parte esterna.

Tradizioni
religiose
La
spiaggia di Marina Grande è il sito dei giochi pirotecnici conclusivi della
festa di san
Rocco, patrono della città di Scilla, per i quali affluiscono in città
numerosi visitatori e appassionati da varie parti della Calabria e
della Sicilia
orientale.
Le
nuove autorità parrocchiali decretavano, nel 2004,
una riduzione del tenore delle celebrazioni in onore di san Francesco da Paola
e, dal 2005,
la loro soppressione, interrompendo una tradizione plurisecolare. Tale
tradizione, dopo un successivo cambio al vertice della parrocchia arcipretale,
veniva simbolicamente riattivata allorquando, il 2 aprile 2009,
con la dedicazione al santo della via che unisce la chiesa dello Spirito Santo
al porto, avevano luogo anche celebrazioni religiose.
La
pesca del pesce spada
Il pesce spada
è una specie migratoria. Gli esemplari non si spostano in branchi ma in coppie,
il maschio sempre affiancato dalla femmina, e se uno viene catturato l'altro lo
segue.
Nel tratto di
mare calabrese compreso nello Stretto di Messina, la pesca tradizionale al pesce
spada si effettua tra l'inizio di giugno e la fine di luglio con speciali
imbarcazioni dotate di lunghe passerelle per l'arpionaggio e di alti tralicci su
cui si arrampicano gli avvistatori.
Un tempo gli
avvistatori potevano prendere posto anche lungo la costa, su qualche roccia o
scoglio elevato, e da lì comunicavano la posizione del pesce agli equipaggi
dello loro barche. Chi avvistava per primo un pesce spada, aveva poi il diritto
di fiocinarlo.

Fonte
|