|
Stilo si trova
ai piedi del Monte
Consolino. Nelle vicinanze di Ferdinandea si
estende il bosco di Stilo, un esempio tipico di bosco delle Serre
calabresi, con abeti bianchi e faggi e con un ricco sottobosco con forte
presenza di eriche e agrifogli.
Come fauna sono presenti il gatto
selvatico, la martora e
numerose specie di picchi.
Il territorio si estende, con un sottile lembo, fino al mare in località
Caldarella.
Secondo il
Barrio e il Marafioti, Stilo prende il nome dalla fiumara Stilaro e
non viceversa, come pensa l'Aceti, il quale ritiene che la città abbia ricevuto
tale nome in virtù della conformazione a colonna, in greco Stylon, del
promontorio di Cocinto (attuale Punta
Stilo), dove si trovava una volta il primo insediamento. Altri pensano si
chiami Stylon, appunto "colonna", per la forma del Monte
Consolino, sua attuale ubicazione.
Le
origini di Stilo sono legate alla distruzione durante il periodo greco, da parte
di Dionisio
I di Siracusa, della città di Kaulon. Secondo Apollinare Agresta ("Vita
di San Giovanni Therestis", 1677), fu edificata in ben tre luoghi diversi:
la prima volta nel promontorio di Cocinto, attuale Punta Stilo (da
indagini subacquee effettuate negli anni '80 sarebbe stata individuata l'area in
cui sorgeva il Coynthum Promontorium, citato nelle fonti greche),
nel Medioevo, sempre in quest'area, sulla destra della fiumara Assi, e
infine sul Monte Consolino.
In
principio fu una città fortificata, un oppidum magnogreco
di nome Consilinum, o in greco Kosilinon (da "kosi",
"villaggio", e "silinon", "della luna").
Stilo
nel periodo del basso impero romano era considerata la Kaulonia italiota e
successivamente cambiò il nome in Stilida.
Il
nome Stilida deriva dalla fiumara Stilaro, dalla forma del promontorio allungato
e dalla colonna del tempio di Giove Omorio. Considerata nell'Itinerarium
Antonini una stazione itinerante distante 400 stadi (unità
di misura di distanza greca) da Locri.
Nella
regione dei Salti (in latino saltus), separata
dalle località Malafrana a est, Maddaloni, Troiano e Napi a sud e da località
Maleni e dallo Stilaro a nord, è stato ritrovato l’unico complesso
residenziale romano in villa,
denominato villa di località Maddaloni, dell'area, a cui è stato
attribuito uno sviluppo in senso monumentale nel corso del III secolo, e almeno
altri 4 siti tardo-antichi a corona.
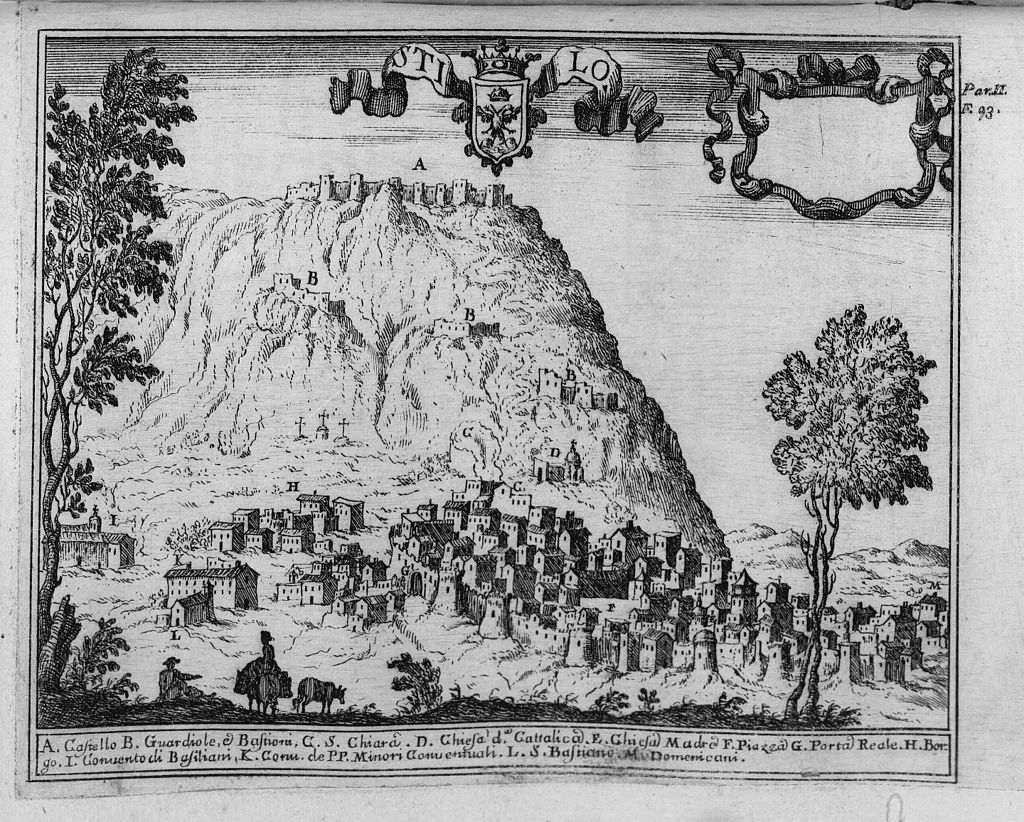
Una battaglia
navale avvenne tra le navi aghlabidi e le navi bizantine
comandate da Nasar, nell'880, al largo di Punta Stilo. Questa località
allora era chiamata "Le colonne", in greco Steilai.
Stilida
divenne parte dell'Impero
bizantino nel VI secolo. Stilida era situata nei pressi di Punta Stilo alla
destra della fiumara Assi. Il 15 luglio del 982 subì danni a causa di
una battaglia tra Ottone II e gli arabo-bizantini, vinta da
questi ultimi.
Nel 995 sarebbe
stata rapita nel casale (chorion bizantino) di Cursano, sito in località
Botterio Signore, la madre di Giovanni Theristis, incinta dello stesso,
tradotta poi a Palermo. 14 anni dopo Giovanni sarebbe tornato a Stilo e da
allora si sarebbero tramandate leggende e credenze popolari sul suo conto.
Nel
corso del Medioevo gli
abitanti della costa si trasferirono sempre di più verso l'interno, creando i
nuclei medievali degli attuali paesi della vallata dello Stilaro; così gli
abitanti di Stilida si spostarono sul Monte Consolino e solo in un terzo momento
dove si trova oggi Stilo. Nel IX secolo venne costruita la Cattolica di
Stilo.
Tra
il 1065 e
il 1071 Stilo resistette all'invasione normanna. Ai tempi era definita oppidum,
cioè città fortificata con cinte murarie. Vi erano cinque porte d'accesso:
Porta Stefanina, Porta Terra, Porta Reale, Porta Scanza li Gutti e Porta Cacari.
Tra
il X e l'XI secolo nacquero e si espandettero i monasteri di diritto
metropolitico di Santa Maria (Theotókos)
d'Arsafia, documentato come il più antico sul territorio (all'inizio della
seconda metà del X secolo, durante la reggenza del metropolita di Reggio
Teofilatto), di San Leonte (oltre la metà dell'XI secolo), di San Pietro dei
Salti e di San Nicola di Soumpesa.
Nei
pressi del territorio di Arsafia sono stati anche individuati quattro siti in
cui erano presenti tre famiglie: Ardabastonai, Mantes, Koubouklesioi.
Sempre nel X secolo, in località Salti, alcuni documenti bizantini e poi
normanni attestano la presenza di possedimenti delle famiglie Gaidarokrites,
Kasiris, Phylores, Phouphounkouloi e Oursoleon, di monasteri e oratori, come
quelli di Santa Maria del Primicerio e di San Pietro dei Salti ed
il chorion (villaggio
bizantino) di Trogion.
Nelle località Marone e Muturavolo erano i possedimenti delle famiglie
Karbounes, Parillas, Maronites e Philommates, risalenti alla seconda metà del X
secolo e alla prima metà dell'XI secolo.
Nei pressi si trovava il chorion di Rousiton.

Nel
periodo normanno Stilo divenne possesso del Regio
Demanio, a differenza di altre città, come Crotone, Catanzaro e Gerace,
proprietà di signori feudali. Conservò questo privilegio fino al XIV secolo,
quando Carlo V di Spagna gli revocò i privilegi.
Fino
al 1094,
anno in cui Ruggero II concesse alcune terre demaniali ad istituti
religiosi, Stilo comprendeva vari casali.
Nel 1260,
sotto Carlo I d'Angiò, la città di Stilo risulta demaniale: il
suo castello era munito di reale presidio contando per una delle principali
fortezze della provincia.
I
giacimenti di Stilo, conosciuti fin dai secoli a.C., nel 1094 risultano
possedimenti dei Certosini di Serra San Bruno in seguito a donazione del conte
Ruggero il Normanno. Qui nacque la ferriera,
che utilizzava anche il ferro estratto dal sottosuolo di Pazzano attorno al
monte Stella, appartenuta agli Aragonesi e ceduta nel 1524, assieme alle
limitrofe ferriere di Spadola e di Fabrizia, da Carlo V a Cesare
Fieramosca, fratello del famoso Ettore. Durante tutto il 1600 gli impianti
di Stilo producevano in gran quantità. Nella ferriera stilese si lavoravano
manufatti ferrosi per uso civile e militare, come "i tubi dell'acquedotto
di Caserta, in base ai modelli ed ai disegni preparati dal Vanvitelli",
come scrive G. Rubino. Questi, derivata dall'inventario del 1761, tracciò una
descrizione della consistenza delle cosiddette "Ferriere Vecchie" di
Stilo, per distinguerle dalle nuove, ubicate presso il vicino corso d'acqua
Assi. "Esse comprendevano, oltre ad una piccola cappella ed alla residenza
per l'amministratore ed i militari di guarnigione, due fonderie, otto ferriere
ed una sega idraulica...".

Nel 1540 Carlo
V d'Asburgo vendette le terre demaniali di molti paesi, tra cui Stilo,
poiché gli serviva denaro per difendere i territori italiani dalle invasioni
turche. Stilo finì nelle mani del marchese Concublet di Arena.
Il
5 settembre 1568 nacque
a Stilo il filosofo Tommaso Campanella. Nel 1575 il re di
Spagna Filippo II restituì il Demanio e la contea a Stilo. Sotto Filippo
III, nel 1599 avvenne una ribellione, capeggiata da Campanella e soffocata dal
governo spagnolo.
Nel 1658,
sotto il regno di Filippo IV, furono riconcessi i privilegi di Regio
Demanio, come si evince dalla Copia del Real Decreto Della Maestà del Rè
Nostro Signore Filippo Quarto in confirmatione dell'antichisimo Demanio e Reali
Privilegii della Regia Città di Stilo nel Regno di Napoli.
La gestione del Regio Demanio era rappresentata da varie figure, tra cui la più
importante era il sindaco, coadiuvato dagli assessori, che restava in carica un
anno. La giustizia si componeva invece del giudice, amministratore della
giustizia ordinaria insieme all'avvocato e all'auditore, del
"baglivo", magistrato, del "mastrodatti", cancelliere che
redigeva gli atti dei processi, e del "baiulo", magistrato che
rappresentava il potere del sovrano. Il "capitano" era invece la
persona incaricata di gestire la giustizia criminale, insieme a una corte e un
notaio. Il "mastrogiurato" eseguiva gli ordini del capitano.
Verso
il 1770 il
sito siderurgico di Stilo venne abbandonato e ne venne edificato un altro a Mongiana,
ben più grande, ricco e più vicino agli sbocchi commerciali e comunicativi,
come Serra San Bruno e Pizzo.
Nel 1783 la Calabria venne
colpita da un terremoto che danneggiò anche il borgo di Stilo.
Nel 1806,
quando i francesi si impossessarono del Regno di Napoli, Stilo venne
saccheggiata dalle loro truppe. Stilo, con il decreto n. 922 per la nuova
circoscrizione delle quattordici province del regno di Napoli, cessò di essere
Regio Demanio e i suoi casali vennero resi comuni autonomi. Venne istituito il Circondario
di Stilo, di cui facevano parte i comuni di Bivongi, Stignano, Pazzano,
Riace, Monasterace, Camini, Guardavalle e Placanica. Il
circondario faceva parte del Distretto di Gerace della Provincia
di Calabria Ultra.
Nel
settembre 2012 il
Diving Center Punta Stilo ha scoperto in località Boario del "Gran Bosco
di Stilo" dei massi molto simili alle pietre neolitiche di Nardodipace,
con incisi segni e forme geometriche.

Luoghi
d'interesse
Per
molti la Calabria significa solo mare. E troppo spesso ci si dimentica che il
volto più "puro" della regione si cela piuttosto nell'entroterra,
gelosamente protetto da boschi lussureggianti, montagne e anfratti rocciosi.
Un'anima verde raggiungibile con strade tortuose che lentamente conducono alla
scoperta di una terra ricca di contrasti, dove convivono, quasi ignorandosi,
straordinari capolavori artistici e brutture architettoniche altrettanto
straordinarie. Luoghi dove le pietre narrano storie di culture diverse e dove la
natura inebria con i suoi profumi intensi e i suoi colori. Così è per la valle
dello Stilaro, nel cuore dell'Alta Locride, su cui domina, a 386 metri di
altitudine, il borgo bizantino di Stilo, uno dei meglio conservati della
provincia di Reggio Calabria.
Lasciati
alle spalle gli azzurri intensi della costa dei Gelsomini, sullo Ionio, Stilo si
raggiunge percorrendo la strada statale 110 fra ulivi, vigneti, piantagioni di
agrumi, alternati a mulini, frantoi, torri di avvistamento e masserie
fortificate sorte contro le incursioni saracene. La Storia ha incastonato il
borgo in posizione strategica sulle pendici rocciose del monte Consolino,
massiccio calcareo dalle morbide forme. Qui, tra il VII e l'VIII secolo si sono
insediate le popolazioni costiere gravitanti attorno a ciò che sopravviveva
dell'antica colonia magnogreca di Kaulon (i cui resti sono visibili nell'area
archeologica del comune di Monasterace, a pochi passi dal mare), ridotta a
piccolo e malsicuro villaggio già in epoca romana. Si trattava di agricoltori e
artigiani cui seguirono presto gruppi di monaci Basiliani, profughi dall'Oriente
e dalla Sicilia conquistata dagli Arabi, che nelle grotte calcaree del monte
trovarono la sede ideale per le loro comunità eremitiche.

È
proprio grazie a questo intenso popolamento che Stilo è cresciuta, divenendo
nel X secolo il principale centro bizantino della Calabria meridionale e
assumendo le sembianze di città fortificata, teatro di importanti battaglie
come quella che il 13 luglio del 982 vide la vittoria delle truppe
arabo-bizantine, momentaneamente alleate, su quelle dell'imperatore Ottone II di
Sassonia. Delle antiche mura e dei torrioni restano la memoria e qualche rovina.
Dei cinque ingressi alla città sopravvive solo porta Stefanina, rimaneggiata
nel '600, che fiancheggia la chiesa di San Domenico. Era
chiamata così perché confinava con il territorio del Convento di Santo Stefano
del Bosco
Ciò
che ha superato i secoli è invece l'impianto urbanistico del borgo, disteso ad
arco su una balza a mezza costa del monte, quasi un anfiteatro affacciato sulla
valle, e animato dall'intricato saliscendi di vicoletti lastricati, dove lo
schietto sole di Calabria si fa largo a fatica per illuminare un muro consunto
dai secoli, un balcone fiorito, una gentile ringhiera in ferro battuto. Le
piccole vie si inerpicano fino alla roccia del monte, sulla cui sommità, a 700
metri di altitudine, ancora resistono i resti del Castello normanno dell'XI
secolo, costruito su un preesistente fortilizio bizantino. Di forma rettangolare
e cinto da opere di difesa, ne rimangono i ruderi delle mura perimetrali, delle
torri e delle porte. Fu distrutto dai Francesi durante la guerra con Carlo
V nel XVI
secolo. Lo si raggiunge in
poco più di un'ora a piedi, seguendo un ripido sentiero che costeggia le
pendici della montagna e che regala spettacolari panorami "a picco" su
Stilo e sul vicino borgo di Bivongi, incorniciati dallo Ionio e dalle Serre
Calabre. Da questo punto, nelle giornate di sereno la vista spazia fino a Isola
di Capo Rizzuto, al limite opposto del golfo di Squillace.

Il duomo
di Stilo, o chiesa matrice, è un edificio religioso di stile tardo-barocco
del XVI secolo.
La costruzione come duomo avvenne tra il XII e
il XIV secolo.
 Viene
menzionata per la prima volta nel 1094 come ecclesia
episcopi, dal latino "chiesa
episcopale", e quindi forse potrebbe essere stata un'antica sede vescovile.
Grazie ai recenti scavi archeologici del 2000 e
allo studio degli elementi architettonici della struttura, si pensa che sia
stata edificata sopra una piccola chiesa bizantina,
a sua volta edificata su una chiesa paleo-cristiana. Viene
menzionata per la prima volta nel 1094 come ecclesia
episcopi, dal latino "chiesa
episcopale", e quindi forse potrebbe essere stata un'antica sede vescovile.
Grazie ai recenti scavi archeologici del 2000 e
allo studio degli elementi architettonici della struttura, si pensa che sia
stata edificata sopra una piccola chiesa bizantina,
a sua volta edificata su una chiesa paleo-cristiana.
Il portale
ogivale in pietra calcarea di stile-romanico-gotico è
del XII secolo.
Alla destra del portale c'è una scultura in pietra di due uccelli stilizzati
che si pensa siano o di fattura normanna o
di fattura bizantina,
mentre alla sinistra sono attaccati alla parete due piedi in marmo provenienti
da una statua romana.
L'interno, in
stile barocco,
conserva la Madonna di Ognissanti (1618-1619),
capolavoro di Battistello
Caracciolo.

L'Abbazia
di San Giovanni Therestis
fu edificata dai Paolotti nel XV
secolo. Dal 1662 fu
dato ai monaci bizantini e in seguito ai padri
redentoristi.
L'ingresso è
caratterizzato da un portone in granito grigio e rosa; al di sopra vi è un
balcone con inciso il nome del priore che lo fece costruire. Ha una cupola
impostata su 4 pilastri con 2 archi a tutto sesto e 2 archi a sesto acuto.
All'interno c'è
un dipinto del XII secolo del periodo svevo, raffigurante Madonna in trono con
la mano destra sulla spalla del bambino, che benedice.
Qui nel 1600
furono portate le reliquie di san
Giovanni Therestis da un vecchio convento, con il consenso del papa
Alessandro VIII tramite la lettera Ad futuram Dei memoriam.

La Chiesa
di San Domenico
fa parte di un convento domenicano,
di cui sono rimasti solo i
ruderi ed edificata su una chiesa bizantina dedicata a sant'Agata. Qui le
famiglie nobili stilesi avevano della cappelle dove seppellivano i loro defunti.
Il Campanella
vi scrisse la tragedia Maria Regina di Scozia, il trattato teologico De
preadestinatione et gratia contra Molinam pro Thomistis, Articuli
prophaetales e l'opera La Monarchia di Spagna.
Nel 1787 dopo
essere stata ricostruita fu scelta come sede della parrocchia di Santa
Marina e Lucia.
Nel 1927 fu
chiusa al culto per il crollo della volta, fu in parte ricostruita ma finì di
essere restaurata nel 1998 grazie
al comune e ai fondi della Regione
Calabria.

Più
in basso, ai bordi dell'abitato, la forte spiritualità di questa terra trova la
sua massima espressione architettonica nelle delicate proporzioni della Cattolica. La piccola costruzione, accovacciata su un costone del Consolino, era
la chiesa principale cui facevano riferimento le laure (grotte) eremitiche
sparse nei dintorni: i monaci bizantini vi confluivano dalle loro cellette per
assistere alle celebrazioni liturgiche.
Fondata
nel IX secolo, è un capolavoro dell'architettura sacra bizantina preservatosi
grazie alla particolare collocazione, tra la roccia e il dirupo, che ha
ostacolato qualsiasi successivo intervento, difendendola dalla sorte di altri
edifici con pianta a croce greca che i Normanni hanno trasformato in chiese a
croce latina. Di grande semplicità e armonia l'esterno, realizzato in
laterizio, sormontato da cinque cupolette. All'interno, resi ancora più
suggestivi dalla luce tenue che penetra dalle piccole aperture, resti di cicli
di affreschi, in parte sovrapposti, rappresentano uno straordinario excursus
sulla storia dell'arte locale tra il X e il XV secolo.
La
Cattolica era la chiesa madre tra le cinque parrocchie del paese, retta da un
vicario perpetuo, che aveva diritto di sepoltura al suo interno. ne sono
testimonianza i resti umani rinvenuti in un sepolcro marmoreo con un anello di
valore.
La
denominazione di Cattolica stava ad indicarne la categoria delle "chiese
privilegiate" di primo grado, infatti con la nomenclatura impiegata
sotto il dominio bizantino nelle province dell'Italia meridionale (soggette al
rito greco), la definizione di katholikì spettava solo alle chiese
munite di battistero. Cosa che è rimasta fino ad oggi in certe località legate
per tradizione a questo titolo, come ad esempio la chiesa "Cattolica dei
Greci" di Reggio Calabria che fu la prima della città. In effetti
l'architettura, la ricchezza degli affreschi e la copertura in piombo delle
cupole dimostrano che non si tratta di un tempietto di minore importanza. La
Cattolica di Stilo, costituisce un'architettura puramente e tipicamente
bizantina, come si può vedere dalla pianta e dalla costruzione, unico esempio
del genere con la sua gemella di San Marco in Rossano ad ovest
dell'Adriatico.

La
Cattolica si rifà al modello della croce greca inscritta, tipico del periodo
medio-bizantino, durante il quale la profonda evoluzione nell'architettura
religiosa fu connotata dall'elaborazione di sistemi particolarmente raffinati ed
originali. All'interno la chiesa è divisa in nove spazi uguali da quattro
colonne, lo spazio quadrato centrale e quelli angolari sono coperti da cupole su
dei cilindri di diametro uguale, la cupola mediana è leggermente più alta ed
ha un diametro maggiore.
Sulla
parte di ponente la costruzione si adagia per lo più sulla roccia nuda, mentre
la parte di levante, che termina con tre absidi, poggia il suo peso su tre basi
di pietra e di materiale laterizio.
L'aspetto
generale dell'edificio è di forma cubica, realizzato con un particolare
intreccio di grossi mattoni uniti tra loro dalla malta. L'uso del materiale
laterizio (più costoso ma più semplice da utilizzare) e la tecnica usata dai
costruttori, non trovarono però concorde Paolo Orsi, sovrintendente al Museo
Nazionale di Reggio Calabria, che data i mattoni come "cortine di
laterizi della buona età imperiale", in contrapposizione ad altri
studiosi che pensavano fossero usati per "disciogliere la plasticità
della parete nell’accentuazione della grana e del colore del materiale".
 La
Cattolica esternamente è quasi priva di decorazioni, a parte le cupolette che
ne sono ricche, rivestite di mattonelle quadrate di cotto disposte a losanga, e
di due cornici di mattoni disposti a dente di sega lungo l'andamento delle
finestre. La
Cattolica esternamente è quasi priva di decorazioni, a parte le cupolette che
ne sono ricche, rivestite di mattonelle quadrate di cotto disposte a losanga, e
di due cornici di mattoni disposti a dente di sega lungo l'andamento delle
finestre.
La
particolare collocazione delle fonti di luce all'interno della Cattolica, mette
in risalto lo spazio e conferisce maggiore slancio. Questa dilatazione dello
spazio serviva a mettere in risalto gli affreschi di cui i muri della chiesa
erano interamente ricoperti in origine, decorazioni pittoriche dunque a cui era
affidato il compito di decontestualizzare la superficie muraria.
Il
piccolo ambiente della chiesa è munito di tre absidi sul versante orientale:
quella centrale (il bema) conteneva l'altare vero e proprio, quella a nord (il
prothesis) accoglieva il rito preparatorio del pane e del vino, mentre quella a
sud (il diakonikon) custodiva gli arredi sacri e serviva per la vestizione dei
sacerdoti prima della liturgia.
In
particolare sopra l'abside di sinistra è posta una campana (di manifattura
locale) del 1577, risalente all'epoca in cui la chiesa fu convertita al rito
latino, che raffigura a rilievo una Madonna con Bambino.






Un
pezzo di colonna antica nell'abside prothesis, fu adibito a mensa per la
conservazione dell'eucarestia, mentre le quattro colonne che sostengono le
cupolette, poggiano su basi differenti, recuperate da epoca molto più antica
(es. una base ionica capovolta innestata sopra un capitello corinzio rovesciato,
o ancora un capitello ionico capovolto).
Infatti
non è da escludere un eventuale uso della Cattolica come oratorio musulmano,
come d'altro canto non è da escludere che le colonne possano essere state
portate sul posto già incise; comunque gli Arabi, il cui scopo generalmente non
era la conquista della regione ma il suo saccheggio, inspiegabilmente non
distrussero la piccola chiesa bizantina, ma decisero di innalzarla a propria
sede di culto e di preghiera, forse perché attratti dalla sua bellezza, e dal
suo particolare posizionamento.
La
Cattolica nel dettaglio - Con la sua inconfondibile sagoma, la Cattolica di
Stilo è uno dei simboli della Calabria Ionica e figura tra i più significativi
esempi di architettura bizantina in Italia.
Edificata
con pianta quadrata nel IX secolo, ha la forma di un cubo sormontato da cinque
cupolette cilindriche. Quattro, rappresentanti gli evangelisti, sono poste sugli
angoli, mentre la quinta, al centro, simboleggia Cristo.
Le
cupole scaricano il loro peso attraverso volte a botte che poggiano su quattro
colonnine di marmo e granito provenienti dall'antica città di Kaulon. La prima
colonna a sinistra rispetto all'ingresso ha come basamento un capitello corinzio
rovesciato, metafora della vittoria della religione sul paganesimo, mentre su
quella a destra è incisa una croce gemmata con l'iscrizione "Dio il
Signore è apparso a noi".
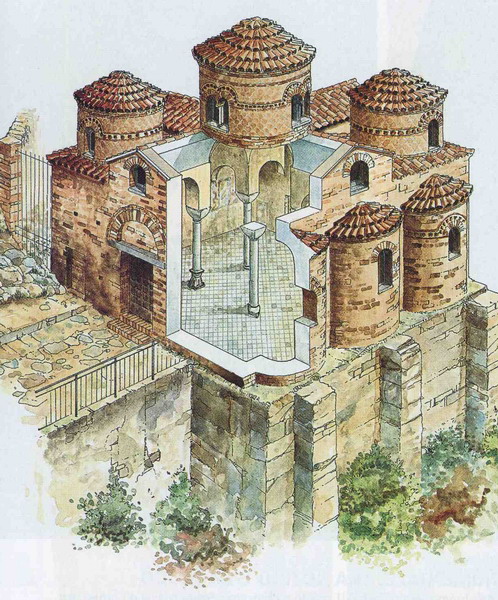
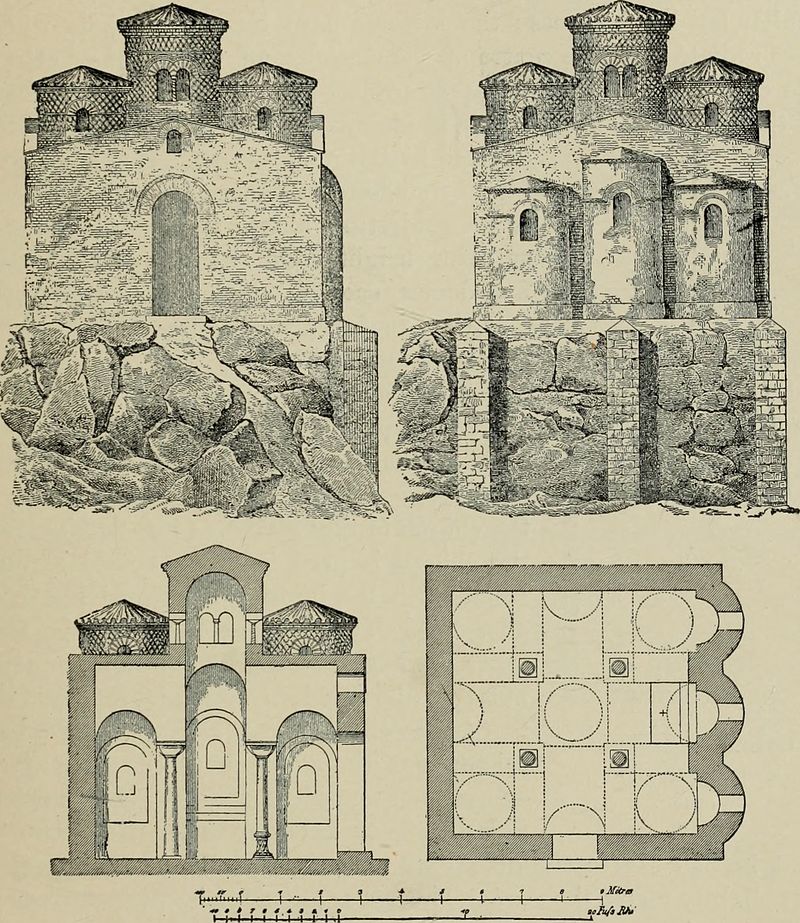
I
frammenti di affreschi dell'interno, in parte sovrapposti, raffigurano alcuni
santi, il Sonno della Vergine XIll-XlV secolo), l'Annunciazione (XI secolo), la
Presentazione di Gesù al tempio (XII secolo) e il Cristo benedicente (XII
secolo).
Il
ruolo mantenuto nei secoli da Stilo come centro religioso è testimoniato dalle
ben 18 chiese che erano presenti sul suo territorio, molte delle quali andate
perdute dopo il devastante terremoto del 1783. Oggi fra le più interessanti
rimangono il duomo del '200, in seguito rimaneggiato, una delle più antiche
sedi vescovili della Calabria, di cui si può ammirare il bel portale gotico e,
incastonati nella facciata, la base di una statua romana accanto ad alcuni
bassorilievi di epoca bizantino-normanna.
Nella
zona nord della cittadina svetta la cupola ogivale della chiesa di San Domenico,
eretta nel '400 e in parte ricostruita dopo il crollo del tetto nel 1927. Faceva
parte del complesso conventuale dei Domenicani, di cui ora restano solo ruderi,
dove sullo scorcio del '500 si formò uno degli uomini illustri di queste
contrade, il teologo Tommaso Campanella. Lo skyline di Stilo è anche segnato
dai due campanili che racchiudono la facciata settecentesca della chiesa di San
Giovanni Therestis. All'interno, le reliquie del santo a cui è dedicata e
quelle dei Santi Nicola e Ambrogio.
A
chiudere l'itinerario tra i luoghi sacri, la chiesa di San Francesco con la sua
facciata barocca e, all'ingresso del paese, la chiesetta di San Nicola da
Tolentino (del XV secolo) con la caratteristica cupola a forma di trullo
svettante sul piccolo edificio che versa in condizioni precarie. Da qui,
rivolgendo lo sguardo alla valle dello Stilaro, si percepisce per intero il
carattere di questo scorcio di Calabria appollaiato, come sosteneva uno
scrittore francese dell'800, "all'altezza dei nidi delle aquile".

Fonte:
Bell'Italia
(Vincenzo Petraglia)
|