|
Situato
su un terrazzo alluvionale ai piedi della dorsale che salda le serre all'Aspromonte,
Taurianova è uno dei più importanti centri della provincia. È situata nella
parte più meridionale della piana
di Gioia Tauro, anticamente denominata "Vallis Salinarum" a
circa 15 chilometri dal mare, 6 chilometri dalla montagna e a 800 metri dal
corso d'acqua più vicino, il torrente Razzà.
Il
nome deriverebbe da Nuova Taurianum, toponimo a sua volta derivante
dall'antico insediamento della Magna
Grecia, un tempo abitata dai calcidei di Zancle (l'odierna Messina)
e dai bruzi della
colonia Tauriana (o
Taureana), quest'ultima distrutta intorno al 950-986 d.C. quando la più feroce
delle incursioni saracene rase al suolo l’antica e florida città costiera di
Taureana, disperdendone gli abitanti.
Tra
i vari paesi sorti o incrementati dai fuggiaschi, sicuramente dovevano esserci
anche i due piccoli nuclei di Radicena e Iatrinoli, ipotesi avvalorata anche dal
fatto che a Radicena sorgeva un monastero di monaci calabro-greci, intorno al
quale erano ben sviluppate importanti attività agricole. L'avvento dei Normanni nel secolo
XI, segna un'importante svolta nella storia della Piana, in quanto furono
proprio loro ad introdurre il feudalesimo nel Mezzogiorno
d'Italia.
Con
la sconfitta di Manfredi a Benevento, ai Normanni subentrarono i Francesi
Angioini che si preoccuparono soltanto di depredare le terre conquistate. Ad
accrescere lo stato di prostrazione del popolo della Piana, sopraggiunsero gli
Spagnoli Aragonesi, che iniziarono a contendersi il dominio delle regioni
meridionali agli Angioini. Pertanto il territorio della piana di Gioia Tauro, si
trasformò spesso in campo di battaglia e proprio a causa del perdurare di tale
situazione di depressione del popolo locale, si sviluppò il fenomeno del Brigantaggio,
come sorta di ritorsione criminosa nei confronti di quello sfruttamento, che
veniva esercitato dai Feudatari della zona.
Così
vanno le cose fino al 1738, quando per effetto del trattato di Vienna, si
insedia a Napoli Carlo III di Borbone, dando inizio ad una nuova dinastia che
dovrà durare, salvo la breve parentesi napoleonica, fino all'Unità d'Italia.
Nel Febbraio 1783 il
più terribile evento storico colpisce la zona della Piana, un tremendo
terremoto sconvolge il territorio al punto di cambiarne l'orografia.
La frazione di San Martino sede di un antico castello, viene spazzata via ed
analoga sorte tocca a tutte le altre città della zona. Per tutto l'anno la
terra continuò a tremare ed alla fine in tutta la Calabria si contarono,
secondo lo storico Pietro
Colletta sessantamila morti e duecento città o paesi
distrutti.
Solo
a seguito dell'avvento del governo Francese, nel 1808 Napoleone
Bonaparte nomina Gioacchino
Murat Re di Napoli, il quale abolisce definitivamente il sistema
feudale. Nel 1908 la situazione si ripete, ma in termini ancora ben più
drammatici, il terremoto e maremoto di Messina e Reggio Calabria produce oltre
77.000 vittime di cui circa 17.000 tra il territorio di Palmi e Reggio.
Iatrinoli e Radicena vedono sorgere rapidamente ai margini dell'abitato
baraccamenti per profughi che diventano ben presto dei veri e propri quartieri.
Oramai i due paesi si toccano e la nuova ferrovia, entrata in funzione nel 1924,
contribuisce con la stazione comune, a saldarne i reciproci vincoli.
La
città di Taurianova nasce ufficialmente come macro-comune il 12 marzo 1928,
dal preesistente comune di Terranova (il
quale riacquisterà poi la sua indipendenza amministrativa il 23 aprile 1946),
unito alle località di Radicena e Jatrinoli, più l'annessione
di frazioni e contrade quali San
Martino, Amato, Pegara e Scroforio (quest'ultima
poi riceduta al comune di Terranova
Sappo Minulio.

Lo
sviluppo dei due centri di Radicena e Iatrìnoli, all'origine dell'odierno
nucleo urbano, e dell'attuale frazione San
Martino, tutti antichi casali di Terranova,
che per la loro posizione geografica si trovano al centro di un importante
sistema viario, può considerarsi parallelo.
Attendibile
è l'esperto di storia bizantina italiana André
Guillou, il quale, richiamandosi a un documento di donazione, dimostra
che Radicena esisteva fin dal 1050 e
menziona dello stesso periodo il monastero di Santa Lucia situato ad ovest del
suddetto centro. Padre Fiore, storiografo del Settecento, afferma che la loro
fondazione è stata opera dei profughi provenienti da Tauriana,
importante e fiorente centro della costa tirrenica, distrutto nel 986 dalle
incursioni saracene dell'emiro di
Palermo, Hasan-Ibn
Alì, di casa Kelbita,
il quale per il mancato tributo dovutogli dai Bizantini decise
di occupare tutta la Calabria.
Padre Fiore così si esprime: «Ond'è da trarre in conseguenza quanto grande e
popolata fosse la già distrutta Taureana, mentre le sue reliquie furono
bastanti a fondare la nuova città di Seminara, a riabitar Terranova, accrescere
San Giorge, e forse ancora a dar principio a tutto dalla maggior parte dei
villaggi i quali sono sotto la giurisdizione di Terranova, cioè Rizziconi, San
Leo, San Martino, Cristò, Vatone, Radicena, Iatrinole, Bracade, Curtulade,
Galatoni, Scroforio e Molochio».
Lo
storico Giuseppe Romeo Toscano arriva alla conclusione che essendo "piazza
Garibaldi" di Radicena tuttora denominata "Chianu 'i San Basili"
(Piano di San
Basilio), potrebbe darsi che ivi già sorgesse uno dei 137 monasteri
italo-greci che lo storiografo polistenese Girolamo Marafioti afferma esservi
stati nella Piana di San Martino, tra Seminara, Rosarno e Galatro,
e che un certo numero di profughi di Taureana vi avesse trovato rifugio dando
origine all'antico nucleo cittadino. A sostegno di questa tesi il fatto che a
Radicena dagli "Atti di visita
pastorale" emerge che esisteva una chiesa di San Basilio nel 1586 e
che dagli atti notarili di fine Seicento si incontra spesso la definizione
"quarterio di San Basilio".
La
derivazione di Radicena e Iatrìnoli da San Martino, invece, è dimostrata da
Domenico Valensise, storico polistenese, per il quale le genti fuggite da
Taureana decisero di stanziarsi nelle zone oltre il fiume
Metauros, dove costruirono un casale a cui diedero il nome di San Martino
(noto per la Sua divina protezione). Molti vi rimasero, altri proseguirono
andando a popolare le zone circostanti, fissandosi in piccoli nuclei abitativi,
tra cui Radicena e Iatrinoli, facenti però sempre capo a San Martino che
divenne il più importante centro civile e religioso della Piana, sede di chiese
e conventi e munito di un Castello. Quest'ultimo mantenne una posizione di
grandezza, di progresso e di tranquillità fino alla discesa dei Normanni.
Nel 1058 Ruggiero
d'Altavilla saccheggiò e devastò San Martino e l'anno successivo
nel 1059 represse
presso la cittadina le ultime resistenze delle fiere genti di questa parte di
Calabria, che furono costrette a riconoscere i Normanni come loro feudatari. San
Martino perse la sua importanza, in particolare, quando dall'altra parte del
torrente Marro sorse un altro borgo che i profughi di Taureana chiamarono con il
nome della loro patria, "Tauriana Nova" poi "Terranova". La
località, ritenuta dai Normanni più sicura, fu promossa a Contea e
successivamente a Ducato. Così Radicena, Iatrinoli e San Martino ne diventarono
casali seguendone le sorti.
Dopo
il dominio feudale dei Laurìa, vi fu quello dei Sanseverino, dei Sant'Angelo,
dei Caracciolo, dei de Cordoba, dei De Marini e dei Grimaldi.
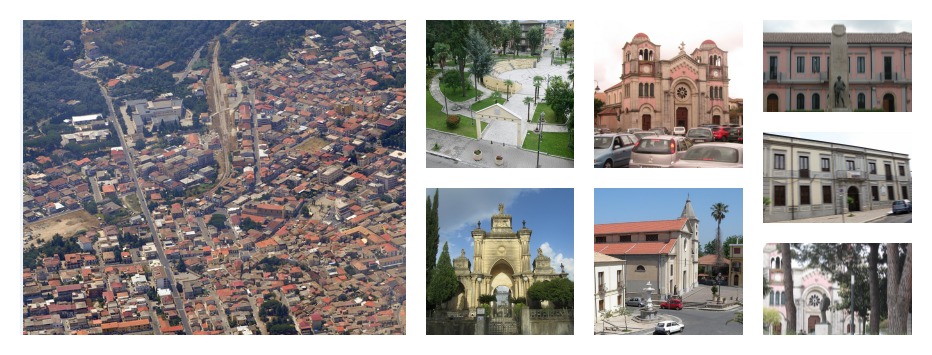
Furono
sottoposti a vari feudatari, tra cui il più lungo fu il dominio feudale dei
Lauria, venendo poi acquistati dalla famiglia
Grimaldi di Gerace nel 1574. Nel corso del Cinquecento risulta dagli
atti notarili che a Radicena e Iatrìnoli abbondavano le coltivazioni di grano e
di gelseti,
quest'ultima era l'unica pianta che producesse una rendita perpetua, e
importante era anche l'allevamento dei cavalli e dei bovini.
Nel
corso del Seicento, nonostante le difficoltà del banditismo e
della carenza delle vie di comunicazione, molte famiglie si spostarono
principalmente dal nord e dal centro Italia e andarono ad abitare nei due
casali. Si trovano così cognomi nuovi come gli Zerbi, di origine ligure, i
Sofia, da Santa
Margherita Ligure, i Loschiavo, dalla Campania.
S'intrecciarono matrimoni con altre famiglie illustri del luogo e dei paesi
vicini: Contestabile residenti a Stilo,
De Leonardis di Gerace,
Luvarà di Terranova. Alla fine del Seicento si collocarono altre famiglie al
centro degli interessi economici della zona: Drago, di origine greca, e Ganini,
con questi ultimi che si distinsero in particolare a Iatrìnoli. Nei due casali
esistevano notevoli coltivazioni di grano, lino, oliveti e vigne e
molti erano i benestanti, tra cui le famiglie già menzionate. Ai proprietari
privati si affiancava, da quanto si evince dagli atti notarili, anche il
Convento di Santa Maria della Misericordia dei Domenicani di
Radicena come il maggiore detentore di beni, infatti faceva compravendita con
privati, permutava e dava soldi in prestito.
Radicena, Jatrinoli e San
Martino furono anticamente delle contrade e casali sotto l'amministrazione
di Terranova
Sappo Minulio. Radicena risale almeno al 1050,
data di donazione della monaca Kometo, vedova di Giovanni, discendente da Elia
Erotikes, alla chiesa di Oppido
Mamertina.
Ai
primi del Settecento si verificò una crisi profonda dell'agricoltura, cardine
dell'economia, e molti subivano il carcere per non poter pagare le tasse e
vendevano tutto quello che possedevano per poter sostenere la propria famiglia.
La proprietà ecclesiastica era molto estesa nei due casali e le terre venivano
date a censo ai
grandi esponenti della nobiltà e della borghesia. Il terremoto
del 5 febbraio del 1783 distrusse completamente sia Terranova che
San Martino, mentre a Radicena e Iatrìnoli si provocarono danni non ingenti:
venne distrutta la Chiesa di Santa Maria della Misericordia o del Rosario, la
torre dei Gemelli annessa alla Chiesa matrice di Radicena. Le chiese e gli
edifici importanti distrutti o danneggiati vennero ricostruiti in forme barocche
e neoclassiche. Dalle statistiche emerge che a Radicena ci furono 756 morti e a
Iatrìnoli 312. Costituita la Cassa
sacra, all'indomani del terremoto, Radicena fece parte del Comprensorio D
(assieme ad Anoia, Laureana, Oppido, Polistena, San
Giorgio Morgeto, Seminara e
Terranova) e il suo distretto comprendeva, oltre alla città, Iatrìnoli, San
Martino e Vatoni. Ma la trasformazione sociale, subentrata dopo il terremoto,
non mutò la condizione delle plebi rurali che sentivano sempre più il peso del
proprietario borghese, col minuscolo pezzo di terra gravato di censo bollare
(contratto con cui veniva data in prestito una somma di denaro dietro garanzia,
che veniva restituita dal richiedente con gli interessi). Per questo stato di
cose dilagava il brigantaggio. Nel periodo dell'istituzione della Repubblica
Partenopea, molti sanfedisti,
fautori dei Borboni,
approfittarono al passaggio del cardinale Ruffo per
diffondere disordine. A Radicena seminavano disordine due bande di malfattori:
una ad opera di Domenico Moretti e l'altra capeggiata da Domenico Sicari,
responsabili di molti delitti compiuti nei paesi vicini.
In
particolare, tra il XI e
il XIII secolo,
la frazione di San
Martino ebbe un ruolo protagonista, tanto da dare anch'essa il nome
alla stessa Piana,
per un certo periodo. San
Martino ospitò diversi nobili e sovrani, oltre che il pontefice Onorio
IV. Ruggiero il Normanno vi celebrò qui il proprio matrimonio. La
frazione Amato invece, fu fondata nei primi decenni del XIX
secolo, su iniziativa del marchese Gagliardi, allora totale possidente
dell'intera Piana.
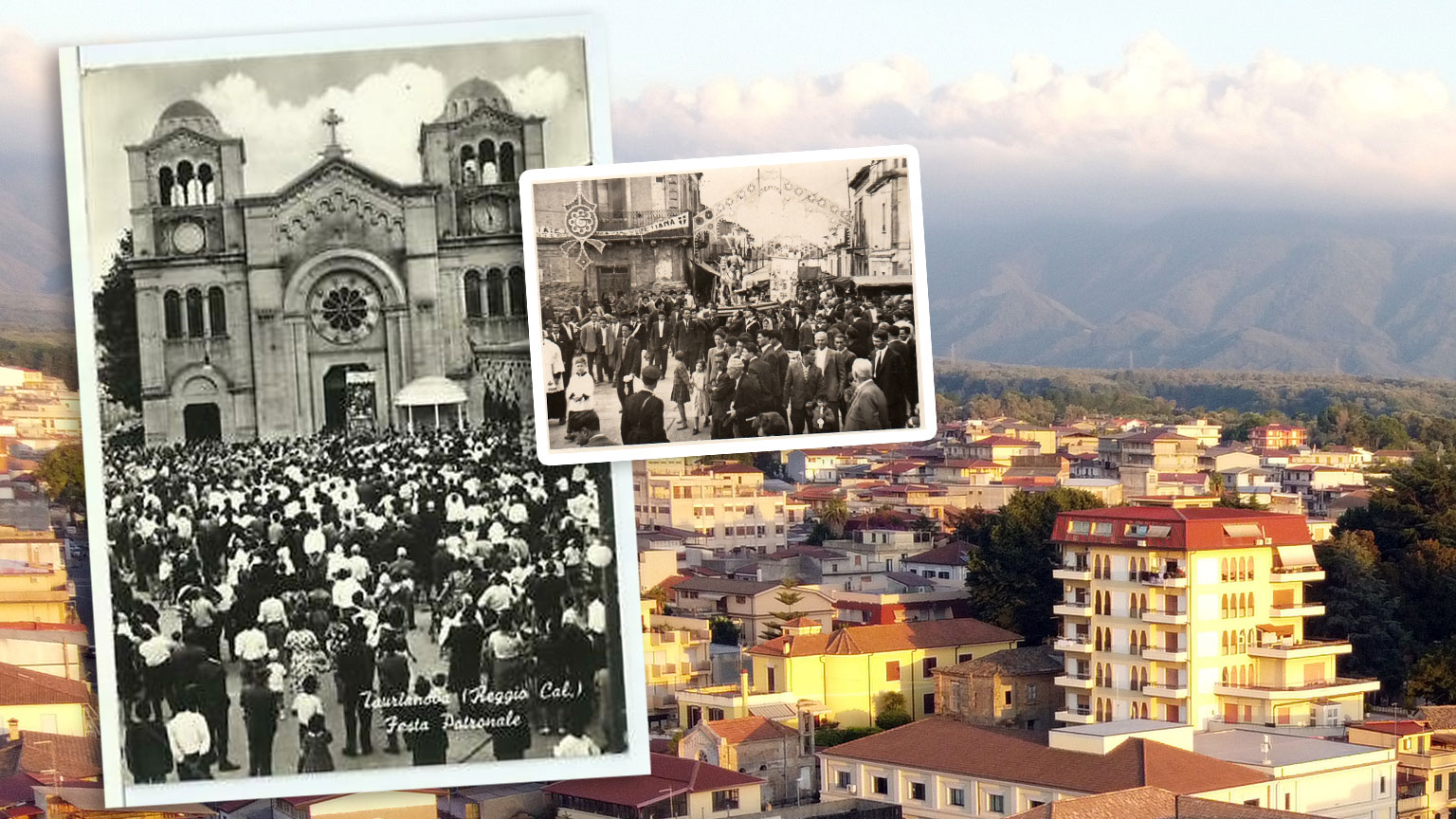
Con
gli anni della ricostruzione post-terremoto
del 1783 e l'abolizione della feudalità nel 1806,
il breve periodo dell'Amministrazione Francese contribuì non poco a dare a
questa parte di Calabria una fisionomia diversa, e lasciarvi fermenti culturali
che lieviteranno idee e comportamenti nuovi. Si tratta di pochi provvedimenti
amministrativi che da soli non sono sufficienti a cambiare in maniera radicale
le sorti della zona, ma che tuttavia sono caratterizzate da un'inusuale sintesi
politica i cui effetti segneranno profondamente la coscienza civile e il
pensiero politico di una collettività fino ad allora relegata nel limbo del
vassallaggio più servile. Per la prima volta, forse, si può parlare di storia,
intesa nel senso nobile della parola, perché per la prima volta si avverte la
presenza attiva di uno Stato che, eliminato il padrone e la sua ingordigia,
ridimensionato il censo alla Chiesa e l'egoismo della borghesia, guarda alla
collettività e ne riconosce i meriti e le necessità. Radicena e Iatrìnoli con
l'ordinamento amministrativo disposto dai Francesi per la legge 19 gennaio 1807,
diventarono Università nel
cosiddetto Governo di Casalnuovo (oggi Cittanova).
Nel 1815 fu
istituito il Distretto
di Palmi che comprendeva 35 comuni tra cui le due cittadine di
Radicena e Iatrìnoli. I comuni erano governati da sindaci, dai decurioni,
dal capourbano, dal sottocapourbano, dal conciliatore e dal supplente
giudiziario. Durante il ricostituito governo borbonico furono emanate per
Radicena diverse ordinanze come l'autorizzazione di un mercato nel sabato di
ciascuna settimana e la fiera di Sant'Orsola che
si celebrava dal precedente giovedì fino all'ultima domenica di settembre e
proseguiva per otto giorni. Era molto rinomata e conosciuta per tutte le
province del Regno.
Il
primo gennaio 1842 il
Circondario di Casalnuovo fu diviso in due circondari distinti: l'uno formato da
Casalnuovo, l'altro si compose del comune di Radicena, che fu capoluogo, del
comune di Iatrìnoli e dei villaggi di San
Martino e Terranova. Molti furono i liberali che lottarono contro il
governo borbonico. Tra i più importanti ricordiamo: Girolamo Zerbi e Antonio
Fera, medico chirurgo. Il primo partecipò a tutti i movimenti insurrezionali e
soprattutto a quello del 2
settembre 1847. Fu arrestato e processato il 23 aprile 1851 e
condannato a morte. La condanna venne commutata in 24 anni di carcere; ma solo
dopo sette anni di tormentosa prigionia, morì. Antonio Fera cominciò a
congiurare insieme agli altri patrioti reggini il 27 agosto del 1847,
riunitosi nel palazzo di Casimiro de Lieto, e per questo fu condannato
all'ergastolo. Molte sono le testimonianze e lettere autografe del suo coraggio
e della sua abnegazione patriottica. Dopo l'unità d'Italia nelle campagne di
Radicena e Iatrìnoli abbondavano la raccolta del lino e degli agrumeti.
Il
9 settembre 1894 avvenne
il miracolo di "Maria Santissima della Montagna", patrona di Radicena.
Verso mezzanotte, come riferisce su "Pro Fide" di quell'anno lo
scrittore taurianovese Francesco Sofia Moretti: "La luna pallida,
spettatrice agli umani eventi, questa volta fu attraversata da due raggi di
luce, come il gran segno di Costantino - due enormi fasci luminosi che
incrociano sul petto del gran disco; e quasi indescrivibile è questa volta lo
spettacolo di una Croce formatasi improvvisamente". Agli albori del
Novecento Radicena era un importante centro agricolo e commerciale, capoluogo di mandamento e
quindi sede di uffici governativi, quali la Pretura,
l'agenzia delle Imposte, l'Ufficio del Registro, la Caserma dei Carabinieri,
oltre che un distaccamento del ventesimo Reggimento Fanteria per la guardia
delle Carceri, di una Banca Agricolo-Industriale, di un teatro di prosa; mentre
a Iatrinoli veniva inaugurato l'ospedale Principessa di Piemonte, sorto per
opera dei lasciti di alcuni esponenti delle famiglie benestanti.
Il terremoto
del 1908 provocò lievi danni a Radicena e Iatrinoli: il crollo
della cupola della Chiesa matrice di Iatrinoli e del campanile di Radicena.
Questo, che ha dato adito alle voci di Miracolo operato dalla Patrona di
Radicena “Maria Ss.ma della Montagna” che avrebbe concesso la sua protezione
ai due comuni. Con regio decreto del 16 febbraio 1928 Radicena,
Iatrìnoli e Terranova
Sappo Minulio (che dal 1946 ritornò ad essere comune autonomo)
formarono il Comune di Taurianova. Durante la seconda
guerra mondiale Taurianova ospitava gli uffici provinciali della Rai e
l'ufficio zootecnico, sfollati da Reggio, e divenne anche sede del Comando della 104ª
Divisione fanteria "Mantova" e della 7ª
Divisione fanteria "Lupi di Toscana". Nella sua immediata
periferia s'installò un deposito per l'approvvigionamento di un'intera armata e
di una polveriera; nelle vicinanze s'accampò una grossa divisione tedesca Panzergrenadier.
Tra
il 1989 ed
il 1991 Taurianova
è stata teatro di una violentissima
faida di 'ndrangheta che
ha causato la morte di oltre trenta persone. A seguito delle violenze mafiose
l'allora Governo
Andreotti VII approvò un decreto
legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali, una risposta
forte alla violenza e prepotenza dei mafiosi che specie nei piccoli centri
comprime significativamente la democrazia. Sul territorio di Taurianova sono
attive alcune 'ndrine che
gestiscono le attività illecite e si sono infiltrate anche nell'economia
legale, l'ambito politico-amministrativo non è immune da tali penetrazioni
tanto che il consiglio comunale della cittadina è stato sciolto per
infiltrazioni mafiosetre volte: la prima nel 1991 (il
primo comune ad essere sciolto per tale motivo in Italia proprio con il
cosiddetto decreto Taurianova poi convertito in legge), la seconda nel 2009 e
la terza nel 2013.
Monumenti
e luoghi d'interesse
Il
comune di Taurianova nasce ufficialmente nel 1928 dall'unione di tre piccoli
borghi preesistenti: Terranova Sappo Minulio, Radicena, Jatrinoli e
l'assegnazione di una serie di frazioni e contrade tra le quali San
Martino, Amato, Pegara e Scroforio.
Secondo
la tradizione storica tutti questi centri abitati sarebbero stati fondati dai
profughi dell'antica città costiera di Tauriana distrutta dai Saraceni nel X
secolo d.C. In modo particolare fra questi va ricordata la frazione San Martino,
che nel medioevo dava il nome a tutta l’attuale piana di Gioia
Tauro, denominata Plana Sancti Martini e nel corso dei secoli XI, XII
e XIII, rivestì un ruolo importante per tutta la Calabria in campo politico e
religioso. Infatti, qui Ruggero il Normanno celebrò il proprio
matrimonio con Giuditta di Gautmesmil, nel castello del quale oggi resta
soltanto qualche rudere, elevandola a contea, al pari di Gerace, Mammola, Oppido, San
Giorgio.
Luoghi
religiosi

Santa
Maria delle Grazie - Il Duomo di Radicena, ora rione del nuovo comune di
Taurianova, è situato in Piazza Macrì (un tempo intitolata a Re Umberto I).
L'edificio è in stile romanico, con influenze gotiche e moresche. La chiesa
originaria, in cui veniva venerata Santa Maria Ambasiade, venne distrutta dal
terremoto del 1736, ricostruita e consacrata da Monsignor Carafa il 4 giugno
1737.
 Il
culto per Maria Santissima della Montagna a Radicena ebbe inizio nel 1763,
sostenuto dall'Arciprete don Domenico Antonio Zerbi, devotissimo fin dalla più
tenera età alla Vergine di Polsi, allorquando nell'anno 1757 ancora sacerdote a
Capistrano, un suo nipote si aggravò gravemente e trovandosi sul punto di
morire don Zerbi gli pose sul capo un'immaginetta della Verginella del Sacro
Monte e l'ammalato istantaneamente guarì. Fu allora che per devozione,
l'Arciprete acquistò una grande immagine scolpita in legno, rivestita di un
vestito in seta e ne dotò la chiesa. Nel 1783 un ulteriore crollo provocò la
caduta della torre dei Gemelli, annessa alla chiesa, distrutta poi dal terremoto
del 1908. I lavori per la costruzione di una nuova chiesa terminarono il 5
ottobre 1929 e vennero effettuati a cura dell'architetto Vittorio Paron. Il
culto per Maria Santissima della Montagna a Radicena ebbe inizio nel 1763,
sostenuto dall'Arciprete don Domenico Antonio Zerbi, devotissimo fin dalla più
tenera età alla Vergine di Polsi, allorquando nell'anno 1757 ancora sacerdote a
Capistrano, un suo nipote si aggravò gravemente e trovandosi sul punto di
morire don Zerbi gli pose sul capo un'immaginetta della Verginella del Sacro
Monte e l'ammalato istantaneamente guarì. Fu allora che per devozione,
l'Arciprete acquistò una grande immagine scolpita in legno, rivestita di un
vestito in seta e ne dotò la chiesa. Nel 1783 un ulteriore crollo provocò la
caduta della torre dei Gemelli, annessa alla chiesa, distrutta poi dal terremoto
del 1908. I lavori per la costruzione di una nuova chiesa terminarono il 5
ottobre 1929 e vennero effettuati a cura dell'architetto Vittorio Paron.
 L'imponente
facciata è decorata con arcatelle e un rosone ed è fiancheggiata da due torri
campanarie, che la superano in altezza e che ricevano luce da alcune trifore.
Nella torre di destra è installato, al centro del quadrante, un grande
orologio. Delle tre campane, già appartenenti al Monastero di Santa Caterina di
Terranova, la maggiore è opera di Jacopo Musurra, fonditore siciliano del sec.
XVI. L'interno è a tre navate e una balaustra in marmo bianco divide la navata
centrale dal presbiterio, dove è collocato l'altare maggiore. Ad uno dei
pilastri che separa la navata centrale dalla laterale è addossato un pulpito
ligneo. L'altare maggiore è in marmo e su di esso è posta l'attuale statua
della Vergine della Montagna, donata in segno di voto nell'anno 1787 dal sig.
Vincenzo Sofia, allorché la figlia ammalatasi gravemente, il povero padre, si
rivolse fiducioso alla Vergine, alla quale promise, a grazia ottenuta, che
avrebbe offerto alla chiesa una statua d'argento raffigurante la Madonna stessa.
Nonostante la giovinetta morisse, il Sofia volle egualmente sciogliere il voto,
almeno in parte, e fece scolpire nel legno, anziché modellare in argento, le
sembianze della Vergine d'Aspromonte, da artisti napoletani della seconda metà
del secolo XVIII. La statua venne successivamente collocata al posto
dell'immagine antica che è ora custodita dai Padri Cappuccini presso il locale
Convento Francescano. Nel 1994 Maria Santissima della Montagna è stata
incoronata Regina di Taurianova. L'imponente
facciata è decorata con arcatelle e un rosone ed è fiancheggiata da due torri
campanarie, che la superano in altezza e che ricevano luce da alcune trifore.
Nella torre di destra è installato, al centro del quadrante, un grande
orologio. Delle tre campane, già appartenenti al Monastero di Santa Caterina di
Terranova, la maggiore è opera di Jacopo Musurra, fonditore siciliano del sec.
XVI. L'interno è a tre navate e una balaustra in marmo bianco divide la navata
centrale dal presbiterio, dove è collocato l'altare maggiore. Ad uno dei
pilastri che separa la navata centrale dalla laterale è addossato un pulpito
ligneo. L'altare maggiore è in marmo e su di esso è posta l'attuale statua
della Vergine della Montagna, donata in segno di voto nell'anno 1787 dal sig.
Vincenzo Sofia, allorché la figlia ammalatasi gravemente, il povero padre, si
rivolse fiducioso alla Vergine, alla quale promise, a grazia ottenuta, che
avrebbe offerto alla chiesa una statua d'argento raffigurante la Madonna stessa.
Nonostante la giovinetta morisse, il Sofia volle egualmente sciogliere il voto,
almeno in parte, e fece scolpire nel legno, anziché modellare in argento, le
sembianze della Vergine d'Aspromonte, da artisti napoletani della seconda metà
del secolo XVIII. La statua venne successivamente collocata al posto
dell'immagine antica che è ora custodita dai Padri Cappuccini presso il locale
Convento Francescano. Nel 1994 Maria Santissima della Montagna è stata
incoronata Regina di Taurianova.
Opere
di rilievo: Pulpito ligneo, Altare in marmo del Sacro Cuore di Gesù con fregio
realizzato da Vincenzo
Romeo, Altare centrale in marmo.
CHIESA
DEL ROSARIO - La
chiesa, anticamente dedicata a San
Basilio, ospitò nel 1535 l'imperatore Carlo
V d'Asburgo e venne concessa dal popolo, insieme con alcuni orti, al
Convento dei Domenicani di Radicena fondato
il 12 marzo 1537 da
P. Niccolò Severino.
Nel
corso del Seicento i Domenicani ingrandirono la chiesa e la dedicarono a Santa
Maria della Misericordia, mentre all'interno del Convento nel 1604 si
era formata la Confraternita di Sant'Orsola che
organizzava nel mese di settembre, in occasione della Festa della Santa Reliquia
della vergine, una grande fiera molto importante dal punto di vista economico e
commerciale.
Anticamente
la chiesa ospitava la cappella di Sant'Orsola e quella del Sacro Cuore di Gesù
e nel 1757 venne
edificata quella dedicata a Vincenzo
Ferreri; nel 1783 l'edificio
religioso venne danneggiato da un grave terremoto e ricostruito, con l'aiuto
dello Stato, nel 1803, come riportato nell'iscrizione sul portale della chiesa
" Templum Misericordiae Matri dicatum funditus cecidit terra trementi
A.D. 1783 at Deo Propitio Magnificentibus resurrexit A. 1803 Vitae Portam Deus O
Quaerntibus Istam".
 Il
7 agosto 1809,
dopo questa data al suo interno nel 1818 FORTUNATO MORANO da Polistena vi lavorò
abellendola di Stucchi e di altari mentre Emanuele Paparo eseguì dei dipinti in
seguito secondo la disposizione di Gioacchino
Murat, il Convento e la chiesa vennero chiusi al culto, ma al momento
della soppressione i monaci avevano già abbandonato la struttura, e resto
chiusa per moltissimni anni. Il
7 agosto 1809,
dopo questa data al suo interno nel 1818 FORTUNATO MORANO da Polistena vi lavorò
abellendola di Stucchi e di altari mentre Emanuele Paparo eseguì dei dipinti in
seguito secondo la disposizione di Gioacchino
Murat, il Convento e la chiesa vennero chiusi al culto, ma al momento
della soppressione i monaci avevano già abbandonato la struttura, e resto
chiusa per moltissimni anni.
La
chiesa, in seguito intitolata al Santissimo Rosario, venne nuovamente
danneggiata dal Terremoto
di Messina del 1908, ma presto restaurata; nel 1986.
Prima di questa data unica volta che trovai la porta aperta in essa ancora si
conservavano gli stucchi gli altari ed un quadro sistemato in alto all'altare
maggiore pitturato in olio. In seguito fu nuovamente chiusa per il rovinoso
crollo del tetto che però venne ricostruito. In atto (2015) la Chiesa è in
fase finale di restauro, soprattutto per quel che riguarda alcuni altari
laterali e il pavimento (danneggiati dal crollo del tetto sopracitato); inoltre
non è aperta al culto, ma è comunque consacrata e viene utilizzata per
svariate iniziative religiose e culturali.
La
chiesa è di gusto settecentesco, con linee neoclassiche e alcuni elementi
ispirati al barocco. La facciata è dominata da un portale in tufo fiancheggiato
da due colonne con capitelli corinzi e sormontato da una cimasa al centro della
quale, in una lastra marmorea, è raffigurato lo stemma dei Domenicani ed è
riportata la data della ricostruzione della chiesa. Al di sopra del portale,
invece dell'usuale rosone, è presente una grande finestra rettangolare con
fastigio decorato da un volto di angelo e le sue ali.
La
navata unica è di forma rettangolare e termine con l'abside e l'altare centrale
realizzato in marmi e stucchi colorati, al centro di esso si apre una nicchia in
cui è posta una piccola scultura della Madonna di Pompei. L'altare centrale è
sormontato dalla tela dell'Annunciazione, mentre subito dopo la chiusura al
culto degli ignoti hanno trafugato due grandi tele che fiancheggiavano l'altare
maggiore raffiguranti una il Giudizio e l'altra San
Gaetano; venne anche rubata una statua in marmo raffigurante Pietro
apostolo posta sull'architrave che collega l'altare alla parete.
Lungo
il lato destro della chiesa si trovano: l'altare di Francesco
da Paola, l'altare della Madonna
del Carmine realizzato in marmo e stucco da Michele Barillari agli
inizi del 1800; l'altare di Santa
Rita; un medaglione in marmo del 1500 raffigurante la Vergine avvolta in
un abbondante panneggio che tiene in braccio Gesù Cristo bambino completamente
nudo, le figure sono sormontante da quattro teste di cherubini. L'opera è
attribuita a Girolamo
Santacroce.
Lungo
il lato sinistro della Chiesa si trovano: l'altare del Cristo Risorto che ospita
una statua in legno alta 1.30 m. e realizzata nel corso dell'800; l'altare di San
Domenico; l'altare di San
Giovanni Evangelista che ospita una statua in legno realizzata nel
1700, un confessionale in legno con sopra il pulpito ed una nicchia in legno
sormontata da un medaglione in marmo.
Durante
i lavori di restauro della chiesa sono state ritrovate al di sotto del pavimento
delle ossa umane, probabilmente risalenti a monaci: sappiamo infatti che nei
pressi del Convento veniva regolarmente praticata la sepoltura.
Inoltre
al centro dell'edificio sono stati ritrovati alcune botole che conducevano sotto
terra: queste adesso sono protette da un vetro che permette di vedere la scala e
illuminate dall'interno.
La
chiesa, dalla fine del '900, viene raramente utilizzata per funzioni religiose
(eccezion fatta per i matrimoni), ma è invece molto sfruttata per iniziative di
tipo culturale quali concerti, convegni, presentazioni di libri, mostre
artistiche, degustazioni, premiazioni ed altre iniziative.
 CHIESA
DELL'IMMACOLATA (di Radicena) - La chiesa dell'Immacolata di Radicena, così
chiamata per distinguerla dall'omonima nel rione Jatrinoli venne
edificata al posto di quella del Ss. Sacramento, probabilmente nel corso del
1800. Qualificata come chiesa sussidiaria rientra nella parrocchia di
Maria Ss. delle Grazie ed è sita in Via Roma, nei pressi di Piazza
Concordia. CHIESA
DELL'IMMACOLATA (di Radicena) - La chiesa dell'Immacolata di Radicena, così
chiamata per distinguerla dall'omonima nel rione Jatrinoli venne
edificata al posto di quella del Ss. Sacramento, probabilmente nel corso del
1800. Qualificata come chiesa sussidiaria rientra nella parrocchia di
Maria Ss. delle Grazie ed è sita in Via Roma, nei pressi di Piazza
Concordia.
Nella
chiesa è contenuto un importante gruppo in marmo di Rinaldo Bonanno
raffigurante Maria con il braccio destro, armato di clava, alzato per difendere
Gesù in braccio a lei da un mostro;ai piedi della donna vi è un putto.
La
chiesa fu decorata in stucchi da Fortunato e Vincenzo Morani da Polistena nel
1898 che poi furono distrutti dal terremoto del 1908 per come afferma l'Arc.
Francesco Maria De Luca, nella monografia di Iatrinoli stampata nel 1922.
Opere
di rilievo: Gruppo marmoreo raffigurante la Madonna del Soccorso con il Bambino
in braccio (1587),
Lastra di ciborio scolpita a bassorilievo raffigurante angeli in
preghiera.
CHIESA
DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO - La chiesa matrice (duomo di jatrinoli)
sita nel rione Jatrinoli, anticamente era composta da tre navate con una copula
all'incrocio dei bracci. A seguito dei vari movimenti tellurici venne demolita
su ordine del Regio Genio Civile e vennero lasciati soltanto alcuni muri e i
pilastri della navata centrale.
Tra
le opere importanti si annovera una statua in marmo attribuita da alcuni
studiosi ad Antonello Gaggini, vissuto tra il 1400 ed il 1500, collocata in una
nicchia nella facciata principale della chiesa. Per permettere a tutti di
ammirare tale opera è stato progettato il ripristino di due cappelle interne
alla chiesa, dove sono stati collocati la statua in marmo e un antico crocifisso
ligneo.
Opere
di rilievo: Statua in marmo (1400-1500), Olio su tela "Sant'Antonio con
Bambino" (1600), Statua di san
Pietro, Statua di San
Paolo, Quadro di Nostra
Signora del Rosario, Crocifisso ligneo.

ALTRI
EDIFICI RELIGIOSI
Chiesa
di San Giuseppe (Radicena)
Chiesa
di San Nicola
Chiesa
di Santa Lucia
Chiesa
dell'Addolorata
Chiesa
di San Giuseppe (Jatrinoli)
Chiesa
dell'Immacolata (Jatrinoli)
Chiesa
del Sacro Cuore
di Gesù
Chiesa
di Maria Ss. della Colomba (San
Martino)
Chiesa
di San Pio X (Amato)
CIMITERO
MONUMENTALE DI RADICENA - Di grande rilievo artistico è uno dei due
cimiteri comunali, quello di Radicena, nei pressi della chiesa del Calvario.
L'ingresso monumentale è sormontato da tre angeli, uno collocato più in alto
rappresentato in piedi mentre suona una tromba, gli altri in due più in basso
sono leggermente piegati.
Tra
gli altri elementi decorativi ci sono numerose colonne dal capitello corinzio di
diverse dimensioni. All'interno del cimitero vi sono numerose opere di artisti
taurianovesi e cappelle riccamente decorate; vi è anche una piccola chiesa,
dove viene celebrata la messa il 2 novembre, e nel terzo ampliamento è stato
realizzato un altare. Nello stesso Cimitero si trova in altorilievo il "
Cristo che porta la Croce " realizzato da Francesco Jerace per la tomba
Ciano.

Palazzi
Nel comune di Taurianova
si trovano numerosi palazzi storici di grande bellezza, i quali si lasciano
ammirare in particolar modo per i loro portali. Alcuni rientrano tra le Dimore
storiche italiane
Poiché
Taurianova nasce nel 1928 dalla fusione di due centri abitati (Radicena e Jatrinoli),
i palazzi si trovano negli originali centri dei due comuni, generalmente lungo
le piazze o le vie principali (soprattutto lungo Via Roma).
VILLA
ZERBI - Il palazzo,
situato all'inizio di Via Roma, venne realizzato nel 1786 sulle
rovine di un casale cinquecentesco distrutto da un violento terremoto;
l'architetto dell'opera, commissionata dai baroni Calfapietra, fu Filippo
Frangipane.
La
facciata, realizzata da artisti provenienti da Siracusa che
utilizzarono una pietra della loro terra, è caratterizzata da un ampio portale
in granito grigio fiancheggiato da lesene e sormontato da un'ampia finestra,
mentre i balconi sono in ferro battuto e i loro sostegni sono decorati da volti
tutti diversi tra loro. La struttura è composta da un corpo centrale e due ali,
alle quali si accede grazie a due rampe di scale che si affacciano sul vasto
cortile; sul retro oltre un
antico arco si apre il giardino ispirato alle residenza nobiliari calabresi. Nel
giardino è possibile trovare una fontana in pietra, una vasca piscina e due
tronchi di ulivi secolari bruciati da un fulmine e modellati dalla natura come
due vere e proprie sculture.
Di
fronte all'edificio si trova la chiesa di San Nicola (in stile barocco e
neoclassico) di proprietà della stessa famiglia Zerbi.
Il
palazzo, restaurato più volte (l'ultima nel 2002 da
Natale Zerbi) rientra oggi tra le dimore storiche calabresi di particolare
interesse artistico-culturale. Utilizzato per ricevimenti durante tutto l'anno,
è spesso anche location di mostre d'arte ed altre iniziative culturali di
grande importanza, tanto da attirare l'attenzione del Corriere
della Sera, del TG1 (che
su Villa Zerbi ha realizzato un servizio) e della Gazzetta
del Sud (che ha
scritto un articolo sul palazzo taurianovese).
Tra
le iniziative più importanti ricordiamo la "Giornata Nazionale delle
Dimore storiche 2015" promossa dall'A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche
Italiane): sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 il palazzo ha ospitato
installazioni artistiche (quadri e opere in ceramica), esibizioni musicali e
degustazioni che hanno compreso l'assaggio dell'olio extravergine d'oliva
"Radicena" prodotto all'interno della stessa villa.


PALAZZO
CONTESTABILE - Il
palazzo, sito in Piazza Vittorio Emanuele II (la principale di Jatrinoli),
venne progettato nel corso del '700 da Carlo
Vanvitelli, figlio di Luigi,
i due architetti della Reggia
di Caserta.
I
lavori vennero commissionati da Pasquale Contestabile, originario di Stilo,
il quale sposò Giulia Sorbilli, nobile locale che possedeva un altro edificio
dove adesso sorge il nuovo palazzo; i lavori vennero portati a termine dal
figlio di Pasquale, Scipione. Durante il restauro iniziato nel 2002,
ad opera dell'architetto Luigi Giuseppe Massara di Cinquefrondi, e finalizzato a
proteggere e consolidare l'edificio è emerso che nel corso del Risorgimento i
proprietari, borbonici, fecero aggiungere delle feritoie per controllare gli
accessi, inoltre era stata disposta una botola per un'eventuale fuga.
Il
palazzo, dalla superficie di 2700 m² con l'aggiunta di 800 m² di giardino, è
diviso in tre corpi comunicanti: il principale ( a tre piani) dà sulla piazza;
vi si accede tramite un ampio portale sul quale è inserito lo stemma della
Famiglia Contestabile, raffigurante dei monti (simbolo dei feudi della
famiglia), dei gradi militari, l'aquila bicipite (simbolo della famiglia
Grimaldi) e i tre moretti (simbolo della famiglia del Capitano Filippo Moretti).
Superato il portone si accede alla corte interna dai lastroni in granito, su cui
si affacciano i locali delle antiche scuderie e rimesse per carrozze. Da qui,
attraverso la scala principale, si accede al piano nobile, dove numerosi
ambienti sono riccamente decorati con stucchi e mobilio di diversi colori,
ripresi anche dai lampadari in vetro
di Murano e nei
pavimenti realizzati da artisti siciliani. All'interno
dell'edificio è presente una cappella privata.
Questo
palazzo, riportato allo splendore originario, viene oggi utilizzato per mostre
artistiche ed altre esposizioni; tra le iniziative più importanti vi sono le
"Giornate FAI di primavera", organizzate dal Fondo
Ambiente Italiano nel
2011, durante le quali gli alunni di un istituto superiore taurianovese hanno
accompagnato i visitatori giunti per la visita al palazzo.

ALTRI
PALAZZI - Nel
patrimonio della città sono inclusi numerosi altri palazzi, alcuni dei quali
versano in grave stato di abbandono, mentre altri sono tenuti in condizioni
migliori; tra questi ultimi i principali sono:
Palazzo
Lo Schiavo (Via Senatore Lo Schiavo): venne realizzato tra il 1850 ed il
1870 da Domenico Genoese Zerbi, ospita oggi la Caserma dei Carabinieri di Taurianova;
Palazzo
De Leonardis (Vico de Leonardis-Via Roma): venne realizzato agli inizi del
1800 da Raffaele de Leonardis, ospita oggi alcune attività commerciali;
Ex
Palazzo Municipale di Radicena (via XX Settembre): è oggi sede della
Consulta delle Associazioni e della Società Civile di Taurianova,
dell'orchestra di fiati "Don Pietro Franco" e viene utilizzato per le
sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi;
Palazzo
Conti Pontalto (Via Galliano): venne realizzato intorno al 1850 dal senatore
Pasquale Loschiavo e dalla contessa Benilde Rossignani; oggi è sede di attività
commerciali;-
Palazzo
Pisani (Via Roma): venne realizzato da Vincenzo Zerbi nel 1830;
Palazzo
Municipale di Jatrinoli (Piazza della Libertà): oggi sede
del Comune di Taurianova.

Monumenti
Monumento
ai caduti di Radicena
Monumento
ai caduti di Jatrinoli
Monumento
ai carabinieri Vincenzo Caruso e Stefano Condello
Monumento
ad Antonino Fava
Monumento
a Giuseppe Macrì
Monumento
a Francesco Sofia Alessio
Monumento
a Giovanni Francesco Gemelli Careri
Fontana
monumentale di Jatrinoli - Singolare è la storia della fontana monumentale
locata in Piazza Vittorio Emanuele II, chiamata talvolta fontana De
cumis: l'opera in marmo venne inaugurata il 31 luglio 1853 e fu
realizzata dall'artista Michele Barillari, ma venne presto spostata dal lato
opposto della strada secondo alcuni per facilitare la viabilità, secondo altri
per permettere all'acqua di raggiungerla. Recentemente però la fontana è stata
restaurata e ricollocata nel sito originale.

Festeggiamenti
in onore di Maria Santissima della Montagna
I
festeggiamenti in onore della Patrona di Taurianova, Maria Santissima della
Montagna, hanno inizio il 29 agosto: in questa data si svolge infatti "u
'mbitu" ("l'invito"), un'antica tradizione taurianovese. Alla
fine di una celebrazione le autorità religiose, politiche e militari assistono
all'accensione dei "luppinazzi", ovvero steli secchi di piante di
lupini, nella piazza di fronte alla Chiesa Matrice per simboleggiare l'inizio
della novena e invitare i paesi vicini alla festa patronale del paese.
Anticamente era tradizione che il fuoco venisse acceso dal sindaco, infatti una
poesia recita "Ndavi l'onori ca davanti a chiazza, na vota a l'annu
aduma i luppinazza" e valeva come gesto di vicinanza da parte del
sindaco al popolo. Adesso accanto alla figura del sindaco c'è quella del
parroco del Duomo di Taurianova durante l'accensione, mentre in piazza e nelle
vie adiacenti giungono migliaia di persone, compresi migranti che tornano a
Taurianova per l'occasione.
Diversi
studiosi del folklore si sono interessati di questa manifestazione, andando a
cercare le sue origini tra il sacro ed il profano. Infatti il fuoco è spesso
utilizzato da Dio come mezzo di comunicazione con l'uomo, ma è anche un segno
che si ripete spesso nella cultura popolare con altri significati. Era anche il
modo migliore per invitare gli altri paesi alla festa, infatti in mancanza di
altri mezzi di comunicazione il fumo che si innalzava dal rogo e il chiarore da
esso provocato erano facilmente visibili ed efficaci.
Molte
leggende avvolgono questo rito, una riguarda la scelta di bruciare proprio
piante di lupini anziché parti di altri alberi di cui la zona è ricca. Si
racconta che Maria, per fuggire da Erode, si nascose con Gesù in un campo di
lupini secchi, che però fecero un rumore tale da attirare le guardie di Erode,
allora Maria maledisse questa pianta, infatti molto amara, e quindi i
taurianovesi la bruciano come segno di spregio e vendetta. La mattina del 29
giungono in Piazza Macrì carri trainati da buoi, bardati a festa e con l'icona
della Madonna al centro della fronte, carichi di "luppinazza"
(anticamente questi venivano offerti dai contadini delle zone vicine,
specialmente da Sambiase). Gli anziani in base alla direzione delle fiamme e
alla loro altezza formulavano ipotesi e supposizioni sull'andamento
dell'agricoltura e del commercio, mentre adesso rimane un'occasione di unione
per il popolo taurianovese e spesso è accompagnato da altre manifestazioni per
dare inizio ai festeggiamenti.
Con
"u 'mbitu" si
dà inizio alla novena, periodo di preparazione alla festa patronale che vede
impegnati i fedeli sia durante le celebrazioni che in altre manifestazioni. Per
esempio in questo periodo è usanza creare delle stelle votive illuminate con
l'immagine della Patrona di Taurianova, da appendere ai balconi delle case, e
ormai da alcuni anni si svolge anche un concorso che vede premiata la stella
votiva più bella. In questi giorni le vie del paese sono animate dalla "cerameda",
solitamente composta da quattro musicisti che suonano strumenti tipici della
zona.
La
festa in onore di Maria Santissima della Montagna ha il suo culmine religioso e
civile in tre giorni: 7, 8 e 9 settembre: l'8 si svolge la solenne processione
per le vie del paese, al termine di questi la statua viene fatta fermare davanti
all'ingresso del Duomo taurianovese, quasi come per assistere allo spettacolo
pirotecnico. Il 9 settembre invece avviene la rievocazione del miracolo. Secondo
la storia un benestante del luogo, Don Vincenzo Sofia, nel 1787 ordinò una
scultura in legno della Madonna ad un artigiano di Serra San Bruno con bottega a
Napoli. Durante il viaggio, la nave che trasportava la preziosa opera, si trovò
in una tempesta e i marinai cercarono di alleggerirla cercando di gettare il
carico in mare, ma ciò risultò impossibile e apparve una donna con le
sembianza di Maria che salvò la nave dalla sciagura. Arrivata a Taurianova si
sentì l'esigenza di venerare questa statua, e mentre una grande folla era
radunata in chiesa l'effigie iniziò a muovere i suoi occhi. Partì subito una
processione che venne interrotta da un altro avvenimento: apparve una croce
nella luna. Questo evento ci viene raccontato da diverse opere scritte, compresa
una poesia di un illustre taurianovese: il latinista Francesco Sofia
Alessio.
Il
16 novembre dello stesso anno Maria manifestò la sua vicinanza al popolo
Taurianovese salvando la cittadina dal terremoto che danneggiò gravemente gli
altri paesi vicini. Da allora in questi tre giorni moltissime persone vengono a
rendere omaggio alla sacra immagine della Madonna e la festa religiosa è
accompagnata da altre manifestazioni civili come l'esibizione di artisti, anche
noti a livello nazionale, sia di musica contemporanea che di musica tipica o di
complessi bandistici.
È
ormai tradizione che il 10 settembre, a festa terminata, al termine di una
celebrazione eucaristica il popolo si appresti a baciare il piede della Madonna
per poi riporre la statua nella nicchia posta sull'altare della Chiesa Matrice.

Fonte:
|