|
Vibo Valentia
è la più piccola provincia della Calabria e abbraccia un territorio che
comprende la costa tirrenica, la catena appenninica delle Serre e il vasto
comprensorio agricolo dell'altopiano del Poro. La città si chiama così dal 192
a.C., mentre il suo nome di antica colonia greca era Hipponion, tra le più
importanti colonie della Magna Grecia, che nel 182 a.C. divenne municipio romano
con il nome di Valentia.
Incastonato nel
cuore meridionale della Calabria, il territorio di Vibo Valentia sembra un
piccolo sperone allungato nel Tirreno. Le radici della città sono antichissime
e custodiscono uno scrigno di storia e cultura che alla bellezza selvaggia dei
luoghi unisce la profonda consapevolezza culturale del passato più antico.
Nel corso della
sua millenaria storia, Vibo Valentia ha avuto differenti nomi, che corrispondono
all'evoluzione della città nelle epoche storiche:
- Veip o Veipuna,
nome dell’insediamento osco;
- Weiponion dopo
la caduta del digamma, nome della polis greca, citata come Hipponion dalle
antiche fonti letterarie;
- Valentia-Vibo
Valentia-Vibonia, nome del municipio romano;
- Mons
Leonis-Monteleone, dal periodo svevo all'Unità
d'Italia;
- Monteleone di
Calabria, fino al 1928.

Al Neolitico,
risalgono tracce di un'intensa frequentazione dell'attuale Vibo Valentia
(strumenti del Neolitico sono venuti alla luce durante lo scavo della Necropoli
Occidentale di Hipponion, Orsi segnalava
altri rinvenimenti relativi a questo periodo vicino ai resti del tempio
dorico in località Belvedere Telegrafo e nel tratto delle mura
greche di Hipponion in località Trappeto Vecchio, il Topa ricorda
vari ritrovamenti del Neolitico a Vibo, infine in recenti scavi presso via Romei
sono emerse significative tracce di questo periodo).
Tracce di
occupazione nell'Età
del bronzo e del ferro sono
state ritrovate durante lo scavo della Necropoli Occidentale, dell'area sacra in
località Scrimbia e nell'area sacra in via Romei. Il nome di questo primo
insediamento indigeno doveva essere Veip o Veipuna. Per avere uno sbocco
commerciale sul mar Tirreno ed evitare di fare il periplo della Calabria e
quindi attraversare lo stretto (sotto l'influenza di Rhegion),
nella seconda metà del VII secolo a.C. i greci di Locri
Epizefiri fondarono la sub-colonia con il nome di Hipponion.
Alla fine del
VI secolo a.C., la città sconfisse in battaglia Crotone con l'aiuto di Locri e
Medma: la notizia è riportata su uno scudo con incisa una dedica ritrovato a
Olimpia, è da sottolineare che Hipponion ricopre il primo posto
sull'incisione di certo per la principalità avuta nello scontro. Inizialmente
si era supposto che lo scudo fosse un trofeo della battaglia
della Sagra, ma la differente collocazione cronologica di questo evento
rispetto alla datazione dello scudo e il fatto che le fonti non riportino
Hipponion e Medma nella battaglia
della Sagra, mentre nella dedica Hipponion occupa il ruolo
principale, ha fatto cadere tale teoria. Lo scudo infatti è della fine del VI
secolo a.C., sembra riferibile piuttosto a una battaglia non ricordata dalle
fonti, inquadrabile probabilmente in un periodo di poco successivo allo scontro
fra Sibari e Crotone,
avvenuto nel 510 a.C.
Nel 422 a.C. Tucidide riporta
la notizia di uno scontro di Hipponiati e Medmei contro la propria madrepatria Locri
Epizefiri, inteso fino a poco tempo fa come una sorta di ribellione delle
sub-colonie contro Locri,
ma in realtà i ritrovamenti archeologici attestano che Hipponion dovette
essere autonoma fin dall'inizio: i ricchi doni votivi dell'area sacra in località
Scrimbia attestano infatti la presenza di una ricca classe aristocratica che
aveva il controllo della città sin dall'età arcaica, ciò fa comprendere come
l'organizzazione sociale di Locri fosse analoga a quella di Hipponion e
quindi non subordinata a quella della città madre.

Un altro segno
dell'indipendenza di Hipponion è
dato anche dallo scudo di Olimpia, dal quale si evince che fu Hipponion la
città che guidò una guerra contro Crotone e dallo stesso Tucidide che
definisce gli Hipponiati come "homoroi" (confinanti) dei Locresi.
Probabilmente
ci furono dei legami di tipo federale fra Locri, Hipponion e Medma secondo
il quale in caso di guerra una polis poteva
richiedere l'ausilio delle altre due, e forse per una richiesta troppo pesante
da parte dei Locresi in questa lega, originò nel 422 a.C., lo scontro.
Dell'esito del conflitto Tucidide non ci dà notizie, ma che sia stato
favorevole a Hipponiati e Medmei sembra certo dai successivi avvenimenti che
videro schierarsi Locri insieme a Dionisio
il Vecchio, tiranno di Siracusa.
All'inizio del IV secolo a.C., infatti, Dionisio si sposava con una donna
locrese e Locri darà supporto al tiranno nelle sue spedizioni in Italia.
Nel 393 a.C.,
il tiranno, una volta occupata Medma, deporta parte dei suoi abitanti a Messana e
lascia il territorio della città ai Locresi. Ciò spinse Hipponion, Rhegion, Kaulon, Kroton, Thurii, Velia e
una serie di centri minori, ad allearsi in vista della minaccia siracusana,
creando la cosiddetta Lega
Italiota, tuttavia nel 388 a.C. dopo la sconfitta degli Italioti a Kaulon
nella battaglia dell'Elleporo (389 a.C.), Dionisio conquisterà Hipponion e
deporterà parte degli abitanti a Siracusa, consegnandone il territorio ai
Locresi.
Nove anni dopo,
nel 379 a.C., i Cartaginesi libereranno
la città e la ripopoleranno con gli Hipponiati deportati da Dionisio e con
altri esuli a causa della tirannia. Nel 356 a.C. la nascita del popolo Brettio
causò non gravi problemi a Hipponion, che forse, seppure per un breve
periodo verrà occupata da questa popolazione Italica. Nel 340-331 a.C.
interverrà contro i Brettii Alessandro
il Molosso re dell'Epiro che
inizialmente riuscirà a liberare la greca Terina (città
a Nord di Hipponion) passata da alcuni anni sotto il controllo brettio e
conquistando le Brettie Pandosia e Cosenza,
dando sollievo a per un certo periodo a Hipponion.
Ma nel 331 a.C.
l'epirota morrà ucciso a tradimento vicino a Pandosia. Inizierà alla fine del
IV secolo a.C. la realizzazione di una nuova fase della cinta muraria,
dotata di torri circolari che dovevano richiedere un enorme spesa pubblica e la
presenza di manodopera specializzata. Nel 294 a.C. Agatocle,
Tiranno di Siracusa conquista Hipponion. Agatocle rese Hipponion uno
dei suoi principali centri per il controllo dei possedimenti in Italia: da Strabone sappiamo
che ne ingrandì il porto, le testimonianze archeologiche attestano il
rafforzamento delle mura che renderanno la città una vera e propria grande
roccaforte. Poco dopo la morte di Agatocle ci sarà lo scontro delle città
della Magna
Grecia con i Romani e l'intervento di Pirro.
Dopo la fine della guerra, Hipponion, come gli altri centri italioti e
Bruzi, passerà sotto il controllo dei Romani e verrà insediato un presidio
romano. Il controllo romano sarà assente durante la seconda
guerra punica, quando i Brettii passati dalla parte di Annibale se ne
impossesseranno.

Nel 192 a.C.,
pochi anni dopo la fine della II Guerra punica, i Romani dedurranno a Hipponion una
colonia a diritto latino chiamata Valentia, con diritto di zecca e varie
autonomie. Il nome Valentia (attestato sulle monete della colonia e
dall'epigrafe di Polla che ricorda la costruzione della via Popilia), in latino
significa forza, potenza militare, insieme al massiccio invio di coloni
superiore a tutti gli altri centri del Bruzio: 4.000 soldati, di sicuro con
donne e figli, fa comprendere come la capitale dell'Impero riconosceva
al centro tirrenico grande importanza strategica ed economica. Successivamente,
dall'89 a.C. quando divenne municipio, Vibo Valentia fu il nome utilizzato per
indicare la città (Strabone, Plinio il vecchio, ecc.).
La città
possedeva un ampio territorio: in epoca greca la sua chora (territorio
in greco) era confinante con quella di Locri Epizephiri. Secondo gli studi più
recenti il suo territorio doveva avere per confine a nord il torrente Lametos
(ora Amato),
a sud Nicotera e a est la catena montuosa delle Serre, a ovest il mar Tirreno;
in epoca romana il confine dell'ager Vibonensis (così come lo chiama Tito
Livio) si era spinto a sud poco più in giù del fiume Mesima (prendendo anche
il posto di Medma,
situata presso l'odierna Rosarno,
che da fiorente colonia greca era ormai scomparsa in epoca romana).
Durante il
periodo romano, la costruzione della Via
Popilia interessò la città che divenne un'importante stazione. Di
grande importanza per lo sviluppo della città fu anche il porto, i cui resti
sono in parte interrati e in parte sott'acqua fra la località Trainiti e Bivona
nel comune di Vibo Valentia. Parlando di Vibo, Strabone riferisce che essa
possedeva un epineion, ossia un porto che sorge a una certa distanza dalla
città da cui dipende, che sarebbe stato rafforzato da Agatocle tiranno
di Siracusa, dopo averlo conquistato nel 294 a.C. Durante l'epoca romana, il
porto divenne il principale scalo di partenza, sul Tirreno, del legname della Silva
Bruttia per la costruzione delle navi del potente esercito romano.
Grazie alla sua
importanza strategica e politica, Vibo ebbe l'onore di ospitare Giulio
Cesare, Ottaviano e Cicerone,
che la ricorda nelle sue lettere. Gaio Giulio Cesare aveva utilizzato il porto
della città, durante le guerre civili, per ospitare metà della sua flotta; lo
stesso Cesare descrive un episodio bellico avvenuto nei pressi del porto della
città. La flotta stanziata a Vibo riuscì a respingere un assalto dei
Pompeiani, guidati da Cassio Longino, distruggendo la nave dello stesso generale
nemico che dovette fuggire su una scialuppa per, poi, una volta raggiunto le
altre navi allontanarsi definitivamente dalle acque Vibonesi.
Ottaviano come
il suo padre
adottivo utilizzò il porto della città come base navale. Infatti,
nel 36 a.C., il futuro imperatore venne sconfitto e messo in fuga da Sesto
Pompeo (figlio del più famoso Gneo)
che si era impadronito della Sicilia,
così con la flotta duramente colpita dalla sconfitta si rifugiò nella fiorente
città tirrenica ove stabilì il suo quartier generale e visse per circa un
anno. Appiano nell'opera
sulle guerre civili descrive i vari spostamenti della flotta che aveva come base
principale Vibo Valentia.
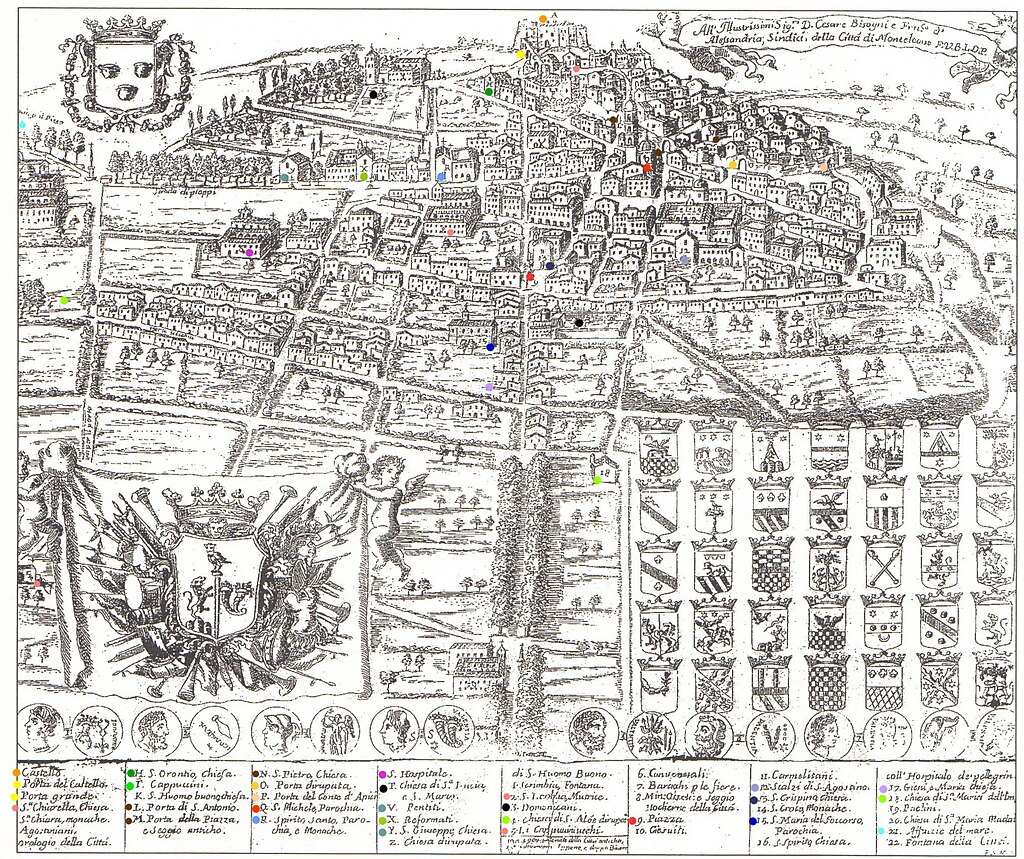
Quando Pompeo
venne definitivamente sconfitto, la città, che per l'importanza e la prosperità
raggiunta era stata scelta come territorio da assegnare ai veterani come
colonia, venne esonerata dal gravoso incarico insieme a Reggio per i meriti
ottenuti in questo frangente, mantenendo così illesa la sua fiorente
economia. Almeno a partire dal V secolo (ma probabilmente già un secolo prima)
diventa sede di una diocesi,
il nome nel tardo impero cambia in quello di Vibona
Dopo la fine
dell'impero romano i bizantini provvidero a fortificarla, ma i saraceni
l'attaccarono e saccheggiarono più volte. Ruggero
I di Sicilia pose nell'XI secolo i suoi accampamenti a Vibo e in
seguito trasferì la sede della diocesi, presente a Vibo fin dal V o IV secolo,
nella sua Mileto.
Sempre in questo periodo, Ruggero smantellò colonne e marmi degli antichi
edifici classici di Vibo Valentia per utilizzarli a Mileto nella
costruzione di altri edifici. Federico
II di Svevia passando dalla città, rimasto impressionato per la
bellezza e il potenziale strategico del luogo (Nicolai
de Jamsilla, De rebus gestis Federici II imperatoris), diede
l'incarico al "secreto" di Calabria, Matteo Marcofaba, di ricostruirla
e ripopolarla e da allora cambiò il nome in Monteleone.
In questo
periodo venne realizzata la prima fase del castello che per errore veniva
attribuita al periodo Normanno. Sotto gli Angioini la
città acquisì ancora più prestigio e prosperità, divenendo serie del vicario
reale. Sempre nello stesso periodo venne ulteriormente rafforzato e ingrandito
il castello e la cinta muraria medievale. In seguito fra il periodo Angioino e Aragonese,
divenne Feudo dei Caracciolo e poi comune demaniale.
 Nel 1501,
usurpando quelli che erano i diritti della città, venne affidata nuovamente
come feudo ai Pignatelli. Per questo scoppiò una rivolta per il quale dovette
intervenire il generale Lo Tufo del regno
di Napoli. Quest'ultimo non riuscendo a domarla, chiamò per discutere i
sette capi del popolo che vennero uccisi a tradimento. Qualche anno dopo, la
monteleonese Diana Recco che aveva perso un fratello e il padre nella rivolta,
uccise a pugnalate il generale Lo Tufo che stava partecipando alla cerimonia di
matrimonio di una delle figlie. In ogni caso i Pignatelli pensarono allo
sviluppo della città, creando filande, oleifici e favorendo molte attività
artigianali. Nel 1501,
usurpando quelli che erano i diritti della città, venne affidata nuovamente
come feudo ai Pignatelli. Per questo scoppiò una rivolta per il quale dovette
intervenire il generale Lo Tufo del regno
di Napoli. Quest'ultimo non riuscendo a domarla, chiamò per discutere i
sette capi del popolo che vennero uccisi a tradimento. Qualche anno dopo, la
monteleonese Diana Recco che aveva perso un fratello e il padre nella rivolta,
uccise a pugnalate il generale Lo Tufo che stava partecipando alla cerimonia di
matrimonio di una delle figlie. In ogni caso i Pignatelli pensarono allo
sviluppo della città, creando filande, oleifici e favorendo molte attività
artigianali.
Nel XVII
secolo, Monteleone è uno dei centri serici più
produttivi della regione. In questo periodo nella città si svolgeva un
importante mercato della seta che
aveva come destinazione Napoli o Cava
dei Tirreni.
Nell'Ottocento
i francesi la elevarono a capoluogo della Calabria
Ultra e da allora fino a pochi decenni addietro fiorirono tanti
mestieri, il cui ricordo è nel nome di strade (Via Forgiari, via Chitarrari,
via Argentaria, ecc.) e di istituzioni come il Real Collegio Vibonese (l'ancora
esistente Convitto Filangieri e il teatro Comunale, demolito negli anni
sessanta). Dopo il ritorno
dei Borbone la
città perse il ruolo di capoluogo e la sua importanza politica ed economica
venne ridimensionata.
Durante le
guerre per l'Unità
d'Italia, Garibaldi passò da Monteleone dove ottenne aiuti materiali e
finanziamenti da parte degli abitanti. Nel 1861,
dopo l'Unità d'Italia,
il nome della città venne cambiato in Monteleone di Calabria.
Sotto il
Fascismo, per opera di Luigi
Razza, giornalista, politico, deputato al Parlamento e Ministro dei
Lavori Pubblici, si avviò un grande rilancio nel campo dei lavori pubblici, in
cui spicca la costruzione del Palazzo del Municipio (finito di costruire nel
1935 e che, secondo il progetto iniziale, avrebbe dovuto accogliere, al termine,
la Prefettura della costituenda provincia) in stile razionalista.
Per iniziativa
dello stesso Razza, nel 1927 un regio decreto ispirato dal governo fascista che
diverrà effettivo il 13 gennaio 1928, ribattezzò la città da Monteleone di
Calabria a, secondo l'antica dizione latina, Vibo Valentia. La spinta edilizia
pubblica nella città ebbe un deciso arresto quando il ministro Razza scomparve
in un incidente aereo in Egitto nel
1935. La città ha successivamente voluto onorarne la memoria con una
statua bronzea, a figura intera, scolpita da Francesco
Longo nel 1938 e personalmente inaugurata da Benito Mussolini nel
1939 durante la sua visita alla città, la quale si erge in Piazza San Leoluca
su un alto piedistallo, sormontato da una stele recante in cima l'effigie
marmorea della Vittoria alata. Un'altra effigie gli è stata riservata nel
Palazzo del Municipio, a lui intitolato. A Luigi Razza la città ha inoltre
intitolato il proprio aeroporto militare, lo stadio, una piazza e una via del
centro storico.
Avvenimento più
importante degli ultimi anni, nel 1992, è stata la proclamazione dell'omonima
provincia, che in precedenza era compresa nella provincia
di Catanzaro.
Nel 1993, con
la realizzazione di un monumento, la città ha inteso onorare la memoria di un
suo abitante, Michele
Morelli, patriota e martire del risorgimento.
Nel corso degli
anni novanta, Vibo Valentia dedica una piazza e un busto bronzeo al poeta
Vincenzo Ammirà.
Il 3 luglio
2006 viene duramente colpita da un'alluvione, che provoca la morte di quattro
cittadini e ingenti danni economici all'industria, al turismo e ai beni dei
privati. I danni maggiori si registrano nelle località di Longobardi, Vibo
Marina e Bivona, investite da una grande quantità di acqua, fango e
detriti. Gli interventi di sistemazione sono stati affidati a una commissione
presieduta da Pasquale Versace, docente di Idrologia e Progettazione di Opere
Idrauliche all'Università
della Calabria.
Luoghi
d'interesse
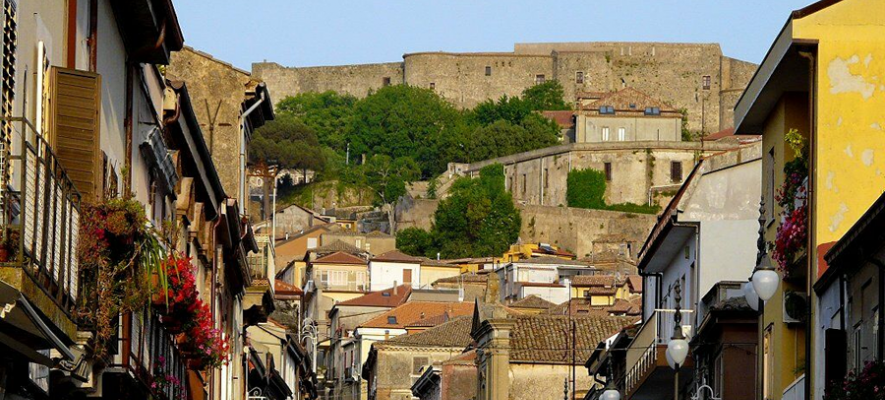
Le radici della
città sono antichissime e custodiscono uno scrigno di storia e cultura che alla
bellezza selvaggia dei luoghi unisce la profonda consapevolezza culturale del
passato più antico. Un patrimonio straordinario di bellezze naturali e
architettoniche, di storia, di cultura, di tradizioni popolari, che contribuisce
a fare della città un importante polo di attrazione e d'interesse per il
turismo nazionale e internazionale. L’architettura del centro urbano è
dominata dall'imponente castello normanno-svevo, oggi sede del Museo
archeologico intitolato a Vito Capialbi, illustre erudito vibonese, che
custodisce la Laminetta aurea, il più antico testo Orfico rinvenuto in Italia e
probabilmente uno dei reperti più preziosi provenienti dal passato ellenico. Il
centro storico conserva intatte le geometrie del borgo medievale, con i palazzi
monumentali in tufo giallo e lastricato con grossi blocchi di pietra lavica.
Il Vibonese
offre scorci di straordinaria intensità emotiva, ricco di paesaggi che
comprendono uliveti, i campi di grano, aranceti e limoneti, vigneti arroccati
sui fianchi delle colline e il profumo inebriante delle zagare in fiore nelle
calde notti estive. Spettacolare è la Costa degli Dei, frastagliata e ricca di
insenature rocciose alternate a spiagge morbide e sabbiose. La Costa degli Dei
è il regno degli sport acquatici, grazie alla possibilità di escursioni
subacquee che permettono di ammirare i bellissimi fondali e la fauna marina. Le
acque marine del vibonese e i suoi venti attraggono molti appassionati di
kitesurf e windsurf, che trovano su questo mare le condizioni ideali per
praticare questi sport.
L'entroterra
della provincia, con i folti boschi e le bellezze della natura, è una meta
ideale per chi ama praticare il trekking. Uno dei luoghi più rinomati è la
zona di Capo Vaticano, che nasconde una tipica fiumara calabrese circondata da
una vegetazione ricca e lussureggiante con oltre 300 specie di piante. Sono
molto belle da esplorare anche le grotte e i sentieri dei monaci nei pressi di
Tropea, dove è possibile anche sfruttare i percorsi per il trekking a cavallo o
in bicicletta. La varietà del paesaggio offre location uniche per osservare la
flora e la fauna e il profilo geologico tipico del patrimonio naturalistico
della zona, con particolare riferimento alla visita dei parchi e delle riserve
naturali. Molti esperti di birdwatching si recano nel vibonese in tutte le
stagioni dell’anno.
Vibo Valentia
rappresenta attualmente uno dei principali poli industriali della regione, con
aziende operanti nel settore alimentare, chimico, tessile e materiale da
costruzione. Rilevante è l'attività del porto che presenta un notevole
movimento di merci, e quella turistica, in forte espansione grazie ad una
lungimirante politica di rivalutazione del patrimonio costiero.

Numerose sono
le occasioni di meraviglia disseminate lungo il centro storico della città e
nel territorio circostante. Il centro storico di Vibo Valentia è un ricco
intreccio di chiese, monumenti ed edifici medievali, barocchi e ottocenteschi
dove è difficile distinguere dove finisce un'epoca e dove ne inizia un'altra e
questa è probabilmente la caratteristica in cui risiede il suo fascino.
Camminando lungo Corso Umberto I non si può non notare il bellissimo portale di
marmo di S. Maria La Nova, mentre dal Belvedere Grande si gode di un
ottimo panorama che abbraccia la costa tirrenica da Capo Palinuro a
Messina.
Il Duomo
di Vibo Valentia, dedicato al patrono S. Leoluca, è stato costruito a fine '600
sui resti di una chiesa bizantina e all'interno custodisce un altare imponente
con la statua della Madonna della Neve. La sua facciata è incorniciata tra due
campanili mentre sono da vedere le bellissime porte in bronzo che raccontano la
storia della città. Dell'antica chiesa, dove si vuole fosse custodito il
sepolcro di San Leoluca, rimangono alcune testimonianze architettoniche di
grande pregio. L'interno è a tre navate e comprende un altare maggiore
settecentesco con un gruppo in marmo di Carrara di A. Caccavello, una tavola del
‘500, Madonna della Sanità mentre di grande splendore è il transetto
sinistro con il suo trittico in marmo di Antonello Gagini.
Annesso al
Duomo è l'elegante e imponente Valentianum, ex convento domenicano
restaurato nel 1982. Le sue sale ospitano il Museo d'arte Sacra, dove si possono
ammirare importanti sculture provenienti dal Ciborio della Certosa di Serra San
Bruno, il sarcofago del patrizio Decio de Suriano, piviali e arredi sacri di
ottima fattura meridionale.
Interessanti da
visitare sono l'Arco Marzano e la Porta Torre del Conte d'Apice,
due porte del XII secolo tra i monumenti più antichi della città.
Vibo Valentia
è anche una città moderna e vale la pena fare una passeggiata lungo il Corso
Umberto I e immergersi in un’atmosfera attuale in mezzo a negozi e botteghe.
Scendendo verso il mare a Vibo Marina, si possono visitare il castello di
Bivona, nato come fortificazione contro le incursioni piratesche, e il
complesso architettonico della Tonnara del 1885.
Chiesa di Santa Maria
Maggiore e San Leoluca (Duomo)

Chiesa
di Santa Maria Maggiore e San Leoluca (Duomo):
La chiesa di Santa Maria Maggiore e San Leoluca è il principale luogo
di culto cattolico di Vibo
Valentia, situato a 497 metri s.l.m. nell'omonima Piazza San Leoluca.
Costruito sopra i resti di una più antica basilica danneggiata dai terremoti,
è decorato da numerosi e pregevoli stucchi barocchi e conserva importanti opere
d'arte, fra cui il trittico statuario di Antonello
Gagini, opera rinascimentale.
L'attuale
chiesa principale di Vibo Valentia sorge dove esisteva anticamente una
cattedrale bizantina probabilmente del IX
secolo, che venne fortemente danneggiata durante i terremoti del 1638 e 1659.
Resa ormai pericolante e inagibile, fu colta l'occasione per un rinnovo
definitivo, in termini di dimensioni e di gusto architettonico. Nel 1680 ebbero
inizio i lavori di costruzione della nuova chiesa su progetto di Francesco
Antonio Curatoli. Il progetto del Duomo nuovo era inizialmente più ampio, ma
venne in seguito ridimensionato su pressione dei vicini padri
domenicani per il fatto che il nuovo edificio, con la sua mole,
avrebbe oscurato la loro chiesa. Il cantiere si protrasse per una quarantina
d'anni e fu ultimato nel 1723,
a un anno dalla morte del suo progettista. Appena costruita, la chiesa
presentava al posto dell'attuale frontone una grande corona basilicale e vi era
anche una cupola con lanterna.
L'edificio venne consacrato nel 1766.
Nel 1783,
solamente diciassette anni dopo la consacrazione, un forte terremoto danneggiò
la struttura, lesionando la cupola, che venne abbattuta. L'interno fu restaurato
su progetto di Emanuele
Paparo. Detti lavori si svolsero nel 1817;
gli stucchi furono eseguiti dal pittore Fortunato
Morano, che seguì i disegni di Paparo. In casa Morani a Polistena
si conservano ancora disegni originali e capitelli in gesso. Anche la facciata
viene parzialmente ricostruita, donandole l'aspetto attuale.
Nell'Ottocento l'edificio
subì nuovi interventi: in particolare vennero aggiunti i vari affreschi neoclassici.


All'esterno, la
chiesa presenta una facciata moderatamente barocca,
un poco plastica e con vaghi accenni rinascimentali.
Sono presenti un corpo centrale, che costituisce la facciata vera e propria
della chiesa, e due campanili gemelli
laterali, che chiudono al loro interno il prospetto della chiesa. Facciata e
campanili sono collegati da un motivo unitario di lesene su
due ordini, quello inferiore tuscanico e
quello superiore ionico,
separati da un cornicione che, al centro, si piega verso l'alto seguendo i
profili del portale sottostante e della finestra al di sopra, evidenziando così
maggiormente la zona centrale e focale del prospetto. L'ordine superiore di
lesene sostiene un altro cornicione, sul quale si impostano il timpano triangolare
del corpo centrale e le celle campanarie dei due campanili, che proseguono verso
l'alto con un ulteriore ordine di lesene ioniche, chiuse in sommità da un
ultimo cornicione e da una copertura a cupola. Unici elementi plastici del corpo
centrale sono i vari fregi e le cornici che decorano il portale d'ingresso e il
finestrone superiore, mentre i due campanili, soprattutto grazie alle varie
nicchie presenti e alle relative cornici, sono caratterizzati da una maggiore
plasticità.
Internamente,
la chiesa è impostata su una pianta a croce
latina, con navata unica
e transetto.
Sull'intersezione fra quest'ultimo e la navata era presente la cupola, inserita
nel progetto originario e poi abbattuta dopo il terremoto del 1783.
L'imposta è ancora presente, così come parte del tamburo con
i finestroni circolari, ma a questo livello l'alzato si interrompe bruscamente
ad è concluso da una generica copertura a volta. Le pareti dell'aula sono
ritmate da lesene di ordine
corinzio, ornate da numerosi ed elaborati stucchi bianchi che ricoprono
anche la volta a
botte di copertura. Sono inoltre presenti quattro cappelle laterali,
due per lato.
La chiesa
custodisce al suo interno un maestoso altare
maggiore settecentesco in marmi policromi di notevole fattura. dal
quale emerge la statua rinascimentale della Madonna
della Neve. L'opera di maggior valore qui conservata nella Cappella del
Purgatorio resta però il celebre Trittico statuario rinascimentale di Antonello
Gagini, eseguito fra il 1523 e
il 1524 e
fatto trasportare all'interno della chiesa da Emanuele
Paparo nel 1810.
L'opera si trovava precedentemente nella chiesa di Santa Maria del Gesù, nota
anche come chiesa di Santa Maria la Nova. Il trittico è composto da una
ordinata cornice architettonica in marmo scuro con colonne corinzie, che
inquadra tre nicchie dove trovano posto, da sinistra a destra, le statue della Madonna
delle Grazie, di San
Giovanni Evangelista e di Santa
Maria Maddalena. Quest'ultima, in particolare, grazie al suo armonico
equilibrio delle parti è considerata un capolavoro della statica. Il
coronamento superiore del trittico, con affresco centrale e volute, è da
considerarsi aggiunta successiva. La chiesa è poi ornata da elaborati stucchi,
anch'essi opera settecentesca, e dai quadri di Emanuele
Paparo che si ispirano ad opere pittoriche di varie epoche.

Ai lati della Cappella
di San Basilio sono documentate la Vergine
con bambino e San
Luca Evangelista.
Giorgio
Vasari nelle sue cronache,
riferendosi all'artista Antonello
Gagini come "Antonio da Carrara" scultore rarissimo,
documenta le opere censite in Calabria, in particolare quelle commissionate da Ettore
Pignatelli, conte e duca di Monteleone, viceré
di Sicilia, custodite a Monteleone.
Nella fattispecie fa riferimento alle tre diverse raffigurazioni della Vergine
Maria: la Madonna delle Grazie, la Madonna della Neve, la Madonna
col bambino destinate in origine alla chiesa di Santa Maria del Gesù o
Santa Maria la Nova dell'Ordine
dei frati minori osservanti. Le commissioni sono state rielaborate in
corso d'opera, arricchendosi rispettivamente delle figure di San Giovanni
Evangelista e Santa Maria Maddalena, San Luca Evangelista, dando
luogo a tre distinti aggregati scultorei custoditi nel medesimo luogo di culto.
Sulla cantoria in controfacciata,
si trova l'organo a
canne Gaetano
Cavalli opus 413, costruito nel 1894.
Lo strumento è racchiuso all'interno di un'artistica cassa lignea dipinta e
scolpita in stile
barocco, che incornicia il finestrone della controfacciata.
La trasmissione è integralmente meccanica e la consolle, ha finestra, ha
un'unica tastiera di 58 note e pedaliera di
27 note.
Santuario
della Madonna della Salute (Chiesa di Santa Ruba)
Sorge a metà
strada fra Vibo e uno dei paesi satelliti della stessa (San Gregorio d'Ippona).
Considerata come il gioiello di San Gregorio d’Ippona, la chiesa di Santa
Ruba si trova tra il verde degli ulivi ed è stata elevata da poco a Santuario
Mariano Diocesano con il titolo di "Maria Santissima della
Salute". Non esistono notizie certe sul motivo della denominazione
"Santa Ruba”, anche perché nella tradizione locale non è mai esistito
il nome Ruba e quindi si pensa che tale nome sia dovuto al luogo impervio sulla
quale fu costruita la chiesa (una Rupe) e dove i monaci si ritiravano a pregare
quindi il nome originario sarebbe stato "Santa Rupa".
Di origini
antiche (venne costruita attorno all'anno 1000 sotto papa
Callisto II), presenta una cupola d'ispirazione orientale.
La struttura
della chiesa è formata da una costruzione a pianta simmetrica di chiesa rurale,
con abside semicircolare, coronata dalla cupola centrale ad ombrello eretto su
un tamburo cilindrico poligonale. La caratteristica principale di questa
struttura è proprio la cupola che si trova in corrispondenza dell’altare
maggiore e da dove si nota il sovrapporsi di strati di tegole in cerchi
concentrici. Le numerose trasformazioni e adattamenti di cui sono rintracciabili
numerose applicazioni di sovrastrutture barocche hanno fatto si che venisse
modificato lo stile originario della chiesa. All’esterno è possibile vedere
un ornamento di lesene con meandro superiore a linee spezzate che ha come
cornice una merlatura a scopo decorativo.

Si dice che
inizialmente questa chiesetta era stata costruita dai monaci basiliani per
pregare e per accogliere i fedeli che abitavano nelle campagne circostanti ed
inoltre costituiva un sostegno per le popolazioni smarrite durante le invasioni
musulmane. Più tardi essa fu ampliata e furono costruite delle stanze annesse,
destinate ai monaci basiliani che vi sarebbero rimasti oltre il XVI secolo. Fu
abitata fino al 1908 quando l’ultimo frate rimasto andò via a causa dei danni
del terremoto del 1905, e da allora fu abbandonata e divenne cadente. In quel
periodo alcuni abitanti di Mezzocasale per evitare che la statua della Madonna
venisse trafugata se la portarono nelle proprie case per poi consegnarla al
sacerdote don Teti.
La chiesa venne restaurata molti anni dopo ad opera della sovrintendenza alle
belle arti e riaperta al culto del pubblico nel 1977. Non esistono notizie certe
che ci possano dare informazioni sul perché della denominazione "Santa
Ruba" anche perché nella tradizione locale non è mai esistito il nome
Ruba e quindi si pensa che tale nome sia dovuto al luogo impervio sulla quale fu
costruita la chiesa (una Rupe) e dove i monaci si ritiravano a pregare quindi il
nome originario sarebbe stato "Santa Rupa".
Un problema che riguarda la chiesa di Santa Ruba è quello della sua datazione,
infatti non esistono documenti certi risalenti al periodo della sua fondazione.
Alcuni studiosi che si sono interessati del caso hanno trovato nella chiesa
tracce di una struttura primitiva fatta risalire al periodo
bizantino–basiliano. Addirittura si pensa che la sua fondazione vada dal X
sec. agli albori dell’XI. Altri studiosi sostengono che sia stata eretta in
questo periodo posticipando però la sua fondazione nel XII sec. sostenendo
inoltre che la chiesa sia stata oggetto di rifacimenti intorno al 1700. A
coronamento di queste interpretazioni dobbiamo citare la testimonianza di Paolo
Orsi che definisce Santa Ruba "un gioiello di origine
bizantina-basiliana con architettura barocca".Un altro studioso afferma che
la costruzione dell’edificio risalga al 1610 e cita il documento contenente la
richiesta da parte di un cittadino di Monteleone, che voleva realizzare questa
chiesa.
Sia essa bizantina–basiliana o con architettura barocca la certezza che
possiamo dare e che vedendola da vicino essa suscita nell’animo una sensazione
di meraviglia, facendoci ammirare l’ingegno degli uomini del passato, che pur
senza mezzi a disposizione riuscirono a creare un tale gioiello di inestimabile
valore. Tutto ciò ci fa capire come le nostre origini siano un grande
patrimonio da custodire con cura. Vi invitiamo a venire a visitarla.
Altri
edifici religiosi
Chiesa del
Rosario - In prossimità della Villa Comunale si trova la Chiesa
dedicata alla Madonna del Rosario, costruita intorno al 1280 dai frati
Minori, ma che ha subito interventi significativi nel corso del ‘700 ed ha
assunto il nome attuale solo nel corso del XIX secolo quando l’edificio,
originariamente dedicato a San Francesco, venne affidato alla Confraternita del
Rosario che aveva visto la propria chiesa distrutta dal terremoto del 1783.
Al
XVII ed al XIX secolo appartengono i molti dipinti delle scuole locali che
arricchiscono l’interno dell’edificio e che rappresentano la Madonna
della Salute, la Crocifissione di San Francesco e il Martirio di Santo Stefano, la Madonna
del Rosario e San Michele Arcangelo. Molto interessante, poi, è la trecentesca
Cappella De Sirica, dedicata a Santa Caterina che ha mantenuto lo stile gotico,
rappresentando uno degli esempi più significativi di questo stile nel sud
Italia.
 
Chiesa
Madonna del Carmine - Questo edificio ha due diverse denominazioni: Madonna
del Carmine e chiesa di San Michele e San Giuseppe. Fu costruita nel 1864
sull’antica chiesa di San Sebastiano risalente al 1500. Questa venne donata
nel 1600 ai padri Carmelitani. Nel 1783 fu danneggiata dal terremoto e nel 1806
diventò il “carcere dei briganti”.
La chiesa sorge
all’interno del perimetro della vecchia chiesa e ha una pianta ellittica che
testimonia il tardivo ricorso a tipologie barocche e a forme barocche in
Calabria. Sull’asse maggiore dell’ellisse si trovano il portale e l’altare
maggiore, mentre su quello minore vi sono le cappelle di dimensioni in profondità
1 metro e 20 centimetri e una larghezza di 3 metri.
Il tetto è a
falde inclinate costituite da manto in tegole in coppi, con struttura portante
poggiante sui muri perimetrali. Il paramento interno è costituito da eleganti
colonne, con capitelli ionici a ghirlanda, sulle quali corre un architrave su
cui si imposta la cupola con nervature decorate a stucco.
Chiesa di
San Michele - Si ha traccia di questa antica chiesa, esempio di architettura
rinascimentale, dalla data dell'8 agosto 1519, quando il vescovo di Mileto,
Andrea Della Valle, la elevò a parrocchia.
La
chiesa è stata aperta al culto nel 1536 nell’anno stesso in cui morì il suo
progettista, l’architetto Baldassarre Peruzzi. L’edificio fu ampliato nel
1671 e fu molto danneggiato nel 1783 a causa del terremoto che colpì l’intera
regione.
Il
campanile, su probabile disegno di Baldassarre
Peruzzi, a torre quadrata, con tre ordini sovrapposti, aveva un orologio
il cui meccanismo è stato ritrovato sul posto e sarà conservato in un museo,
all'interno vi è un quadro di Luca
Giordano San Michele che scaccia Lucifero. Presente anche un dipinto
di Ludovico
Mazzanti Estasi di Sant'Ignazio.
La
chiesa è costituita da un’unica navata rettangolare coperta da una volta a
botte lunetta, da un ambiente centrale con la cupola a tamburo e da un capellone
a sinistra, rispetto all’altare Maggiore, costruito nel 1695 che, insieme
all’altro altare di destra, posizionato leggermente più in profondità,
definisce il braccio del transetto coperto con volta lacunare. Quest’ultimo
altare è ritenuto l’antico oratorio del Santissimo Sacramento, dove è
preservata la maggior parte dei tesori sacri della chiesa. Il campanile di San
Michele, alto circa 30 metri fu costruito su quattro piani sovrapposti con una
serie di paraste alleggerite.


Chiesa di Santa Maria degli Angeli - Costruita tra il 1621 e il 1666,
dapprima annessa al convento dei frati minori riformati (oggi Convitto
Nazionale), è dal 1866 curata dai padri
cappuccini.
Conserva
all'interno un Crocifisso ligneo detto "degli Angeli" di ignoto autore
del '600, meta di migliaia di devoti che si recano ogni anno, per antica
tradizione, in pellegrinaggio nei venerdì di marzo. In più due quadri
attribuiti a Luca
Giordano e la scultura Madonna con bambino di Michelangelo
Naccherino.
Chiesa di
Santa Maria del Soccorso - L’edificio
sacro risale agli inizi del XVII secolo. È stato aperto al culto nel 1632 e
come le altre, fu danneggiata dal terribile terremoto del 1783. Qualche anno più
tardi fu restaurata dall’ingegnere Bernardo Morena. Nel 1800 furono installati
due mosaici romani. L’abside fu rifatta interamente nel 1879. Il restauro,
successivamente, interessò l’intero edificio.
La
chiesa oggi presenta un’ampia navata centrale con transetto e abside,
fiancheggiata da due navatelle minori, notevolmente più basse, divise da quelle
centrali da robuste colonne toscane. Il tetto della navata centrale è a doppia
falda ed è costituito da mante in coppi, poggianti sui muri perimetrali della
navata centrale e sugli altri muri perimetrali.
L’esterno
di presenta a due piani con l’inferiore largo fino a comprendere l’intero
corpo, e il superiore impanato, corrisponde invece alla sola navata centrale. Il
raccordo tra i due livelli è risolto con delle balaustre occultanti le
coperture delle navate laterali. Il primo livello con paraste e specchiare, è
caratterizzato da un portale poco sporgente, coronato da un timpano curvilineo;
il secondo livello, anch’esso segnato da paraste, presenta due nicchie
laterali e una specchiata centrale davanti alla quale vi è una statua della
Madonna.

Chiesa di
San Giuseppe - Voluta dai Padri Gesuiti e annessa al collegio da loro ivi
fondato, venne edificata sulla base di un progetto di Francesco
Grimaldi e fu aperta al culto nel 1701 col titolo di Sant'Ignazio o
del Gesù.
Conserva
all'interno numerose opere pittoriche tra cui La visione di Sant'Ignazio e
scultoree come il gruppo ligneo di San Giuseppe sull'altare maggiore.
E' sede
parrocchiale unitamente alla vicina chiesa di San Michele e vi è tuttora attiva
la Confraternita di Gesù, Maria e Giuseppe che cura tra l'altro la suggestiva
processione della Madonna Desolata la notte del Venerdì Santo.
Chiesa Santa
Maria la Nova - Costruita nel 1521 con il nome di Santa Maria di Gesù dal
duca Ettore Pignatelli, ne custodisce il sarcofago. Si presenta attualmente con
stili diversi e ospita al suo interno un marmo del Gagini.
Durante la
dominazione napoleonica fu adibita a stalla e deposito militare, fu restaurata e
riaperta nel 1837 per volontà di Enrico Gagliardi. All'interno presenti opere
del pittore fiammingo Dirk
Hendricksz.
Chiesa di
Sant'Antonio di Padova - Chiesa del XVII secolo annessa al convento dei
Frati Minori Cappuccini.
All'interno è
possibile ammirare una tela di Luca
Giordano, La Madonna col bambino tra i Santi Anna e Felice, e l'Immacolata
con i santi Francesco e Antonio di Padova di Pacecco
De Rosa.

 
Chiesa di
Sant'Omobono - L’edificio sacro è stato aperto al culto nel 1710. La
chiesa è a navata unica con specchiature laterali. Le sue dimensioni sono
assimilabili a quelle caratteristiche di una schiera vibonese e, pertanto, si
potrebbe pensare che il “basso” sede della confraternita di Sant’Omobono
(nell’immagine sotto a sinistra) coincidesse con la chiesa. panni. Le riunioni
avvenivano nella sala capitolare del convento di S. Pietro a Belluno e nel 1461
venne deliberato di erigere nel chiostro anteriore una cappella intitolata a S.
Giovanni Battista, S. Giovanni evangelista e Sant’ Omobono.
 I
primi statuti risalgono al 1344, mentre un aggiornamento venne fatto nel XVI
secolo. Essi regolavano la vita della confraternita sia dal punto di vista
devozionale che professionale, fissando i giorni lavorativi e i rapporti tra
maestri e lavoranti. Da un inventario del 1772 sappiamo che la scuola, oltre ai
registri pervenutici, possedeva altri due libri delle parti, due di contabilità,
uno di affittanze, una matricola ed uno statuto a stampa. I
primi statuti risalgono al 1344, mentre un aggiornamento venne fatto nel XVI
secolo. Essi regolavano la vita della confraternita sia dal punto di vista
devozionale che professionale, fissando i giorni lavorativi e i rapporti tra
maestri e lavoranti. Da un inventario del 1772 sappiamo che la scuola, oltre ai
registri pervenutici, possedeva altri due libri delle parti, due di contabilità,
uno di affittanze, una matricola ed uno statuto a stampa.
Il
protettore dei sarti - La confraternita raggruppava i sarti, i cimatori, i
lanari e i drappieri, tutte categorie attinenti la lavorazione dei panni. Le
riunioni avvenivano nella sala capitolare del convento di S. Pietro a Belluno e
nel 1461 venne deliberato di erigere nel chiostro anteriore una cappella
intitolata a S. Giovanni Battista, S. Giovanni evangelista e Sant’ Omobono. I
primi statuti risalgono al 1344, mentre un aggiornamento venne fatto nel XVI
secolo. Essi regolavano la vita della confraternita sia dal punto di vista
devozionale che professionale, fissando i giorni lavorativi e i rapporti tra
maestri e lavoranti. Da un inventario del 1772 sappiamo che la scuola, oltre ai
registri pervenutici, possedeva altri due libri delle parti, due di contabilità,
uno di affittanze, una matricola ed uno statuto a stampa.
Una
mano da artista - La tradizione sartoriale calabrese e meridionale è
riconosciuta in tutto il mondo e trova radici molto antiche. Il culto di
Sant’Omobono, protettore dei sarti e lui stesso sarto, ne è testimonianza. La
confraternita dei sarti in Calabria trae la sua origine a Catanzaro nei primi
del Seicento ed è stata molto attiva anche a Vibo Valentia. La confraternita si
riuniva proprio nella chiesa che oggi è intitolata a Sant’Omobono.
Il
mestiere del sarto ancora oggi trova a Vibo Valentia un’espressione di
altissima qualità. In realtà quella del sarto è un’attività ad alta
professionalità. La parte più difficile è quella del taglio. Sbagliare
significa dover rifare tutto e rimetterci denaro. A pari merito di difficoltà
si colloca la presa delle misure. Il sarto deve avere l’occhio allenato e
realizzare un abito su misura perfetto è pressoché impossibile.
Un
buon sarto deve conoscere a perfezione il corpo umano, capire le diverse
conformazioni e “progettare” un taglio che “copra” i difetti. Non c’è
sarto che non sia dotato della pazienza di Giobbe. I clienti (che spesso
sborsano somme di non poco conto) sono, di solito, molto pignoli e il sarto deve
mettere mano all’abito più volte dopo le prove. Ma non c’è più grande
soddisfazione di un abito che cala a pennello. La mano del sarto è esattamente
come quella di un artista. Egli deve sbalordire non solo chi indossa l’abito,
ma anche chi lo guarda.
Chiesa dello
Spirito Santo - Edificata nel 1579, è tuttora sconsacrata al culto; fu il
primo duomo della città prima della costruzione dell'attuale, nonché sede
straordinaria e dimora, nel 1613, dell'allora vescovo Virgilio Cappone.
Conservava al
suo interno molte opere artistiche che, alla sua chiusura furono spostate in
altre chiese della città; la parrocchia di cui era sede fu trasferita, pur
mantenendo lo stesso titolo, nella vicina chiesa di Santa Maria La Nova.

Castello
normanno-svevo
Il
castello sorge dov'era ubicata probabilmente l'Acropoli di Hipponion che in
parte si estendeva pure sulla collina vicina. Del castello, che nel corso dei
secoli ha subito diverse modifiche e danni, rimane ancora molto in piedi, anche
se una delle ragioni per cui lo visitano in tanti è la vista che da qui è
meravigliosa e spazia dai golfi sul Tirreno alla Sila e alle Serre.
Nonostante
la prima fase di costruzione della struttura venga volgarmente attribuita all'età
normanna, in realtà, essa risale al periodo svevo quando Matteo Marcofaba
governatore della Calabria venne incaricato da Federico
II di ripopolare e favorire lo sviluppo della città. il castello
venne ampliato da Carlo d'Angiò nel 1289 quando assunse più o meno un aspetto
simile a quell'odierno. Fu rafforzato dagli Aragonesi nel XV secolo e infine
rimaneggiato dai Pignatelli tra il XVI-XVII secolo, perdendo quasi del tutto la
funzione militare e assumendo invece quella di abitazione nobiliare.
Il
secondo piano fu demolito di proposito, in quanto pericolante, a causa dei danni
riportati dopo il terremoto
del 1783. Il castello presenta oggi delle torri cilindriche, una torre
speronata e una porta a un'arcata di epoca angioina.
 Il
castello ospita il Museo archeologico statale. Fondato nel 1969 e intitolato
all'archeologo vibonese Vito Capialbi, è situato all’interno del Castello e
custodisce reperti significativi dell’età tardo ellenistica e romana. Il
museo è prevalentemente caratterizzato da quattro sezioni riguardanti reperti
provenienti da luoghi di culto, reperti archeologici di necropoli, materiali
risalenti all’età romana. Di particolare importanza è la spada risalente al
tredicesimo secolo a.C. proveniente da una necropoli romana; il monetiere
Capialbi, che contiene pregiati aurei locresi ed una collezione di monete
d’argento Brettie risalenti alla fine del terzo secolo a.C. ed il busto di
Agrippa. Il
castello ospita il Museo archeologico statale. Fondato nel 1969 e intitolato
all'archeologo vibonese Vito Capialbi, è situato all’interno del Castello e
custodisce reperti significativi dell’età tardo ellenistica e romana. Il
museo è prevalentemente caratterizzato da quattro sezioni riguardanti reperti
provenienti da luoghi di culto, reperti archeologici di necropoli, materiali
risalenti all’età romana. Di particolare importanza è la spada risalente al
tredicesimo secolo a.C. proveniente da una necropoli romana; il monetiere
Capialbi, che contiene pregiati aurei locresi ed una collezione di monete
d’argento Brettie risalenti alla fine del terzo secolo a.C. ed il busto di
Agrippa.
L'attuale
allestimento, in ordine topografico e cronologico, comprende materiale
proveniente dai recenti scavi della città e della zona, oltre a nuclei
antiquari otto-novecenteschi appartenenti a studiosi locali. La collezione è
divisa in quattro sezioni principali: reperti dagli edifici sacri, dalle
necropoli, dalle collezioni private e materiale d'età romana.
Da
vedere ancora il corredo di una tomba dell'età del Bronzo; materiali votivi
provenienti dal santuario rinvenuto in località Scrimbia; tra i reperti delle
necropoli, una lamina in oro con iscrizione greca relativa al culto orfico.
Inoltre vasi a figure nere e a figure rosse, frammenti architettonici dipinti,
provenienti da collezioni private vibonesi. Nella torre nord sono esposti alcuni
reperti provenienti dalle necropoli romane, dalla città tardo-antica e dalle
ville rinvenute nel territorio.



Castello
di Bivona
Il castello di
Bivona venne fatto edificare nella prima metà del Quattrocento da Mariano
d'Alagno fratello di Ugone e di Lucrezia, governatore di Monteleone, a difesa
del porto. Il castello ha una pianta più o meno rettangolare con quattro torri
circolari agli angoli. Venne abbandonato alla fine del Seicento per la
formazione di paludi nelle vicinanze.
Oggi il
castello si presenta molto degradato e sono in corso programmi di recupero e di
restauro. La pianta è regolare, lievemente trapezoidale con delle torri
circolari agli angoli esterni.
Mettete dei
fiori nei vostri cannoni - Nel 1500, sotto il governo dei Pignatelli, il
castello fu utilizzato per la lavorazione della cannamele (canna da zucchero)
alla cui coltivazione erano dedicati i terreni vicini. Una incredibile
trasformazione dell’uso che da militare divenne industriale. Fra le mura del
castello i truci militari che preparavano munizioni per i cannoni, furono
sostituiti da pacifici lavoratori che trasformavano gli steli legnosi del
“Saccharum officinarum” in dolcissimo zucchero o nel cosiddetto
“falso-miele”. La lavorazione della cannamele fu interrotta nel 1680
probabilmente per l’insalubrità dell’aria causata dalla stagnazione di
acqua proveniente dai torrenti Trainiti e Sant’Anna.
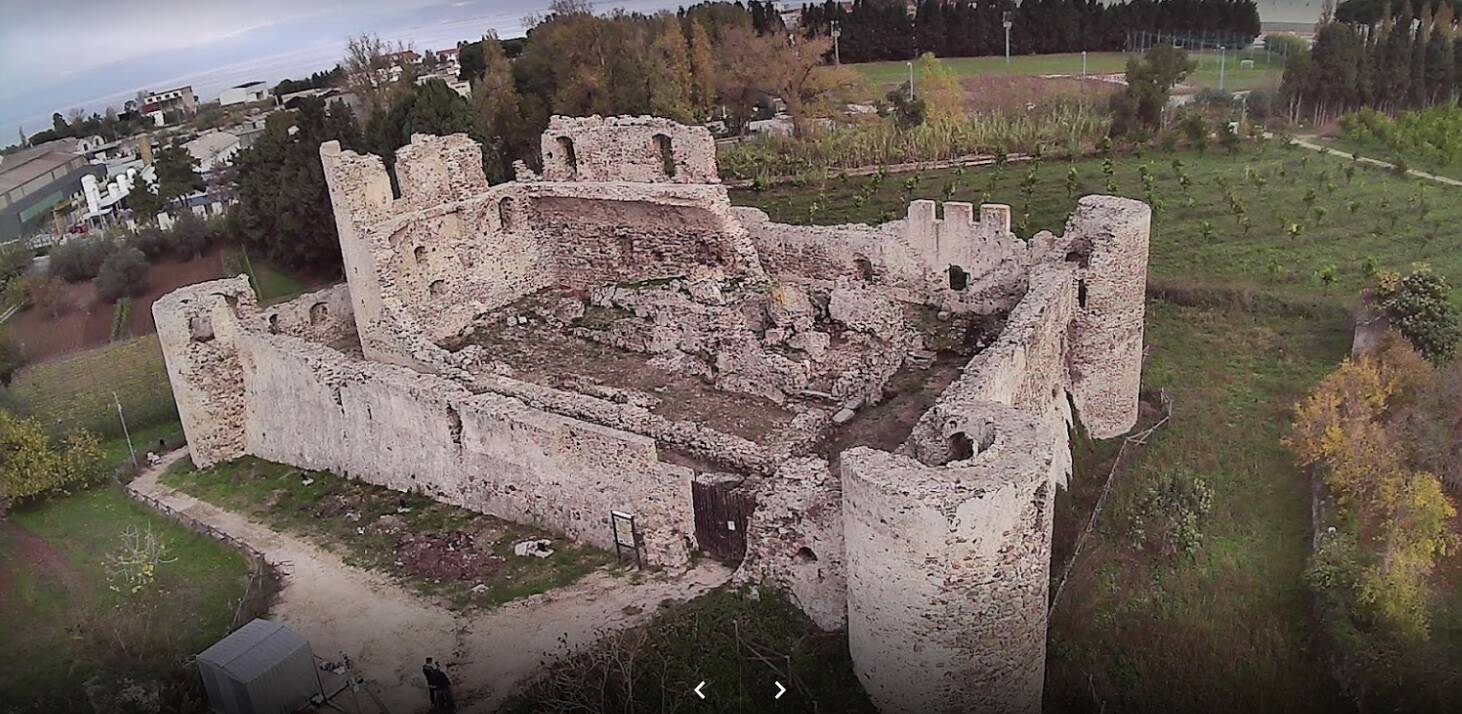
 Pag. 2
Pag. 2
|