|
La
sua morfologia si divide in due parti: la parte superiore, dove si trova la
popolazione e dove si svolge la vita quotidiana del paese, e una parte inferiore
(chiamata "Marina"), che si trova a ridosso del mare e del porto di
Tropea.
Tra
le altre zone periferiche, vi sono la località "Carmine" e la località
"Campo" (divisa a sua volta in "Campo di sopra",
prevalentemente occupato da orti e campagne con qualche zona residenziale, e
"Campo di Sotto", dove hanno sede la locale caserma dei carabinieri e
l'ospedale).
La
città, nella parte superiore, si presenta costruita su una roccia a picco sul
mare, con un'altezza s.l.m. che varia tra circa 50 metri nel punto più basso e
61 metri nel punto più alto.
L'abitato
storico era un tempo cinto di mura e incastellato su un lato; vi si poteva
accedere solo attraverso delle porte provviste di sistemi di difesa. Con una
superficie territoriale di 3,66 Kmq, Tropea è il secondo comune meno esteso
della Calabria, preceduto da Piane Crati.
La
leggenda vuole il fondatore sia stato Ercole quando, di
ritorno dalle Colonne d'Ercole (attuale Gibilterra), si fermò
sulle coste del Sud Italia.
Nelle
zone limitrofe sono state rinvenute tombe di origine magno-greca.
La
storia di Tropea inizia in epoca romana, quando lungo la costa Sesto Pompeo sconfisse Cesare
Ottaviano. A sud di Tropea i romani avevano costruito un porto commerciale,
vicino all'attuale Santa Domenica, a Formicoli (toponimo derivato da una
corruzione di Foro di Ercole), di cui parlano Plinio e Strabone.
Per
la sua caratteristica posizione di terrazzo sul mare, Tropea ebbe un ruolo
importante, sia in epoca romana (attestato dalla cava di granito che sorge a
circa 2 km dall'abitato, nell'attuale comune di Parghelia) sia in epoca
bizantina; molti sono i resti lasciati dal bizantini, come la chiesa sul
promontorio o le mura cittadine (chiamate appunto "mura di Belisario").
Dopo
un lungo assedio, la città fu strappata ai bizantini dai pirati arabi,
per poi essere riconquistata dai Normanni, sotto i quali prosperò.
Tropea
continuò a prosperare anche sotto il dominio degli Aragonesi.

Nota località balneare, sorge in un alto promontorio di
tufo, affacciato sul Mar Tirreno, nella costa occidentale della
Calabria, in provincia di Vibo Valentia.
Di notevole interesse è il centro storico della città,
con molti palazzi nobiliari del XVIII E DEL XIX secolo, arroccati sulla rupe che strapiomba sulla spiaggia
sottostante.
Tra questi è doveroso menzionare Palazzo Toraldo, eretto a fine del XIX
secolo, che si trova all'inizio del centro storico. Al suo interno, dietro
appuntamento, può essere visitata una ricca biblioteca privata con antichi
documenti.
 Sempre nel
centro storico c'è Piazza Ercole - dedicata all'eroe leggendario. In
questa piazza è possibile trovare il monumento al filosofo Galluppi e il Sedile
dei Nobili con l'antico orologio. E' qui che si sviluppa la vita notturna a
Tropea, poichè nei dintorni della piazza ci sono tanti locali aperti fino a
tarda notte. Sempre nel
centro storico c'è Piazza Ercole - dedicata all'eroe leggendario. In
questa piazza è possibile trovare il monumento al filosofo Galluppi e il Sedile
dei Nobili con l'antico orologio. E' qui che si sviluppa la vita notturna a
Tropea, poichè nei dintorni della piazza ci sono tanti locali aperti fino a
tarda notte.
Simbolo della città è il santuario di Santa Maria dell'Isola,
che sorge su un promontorio di fronte alla cittadina.
Le numerose chiese, costruite in varie epoche fuori e
dentro la cinta muraria della città antica, costituiscono un patrimonio di
notevole importanza artistica.
Chi
si avventura alla scoperta del centro storico di Tropea, tra le molteplici bellezze
disseminate tra i palazzi patrizi, chiese e conventi, non può fare a meno
di scorgere tra i larghi e i vicoli del borgo, la presenza
diffusa delle edicole votive, in dialetto locale definite cresiolee,
ossia piccole chiese. L’impiego di altari di piccole dimensioni, in legno,
ceramica o muratura, con immagini sacre o di altro genere ha origini
antichissime, probabilmente diffusosi dall’ambiente magnogreco a quello
romano-italico. Tale utilizzo si manterrà in età cristiana e per tutto il
Medio Evo, eccetto la gravosa parentesi del periodo delle lotte iconoclaste
(VIII-IX secolo). La presenza delle edicole votive nella Tropea antica aveva molteplici
funzioni.

La
popolazione più umile e di condizioni meno abbienti che viveva nei seminterrati
affollati degli edifici nobiliari, desiderosa di evadere da quei bassifondi
malsani, durante i mesi primaverili ed estivi si radunava nei larghi e nei
vicoli spaziosi per raccogliersi in preghiera intorno le sacre icone collocate
nelle edicole. Questi rituali collettivi non avevano solo una funzione
religiosa, ma anche sociale, in queste occasioni, infatti, la gente più povera
conversava e interagiva su questioni quotidiane. Altro elemento importante era
legato al fatto che non tutta la popolazione poteva avere accesso nelle
chiese del centro storico, i fedeli meno avvantaggiati potevano, per mezzo
delle edicole votive, espletare le funzioni religiose come la recita
del rosario durante le novene.
Le
edicole votive essendo sempre illuminate da torce, lanterne o lumini,
funsero per secoli come illuminazione pubblica, riuscendo a rischiarare gli
angoli più bui. Le immagini sacre predilette nelle edicole votive sono la Madonna
di Romania, patrona della città, San Francesco di Paola, molto venerato dai
pescatori, San Giuseppe, patrono di falegnami e artigiani, poi vi abbiamo i
Santi medici Cosma e Damiano, San Nicola, la Madonna della Pietà e del
Carmelo.
Ogni
vicolo o palazzo è ornato da questi piccoli altarini, le “cresiolee” tanto
care alle anziane che vivono nel borgo antico. Da un punto di vista artistico e
architettonico, si tratta di piccole nicchie prive di decorazioni e in alcuni
casi con colonne e cornici in stucco, mentre le immagini sacre dipinte sul muro
o su tavole lignee sono opera di un artigianato creativo e vivace che nei
secoli, tra terremoti e modifiche antropiche, ha saputo plasmare con coscienza e
originalità l’aspetto estetico del centro storico. Secondo un approssimativo
censimento, il centro storico di Tropea conta una cinquantina di queste
icone, ma molte sono conservate anche all’interno dei palazzi e, quindi,
difficilmente catalogabili.

“Solo
i portali, numerosi e possenti, ostentano ancora intatta, nella squadrata
robustezza delle loro bugne granitiche e nel complesso giro compositivo,
l’opulenza di un’antica nobiltà e la vibrante dinamica di maestranze
operose e sensibili.” Con questa descrizione in prosa poetica dello
studioso Francesco Pugliese, per i tropeani “il Teologo”, vi
abbiamo una precisa narrazione del nucleo monumentale del centro storico di
Tropea e dei suoi famosi portali dei palazzi patrizi, delle chiese e
dei conventi.
Il
portale rappresenta di per sé l’elemento architettonico che caratterizza un
insieme di fattori, non solo artistici, ma anche e soprattutto rappresentativi
del gusto delle ricche committenze della nobiltà tropeana, desiderose di
esprimere il loro potere e prestigio, e in modo particolare, dell’abile
creatività delle maestranze locali che nei secoli hanno saputo plasmare
originali soluzioni stilistiche tra i vicoli suggestivi che si articolano fra i
larghi e gli affacci panoramici protesi sul mare. La maggior parte dei portali
risalgono al periodo barocco (XVII-XVIII secolo), altri sono stati
rimaneggiati in seguito a diverse modifiche che subì il tessuto urbano fra il
sisma del 1783 e la creazione dell’attuale Corso Vittorio Emanuele III
verso la fine del XIX secolo.
     Molti
sono realizzati in granito e tufo locale, rari quelli in marmo e
muratura, composti da un massiccio rivestimento e con una elegante disposizione
decorativa tipica dello stile bugnato, spesso circondati da una cornice continua
alternata a bugne a cuscino rettangolare scanalate ai lati e doppie bugne a
diamante (Palazzo Collareto-Galli in Largo Galluppi, Palazzo Pelliccia-Cesareo
in Via Boiano, Palazzo Pelliccia Bongiovanni in Via Pietro Vianeo, Palazzo Tocco
in Largo Guglielmini, Palazzo Caputo in Largo Mercato). Altri
sono realizzati con una semplice cornice a bugna rettangolare
posizionata in modo lineare e continuo su tutta la superficie sia dell’arco
che dei piedritti (Palazzo Sant’Anna in Largo Padre Di Netta, Palazzo Caputo
in Largo Ruffa). Altri ancora sviluppano una varietà di stili e di influenze
con la cornice caratterizzata da un bassorilievo continuo, sia sui
piedritti che sull’arco, raffigurante forme geometriche e floreali (Palazzo
Mottola Braccio e Pontoriero Barone Adesi in Via Aragona) altri con la cornice
composta da due basi strette e lunghe a forma di plinti incorniciati su cui
appoggiano due colonne altrettanto strette e proiettate verso il capitello in
rilievo (Portale ingresso meridionale della Cattedrale) e sempre con le colonne
ioniche in rilievo (Palazzo Zinnato in Via Boiano e Palazzo Mottola in Largo
Migliarese). Molti
sono realizzati in granito e tufo locale, rari quelli in marmo e
muratura, composti da un massiccio rivestimento e con una elegante disposizione
decorativa tipica dello stile bugnato, spesso circondati da una cornice continua
alternata a bugne a cuscino rettangolare scanalate ai lati e doppie bugne a
diamante (Palazzo Collareto-Galli in Largo Galluppi, Palazzo Pelliccia-Cesareo
in Via Boiano, Palazzo Pelliccia Bongiovanni in Via Pietro Vianeo, Palazzo Tocco
in Largo Guglielmini, Palazzo Caputo in Largo Mercato). Altri
sono realizzati con una semplice cornice a bugna rettangolare
posizionata in modo lineare e continuo su tutta la superficie sia dell’arco
che dei piedritti (Palazzo Sant’Anna in Largo Padre Di Netta, Palazzo Caputo
in Largo Ruffa). Altri ancora sviluppano una varietà di stili e di influenze
con la cornice caratterizzata da un bassorilievo continuo, sia sui
piedritti che sull’arco, raffigurante forme geometriche e floreali (Palazzo
Mottola Braccio e Pontoriero Barone Adesi in Via Aragona) altri con la cornice
composta da due basi strette e lunghe a forma di plinti incorniciati su cui
appoggiano due colonne altrettanto strette e proiettate verso il capitello in
rilievo (Portale ingresso meridionale della Cattedrale) e sempre con le colonne
ioniche in rilievo (Palazzo Zinnato in Via Boiano e Palazzo Mottola in Largo
Migliarese).
Il
più sontuoso e rappresentativo è portale di Palazzo Braghò in
Via Boiano, realizzato in granito locale nel 1721. La cornice è ricca di elementi
decorativi: piedritti con lesene da ambo i lati simmetricamente con
ulteriori decori in bassorilievo con grandi foglie e conchiglie e con due
piccoli felini in rilievo e due vasi fioriti. Le lesene continuano anche
sull’arco superiormente, interrotte da cunei con inseriti rilievi di foglie e
alla cui estremità superiore sono poste sei grandi conchiglie. L’elemento
centrale in chiave d’arco presenta una ghirlanda con frutta, verdura
e fiori. Sono tutti elementi simboleggianti la ricchezza data dal mare e dalla
terra. Ai portali si uniscono gli stemmi nobiliari, sempre disposti sulla chiave
d’arco. Diffuse sono le maschere apotropaiche contro il malocchio
applicate in chiave d’arco.

Il sito dove
anticamente sorgeva il Castello di Tropea è oggi occupato da Palazzo
Toraldo-Serra. Il Castello si estendeva all’ingresso della città, in
corrispondenza dell’inizio del Corso Vittorio Emanuele III, su un ammasso
roccioso alto quindici metri d’altezza sulla strada che, ancora oggi, conduce
alla zona della Marina. La possente fortificazione a pianta trapezoidale,
con quattro torri angolari, due giardini con un’antichissima chiesa addossata
alle mura dedicata a Santa Maria del Bosco, possedeva anche una Torre Mastra e
una torre centrale alta circa 30 m., detta “Torre Lunga”, essa faceva
parte di un compatto sistema difensivo costiero voluto da Don Pietro di Toledo,
viceré di Napoli sotto Carlo V, per far fronte alle incursioni turchesche
che imperversavano in queste aree. Dalla cima della “Torre Lunga” si poteva
ammirare il passaggio delle navi e delle imbarcazioni dal golfo si
Sant’Eufemia e golfo di Gioia Tauro.
Nei secoli
questo sistema difensivo rese Tropea inespugnabile, fu più volte adibito a
carcere e sede del governatore regio. La più antica fase della Cinta Muraria,
che si articolava fino alla Porta di Mare ad oriente e alla Porta
Vaticana ad occidente, risale ai tempi della guerra Greco-Gotica (535 d.C.),
opera del generale bizantino Belisario che volle rendere Tropea una
roccaforte inespugnabile. Le uniche testimonianze rimaste oggi costeggiano la
strada che porta alla Marina, dal giardino prospicente Palazzo Toraldo-Serra
fino alla Cattedrale.
Dopo il
terremoto del 1783, fu ricavata una terza porta, Porta Nuova, corrispondente
all’attuale inizio del Corso. Durante le fasi della demolizione del
Castello, avvenuta tra il 1825 e il 1876, furono rinvenute diverse decine di
epigrafi funerarie paleocristiane (V sec. d.C.) con nomi di religiosi come Monses
Presbiter (il prete Mosé) e Leta Presbitera (una donna prete!) e
di Hirene Conductrix Massae Trapeianae, la prima attestazione del nome
Tropea. Insieme alle epigrafi trovate nello scavo archeologico avvenuto in Largo
Duomo nel 1980, oggi visitabili presso il Museo Diocesano, Tropea vanta il
più grande e considerevole patrimonio epigrafico di età paleocristiana della
Calabria.

Nella cultura
antropologica meridionale rientrano le maschere apotropaiche ossia
quelle facce mostruose che si trovano sugli stipiti delle porte e sui balconi
per allontanare il malocchio e le energie negative, queste riflettono lo spirito
scaramantico tropeano. Presenti in molte culture, ma specialmente diffuse nel
Mezzogiorno, avevano il compito di allontanare gli spiriti maligni. La loro
iconografia è molto varia, ma di solito hanno forma antropomorfica di Satiri e
Gòrgoni in pietra o terracotta che ornavano per lo più le entrate dei templi
greci e romani. Tutto ciò richiama il teatro greco dove le maschere
avevano un ruolo importante legato alla religione e alla cultura della Magna
Graecia.
Come risulta
dagli scavi archeologici, l’uso nella regione è antico, nelle maschere
moderne vengono aggiunte le corna, per simboleggiare il diavolo. Nell’atto di
provocare vengono rappresentate con lingua penzolante, naso storto, occhi
sporgenti capelli arruffati e con le immancabili corna. Inoltre i tropeani
spesso si circondavano di diversi simboli: ferro di cavallo posizionati a
corna, scope inchiodate o corna di bue ma ormai questa tradizione nelle nuove
generazioni sta venendo meno.
Era inoltre anche diffuso inchiodare gli uccelli, preferibilmente
notturni, sugli stipiti delle porte, rito molto antico di origine romana. Si
credeva che le forze ostili trovassero così una barriera, e la casa
diventava così uno spazio protetto. Nel portale di un palazzo patrizio del
centro storico viene raffigurato il mito dell’uomo preadamita, secondo alcune
tradizioni ebraiche e cristiane, vissuto prima di Adamo. Questi uomini
presentavano tre occhi, quello posto sulla fronte rappresentava la conoscenza
divina, ma quando l’uomo cadde nel peccato perse questo status ed è per
questo che in alcune maschere è rappresentato cadente.
Altro
mascherone è quello dei Rosacroce, una confraternita di ricercatori
spirituali la cui origine risale al XIV secolo in Germania. La confraternita dei
Rosacroce insegnava la vera religione e la vera filosofia e tramandava le
scienze più segrete. Ma solo chi ne erano degni potevano superare dei
“passaggi” per ricevere l’illuminazione della conoscenza divina.

Santuario
Santa Maria dell'Isola
Sul lato nord
di Tropea, antica città del Tirreno calabrese sorta su un grosso frammento di
roccia, sorge, staccato dalla massa principale, lo scoglio di Santa Maria
dell'Isola. Un tempo tutto circondato dal mare, da qui il suo nome storico
rimasto immutato nel tempo.
Fin dall'Alto
Medioevo, l'isola fu meta di comunità monastiche, ricercatori di solitudine e
spiritualità, luogo di stimolo alla preghiera ed al raccoglimento. Nulla di
certo sappiamo della sua erezione, ma dalla ricerca di alcuni storici emerge
l'ipotesi, verosimile, che vi fosse un primo insediamento di monaci eremiti
greci.
A cavallo tra
il 1066 e il 1090 la chiesa di Santa Maria dell'Isola e alcuni territori dei
dintorni, furono donati dai Normanni all'abate di Montecassino, Desiderio,
divenuto poi papa Vittore III. A testimonianza di ciò vi è un'incisione su di
una formella della porta bronzea della Basilica di Montecassino la quale attesta
la proprietà di "Sancta Maria de Tropea cum omnibus pertinentiis
suis". Ancora oggi, il Santuario e tutto lo scoglio dell'Isola sono
proprietà dell'Abazia di Montecassino.

Effettivamente tutti i documenti visionati, raccontano
di una chiesa probabilmente di grande rilevanza che senza dubbio amministrava
cospicui beni. Narra una leggenda che in tempi remotissimi una
nave dall’Oriente approdò sull’isolotto di Tropea e non riprese più il
largo fin quando la statua lignea della Vergine non fu sbarcata.
L'effige miracolosa fu posta in una grotta, poi traslata in
una caverna sotterranea su cui nacque la basilica. Tuttavia della statua
miracolosa si sono perse le tracce.
Nel corso dei
secoli, quindi, a causa dei violenti terremoti e, probabilmente, delle varie
incursioni, il complesso ha subito vari restauri e rifacimenti tanto da non
conservare più l'assetto originario. Solamente all'interno della chiesa sono
rintracciabili alcuni elementi architettonici tipici delle epoche che il
Santuario ha attraversato.
In origine fu costruito un edificio di culto a forma
quadrata con vano centrale circondato da peribolo con volta a botte, delimitato
dal vano centrale da pilastri ed archi a conci tufacei. Del peribolo rimangono
intatti un lato e la maggior parte del secondo. Sono tutt’ora indenni anche le volte a botte nella zona
pilastrata.
In età gotica l’edificio fu restaurato e riadattato
con costruzione di ambienti con volta a crociera gotica costolana. Vi rimane una
semicrociera nel vano tra l’Altare, la Cisterna e la parte terminale
dell’edificio primitivo. A questi lavori seguì una
consacrazione del tempio come è indicato da una iscrizione ancora sul posto:
Anno Domini MCCCLXXXXVII XXIII mensis aprilis indictione quinta consecrata est
ecclesia sanctae Mariae de Insula de Tropea. Riguardano questa età alcune
sculture sepolcrali conservate anche se non in condizioni di integrità.
Qualche secolo dopo l’edificio subì una radicale
trasformazione. Fu sventrato nella parte centrale. Vi furono aggiunti i pilastri
ed archi con volta a botte. L’interno prese la forma di piccola basilica con
le irregolarità dovute alla conservazione delle parti salvabili del primitivo
edificio. L’esterno prese l’aspetto di parallelepipedo sormontato dalla
volta della navata centrale con l’estradosso allo scoperto, di effetto
stranamente arabeggiante.
Verso la fine del Seicento vi fu aggiunto un
portico che diede la
possibilità di costruire nel piano superiore una serie di stanzette per
abitazione degli eremiti.

Più tardi il portico fu in parte eliminato murando gli
archi che sono tutt’ora rilevabili sotto la muratura. Ne rimasero aperti solo
tre. Da un lato vi si ricavò la sacrestia, dall’altro il deposito. In fondo
si aprì una porta, si sventrò il muro terminale della navata centrale e della
navatella destra e si allungò la pianta della chiesa.
Nel 1810 esistevano nell’orto, nella parte nord
dell’edificio altri vani che furono poi eliminati senza lasciarvi tracce
visibili.
L'ultimo
rifacimento risale al 1908, dopo che il terremoto del 1905 ha distrutto una
parte del portico. Mentre il restauro della facciata è datato 2010-2011.
Dopo il terremoto del 1905 fu rifatta tutta la facciata
che aveva subito il crollo dell’arco centrale del portico, dandole l’aspetto
non certo felice che conserva tutt’oggi. Oggi la Chiesa, ospita le statue
della Sacra famiglia (al momento sistemate presso la chiesa del Rosario),
portate in processione in mare ad ogni 15 di agosto. Per raggiungere la Chiesa a
tre navate si accede attualmente da una ripidissima scalinata scavata nel tufo,
prima però ci si poteva inerpicare sull’isola Bella attraverso gli scogli.
Sul percorso era comunque possibile ammirare una chiesetta dedicata a San
Leonardo che però venne utilizzata dai pescatori per custodire gli arnesi.
Inoltre un bellissimo museo custodisce i segreti del Santuario.
L'attenzione,
entrando all'interno della piccola chiesa, viene rapita dalle statue
rappresentanti la Sacra Famiglia opera del Settecento, venerata tutt'oggi dalla
popolazione tropeana con una tradizionale processione in mare il 15 agosto.


La devozione
alla Madonna dell'Isola nasce, molto probabilmente, in epoca bizantina. Per
lunga tradizione sembra che i riferimenti di questo culto fossero due: uno nella
cripta esistente nella Chiesa, l'altro a metà della scalinata d'accesso, dove
vi si può ammirare una piccola edicola con la scritta in latino "locus ubi
steterunt pedes eius". Si riferisce all'uso immemorabile di portare i
sofferenti di disturbi gastrici e di stenderli sul masso retrostante. Si
racconta che numeroso erano le grazie di guarigioni.
Non conosciamo
la realtà iconografica dell'icona venerata all'Isola; sappiamo solo, da
documenti, che in un determinato periodo storico era chiamata Sancta Maria ad
Praesepe.
Oggi l'Isola è
divenuta uno degli emblemi turistici della Calabria, ed è oggetto di interesse
e ammirazione di milioni di vistatori, rapiti non solo dall'imponente Scoglio e
dalla bellezza del suo Santuario, ma anche dal complesso paesaggistico nel quale
è immerso.
Un ulteriore
contributo, infatti, è dato, oltre che dal retrostante giardino dove è
presente una vasta varietà di vegetazione mediterranea, anche dal suggestivo
panorama che si gode, in particolare al calar del sole che all'orizzonte si
spegne nelle pendici del vulcano Stromboli.

Cattedrale
di Maria Santissima di Romania
La Cattedrale
di Tropea fu eretta nel 1163 durante la dominazione normanna e consacrata
all’Assunta. Si sviluppa a pianta basilicale su tre navate, con pilastri
ottagonali e conci policromi, come da tradizione del romanico siculo-normanno. A
causa di terremoti e incendi, venne rimaneggiata più volte nel corso dei
secoli. Fu riportata al suo stile “originario” tra il 1926 e il 1931, questi
interventi, tuttavia, cancellarono quasi ogni traccia di stile barocco e
neoclassico. Sulla facciata si apre l’ingresso principale con un portale
ad archeggio sopraelevato in tufo. Il complesso absidale esterno a tre
curvature ha archeggi decorativi con pietra tufacea e lavica.
La facciata
nord è quella originale di epoca normanna, si apre un altro portale
settecentesco di ridotte proporzioni rispetto al principale, sormontato da una
struttura in pietra, che riproduce il quadro della Madonna di Romania.
Nella prima cappella di destra troviamo sepolture della famiglia Galluppi,
risalenti al 1598 e al 1651, e la tomba del filosofo Pasquale Galluppi.
Nella seconda cappella è collocato un grande Crocifisso ligneo del XV secolo e
la tomba del Beato Francesco Mottola. Andando avanti segue l’ingresso laterale
e la tomba della famiglia Gazzetta (1530).

Da qui si
accede alla sagrestia e alla sala capitolare che ospita i ritratti dei
Vescovi della Diocesi e arredi lignei settecenteschi. Proseguendo si giunge alla
cappella della Madonna delle Grazie e del S.S. Sacramento e di
Santa Domenica che ospita pregevoli altari in marmo policromi e decorazioni
del 1740. I pennacchi della volta e delle lunette ospitano tele di Giuseppe
Grimaldi raffiguranti il martirio di Santa Domenica. Uscendo dalla cappella, vi
sono l’organo e l’altare con la Madonna del Popolo, opera di Giovanni
Angelo Montorsoli, allievo del Buonarroti, scolpita nel 1555.
Sulla parete
dell’abside maggiore è collocata l’icona in legno di cedro della Vergine
Maria di Romania, opera di scuola giottesca attribuita a Lippo di Benivieni
(prima metà del XIV). La pietà popolare le attribuisce numerosi
miracoli che protessero la città da terremoti, pestilenze e dalla distruzione
bellica. Nella navata maggiore troviamo il pulpito settecentesco sotto il quale
è collocato un bassorilievo della Natività, opera di Pietro Barbalonga (1598).
Passando dalla
navata sinistra, nell’abside troviamo un pregevole tabernacolo marmoreo di
scuola toscana del XV secolo, commissionato dal Vescovo Pietro Balbo, e sopra la
statua della Madonna della Libertà in marmo carrarese (del XVII), ex
voto per l’annullamento della vendita di Tropea in favore del Principe
Vincenzo Ruffo nel 1615. Sull’uscita laterale verso nord, un bassorilievo
raffigurante la Resurrezione, attribuito al Gagini (metà del XVI secolo) e
due tondi raffiguranti l’Annunciazione, dello stesso periodo.
 Culto
della Madonna di Romania - Sull’arrivo
del quadro della Madonna di Romania la leggenda tramanda che al tempo delle
lotte iconoclaste, giunse un’icona su una imbarcazione proveniente
dall’oriente bizantino sospinta da una tempesta nel porto di Tropea: per
questo venne denominata Madonna di Romania (con Romània si intendeva
l’Impero Romano d’Oriente). Riparati i danni, il capitano cercò di
ripartire, ma la nave rimase ferma. Nella stessa notte, il vescovo della città
sognò la Madonna che gli chiese di rimanere a Tropea e diventarne la
Protettrice. Il sogno si ripeté per varie notti. Alla fine il Vescovo, convocati
gli alti funzionari e i cittadini, si recò al porto a prendere il quadro
della Madonna. Non appena il quadro fu portato a terra la nave ripartì. Culto
della Madonna di Romania - Sull’arrivo
del quadro della Madonna di Romania la leggenda tramanda che al tempo delle
lotte iconoclaste, giunse un’icona su una imbarcazione proveniente
dall’oriente bizantino sospinta da una tempesta nel porto di Tropea: per
questo venne denominata Madonna di Romania (con Romània si intendeva
l’Impero Romano d’Oriente). Riparati i danni, il capitano cercò di
ripartire, ma la nave rimase ferma. Nella stessa notte, il vescovo della città
sognò la Madonna che gli chiese di rimanere a Tropea e diventarne la
Protettrice. Il sogno si ripeté per varie notti. Alla fine il Vescovo, convocati
gli alti funzionari e i cittadini, si recò al porto a prendere il quadro
della Madonna. Non appena il quadro fu portato a terra la nave ripartì.









Successivamente
la Madonna verrà ancora in sogno ad un altro vescovo, Ambrogio Cordova,
avvertendolo di un terremoto che avrebbe devastato la Calabria. Questi, il 27
marzo 1638, istituì una processione di penitenza, che coinvolse tutto il popolo
tropeano. Durante la processione si scatenò il terremoto che non procurò alcun
danno ai tropeani. Da questo avvenimento si rafforzò la devozione di Tropea per
questa Madonna, a cui i tropeani riconoscendone la sua intercessione benefica,
la proclamarono Protettrice, e tutt’oggi i tropeani ricordano quel 27 di marzo
1638.
Attribuite alla
Madonna di Romania furono anche la salvezza dall’epidemia di peste che nel
1656 si espanse in tutto il regno di Napoli e che portò migliaia di
vittime e poi, durante la seconda guerra mondiale, la non esplosione di sei
grandi ordigni bellici, due di questi custoditi nella Cattedrale di Tropea a
ricordo di quella tragedia evitata. Il 9 settembre di ogni anno,
anniversario della Incoronazione della Sacra Icona, si svolge la processione che
accompagna la venerata Immagine per le vie cittadine insieme a tutte le
confraternite religiose. La partecipazione popolare è altissima e la
devozione alla Madonna è confermata dagli innumerevoli fedeli, che nei giorni
della Novena che precede la festa, partecipano con entusiasmo e devozione,
celebrando con inni e canti le lodi alla Madre di Dio.
Chiesa
del Gesù
La Chiesa del Gesù risale
agli inizi del 1600, edificata dai Padri Gesuiti giunti a Tropea
nel 1594. L’edificio sorge sul sito dell’antica chiesa di “San
Nicola della Cattolica” (VIII-IX sec.), Cattedrale di Tropea prima del
Duomo attuale, ma di rito greco-ortodosso. Demoliti i resti dell’antica
chiesa bizantina, fu costruita la chiesa come la vediamo oggi sul disegno della
Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli (a croce greca, con cupola e volte a botte sulle
braccia, che però non fu mai completata).
La
facciata è in stile barocco in sintonia con l’interno. Vi abbiamo
quattro lesene in rilievo sporgenti dalla parete facciale che reggono il
timpano, al cui centro si apre un finestrone con lo stemma dei Padri Gesuiti
“I.H.S”: Iesus Hominum Salvator (Gesù Salvatore degli uomini). In
mezzo alle lesene vi abbiamo quattro nicchie terminanti a gusci di conchiglia
con le statue dei maggiori Santi Dottori della Chiesa d’Occidente:
Sant’Agostino, San Gregorio Magno, Sant’Ambrogio e San Girolamo.
L’ingresso è composto da una massiccia porta a cassone ornata di croci e
rosoni in bronzo. Sopra l’altare maggiore troviamo la tela della “Circoncisione
di Gesù” attribuita a Giuseppe Schifino (1580-1640). Sui pennacchi,
sulle lunette sotto la cupola e sulle pareti di fondo vi sono effigiate le virtù
e scene bibliche a firma del pittore tropeano Giuseppe Gaetano Grimaldi
(1690-1748).
Sempre
dello stesso autore abbiamo la grande tela de “La Natività” che
si si ammira sopra il portone d’ingresso. L’opera è datata 1731 e occupa
ben 38 metri quadrati; raffigura al centro la Madonna col Bambino e intorno
scene di vita campestre e pastorale. Sulla sinistra vi abbiamo l’autoritratto
del Grimaldi mentre indica la Natività. Entrando in chiesa, sulla sinistra
troviamo il busto di Carlo Scattaretica con l’epigrafe in cui viene riportata
la sua donazione di 600 ducati nel 1676 per il rifacimento della chiesa e la
Cappella di Sant’Alfonso Maria dei Liguori (1696-1787), fondatore della
Congregazione dei Missionari Redentoristi. L’altare settecentesco è in tarsie
marmoree, fu comprato a Messina dal P. Vito Michele Di Netta e dedicato al santo
fondatore dei Redentoristi in occasione della sua canonizzazione nel 1839.

Forse
questi marmi appartenevano a chiese distrutte dal terremoto del 1783. A sinistra
di questo altare spicca la tela di San Clemente Maria Hofbauer (1750-1820)
e sulla destra il Patrono della Calabria, San Francesco di Paola (1416-1507).
Prima questa cappella era dedicata a San Nicola. La cappella che si trova
sulla destra è dedicata a San Gerardo Maiella (1726-1755). Questo altare è
un’imitazione simmetrica in stucco dell’altare di Sant’Alfonso Maria dei
Liguori. In questa cappella vi abbiamo le statue della Madonna Addolorata e il
Crocefisso, a cui originariamente la cappella era dedicata. Nella parete
sinistra troviamo la tomba del Venerabile Servo di Dio P. Vito Michele Di Netta
(1787-1849). Avanzando verso il centro della chiesa, sulla sinistra troviamo
l’altare di Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556), fondatore dell’Ordine dei
Gesuiti. La tela, opera di Giuseppe Pascaletti (1699-1757), raffigura il santo
mentre ha una visione di Gesù che gli dice: “A Roma ti sarò
propizio”.
Ai
lati di questo altare si ammirano due tele del Grimaldi: quella di destra
raffigura Sant’Ignazio mentre scrive gli esercizi spirituali dettati dalla
Madonna, mentre quella sinistra rappresenta la morte del santo. Sopra l’altare
si ergono le statue in gesso di San Francesco Borgia (1510-1572) e San Francesco
de Geronimo (1642-1716). Al centro di questo altare, in alto, la statua della
Immacolata e sulla destra il busto di San Gennaro (+ 305). Sotto l’altare vi
è il simulacro di Santa Filomena (+ 311). Sulla destra della chiesa troviamo
l’altare di San Francesco Saverio (1506-1552), uno dei primi compagni di
Sant’Ignazio chiamato “l’apostolo delle Indie”. Sopra l’altare vi
abbiamo un’altra tela di Giuseppe Pascaletti raffigurante il santo.
Ai
lati dell’altare vi troviamo due tele del Grimaldi: sulla sinistra San
Francesco Saverio nell’atto di ricevere il crocifisso recuperato da un
granchio e sulla destra la morte del santo. Le due statue in gesso poste in alto
sull’altare rappresentano a sinistra San Stanislao Kostka col Bambino Gesù
(1550-1568) e a destra San Luigi Gonzaga (1568-1591), ambedue santi gesuiti. Il
alto al centro vi abbiamo Dio Padre. Sotto l’alare vi abbiamo la statua lignea
settecentesca del Cristo Morto che ogni anno, il Venerdì Santo, viene portata
in processione insieme a quella della Madonna Addolorata. Il grande lampadario
ottocentesco in vetro di Murano fu regalato dal conte Pasquale Gabrielli in
segno di riconoscenza ai Missionari Redentoristi.
Chiesa
della Michelizia

La chiesa della
Michelizia, sorta in onore
della Madonna della Neve, è un monumento architettonico tra i più rari della
Calabria per la sua cupola rinascimentale;
Le origini risalgono al XIII secolo dedicata a Santa
Maria della Neve, anche se è conosciuta come “Chiesa di S. Maria
Michelizia” o più semplicemente “Chiesa di Michelizia” secondo
la tradizione che la ritiene fondata da un ricco mercante siciliano di nome
Michele Milizia (da cui Michelizia) che,
in una notte di tempesta, trovandosi in pericolo in mezzo al mare, fece voto
alla Madonna della Neve che avrebbe edificato una chiesa se si fosse salvato.
Immediatamente, apparve una luce lungo la costa e il ricco navigatore si salvò,
costruendo proprio in quel luogo la chiesa in onore della Madonna della Neve.
L'edificio consta di due parti distinte anche se
accostate: la parte cupolata e la navata longitudinale. La parte più
interessante è la cupola. La sua struttura architettonica di influenza
bizantino-araba. Infatti,
la monumentalità della parte cupolata, la razionalità delle forme geometriche,
il movimento ascensionale, dal cubo sottostante al tamburo centrale, sono
elementi che creano una forma estetica di alto valore e di piena originalità.
L'edificio può essere ammirato dal porto di Tropea o dall'orto retrostante la
chiesa, che un tempo campeggiava su un grande agrumeto e forniva ai suoi
visitatori la possibilità di ammirare un paesaggio stupendo della rupe di
Tropea.
Altri
luoghi d'interesse

La chiesa di San Francesco di
Paola, fondata nel 1552,
testimonia il passaggio a Tropea di S. Francesco di Paola, che volle costruire
fuori dalle mura della città una chiesa e un convento, attualmente la chiesa si
contraddistingue per un elaborato portale granitico, il convento invece oggi è
una villa privata;
La cappella di S. Margherita
invece è un monumento
funebre del XIV sec. di notevole interesse storico, infatti presenta uno stemma
misterioso che induce gli studiosi ad attribuirlo ad una casa regnante,
purtroppo attualmente la zona, pur essendo nel centro storico, è in totale
abbandono;
La Chiesa dei Gesuiti o dei Liguorini
è una costruzione
seicentesca, la cui facciata è stata trasformata in età recente; all'edificio
è annesso l'antico collegio dei Gesuiti, che ora è diviso tra il Comune, che
vi ha sede, e i padri Liguorini;
La chiesa del Carmine, sorta nel 1569 fuori dal centro
città per generosa iniziativa del nobile tropeano Alessandro D'Aquino, fu
affidata ai padri carmelitani, annesso alla chiesa vi era un convento, che oggi
non esiste più. La chiesa del Carmine è stata modificata nel Settecento, come
testimonia l'interessante facciata e la sua splendida scalinata;
La chiesa
dell'Annunziata, costruita su volere
dell'imperatore Carlo V nel 1521 lontano dal centro storico di Tropea, è un
edificio ad una sola navata, in cui si distinguono per pregio l'altare in marmi
scuri, opera del Cinquecento con aggiunte del Seicento e il grande soffitto
rinascimentale-barocco a cassettoni.
Inoltre la città ospita, negli antichi locali del
Vescovato, il museo diocesano, contenente ori e argenti della cattedrale e
parecchie opere pittoriche, sculture e affreschi, manufatti e arredi.
Recentemente, inoltre, è stata aperta la sezione archeologica.
Un luogo divenuto il centro culturale cittadino è poi
il complesso di Santa Chiara, recentemente restaurato; esso ospita una sala
congressi nell'antica chiesa medievale, mentre le sale che furono un tempo parte
del convento delle clarisse sono state destinate al Museo civico del mare.
Numerosi e caratteristici sono gli affacci a mare,
chiamati anche villette, tra cui l'affaccio Raf Vallone o dei Sospiri, considerato
uno degli affacci più belli del Sud Italia.
Nel 2020, in occasione della festa della Repubblica,
alla presenza delle più alte autorità, è stata inaugurata la nuova piazza
della città, piazza Vittorio Veneto.

La
Cipolla Rossa
Le prime
coltivazioni della cipolla di Tropea risalgono al periodo
fenicio, quando venne introdotta nelle zone del vibonese e successivamente
nelle aree circostanti, per poi diffondersi lungo tutta la fascia del mar
Tirreno. A causa del suo forte odore distintivo e spesso poco
piacevole, la cipolla di Tropea e più in generale tutti i tipi di cipolle
sono sempre state bistrattate ed incomprese.
Tuttavia,
grazie alle qualità e potenzialità anche curative della
cipolla di Tropea, quest’ultima è riuscita nel tempo ad ottenere i meritati
riconoscimenti. Si dice addirittura che Plinio il Vecchio citi,
in un suo scritto, una certa qualità di cipolla prodotta in Calabria,
dalle particolari attività benefiche per la salute, diventando così un
prodotto indispensabile nella vita quotidiana dei romani. Conobbe un
più importante sviluppo durante il periodo borbonico, e venne così
introdotta anche sui mercati del nord Europa nei quali era sempre più
richiesta ed apprezzata. Le prime testimonianze scritte di una coltivazione
più sviluppata e redditizia sulla cipolla in Calabria si hanno
intorno alla prima metà del ‘900, con dati statistici riscontrabili all’interno
dell’Enciclopedia agraria Reda e grazie agli scambi commerciali che
la resero famosa anche nei mercati d’oltre oceano.
Le
caratteristiche specifiche della Cipolla di Tropea, che la rendono così
famosa ed apprezzata, non solo nel commercio nazionale ma anche
internazionale, sono determinate dalla particolare composizione della zona
di produzione in cui viene coltivata. Si tratta di un territorio
tipicamente sabbioso e argilloso, molto fertile e ricco di sostanze organiche,
il quale, insieme ad un microclima mediterraneo, crea le condizioni
perfette per la crescita e lo sviluppo di questo prodotto.
Questa
eccellenza del territorio viene coltivata lungo la costa tirrenica in vari
comuni delle province di Cosenza, Vibo Valentia e Catanzano, ma deve il nome a
Tropea perchè era dal suo porto che veniva spedita in tutto il mondo.
Le sue peculiarità
spiegano come sia diventata un’importantissima risorsa per l’agricoltura
calabrese non solo economica ma anche culturale; la cipolla
di Tropea infatti, per le sue singolari proprietà organolettiche ha creato
uno stretto legame con il suo territorio d’origine, che corrisponde
principalmente ai territori calabresi delle province di Vibo Valentia
e Catanzaro.
Dalla
caratteristica forma a trottola, un po’ allungata ai lati e
tondeggiante al centro, la Cipolla di Tropea è unica nel suo
genere ed è protetta dal bollino IGP, proprio per tutelare e assicurarne
la sua originalità. Nonostante non rappresenti un’alta percentuale della
produzione e del commercio calabrese, la sua appetibilità è apprezzata e ricercata
in tutto il mondo, sia sui mercati nazionali che su quelli esteri.

La preparazione
dei vivai per la crescita delle Cipolle di Tropea avviene tra
l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre; i vivai
vengono ricoperti con delle felci per proteggere la germinazione del bulbo.
Il trapianto
dei fili di cipolla, tolti dai vivai, avviene poi verso novembre e si dovrà
aspettare fino a febbraio per veder germogliare i primi cipollotti, mentre
da aprile/maggio sarà possibile raccogliere le primizie.
La Cipolla di
Tropea viene commercializzata in modi differenti:
- il cipollotto,
ad esempio viene venduto in mazzi;
- la cipolla da
consumo, che presenta dimensioni maggiori rispetto al cipollotto si trova
in commercio fresca;
- la cipolla
da serbo, invece, ha un colore violaceo e presenta bulbi disidratati,
spesso viene venduta in trecce.
Il suo
inimitabile e distintivo color rosso intenso è dato dalla
sua particolare composizione organica ricca di antocianine. Si
tratta di composti polifenolici solforati che appartengono alla
famiglia dei flavonoidi e caratterizzano il prodotto in maniera unica
e riconoscibile.
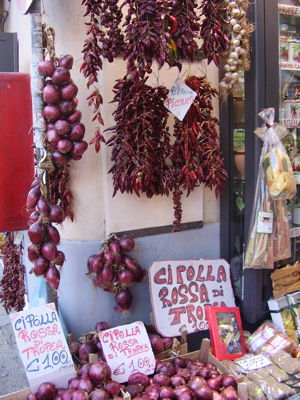 Le specificità
della cipolla rossa di Tropea sono dovute principalmente
all’interazione con l’ambiente, al tipo di terreno, e a caratteristiche
quali vicinanza con il mare, temperatura, umidità e ore di esposizione ai
raggi solari. Sembrano elementi scontati ma sono proprio le peculiarità
del territorio e del clima che conferiscono delle specifiche qualità
fisiche ed organolettiche ad un qualsiasi prodotto, cipolla di Tropea inclusa. Le specificità
della cipolla rossa di Tropea sono dovute principalmente
all’interazione con l’ambiente, al tipo di terreno, e a caratteristiche
quali vicinanza con il mare, temperatura, umidità e ore di esposizione ai
raggi solari. Sembrano elementi scontati ma sono proprio le peculiarità
del territorio e del clima che conferiscono delle specifiche qualità
fisiche ed organolettiche ad un qualsiasi prodotto, cipolla di Tropea inclusa.
Le suevarie
tipologie differiscono per forma, che può essere più
tondeggiante o allungata, e per maturazione. Quest’ultima determina tre
sottoprodotti:
- la precoce,
viene raccolta tra aprile e maggio;
- la medio-precoce è
raccolta tra maggio e giugno;
- la varietà tardiva raggiunge
maturazione nei mesi di giugno e luglio.
Anche il colore e la pezzatura possono cambiare e variare tra il rosso
intenso e quello più tenue per la prima caratteristica, mentre può essere
media o media-grossa per la seconda.
Prevalentemente
composta da acqua, la cipolla presenta uno scarso livello di
macronutrienti, nel dettaglio circa l’1% di proteine e grassi. I carboidrati
sono formati in quasi totalità da zuccheri semplici tra cui un polimero
del fruttosio che dal punto di vista nutrizionale risulta importante
per l’equilibrio della flora batterica.
Si tratta di
una fibra insolubile che permetterebbe la proliferazione di batteri della
flora bifida a scapito di quella putrefattiva, producendo benefici sulla
salute. Rilevanti sono infine alcuni elementi minerali quali potassio,
ferro, calcio e fosforo.
La cipolla,
nonostante sia poco amata per il suo odore persistente e poco
gradevole, sembrerebbe avere numerose qualità salutari. Si pensa
infatti abbia poteri afrodisiaci, caratteristiche antisettiche, diuretiche
ed anestetiche: in quest’ultimo caso ad esempio veniva utilizzata
contro le punture di medusa per ridurre il bruciore e l’infezione.
Sembrerebbe
essere un ottimo aiuto contro i reumatismi, il mal di testa, gli
ascessi, le verruche e le punture di insetti: sfregandone una parte sulla
puntura, infatti, si alleviano il dolore ed il prurito.
Evita inoltre raffreddori
ed influenze; in questo caso il consiglio è di posare una cipolla tagliata
a metà sul comodino o quanto più vicino al naso per permettere la
respirazione dei fumi salutari durante il sonno. È inoltre un buon alleato
contro il diabete, allontana il rischio tumorale e preserva dall’invecchiamento
cellulare.
La Cipolla
rossa di Tropea sprigiona il suo massimo gusto se mangiata cruda, in
insalata di pomodori, grazie alla sua polpa carnosa e croccante. Tuttavia
è possibile utilizzarla come ingrediente per sfiziose frittate o sottoforma
di confettura per delle crostate alternative. È ottima come sott’aceto,
oppure fresca come ingrediente per sughi o soffritti.

- Fonte
- https://it.wikipedia.org
- https://tropea-tourism.com/storia-e-cultura
- https://www.facebook.com/SantaMariadellIsola
|