|
Sulla
Piazza Umberto I s'affacciano anche importanti edifici civili: il Monte
delle Prestanze (Monte
di Pietà), progettato nella seconda metà del
Settecento dal Bonajuto ed oggi sede del Banco
di Sicilia, caratterizzato al piano inferiore da esili colonne
corinzie su alti plinti che marcano il susseguirsi
delle eleganti aperture; il Palazzo Crescimanno
d'Albafiorita, sontuosa dimora settecentesca ricca di opere d'arte; il
Palazzo Libertini di San Marco, il cui ingresso si trova in via Taranto.
Da qui si può compiere una digressione. Discendendo per la gradinata
che caratterizza la via Taranto, si giunge nella vecchia Piazza del
Mercato, oggi Piazza Innocenzo Marcinnò, da cui si diparte la via
Cappuccini, una stretta via medievale in fondo alla quale si trova il
Convento dei Cappuccini, costruito con l'adiacente chiesa alla fine del
Cinquecento; esso è meta di pellegrinaggi da parte dei devoti di padre Innocenzo
Marcinnò.
La
fondazione del primitivo convento risale al 1540. La
costruzione venne edificata fuori dalla città, in contrada
"Semini", conosciuta oggi come "Cappuccini vecchi".
A causa
dell'aria insalubre, il luogo venne abbandonato, e nel 1585 furono
avviati i lavori per l'edificazione del nuovo complesso conventuale, che
sorse accanto alla preesistente chiesa di Santa Maria Odigitria.
I frati
occuparono la nuova struttura nel 1607, a motivo del protrarsi dei
lavori edili.
Il
convento, per le sue notevoli dimensioni e per la sua favorevole
posizione, raggiungibile facilmente da tutto il Val di Noto, è
stato sede, nel corso dei secoli, di numerosi capitoli provinciali.
Qui maturò la vocazione religiosa il Venerabile padre Innocenzo
Marcinò (1589-1655), ministro generale dell'Ordine (1643-1650),
di cui è in corso il processo di Beatificazione.
Con la soppressione
degli ordini religiosi (1866), il convento e la chiesa divennero
proprietà demaniale. I frati vi fecero ritorno (anche se solo in
una piccola parte dell'intero complesso) nel 1955.

La
chiesa conventuale, dedicata a Maria Odigitria, possiede un'unica navata,
con una cappella, quattro altari minori e un pregiato soffitto ligneo
con capriate.
Il polittico dell'altare
maggiore si compone di sette dipinti: la pala centrale,
raffigura la Madonna Odigitria con i santi Giacomo e Bartolomeo,
opera del pittore manierista toscano, Filippo Paladini (1604);
a sinistra è collocata una tela con San Felice da Cantalice che
riceve il Bambino dalla Madonna, mentre a destra troviamo la Beata
Lucia da Caltagirone; entrambi i dipinti sono attribuiti a Semplice da
Verona (1646). Nell'appendice in basso a sinistra si trova il
ritratto, a mezzo busto, della martire Sant'Agata; mentre in
quella di destra la martire siracusana Santa Lucia; entrambe
le opere datate 1604, sono del Paladini. Infine, altri due piccoli
dipinti si trovano al di sopra delle tele laterali: a sinistra Cristo
coronato di spine; a destra l'Addolorata; attribuiti a Semplice da
Verona.
I
dipinti sono incastonati in una pregiata intelaiatura lignea, realizzata
dai frati Giuseppe e Giorgio da Ragusa, e Bernardino da Sortino. La
cornice è provvista di un magnifico tosello (tettuccio ligneo), sul
quale è dipinto l'Eterno Padre, l'Agnello Divino e i
quattro Evangelisti, opera del pittore palermitano Bernardino
Bongiovanni (XVIII sec.).
L'altare
maggiore, infine, custodisce una pregevole custodia lignea,
realizzata in noce con intarsi in avorio, cipresso e tartaruga,
opera di frati ebanisti trapanesi (XVII sec.).
Meritano,
ancora, di essere menzionati: gli altari-reliquiari di Sant'Antonio, San
Francesco e dell'Addolorata, l'artistico reliquario della Cappella
delle reliquie e il sacrario del Venerabile Innocenzo Marcinò da
Caltagirone.
Nella cripta del
convento, è allestito un monumentale presepe permanente, in terracotta locale.
Il
convento, inoltre, è sede del museo provinciale Padre
Innocenzo Marcinò, in cui si ammira una ricca pinacoteca, diverse
custodie di pregevole fattura (secoli XIV-XVII), antichi paramenti
liturgici ricamati a mano e preziose suppellettili liturgiche in
argento.

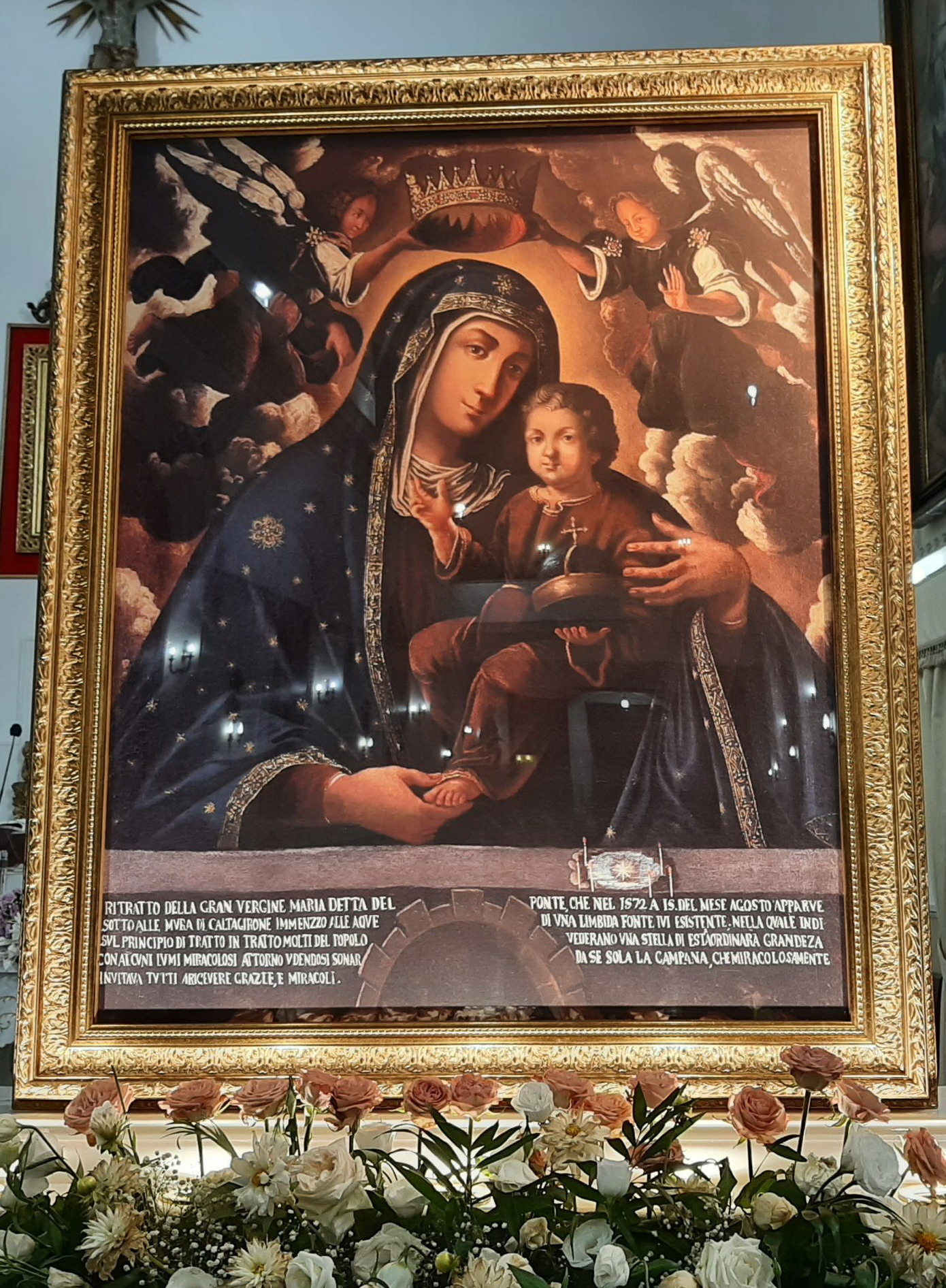
Mediante
la via Maria Santissima del Ponte, si giunge al Santuario di Santa Maria
del Ponte, edificato nella seconda metà del Cinquecento ed interamente
ricostruito nel Settecento.
Il
Santuario di Santa Maria del Ponte di Caltagirone (Catania). Nel
santuario è conservato un reliquiario in legno, dove si riconoscono le
reliquie di vari santi, fra cui un frammento della Croce di Cristo. Il
15 agosto 1572, alla fonte del rione Ponte, una bambina sordomuta,
attingendo acqua, vide riflessa la Vergine con in braccio il Bambino Gesù.
La notizia si sparse per l’intero paese, ma l’immagine della Madonna
era visibile soltanto a chi era in grazia di Dio.
Un
pittore ritrasse la Vergine (il dipinto è conservato nel santuario) e
un anno dopo il quadro si trovava sul luogo dell’apparizione. Alla
fine del XVI secolo si avverò un altro straordinario evento: la
domenica dopo il giorno dell’Ascensione si udirono le campane suonare
spontaneamente e nella fonte, ormai divenuta celebre, si vide una Stella
luminosa con sei candele intorno.
Dal
1777 Maria Santissima del Ponte è patrona della città e nel 1942 il
santuario fu eretto a parrocchia. Nella metà degli anni Sessanta del
Novecento fu costruita la nuova chiesa parrocchiale, dove fu posta
l’immagine della Vergine e nel 1987 divenne santuario mariano
diocesano. L’anno successivo l’immagine di Maria Santissima fu
incoronata da monsignor Vittorio Mondello, vescovo di Caltagirone.
L’antica
fonte dell’apparizione è oggi inglobata all’interno del santuario,
in una cappelletta marmorea, a cui i pellegrini attingono l’acqua
miracolosa. Nel nuovo tempio troviamo anche due bassorilievi
all’ingresso, mosaici, una via Crucis in terracotta, una vetrata
istoriata che rappresenta l’apparizione, una statua della Pietà e del
Sacro Cuore, abside in ceramica e presepio in terracotta. Sulla destra, in via
Discesa del Collegio, si può ammirare la chiesa del Gesù o del
Collegio che,
insieme al Collegio dei Gesuiti, costituisce uno dei principali
aggregati monumentali ubicati nel centro storico.
Il 18
di settembre del 1569 il Viceré
di Sicilia Francesco Ferdinando d'Avalos, principe di
Francavilla, suggerisce al Consiglio Comunale di Caltagirone, la
fondazione di un Collegio
dei Gesuiti facendo presente i vantaggi che avrebbe ottenuto
la popolazione " ...così in fatto di religione come in fatto
di istruzione".
Nel
1571 ha avvio la costruzione, nel 1574 dirige i lavori l'architetto
messinese Andrea
Calamech, tra il 1589 e il 1592 si registra l'intervento di Antonuzzo
Gagini. Nel 1593 è documentata l'apertura al culto celebrata con
l'iscrizione marmorea "TEMPLVM HOC QVOD AN. MDLXX SENATVS
MVNIFICENTIA EREXIT ANNO MILLESIMO QVINQVAGESIMO NONAGESIMO TERTIO JESV
NOMINE DICATVM EST".
 Il terremoto
del Val di Noto del 1693 atterra le fabbriche risparmiando
il primo ordine delle costruzioni. Nel XVIII
secolo segue una campagna di restauri, lavori conclusi con
la consacrazione avvenuta il 21 dicembre del 1733, rito presieduto da
monsignor Matteo
Trigona, vescovo di Siracusa. Il terremoto
del Val di Noto del 1693 atterra le fabbriche risparmiando
il primo ordine delle costruzioni. Nel XVIII
secolo segue una campagna di restauri, lavori conclusi con
la consacrazione avvenuta il 21 dicembre del 1733, rito presieduto da
monsignor Matteo
Trigona, vescovo di Siracusa.
Nel
1767 con la Soppressione
della Compagnia di Gesù, i religiosi Gesuiti sono
costretti ad abbandonare la città. Le religiose teresiane
subentrate nella gestione delle strutture hanno introdotto ed
incentivato il culto di Santa Teresa d'Avila.
Le
religiose provenienti dall'antico palazzo di monsignore Bonaventura
Secusio, abitarono la sede gesuitica fino al 14 gennaio 1876,
anno in cui furono trasferite nel monastero del Santissimo Salvatore.
Il 28
ottobre del 1876 fu attuato il progetto di restauro e riduzione dell'ex
collegio - monastero per adattarlo a locali per istituto di Pubblica
Istruzione. I lavori si protrassero fino al 1886.
Il terremoto
di Messina del 1908 ha causato ulteriori distruzioni, il
sindaco Luigi
Sturzo suggerisce al Rettore di chiudere la chiesa, essa sarà
riaperta al culto nel 1910.
Nel
1921 la chiesa versava in uno stato di degrado avanzato, per la pubblica
sicurezza si decise di togliere le statue che decoravano il prospetto,
fu demolito l'antico campanile.
I
bombardamenti aerei del secondo
conflitto mondiale hanno arrecato danni nei prospetti, in
particolar modo all'apparato decorativo della facciata. Il pomeriggio
del 9 luglio 1943 delle fortezze volanti americane, nel tentativo di
ostacolare l'avanzata della divisione tedesca, sorvolarono Caltagirone
sganciando su di essa centinaia di bombe. Fu colpita la piazzetta
antistante il prospetto e alcuni palazzi adiacenti, con lo spostamento
d'aria il portone principale fu scardinato, il tetto dissestato e
frantumati tutti i vetri.
Nel
1955 ha inizio un ciclo di restauri, completato nel 1959.
L'inaugurazione della chiesa avvenne nel 1960, mentre nel 1980 il
convento fu oggetto di restauri e consolidamento strutturale ad opera di
Salvatore Boscarino.
Il
prospetto è rivolto a sud - ovest, abside rivolta a nord - est. Il
campanile è stato ricostruito a nord, estremità lato sinistro. Il
tetto a falde presenta nel suo intradosso un soffitto a cassettoni di
recente realizzazione.
La
facciata è ripartita in due ordini, quello inferiore è il più antico.
Il prospetto presenta nella partizione centrale un portale sormontato
da finestrone con timpano ad arco. il telaio verticale del prospetto è
costituito da una serie di tre lesene per
lato al piano terra, che diventano due nel livello superiore. Fra coppie
di lesene in nicchie sovrapposte sono collocate le statute di otto santi
appartenenti alla Compagnia di Gesù. In basso a destra accanto al
portale i cartiglio indica San
Francesco Saverio. Degli altri sette, seguendo l'esposizione
presente sulla facciata di Casa
Professa, è verosimile identificare San
Francesco Regis, San
Giacomo Kisai, San
Giovanni Soan di Gotò, Sant'Ignazio
di Loyola, San
Francesco Borgia, San
Paolo Miki, San
Francesco de Geronimo o San
Stanislao Kostka.
Due cornicioni - marcapiano separano
i due ordini, due volute a ricciolo raccordano esternamente il secondo
ordine al primo. Sulle mensole ricavate su ciascuna di esse, sono
collocate rispettivamente le statue raffiguranti San
Pietro e San
Paolo. All'interno delle nicchie le sculture raffiguranti la Vergine
Maria a sinistra, e San
Giuseppe a destra.
Il
portale presenta colonne binate con capitelli
corinzi collocate su alti plinti.
Il fusto inferiore presenta degli arabeschi, quello superiore è
scanalato per i due terzi. L'architrave presenta
dadi aggettanti sormontati da volute in rilievo, delimitate da vasotti
fiammati e grande stemma intermedio sorretto da putti. La prospettiva si
chiude con un frontone contraddistinto
da lunetta centrale,
delimitato da vasi fiammati e sormontato da croce apicale in ferro
battuto.
Controfacciata:
nel 1623 fu realizzata la cantoria lignea posta sopra l'ingresso
principale, le due tribunette laterali ed il pulpito.
All'interno, ad unica navata, si
possono ammirare le preziose decorazioni in stucchi e marmi, il soffitto
a cassettoni, l'altare barocco con colonne tortili in marmo mischio, il
fastoso pulpito in legno intarsiato e le pregevoli cappelle laterali tra
cui si segnalano, in particolare, quella della Pietà e quella dedicata
ad Ignazio
di Loyola, fondatore dell'ordine dei Gesuiti,
particolarmente elaborata e riccamente ornata.
Nella vicina via degli
Studi si erge il Collegio dei Gesuiti: particolarmente degni di nota i
due portali attraverso cui s'accede ai due cortili un tempo non divisi.
Si tramanda che il Collegio abbia avuto fra i suoi discepoli anche
Giuseppe Balsamo, conte
di Cagliostro.

Nelle
immediate vicinanze, in via Discesa Verdumai, dopo pochi gradini
s'arriva davanti al Teatro Stabile dell'Opera dei Pupi. Il museo
ha sede negli stessi ambienti che hanno ospitato la "primaria
compagnia", nata nel 1918 grazie a don Giovanni Russo e attiva fino
al 1989, anno della scomparsa di Gesualdo Pepe, che fino all’ultimo
sarà regista, impresario, allestitore e soggettista del piccolo stabile
calatino.
L'esposizione
ripercorre il cammino storico dell'opera dei pupi siciliani attraverso
una collezione di oltre 120 pupi del periodo 1918-1920, cartelloni
d'epoca, armature, costumi, scenari, rappresentazioni e supporti
audiovisivi.
Piazza
Municipio un tempo era detta della Loggia per la presenza di una grande
balconata dalla quale la nobiltà cittadina assisteva alle pubbliche
manifestazioni.
Sulla piazza s'affacciano alcuni degli edifici
storicamente più rilevanti della città: il barocco Palazzo dei
principi Interlandi Bellaprima o Palazzo dell'Aquila, oggi sede del
Municipio, ridisegnato in linee neoclassiche ed arricchito da uno
scalone dell'architetto Nicastro. Girando attorno al palazzo se ne può
ammirare il retro in stile liberty; l'ex Palazzo Senatorio, poi
trasformato nel Teatro Comunale Garibaldi ed oggi occupato dalla
Galleria Luigi Sturzo; il Palazzo dei principi Gravina, oggi dei baroni
Pace Gravina, in stile tardo rinascimentale, sul cui prospetto risalta
il balcone sostenuto da decorativi mensoloni attribuiti ai Gagini; la
Corte Capitaniale, in origine sede del Capitano di Giustizia, con
seicentesche decorazioni, dei Gagini, alle finestre.
La
chiesa di Santa Maria del Monte, l'antica Matrice, risale alla fine del
medioevo ma oggi si presenta con l'aspetto conferitole dalla
ricostruzione settecentesca. Fu probabilmente costruita utilizzando le
pietre dell'antico castello di Caltagirone. Al suo interno sono
custoditi un prezioso dipinto del XIII
secolo raffigurante la Madonna
di Conadomini, sculture cinquecentesche, una statua
marmorea gaginesca del Quattrocento
raffigurante la Vergine col Bambino ed una pittura lucchese del secolo
XIII. La campana d'Altavilla, strappata ai musulmani dalla rocca di
Judica al tempo del conte Ruggero, rappresenta ancora oggi il simbolo
della memoria storica della città.
Nel piazzale antistante la chiesa,
alcune rampe di scale portano all'ex Istituto Salesiano di
Sant'Agostino, luogo dove sorgeva l'antico castello. La chiesa di Santa
Maria del Monte è uno dei pochi casi di edifici in cui la scalinata che
la precede è più apprezzata della chiesa stessa.
Di
straordinario effetto visivo, le vivaci formelle che adornano la Scala
di Santa Maria del Monte; sono tutte realizzate in maiolica e
dipinte a mano, con motivi ornamentali che riflettono la storia della
città e della Sicilia intera. Echi della sapienza greca, araba - cui si
devono tecniche più avanzate per lavorare l'argilla locale e impiegare
colori e smalti - normanna, genovese, spagnola si assommano in questo
spettacolare capolavoro, ulteriormente valorizzato dalle migliaia di lumere
che per alcune ore, a fine luglio, vengono accese la sera per celebrare
il patrono.
 Era
stata originariamente costruita a sbalzi che ne interrompevano la
pendenza da maestranze gaginesche coordinate
dal capomastro regio Giuseppe Giacalone. Era
stata originariamente costruita a sbalzi che ne interrompevano la
pendenza da maestranze gaginesche coordinate
dal capomastro regio Giuseppe Giacalone.
Nel 1844 furono
unificate le varie rampe, su progetto dall'architetto Salvatore
Marino. Nacquero così i 142 gradini della scalinata di Santa
Maria del Monte, che dal 1954 è
decorata interamente, nelle alzate dei gradini, con mattonelle di ceramica policroma
prodotte dalla Maioliche
Artigianali Caltagironesi. In ogni alzata di gradino è stato
applicato un rivestimento di maiolica policroma,
dello stesso tipo di quella che, nei secoli, ha reso famosa la città. I
temi figurativi, floreali o geometrici, rappresentano nella serie di
blocchi lo stile arabo, normanno, svevo, angioino-aragonese, spagnolo, chiaramontano,
rinascimentale, barocco, settecentesco,
ottocentesco, contemporaneo.
Le
maioliche sono decorate con motivi isolani che vanno dal X al XX
secolo, raccolti e adattati - si legge a piè di scala - da Antonino
Ragona. L'effetto è mirabile e il colpo d'occhio davvero
spettacolare.
La
scala dei 142 gradini è annualmente illuminata il 24 ed il 25 luglio
(per la festa di San
Giacomo, patrono della città), da migliaia di lumini a fiammella
viva. Poiché in questa occasione è interrotta ogni forma di
illuminazione elettrica,
il risultato visivo che ne deriva è una sorta di colata lavica,
un fiume di fuoco che nella sua palpitante luminosità disegna eleganti
figure decorative, frutto dell'abilità di un capomastro, agli ordini
del quale lavorano diverse decine di addetti alla sistemazione delle
lucerne. A formare il singolare arazzo di
fuoco è un insieme di quattromila lanternine dette "lumere".
L'illuminazione
della scala ha storia antica. Il primo ad aver pensato, verso la fine
del 1700,
ad un disegno luminoso, fu l'architetto Bonaiuto. Ma si deve ad un
frate, Benedetto
Papale, la scenografia della scala illuminata. Per quarant'anni
il monaco disegnò motivi ornamentali, soprattutto floreali, di grande
effetto. La sistemazione a disegno prestabilito della luminaria
presuppone un mese di preparazione. Gli addetti se ne tramandano l'arte
di padre in figlio.
Il
momento della collocazione delle quattromila lucerne ("coppi")
è assai curioso. Vi si assiste nel più rigoroso silenzio. È il
capomastro a dirigere la "chiamata" del disegno, che consiste
nel deporre lentamente i "coppi" al loro giusto posto.
Emozionante è il momento dall'accensione: un gran numero di uomini,
molti dei quali ragazzi, appostati lungo la scalinata, attendono il
segnale convenuto (è fissato alle 21:30) per accendere gli stoppini con
steli di piante secche,
chiamati "busi". Le "lumere" s'accendono
all'improvviso, una dopo l'altra, dando vita ad un impressionante
serpente di fuoco. L'arazzo ha vita per un paio d'ore, nel corso delle
quali una marea di spettatori s'assiepa festosamente ai piedi. In
primavera (maggio-giugno), la scala decorata con composizioni floreali:
migliaia di piantine in vasetto sono sistemate sui gradini col fine di
comporre un determinato tema.
La
scala, vera opera d'arte degli abili ceramisti locali, fu progettata nel
Seicento per collegare la città bassa (piano di San Giuliano), e cioè
la parte nuova della città, a quella alta, al centro storico, ed è costituita
da una serie di centoquarantadue gradini in pietra lavica decorati, nel 1953,
da mattonelle in maiolica nei tipici colori della ceramica di
Caltagirone, fra cui prevalgono il verde, l'azzurro e il giallo. Ogni
gradino è decorato con mattonelle diverse, con motivi geometrici o
figure tratte dalla tradizione locale raccolti da Antonino Ragona.
L'intera gradinata è suddivisa, per così dire, in settori costituiti
da quattordici gradini in cui le decorazioni delle maioliche si
richiamano a diversi periodi storici, dal X
secolo ai nostri giorni. È un vero spettacolo di
colori, ma ancor di più quando, in occasione della festa patronale di
san Giacomo, che si svolge in luglio, viene illuminata da migliaia di
lanterne di color bianco, rosso e verde disposte in modo da disegnare
un'immagine.

Quasi
a metà della scala, in via del Carmine, sorge la chiesa del Carmine, su
uno spiazzo dal quale si gode una bella vista sui tetti della città.
La
Chiesa dell’Annunziata, più comunemente detta del “Carmine" fu
sede dei Carmelitani che giunsero in città intorno al 1396. L'Ordine
dei carmelitani, sorto in Oriente nella seconda metà del XII secolo
prese il nome dal Monte Carmelo in Palestina sul quale si raccolsero un
gruppo di asceti che avevano partecipato alle crociate, si
contraddistingue per una regola di vita fondata sulla contemplazione, il
silenzio, la solitudine, la preghiera intensa. Oggi la chiesa, in parte
ricostruita dopo il rovinoso terremoto del 1693 che sconvolse gran parte
della Sicilia Orientale, si presente con un prospetto del settecento
semplice e maestoso che rispecchia le regole dell'Ordine ed ornato da un
portale in pietra dura opera di scuola gaginesca; i venti gradini della
scalinata che consentono l’accesso alla chiesa esaltano le forme
architettoniche e sottolineano la solennità del luogo di culto; quello
che un tempo, poi, era il convento destinato ad ospitare l'Ordine dei
Padri Carmelitani Scalzi e che si estendeva sulla sinistra fin quasi ad
affacciarsi lungo la scalinata, dopo la ricostruzione dovute ai
bombardamenti del 1943, fu adibito a scuola elementare.
La
pianta della chiesa è a croce latina ad unica navata ed è
caratterizzata da diciotto grandi lesene sormontate da eleganti
capitelli in stile corinzio, mentre gli affreschi di Bernardino
Dongiovanni, che, impreziosiscono la volta, raffigurano
l’Incoronazione della Vergine Maria; ai lati, in due medaglioni, sono
rappresentate figure femminili simboleggianti le due virtù teologali
della Fede e della Carità.
Numerosi
sono i tesori custoditi negli alteri laterali: quello di S. Teresina di
Gesù Bambino, dove una nicchia custodisce la statua della santa, la
Cappella dell’Annunziata con un quadro ad olio dipinto nei 1878 dai
fratelli Vaccaro che raffigura la Vergine Maria inginocchiata, la
Cappella di san Spiridone in cui è raffigurato il santo che indossa
l’abito carmelitano ornato dalla croce abbaziale, l'artistico
Crocifisso ligneo posto nelòl'altare a destra del presbiterio.
 In
fondo alla navata, nelle pareti del transetto, si trova un antico quadro
ad olio con un’artistica cornice che raffigura la “Vergine tra i
Santi” con Gioacchino e Sant’Anna ed in basso San Giuseppe, il
profeta, Sisa, S. Alberto, Santa Teresa d’Avita e altri santi
carmelitani. In
fondo alla navata, nelle pareti del transetto, si trova un antico quadro
ad olio con un’artistica cornice che raffigura la “Vergine tra i
Santi” con Gioacchino e Sant’Anna ed in basso San Giuseppe, il
profeta, Sisa, S. Alberto, Santa Teresa d’Avita e altri santi
carmelitani.
Prima
dell'arco maggiore, racchiusi in due comici in stucco, si trovano due
quadri ad olio raffiguranti, a destra, S.Liborio Vescovo, a sinistra S.
Sirmione Stoch carmelitano. La devozione alla Madonna del Carmelo è
ancora oggi molto sentita dai calatini; in occasione della festa della
Madonna del Carmelo che si celebra il 16 luglio a ricordo
dell’apparizione delta Vergine a S. Simone Stoch (1251), numerosa è
la presenza di fedeli che partecipano devotamente alle solennità del
triduo di preghiera dedicato alla Vergine.
Alla base della scala, sulla sinistra, si trova la chiesa di San
Giuseppe dalla caratteristica pianta centrica non
comune nell'architettura siciliana.
Il
tempio fu costruito dal Comune di Caltagirone con delibera del 25 marzo
1572, in sostituzione della primitiva chiesetta
di Santa Barbara. Le strutture della chiesa seicentesca furono
rase al suolo dal terremoto
dell'11 gennaio del 1693. Prontamente ricostruito, il tempio fu
affidato alla Congregazione
dei falegnami e degli ebanisti.
I
lavori incominciarono nel 1746, i lavori furono affidati a Rosario
Gagliardi. Nel 1751 l'architetto tornò a Caltagirone per
realizzare la copertura centrale dell'edificio.
Nel
1863 Salvatore Strazzuso promosse il restauro ed il rinnovamento degli
stucchi della chiesa. Il 16 novembre del 1881 l'architetto del Comune di
Caltagirone, Gesualdo Montemagno, fu incaricato di progettare l'ingresso
rimasto sopraelevato dai lavori di abbassamento della strada sulla quale
prospettava.
Nel
1958 sul prospetto laterale fu collocato un pannello di maiolica,
raffigurante San Giuseppe artigiano, mentre nel 1968 il prospetto
principale fu restaurato ad opera della Soprintendenza
ai Monumenti di Catania.
La
pavimentazione in marmo fu rinnovata nel 1978. Alcune piastrelle di
maioliche policrome, data d'esecuzione 1864, sono custodite presso il
locale Museo
statale della ceramica.
L'edificio
presenta oggi un prospetto in conci di pietra d'intaglio con abside
rivolta ad occidente, composto da due registri sovrapposti terminati da
due piccoli campanili, nervature verticali costituite da paraste piatte,
concave e convesse arricchite da capitelli
corinzi. Il corpo centrale è aggettante rispetto alle strutture
campanarie, reca al centro il grande portale d'accesso
decorato da cornici e timpano ad arco, sormonta l'ingresso una finestra
tamponata. Nel secondo ordine sfaccettato, delimitato in basso da un
elaborato cornicione - marcapiano dalla
ricca modanatura,
è presente un grande oculo.
Le celle campanarie laterali presentano grandi monofore e copertura a
bulbo arricchite con sfere in pietra, pinnacolo e banderuola.
Tetto
costituito da una grande calotta semisferica, il tamburo che
la sostiene presenta delle finestre. Da due porte si accede anche a
delle scale a chiocciola in pietra attraverso cui si ha accesso ai
torrini campanari. L'entrata è posta ad un livello più basso del piano
di calpestio, una breve scalinata la collega al portone scalinato che
degrada sulla strada in forte pendenza.
Nel
campanile, a destra del prospetto, vi sono due campane: la campana
grande reca soltanto la data della fusione: 1760. Sulla campana mezzana
si legge «Mariae Virginis Sponsori - Dicatum hoc aes - Rev.do Sac.
Rectore Francisco Vaccaro. Anno 1816 - Acciaio (bronzo) di Gerbino
Francesco - Caltagirone».
Edificio
con aula unica a pianta decagonale con
sviluppo a ventaglio sul lato occidentale in corrispondenza dell'abside,
opera dell'architetto Rosario
Gagliardi su spunti rinascimentali tratti dagli studi di Sebastiano
Serlio e Andrea
Palladio. La pianta centrica presenta quattro nicchie rialzate da
un gradino e volta a cupola.
Il coro,
posto in posizione sopraelevata rispetto all'entrata principale. Sopra
il portale d'accesso alla navata è collocato un organo a canne,
arricchito da custodia in legno intagliato e indorato ad oro zecchino.
La
chiesa custodisce una piccola acquasantiera a muro posta sul lato destro
dell'entrata.
L'altare
si presenta come un ulteriore spazio rialzato di forma quadrata. Fu
completato nel 1963 dalla Confraternita
di Maria e Gesù utilizzando quattro colonne con capitelli,
disassemblate dalla chiesa
di San Gregorio e qui trasferite da padre Giacomo Cona. Nel
coro esisteva un pavimento ideato e dipinto nel 1755 da uno dei maggiori
esponenti coevi dell'arte della maiolica, Francesco Branciforti,
compagno di lavoro di Nunzio Campoccia, zio del celebre maiolicaro
Ignazio Campoccia.
La
finestra posta sopra l'altare maggiore contiene un dipinto realizzato
nel 1937 dal pittore Giuseppe
Barone raffigurante la Sacra Famiglia con San
Giuseppe nell'atto di svolgere la propria mansione di falegname. In
basso l'iscrizione "QUOS RELUCTANTES PER AC(?)A RERUM URGET
EGESTAS", sull'arco lo stemma con il motto "ITE AD JOSEPH
- 1883".
La
sopraelevazione con nicchia è costituita da colonne
ioniche sormontate da capitelli
corinzi e timpani sfalsati, architrave e frontone con
stemma intermedio. Nella grande nicchia centrale è collocata la statua
raffigurante San Giuseppe e Gesù fanciullo.

Effettuando una digressione sulla
medievale via San Bonaventura si possono osservare i palazzi gentilizi
Spadaro e Secusio. In fondo vi è la chiesa di San
Bonaventura, eretta nel 1624,
affrescata da Pietro
Paolo Vasta ed ornata da pregevoli maioliche.
Nell'antico
quartiere della Matrice il punto più panoramico è il piazzale che si
apre a partire dalla via Sant'Agostino, nei pressi della quale si trova
la chiesa di San
Nicola, esistente già nell'XI
secolo, che ha subito nel tempo numerose modifiche e
parziali ricostruzioni. Il bel campanile è del Maruviglia. La chiesa
ospita il Museo Etnologico Siciliano, una raccolta d'oggetti della
civiltà rurale che prevalentemente risalgono al periodo fra Ottocento e
Novecento.
Da qui, percorrendo la via San Gregorio, si giunge ad una
delle istituzioni più importanti della città, l'Istituto d'Arte per la
Ceramica, fondato nel 1928
con lo scopo di contribuire all'incremento ed al perfezionamento
dell'arte dei vasai ceramisti. L'Istituto accoglie, inoltre, un museo ed
una biblioteca, che dispongono di una raccolta di ceramiche rare e di
libri di grande valore documentaristico. Vi si trovano esposti anche i
migliori lavori realizzati dagli allievi dagli anni
cinquanta ad oggi.
 Accanto all'istituto si può
ammirare la Torre di San Gregorio, un tempo campanile del monastero
delle benedettine. L'ex Monastero e la Torre ospitano dal 1997
una mostra naturalistica permanente. Accanto all'istituto si può
ammirare la Torre di San Gregorio, un tempo campanile del monastero
delle benedettine. L'ex Monastero e la Torre ospitano dal 1997
una mostra naturalistica permanente.
L'esposizione
raccoglie reperti provenienti da varie zone della Sicilia ed in
particolare dal territorio di Caltagirone. Il comprensorio è presentato
in tutti i suoi aspetti, da quello geografico e geologico a quello
biologico. Vi è la possibilità, per i gruppi e le scolaresche,
d'assistere alla proiezione di audiovisivi e di svolgere attività
didattica con materiali geologici e biologici predisposti allo scopo.
Attraverso
immagini, schemi, cartografie, pannelli e bacheche interattive si passa
dai pesci fossili ai minerali. Completano la mostra un vasto erbario e
cinque bacheche con animali tipici dell'ambiente.
Se, partendo da Piazza Municipio, si
imbocca invece la via Luigi Sturzo, una delle più importanti della città,
si entra nel quartiere San Giorgio.
Subito, sulla destra, s'incontra la
chiesa del Purgatorio, il cui aspetto attuale si deve alla ricostruzione
settecentesca e al cui interno si possono ammirare numerosi dipinti di
pregevole fattura, realizzati dai fratelli Vaccaro.
A
fianco di codesta chiesa, si trova la settecentesca chiesa di Santa
Chiara, opera dell'architetto Rosario
Gagliardi, caratterizzata dalla pianta ellittica ed
arricchita da un bel pavimento maiolicato. Sul successivo tratto di via
Sturzo s'affacciano numerosi edifici prestigiosi, fra i più notevoli
Palazzo Aprile di Cimia e Palazzo Longobardi.
Poco più avanti,
proseguendo sulla medesima via, si trova Palazzo Vella o Magnolia, in
stile liberty, caratteristico per la sua facciata in terracotta.
A pochi passi si incontra il largo San Domenico dove sorgono, l'una di
fronte all'altra, la chiesa di San
Domenico e la chiesa del SS. Salvatore. La prima,
attualmente adibita ad auditorium
musicale, è stata eretta nell'Ottocento ed è caratterizzata da due
campanili gemelli che affiancano il timpano di coronamento. La seconda,
anch'essa ottocentesca, conserva una Madonna cinquecentesca di Antonello
Gagini e la tomba di don Luigi
Sturzo.

Più
avanti, sulla sinistra, si incontra l'ex Ospedale delle Donne, dal
prospetto rinascimentale, disegnato dal Nicastro, decorato da medaglioni
di terracotta in rilievo realizzati intorno alla metà dell'Ottocento
dallo scultore S. Failla. Oggi è sede della Galleria Civica d'Arte
Contemporanea, istituita nel 1996,
che ospita una collezione permanente di opere dello scultore Ballarò ed
un'esposizione antologica di opere d'artisti contemporanei, acquisite
dalle Rassegne Nazionali della Ceramica a partire dagli anni
ottanta, con una particolare attenzione alla
produzione ceramica, con l'intento di creare un legame di continuità
con questa secolare tradizione. La Galleria possiede una ricca
biblioteca specialistica ed un archivio documentario e fotografico. In
fondo alla via Sturzo si apre il largo San Giorgio dove sorge l'omonima
chiesa. Della struttura originaria, risalente - secondo la tradizione -
all'XI
secolo ed attribuita ai Genovesi che in quel tempo si
trovavano in città, sono visibili nell'attuale edificio alcune feritoie
e il portale; da notare la bella torre campanaria coronata da merli.
All'interno è conservato il Mistero della Trinità, dipinto fiammingo
attribuito a Roger
van der Weyden. Nel medesimo quartiere si trova la
casa natale di don Luigi Sturzo, all'incrocio delle vie Edera e Santa
Sofia.
Sempre
da Piazza Municipio, il salotto della città, attraverso la via Vittorio
Emanuele ci si può dirigere verso la Basilica di San Giacomo. Lungo la
strada, che è meta del passeggio serale, sono allineati tanti negozi
per lo shopping e bar e gelaterie per una piacevole sosta.
Sulla
sinistra s'incontrano una mostra permanente della ceramica ed un Presepe
monumentale di 200 mq, il più grande d'Italia, che è animato da
speciali effetti visivi e sonori e dotato di oltre cento figurine in
terracotta colorata che riproducono scene di vita quotidiana. Sul lato
opposto della strada sorge il Palazzo di conti Grifeo
dei Principi di Partanna, un tempo residenza
dell'antica famiglia nobiliare.
Pochi
metri dopo, sulla sinistra si può ammirare il Palazzo delle Poste,
pregevole edificio del XX
secolo in stile liberty, opera di Saverio
Fragapane. Proseguendo, sullo stesso lato s'incontrano
le ceramiche d'arte Lucidi e, più avanti, lo studio d'arte di Salvatore
Raimondo.
Giunti in fondo alla via, sulla destra sorge la Basilica di
San Giacomo, edificata in età normanna per volere del conte Ruggero e
ricostruita dopo il terremoto del 1693 dall'architetto agrigentino Simeone Mancuso sulla pianta originaria. Sulla facciata si
mettono in evidenza massicce colonne marmoree. Al suo interno sono
custodite opere dei Gagini come il portale del Reliquiere nella navata
di sinistra, l'arco della Cappella del Sacramento e l'arca argentea
delle reliquie di San
Giacomo. Sin dal 1518,
in occasione della festa patronale, nel piazzale antistante la Basilica
si svolgeva una grande fiera dove venivano esposte le più svariate
mercanzie, fra cui i caratteristici fischietti di terracotta.

Il cimitero
di Caltagirone
venne realizzato nella seconda metà del 1800. Si trova nella via
Nicastro, a tre chilometri dal centro abitato. Viene chiamato cimitero
del Paradiso, dal nome della contrada omonima in cui sorge. Fu
dichiarato monumento
nazionale nel 1931.
Nel
1852, don Pasquale Gravina, un nobile calatino, invitò l'architetto Giovan
Battista Filippo Basile a realizzare un progetto per il
camposanto di Caltagirone, ma il piano realizzato da costui non ebbe
seguito, perciò nel 1866 la progettazione venne affidata all'architetto Giovan
Battista Nicastro che due anni prima aveva realizzato il
palazzo di Città.
Nel
1875 i lavori erano già in stadio avanzato e si presentava come è nei
tempi odierni ad eccezione della chiesa centrale. Il complesso,
realizzato in stile gotico-siciliano, ha pianta quadrata con croce greca
costituita da 170 arcate, che vanno a formare i portici che
costituiscono le quattro vie principali.
L'architetto
Nicastro utilizzò materiali facilmente reperibili in Sicilia, quali la
pietra bianca del ragusano, la pietra lavica e la terracotta, per la
quale fu richiesta l'opera di: Enrico Vella, Giuseppe Di Bartolo e
Gioacchino Alì. L'area del cimitero, inizialmente di ventimila metri
quadrati, è stata in seguito notevolmente ampliata.
Il
cimitero è ricco di pitture, sculture, fregi e capitelli, che lo
rendono monumento nazionale e meta di visitatori italiani e stranieri.
Lungo l'asse nord-sud vi sono gli elementi più importanti: il portico
d'ingresso, il Famedio,
l'Ossario, interrato e posto al centro della croce
greca nella piazza ottagonale. Vi sono diverse cappelle
gentilizie liberty realizzate
dall'architetto Saverio
Fragapane.
Il
centro storico sorge a tra i 600 e i 700 metri d'altitudine; fino
al primo dopoguerra era
l'unico insediamento urbano, ed ha origini millenarie. Nel settore
orientale vi è il quartiere San Giorgio che prende nome dall'omonima
chiesa, la più importante della città. Il centro storico è ricco di
numerose chiese e diversi monumenti, oltreché le principali istituzioni
ed enti (comune, teatro, banche e assicurazioni).
A
sud vi sono le aree urbane più basse rispetto al centro storico, vale a
dire il quartiere Acquanuova, San Pietro e San Francesco di Paola, nella
quale si trova il giardino pubblico, considerato il polmone verde della
città.
 Per
quanto concerne la planimetria, il centro storico di Caltagirone è
disposto ad anfiteatro. È una delle poche città della Sicilia
centro-orientale ad aver conservato, dopo il terremoto del 1693,
parte delle testimonianze dell'arte e dell'architettura medievali e,
soprattutto, la tipologia dell'abitato. Per
quanto concerne la planimetria, il centro storico di Caltagirone è
disposto ad anfiteatro. È una delle poche città della Sicilia
centro-orientale ad aver conservato, dopo il terremoto del 1693,
parte delle testimonianze dell'arte e dell'architettura medievali e,
soprattutto, la tipologia dell'abitato.
Un'altra
importante attrazione della città è rappresentata dalla ceramica,
risalente al V
secolo a.C.: oltre alla visita del Museo della ceramica, questa
parte di città testimonia la presenza di questa tradizione, come si può
notare in alcuni edifici e monumenti; tra questi, vanno menzionati la
Cattedrale di San Giuliano, con il campanile e la cupola decorate in
maiolica, la chiesa di San Pietro, esempio di neo-gotico adattato alla
realtà locale (evidenti gli inseri in ceramica policroma) e il ponte di
San Francesco, decorato con raffigurazioni araldiche e di motivo.
Alle
spalle del Museo della Ceramica si trova la Villa
Vittorio Emanuele, risalente al XIX secolo: è uno dei giardini
pubblici più grandi della Sicilia, ed è caratterizzato da una
considerevole presenza di vegetazione, nonché di ampi spazi ricreativi.
Per carruggi s'intendono
in generale le strade, i larghi, i vicoli e i ronchi del centro storico
della città, datati presumibilmente all'XI secolo, di natura simile
alle kasbah arabe. Il termine è una sicilianizzazione del
termine ligure caróggio: molto
probabilmente la loro costruzione può essere attestata ai coloni liguri
che lì si stanziarono. È molto probabile che essi siano stati
costruiti anche per natura difensiva, dato che ai tempi si susseguivano
battaglie tra normanni e saraceni.
Queste si sono conservate, nonostante nel tempo la città sia stata
investita da una generale distruzione a seguito del Terremoto
del Val di Noto del 1693.
Sono
caratterizzati dalle loro anguste proporzioni, specialmente in
larghezza, che li rendono spesso di difficile transito per i mezzi e in
alcune occasioni anche per le persone. Sono le più tipiche e comuni
tipo di vie presenti all'interno dell'antico centro cittadino, che ne
caratterizzano l'intero aspetto generale. Alcune di queste permettono il
transito dei veicoli, mentre altre sono esclusivamente di tipo pedonale.
I carruggi possono essere sia vie in basolato che a scale, anche se
alcune se ne possono incontrare asfaltate.
Sant'Ippolito è
un sito archeologico preistorico.
Si trova a circa 4 km a nord-est rispetto all'abitato moderno, su una
leggera elevazione di natura gessosa (400 m s.l.m.), con
pendici scoscese, chiamata collina di Sant'Ippolito o colle del
Bersaglio, nella valle del torrente Caltagirone.
Nel XIX
secolo vi era nota la presenza di manufatti e gli scavi, condotti
nel 1928 da Paolo Orsi rivelarono la presenza di due
villaggi di epoca neolitica e calcolitica e di
tracce di frequentazione fino al VII secolo a.C., epoca dell'arrivo
nella zona della colonizzazione greca.
Il
villaggio neolitico venne rinvenuto su un pianoro del pendio orientale,
lambito da un piccolo corso d'acqua e restituì fondi di capanne, resti
di focolari, frammenti di asce e punte di freccia in pietra e frammenti ceramici del
tipo detto "di Stentinello", decorati con semplici motivi
geometrici incisi o impressi. La necropoli del villaggio
comprendeva alcune tombe del tipo detto "a forno", scavate sul
pendio dal lato opposto del corso d'acqua.
Sulla
cima del colle, già frequentata in epoca neolitica, come provano i
ritrovamenti di ceramica di Stentinello, si insediò nell'età del rame
un secondo villaggio, più esteso del precedente, che sembra essere
rimasto attivo fino all'età del ferro. Vi è stata identificata
dall'archeologo Luigi Bernabò Brea una facies culturale
datata tra il 2000 e il 1800 a.C., che avrebbe preceduto
quella di Castelluccio e che ebbe rapporti con il mondo egeo e
anatolico.
Il
sito ha restituito una tipica produzione di ceramica ("ceramica di
Sant'Ippolito") dipinta con motivi di linee e triangoli in colore
scuro su fondo giallo-rossiccio. Forme tipiche furono una fiaschetta con
corpo ovoidale e unica ansa, un vaso emisferico con beccuccio cilindrico
e fruttiere con basso piede conico, che richiamo modelli orientali. Sono
presenti anche recipienti a partizioni multiple di uso incerto. La
ceramica di Sant'Ippolito sarebbe stata collegata alla successiva
"ceramica di Castelluccio".
I
materiali scavati nel sito sono conservati nel Museo archeologico
regionale "Paolo Orsi" di Siracusa e nella
stessa Caltagirone nel Museo della ceramica e nella sezione archeologica
dei Musei civici.
Poco
più a nord, in contrada Montagna, dai 77 metri di poggio Rocca fino ai
600 dei poggi Valfà e Mantina, si estende una grande necropoli di epoca siculo-greca.
Le tombe sin qui esplorate risalgono ad anni compresi tra il II
millennio e il VII secolo a.C. I sepolcri a thòlos sono
scavati nella roccia.

Pag.
1 
|