|
Zafferana
Etnea sorge a 574 m. s.l.m.,
alle pendici orientali dell'Etna.
Si estende fino alla vetta sommitale del vulcano, includendo nel proprio
territorio paesaggi di inestimabile bellezza naturalistica, dai fitti boschi
alle distese di deserto lavico.
È
uno dei comuni del Parco
regionale dell'Etna e
nel suo territorio rientrano le tre grandi valli che secondo accreditate
ipotesi rappresentano la testimonianza della sequenza della genesi del
vulcano: Valle
del Bove, Val
Calanna e Valle
San Giacomo.
Zafferana
rappresenta una delle porte d'accesso al vulcano, grazie alla strada
provinciale dell'Etna che la collega alla stazione turistica di Rifugio
Sapienza (Nicolosi)
da un lato, e a quella di Piano Provenzana (Linguaglossa)
dall'altro.
Diverse
sono le ipotesi sull'origine del nome; alcuni studiosi ritengono che la
parola derivi dall'arabo Zaufanah,
che significa “giallo”, per l'abbondanza dei giunchi e
delle ginestre che
si trovano nei boschi del territorio; altri pensano che il nome provenga da
parole arabe col
significato di “contrada ricchissima d'acqua” oppure “fischio del
vento”.
L'ipotesi
più attendibile la si trova nell'Enciclopedia italiana di Gerolamo
Boccardo,
in cui facendo accenno alla coltivazione dello zafferano egli scrive
che questa coltivazione «era industria principale nel moderno comunello di
Zafferana Etnea; che da detta cultura prese il nome». Questa supposizione
è avvalorata dal quadro della Madonna della Provvidenza (1838)
di Giuseppe
Rapisardi,
in cui è dipinto un vaso con fiori di zafferano.
Il
territorio di Zafferana Etnea era attraversato, fin dal tempo
dell'occupazione romana, da un importante asse viario che collegava la città
di Tauromenium a
quella di Katane,
costituendo un percorso alternativo alla via
Consolare Pompeia che
costeggiava il litorale jonico.
Questa strada pedemontana consentiva lo spostamento dei soldati romani al
riparo dagli attacchi nemici e permetteva di raggiungere e attraversare
l'imponente Bosco
d'Aci,
la cui legna veniva utilizzata per la costruzione delle navi.
A
tal proposito, il celebre antropologo palermitano Giuseppe
Pitrè,
nella sua Biblioteca delle tradizioni popolari, cita Zafferana come
luogo di passaggio dei tre santi
Alfio, Filadelfo e Cirino,
condotti dal preside Tertullo da Tauromenium a Leontini per
esservi martirizzati il 10 maggio 253.
Secondo alcune fonti in quel caso un'eruzione dell'Etna aveva reso
impraticabile la strada costiera (via Pompeia), costringendo la legione e i
condannati a servirsi della strada etnea.
Una
piccola parte di questa antica strada lastricata, in seguito riadattata a mulattiera e
utilizzata fino agli inizi del secolo scorso, è ancora visibile presso la contrada Dagalone.
Altra testimonianza della presenza dei romani nel territorio è
rappresentata dal ritrovamento di alcune monete romane.
A
causa delle eruzioni dell'Etna e dei terremoti che
più volte devastarono la zona, non si hanno altri reperti storici anteriori
al sisma
del Val di Noto del 1693.
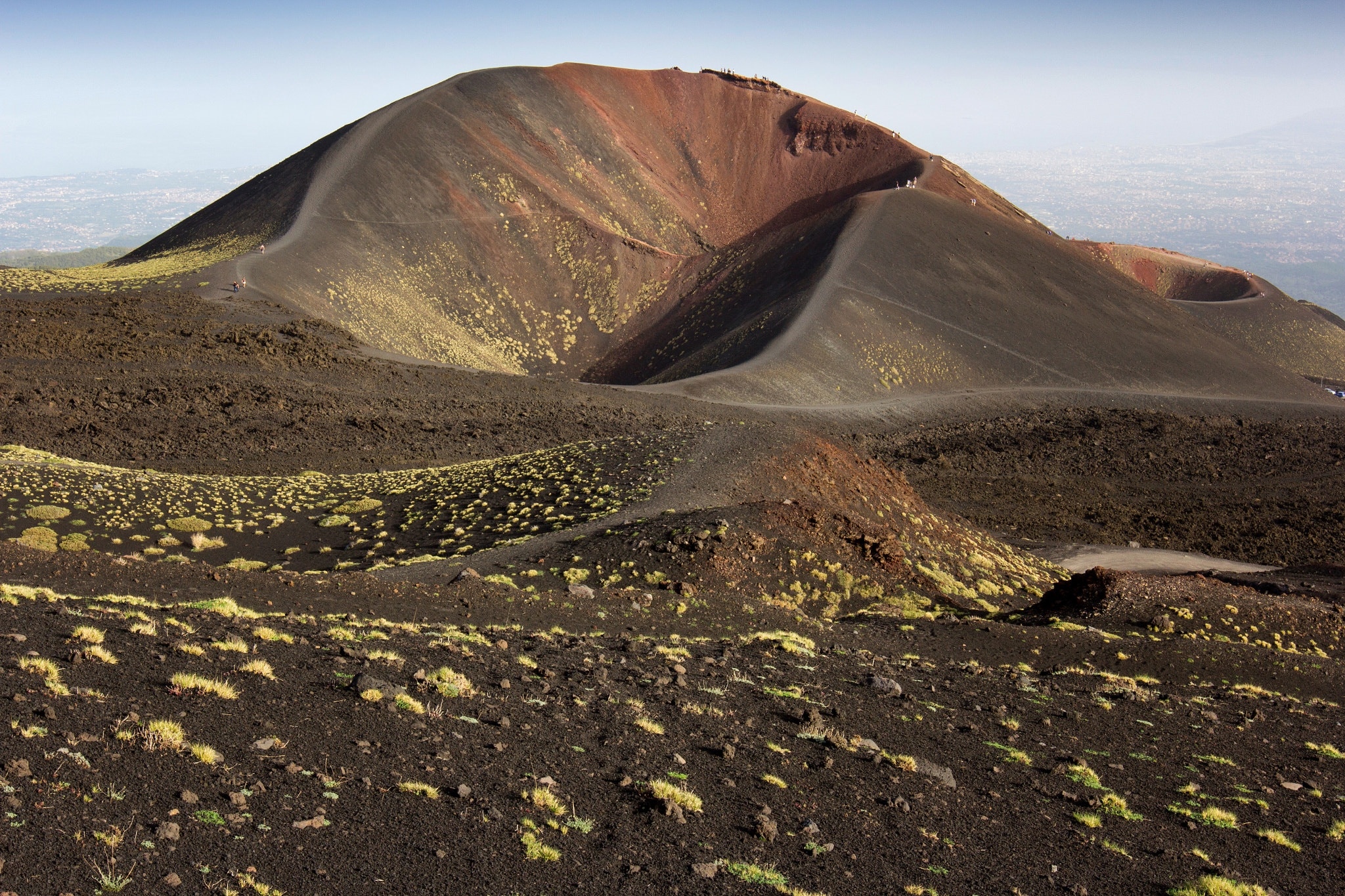
La
storia dell'abitato attuale ha origine con la fondazione del Priorato di San
Giacomo, un monastero benedettino
costruito nel Medioevo e
di cui si hanno notizie certe a partire dal 1387 in
un documento firmato dal Vescovo di
Catania Simone
del Pozzo.
Da una bolla
papale firmata
da Papa
Eugenio IV nel 1443 si
apprende dell'esistenza di un'annessa chiesa dedicata a san Giacomo,
sacramentale e parrocchiale, il che fa presumere che fosse frequentata da un
primo nucleo di abitanti sorto attorno al monastero, oltre che dai numerosi
pellegrini che accorrevano nel giorno della festa del santo, il 25 luglio.
La vita monastica nel Priorato finì nel 1464,
ma la chiesa rimase aperta al culto fino almeno al 1677,
venendo poi probabilmente distrutta, insieme all'intero complesso, dal
terribile terremoto del 1693.
Il Priorato si trovava all'inizio della svasatura della Valle
San Giacomo,
a monte dell'odierno abitato.
Alcuni
studiosi agiografi sostengono
che un primo piccolo monastero in territorio zafferanese fosse stato
istituito da san
Sabino (m.
15 ottobre 760), vescovo di Catania, che lasciò la gestione della diocesi
per ritirarsi in un luogo pacifico insieme ai suoi discepoli.
Questo fatto non è sostenuto da fonti certe, ed è azzardato ipotizzare che
il Priorato di san Giacomo sia sorto in seguito sull'originario Monastero di
san Sabino.
Il
primo toponimo che
si riscontra nella storia di Zafferana è “Cella”, che indicava lo
stesso territorio di San Giacomo, dove era ubicato il priorato.
In un documento del 1694,
invece, compare per la prima volta il toponimo “Zafarana” che darà poi
il nome al paese.
Le terre della contrada Zafarana dipesero amministrativamente dai comuni di Trecastagni, Viagrande ed Aci
Sant'Antonio fino
al 1826,
mentre dal punto di vista religioso la chiesa del borgo (chiesa della
Madonna della Provvidenza), costruita agli inizi del Settecento,
fu vincolata all'Arcipretura Parrocchiale "S. Nicola di Bari" di
Trecastagni fino alla costituzione della parrocchia (1753).
Il
21 settembre 1826 un
decreto di Francesco
I,
dispose che i quartieri Zafarana Etnea, Sarro, Rocca d'Api, Bongiardo e
Pisano formassero, distaccandosi dai comuni di Trecastagni, Viagrande ed Aci
SS. Antonio e Filippo,
un nuovo comune col nome di Zafarana Etnea, poi Zafferana Etnea. A questo
nuovo Comune si unirono in seguito le altre frazioni di Fleri (1851)
e Petrulli (1951),
mentre la frazione Bongiardo passò,
nel 1934,
al neo-costituito comune di Santa
Venerina.

Cronologia
degli eventi sismici
-
11 gennaio 1693, terremoto
del Val di Noto -
il Priorato di san Giacomo e l'annessa chiesetta vengono rasi al suolo.
-
20 febbraio 1818,
tardo pomeriggio - 34 vittime, 29 delle quali all'interno della Chiesa
Madre.
-
30 settembre 1911,
ore 00.40 (magnitudine macrosismica 3.4) - epicentro a Zafferana Etnea.
-
19 marzo 1952,
ore 08.13 (magnitudine macrosismica 3.9) - epicentro a Santa
Venerina -
Distruzione del cimitero comunale di Zafferana Etnea.
-
19 ottobre 1984,
ore 18.43 (magnitudine macrosismica 3.7) - Epicentro a Zafferana Etnea - Il
terribile evento sismico creò il panico tra gli abitanti di Zafferana e dei
borghi limitrofi: si contò una vittima colpita
da un calcinaccio durante la fuga; ingenti i danni alle abitazioni, agli
edifici civili e amministrativi, a quelli sacri.
La
Chiesa Madre fu interessata dal crollo della volta della navata centrale che
cadde rovinosamente sul pulpito distruggendolo, da crepe sugli stucchi e da
profonde fratture lungo i pavimenti e
le pareti; i danni la resero inagibile alle sacre funzioni e fu sostituita
da una tensostruttura realizzata nella vicina Piazza della Regione
Siciliana, che ospitò i fedeli per ben quattordici anni. Anche il Palazzo
Municipale divenne impraticabile per i pericoli di crollo.
Gli
abitanti, privati delle loro case, furono ospitati per mesi in tende messe
a disposizione dalla Croce
Rossa Italiana e
dall'Esercito
Italiano,
chiamati sul posto per far fronte alle necessità dei senza tetto.
Una
replica importante si ebbe sei giorni dopo, il 25 ottobre 1984, con
epicentro nella frazione Fleri.
Anche questo terremoto causò danni ingenti agli edifici civili e sacri
nella frazione stessa e in quella limitrofa di Pisano
Etneo.
-
25 ottobre 1984, ore 01.11 (magnitudine macrosismica 3.0) - Epicentro a
Zafferana Etnea, danni ingenti ad edifici civili e sacri nelle frazioni di
Fleri e Pisano Etneo.
-
9 gennaio 2001,
ore 02.51 (magnitudine macrosismica 3.4) - Epicentro a Zafferana Etnea.
-
29 ottobre 2002,
ore 10.02 (magnitudine macrosismica 4.1), terremoto
di Santa Venerina -
Epicentro a Santa Venerina.
-
29 ottobre 2002, ore 17.14 (magnitudine macrosismica 3.7) - Epicentro a Milo.
-
26 dicembre 2018,
ore 03.19 (magnitudine macrosismica 4.8), terremoto
di Viagrande -
epicentro a Viagrande,
danni ingenti ad edifici civili e sacri nella frazione di Fleri.

Cronologia
degli eventi eruttivi
-
1792 -
A seguito degli eventi eruttivi cominciati nel marzo 1792,
il primo di giugno si aprì un cratere sul
lato est dell'Etna, preannunciato da terremoti. Il fuoco del vulcano divorò
fertili terreni lasciando dietro di sé una lingua nera di lava.
I
primi di agosto la colata lavica si affacciò dalle colline che vanno
dall'Airone alla Valle San Giacomo, seminando il panico nel piccolo borgo.
Ormai privi di speranza per la salvezza delle proprie case, gli zafferanesi
raccolsero le loro cose e si prepararono a lasciare le loro proprietà.
«La
montagna conica dell'Arcimisa restò in gran parte seppellita da questa
copiosa ed alta corrente di lava, la quale empì la profondissima valle del
signor Gioacchino a segno di non lasciarne il menomo vestigio. Da qui il
torrente focoso diviso in cinque braccia proseguì il suo corso nelle
contrade di Cassone, distruggendo e snaturando tutte quelle fertili
campagne, che incontrò nel suo passaggio ed andò finalmente a devastare le
vigne in faccia della Zafarana. Gli abitanti del paese colti dallo spavento
erano già in istato di abbandonare le loro case in preda del torrente
infocato; ma la lava divisa in tante ramificazioni, si arrestò in quella
scoscesa collina tutta vestita di vigneti, che è a poca distanza dalla
Zafarana» (Giuseppe
Recupero, Storia
naturale e generale dell'Etna Catania 1815)
Dai
zafferanesi, che in un impeto di fede avevano portato in processione dalla
chiesa la statua della Madonna della Provvidenza, l'improvviso cessare
dell'eruzione alle porte dell'abitato venne inteso come una grazia
straordinaria. Il popolo tutto gridò al miracolo e fece voto di recarsi in
quel luogo in pellegrinaggio ogni anno. Sul posto nel 1861 venne edificato
un monumentale altarino e, ancor oggi, la cittadinanza scioglie il voto dei
padri recandovisi ogni anno durante i festeggiamenti patronali.
-
1852 -
La lava lambisce l'abitato distruggendo boschi e fertili terreni.
-
1992 -
La lava si arresta a meno di un chilometro dal centro abitato, in contrada
Piano dell'Acqua. Cominciata il 14 dicembre 1991 e terminata il 30 marzo del
1993, fu l'eruzione etnea
di più lunga durata tra quelle recenti. La lava fuoriuscì da un sistema di
fratture localizzate lungo la base del cratere di sud-est, in direzione
nord-sud, che si estese nel giro di alcuni giorni da quota 3.100 a quota
2.200 s.l.m.
Chiesa
di Santa
Maria della Provvidenza

La chiesa
di Santa Maria della Provvidenza è la chiesa
madre di Zafferana
Etnea.
Svettante
su di un'ampia e scenografica scalinata in pietra
lavica,
in netto contrasto con la bianca facciata, la Chiesa Madre, intitolata alla Patrona,
è il monumento più importante della città.
La
sua costruzione, iniziata nel 1731 per
volere di don Francesco Gagliano, decano della Basilica
Collegiata di Catania,
si protrasse per lungo tempo, più volte ripresa a causa dei numerosi eventi sismici che
la resero inagibile. Nei secoli la sua struttura fu rimaneggiata e ampliata.
La chiesa originaria, infatti, era molto più piccola, disposta
perpendicolarmente a quella attuale; il 20 febbraio 1818 un
terribile terremoto distrusse l'edificio causando ventinove vittime tra i
fedeli presenti alle sacre funzioni.
I
lavori di ricostruzione, cominciati nel 1832 e
conclusi nel 1837,
valsero alla chiesa la possibilità di essere dichiarata "Chiesa
Matrice" dall'allora vescovo di
Catania, mons. Orlando. Nel 1882 un
nuovo intervento di ampliamento portò all'allungamento delle navate.
L'ultimo
intervento di recupero e di restauro risale agli anni precedenti al 1997,
quando la chiesa venne riaperta al culto dopo quattordici anni, essendo
stata resa inagibile dal terremoto del 1984,
che causò il crollo della volta della navata centrale e innumerevoli altri
danni strutturali.
L'esterno
è caratterizzato da un'imponente facciata in
pietra bianca di Siracusa,
realizzata dal 1897 al 1928 in
stile eclettico,
con elementi che vanno dal barocco siciliano
al liberty su
progetto dell'architetto Carmelo
Sciuto Patti.
Il prospetto è formato da un corpo centrale lievemente arretrato rispetto
ai due campanili gemelli.
A
seguito della riapertura della Chiesa, avvenuta il 30 ottobre 1997,
le porte sono state decorate con pannelli bronzei in rilievo. Nella porta
centrale troviamo rappresentate la processione durante
l'eruzione
del 1792 (in
basso a sinistra), una scena di vita monastica del Priorato di San Giacomo
(in basso a destra) e in alto scene tratte dal Nuovo
Testamento in
cui è presente la Madonna.
Le porte laterali, invece, sono arricchite da pannelli che raffigurano scene
della vita di Cristo.
Sul
portale maggiore, a ridosso di una cornice curvilinea, si trova un grande
Cristo Pantocratore che, con le braccia aperte, accoglie i fedeli e li
invita ad entrare. Sul livello superiore, al centro di un trittico, è posta
una statua di pregevole fattura raffigurante la Titolare della chiesa e
Patrona della città, Maria Santissima della Provvidenza. Su di essa, nel
frontone, si erge lo stemma mariano.


Delle
due torri campanarie, d'impronta prettamente barocca,
solo quella di destra ospita cinque campane.
Dei
due ingressi sui prospetti laterali, il più interessante è quello di
destra, rivolto ad oriente. È in pietra lavica scolpita, e sulla sua soglia
è incisa la data del 1730,
l'anno in cui furono iniziati i lavori di costruzione della chiesa. Pare
certo che questo fosse, nel progetto iniziale, l'ingresso principale della
chiesa, allora molto più piccola, e rivolta quindi ad oriente
perpendicolarmente alla chiesa attuale.
La
cupola, di forma ottagonale, è artisticamente rivestita da tessere in maiolica blu,
caratteristica comune a molte delle cupole e delle guglie delle chiese
etnee.
L'interno,
elengante e sobrio nel suo insieme, è a croce
latina e
a tre navate. All'incrocio del transetto con
la navata centrale si innalza la cupola.
Nonostante gli eventi sismici remoti e recenti l'abbiano spogliata di molte
delle finiture e degli affreschi originari, la chiesa conserva interessanti
opere artistiche.
All'ingresso,
sulla destra, è collocato il fonte
battesimale in marmo,
sormontato dall'Agnello e circondato da una ringhiera in ferro battuto.
 L'abside presenta
un altare maggiore di pregevole fattura, al di sopra del quale si erge
maestoso un grande quadro della Madonna della Provvidenza, opera
novecentesca del pittore Raffaele
Stramondo;
dello stesso autore, sempre nell'abside, troviamo a destra Il
sacrificio di Melchisedech e a sinistra La Cena di Emmaus. L'abside presenta
un altare maggiore di pregevole fattura, al di sopra del quale si erge
maestoso un grande quadro della Madonna della Provvidenza, opera
novecentesca del pittore Raffaele
Stramondo;
dello stesso autore, sempre nell'abside, troviamo a destra Il
sacrificio di Melchisedech e a sinistra La Cena di Emmaus.
Ai
lati dell'altare maggiore due splendide porte in legno scolpito, recanti i
rispettivi simboli iconografici, conservano le statue di San Giuseppe (a
destra) e della Madonna della Provvidenza (a sinistra), mentre dietro l'altare,
al centro, si trova una simile porta che custodiva un tempo la statua di
Sant'Antonio abate.
In
fondo alla navata destra si trova la cappella della Madonna della
Provvidenza, uno splendido altare in marmo policromo in cui è incastonato
il venerato quadro della Madonna, dipinto nel 1838 da Giuseppe
Rapisarda.
In
fondo alla navata sinistra, invece, si trova la cappella del Santissimo
Sacramento;
sull'altare, fiancheggiato da due statue raffiguranti Santa
Margherita Maria Alacoque e Santa
Giuliana Falconieri,
è posto il simulacro del Sacro
Cuore di Gesù.
Lungo
il transetto troviamo invece a destra l'altare di San Giuseppe, con una
grande pala dipinta dal pittore zafferanese Giuseppe
Sciuti nel 1854 a
soli vent'anni; a sinistra, l'altare del Santissimo Crocifisso, con un
monumentale Crocifisso ligneo ottocentesco alla base del quale è posto un
quadro dell'Addolorata.
Due
statue si fronteggiano, poste nelle navate laterali: a destra troviamo
quella di Sant'Antonio
di Padova,
a sinistra quella di Sant'Antonio abate, compatrono della città.
Altri
interessanti simulacri sono conservati nella Matrice, ma esposti solo nei
giorni delle rispettive feste; tra questi ricordiamo: il Cristo Morto col
suo cataletto (portantina),
di fattura settecentesca; la Madonna della Provvidenza, scolpita intorno
alla metà del secolo XIX; l'Addolorata e San
Giovanni Apostolo; Santa
Rita da Cascia; San
Giuseppe;
la Madonna di Lourdes; il piccolo simulacro di Maria Santissima Bambina; Sant'Agata; Santa
Lucia;
il Cristo Risorto.
Chiesa
di Santa Maria delle Grazie
 La
costruzione originale era in legno su
una proprietà privata, e venne iniziata dopo il terremoto del 1818,
che aveva reso inagibile la chiesa
madre Santa Maria della Provvidenza. La
costruzione originale era in legno su
una proprietà privata, e venne iniziata dopo il terremoto del 1818,
che aveva reso inagibile la chiesa
madre Santa Maria della Provvidenza.
In
seguito cominciarono i lavori definitivi, che non furono però ultimati,
lasciando così la chiesa incompleta. Un recente intervento di completamento
e restauro ha permesso di aprirla al culto, consacrata l'8 dicembre 1995 dall'arcivescovo
emerito di Catania Luigi
Bommarito.
Nella
facciata, in stile liberty,
si trova una nicchia che ospita una statua in pietra bianca della Madonna
delle Grazie.
Al
di sopra del portale,
all'interno di una cornice semicircolare, si trova un altorilievo raffigurante
due angeli che sostengono la "M" di Maria.
La
facciata è suddivisa in tre parti, separate tra di loro da paraste con
inserti liberty; la porzione centrale presenta il portale d'ingresso e
culmina nella croce, quelle laterali si elevano per finire a destra nella
torretta dell'orologio, e a sinistra nella torre campanaria.
Quest'ultima
possiede una particolarità: le due campane suonano a slancio, ovvero è
tutta la campana ad oscillare e non solo il batacchio, come invece avviene
di norma.
L'interno
si sviluppa in un'unica navata a copertura lignea.
L'altare
maggiore ospita, su una mensola marmorea, la statua lignea della Madonna
delle Grazie.
Nella
parete destra si trovano un dipinto che raffigura la Visitazione di Maria a
santa Elisabetta e la statua del Sacro
Cuore di Gesù;
nella parete sinistra, invece, un dipinto raffigurante l'Annunciazione e una
statua di san
Mauro abate.
Capitelli
votivi
Capitello
della Madonna della Provvidenza - In centro storico. Fu costruito nel 1861 ad
opera dei fedeli nello stesso luogo in cui nel 1792 avvenne un miracolo attribuito
all'intercessione della Vergine: il fronte lavico dell'eruzione dell'Etna,
ormai incombente sull'abitato, prodigiosamente si arrestò nel medesimo
punto in cui il simulacro della Madonna fu portato in processione.
Proprio
a ricordo di quell'evento sul timpano che sormonta l'altare è
scritto: "TU SALUS NOSTRA", cioè "Tu nostra salvezza".
Ancor oggi l'Altare contiene l'originario simulacro della Vergine, bella
opera settecentesca in gesso dipinto.
Questo Altarino rappresenta una testimonianza della devozione alla Madonna e
ogni anno, in memoria del miracolo del 1792, il popolo scioglie l'antico
voto pronunciato dagli avi, raggiungendolo in processione il sabato che
precede la seconda domenica di agosto.
 Una
lapide marmorea, collocata ai piedi del simulacro della Madonna, così
recita: "A piè di questo simulacro dell'Augusta Vergine della
Provvidenza, la lava etnea del 1972 prodigiosamente qui ristette. I
fedeli questo monumento vi eressero nel 1861". Una
lapide marmorea, collocata ai piedi del simulacro della Madonna, così
recita: "A piè di questo simulacro dell'Augusta Vergine della
Provvidenza, la lava etnea del 1972 prodigiosamente qui ristette. I
fedeli questo monumento vi eressero nel 1861".
Capitello
della Madonna delle Grazie - In
centro storico. Il primo altarino dedicato alla Madonna delle Grazie venne
costruito quando ancora la strada non esisteva, nel torrente
sottostante.
Qui
si trovava la piccola abitazione di un mendicante che, per guadagnarsi da
vivere, vendeva l'acqua alle
famiglie, non essendovi ancora una rete idrica. Un giorno, durante una
piena, il mendicante venne
trascinato dalle acque; impaurito, pregò la Madonna e improvvisamente si
sentì afferrato dai capelli e trascinato verso un masso dove credette di
scorgere il profilo della Madonna.
Con
la costruzione della strada attuale, la famiglia Marano, allora proprietaria
del parco comunale (Villa Anna), offrì lo spazio per costruire questo nuovo
altarino, all'interno del quale è stata riportata la pietra che salvò il
mendicante.
Capitello
votivo della Madonna della Provvidenza - Nella contrada Piano
dell'Acqua. Il capitello a forma di stele raffigura la Madonna della
Provvidenza, voluta dai cittadini zafferanesi a memoria del prodigioso
arresto della colata lavica che nel 1992 incombeva sull'abitato. Allora, in
processione, il popolo dei fedeli raggiunse il fronte lavico, chiedendo la
grazia della salvezza della loro città. E così fu: la lava si fermò poco
tempo dopo nel punto in cui il simulacro della Madonna era stato
portato.
La
stele col simulacro della Madonna venne inaugurata il 13 novembre 1994 dal cardinale
Salvatore Pappalardo e
fu fatto voto di raggiungere questo luogo in processione ogni primo sabato
di giugno.
Ai piedi della stele,
una targa commemorativa, così recita: "Tu fosti, o Madre della Divina
Provvidenza, difesa e baluardo della nostra città che a Te deve salvezza
dal fuoco ormai incombente dell'eruzione 1991-'92. Il
popolo grato questa stele eresse il 13 novembre 1994 ".
Capitello
votivo della Madonna della Provvidenza, quartiere Cancelliere.
Capitello
votivo della Madonna della Provvidenza, contrada Dagalone.
Capitello
votivo di San Vito martire.
Capitello
votivo del Santissimo Redentore, frazione Fleri.
Capitello
votivo della Madonna delle Grazie, quartiere Fortino.
Palazzo
Municipale

L'elegante
costruzione fine ottocentesca, posta sullo stesso livello urbanistico della
chiesa madre, si affaccia sulla centralissima piazza Umberto
I.
Il
palazzo è un gradevole esempio di stile
Liberty,
con cornicione merlato, inserti floreali sul prospetto principale e, al
centro, sopra il balcone d'onore,
uno stucco riprende lo stemma comunale, con l'aquila che tiene tra gli
artigli due grappoli d'uva, posta sopra un medaglione su cui è dipinta
l'Etna in eruzione.
L'edificio,
reso inagibile dal terremoto del 19 ottobre 1984,
dopo un lungo restauro, è stato inaugurato il 30 maggio 2009 alla
presenza delle istituzioni comunali, del presidente della Regione Siciliana Raffaele
Lombardo e
dell'arcivescovo metropolita di Catania Salvatore
Gristina.
Al
suo interno si conservano due importanti opere del pittore locale Giuseppe
Sciuti: Il
Benessere e le Arti ed un autoritratto. Per raggiungere il
municipio dalla piazza si percorre una coreografica scalinata curvilinea a
doppia rampa, con lampioni anch'essi
Liberty; al centro della scalinata è collocato un busto del pittore
Giuseppe Sciuti, in memoria dell'artista cui Zafferana diede i natali.
Villa
Manganelli
Villa
Manganelli è un edificio monumentale di Zafferana
Etnea,
appartenuto alla nobile famiglia catanese dei Principi Paternò
- Manganelli.
La sua costruzione avvenne tra la fine del XIX e
gli inizi del XX
secolo,
in contrada Sarro.
 Vi
si accede attraverso un monumentale ingresso sulla SP9, in prossimità
dell'antica chiesa di san Vincenzo Ferreri, in contrada Sarro, percorrendo
un viale alberato immerso in un florido parco. La villa si trova più in
alto rispetto al piano stradale, e la si può vedere da più parti dominare
sul territorio circostante. Vi
si accede attraverso un monumentale ingresso sulla SP9, in prossimità
dell'antica chiesa di san Vincenzo Ferreri, in contrada Sarro, percorrendo
un viale alberato immerso in un florido parco. La villa si trova più in
alto rispetto al piano stradale, e la si può vedere da più parti dominare
sul territorio circostante.
Lo
stile utilizzato rispecchia quello della Secessione
viennese,
movimento artistico che si diffuse a partire dalla fine del 1800 in tutta
Europa e negli Stati Uniti ed anche lo stile "Neoclassico"
come quello "Georgiano"
è presente, il che rende villa Manganelli probabilmente l'unico edificio
del Sud Italia con
stile inglese-americano coloniale del 1700. L'edificio si innalza su tre
piani, e il prospetto principale, rivolto ad est, è caratterizzato da un
corpo centrale avanzato, nel cui piano intermedio, al di sopra del portale
d'ingresso, si trova un balconcino d'onore provvisto di balaustra a
colonnine. Il prospetto posteriore, ad ovest, presenta di contro un corpo
centrale incassato, formando così una sorta di corte dalla quale si accede
alla villa provenendo dal parco retrostante.
Gli
interni, nonostante l'incuria degli anni passati, a seguito di un recente
restauro conservativo, hanno ritrovato il loro splendore. I pavimenti sono
in stile
liberty,
ed i soffitti affrescati con motivi a festoni e ghirlande intervallati da
motivi geometrici, opera magistrale dell'architetto Joseph
Maria Olbrich.
Attorno
alla villa si trova uno splendido parco composto di sciare e castagneti, e
di alberi di vario genere, comunemente chiamato il feudo dagli
abitanti locali.
Attualmente
la Villa Manganelli è di proprietà dell'Ente
Parco dell'Etna,
in attesa di una prossima destinazione d'uso. Tra le varie proposte, quella
di utilizzare la villa come sede di una futura facoltà di Scienze
Forestali,
oppure di adibirla ad ospitare un museo dedicato all'Etna.
Parco
Comunale

Il
Parco Comunale è il più grande giardino pubblico del comune, situato in
pieno centro, sul lato nord del torrente Salaro
in prossimità della Chiesa della Madonna delle Grazie e vi si accede da un
piazzale intitolato a papa
Giovanni Paolo II.
Il
giardino è di notevole interesse sia dal punto di vista naturalistico che
culturale. Un intricato percorso di tortuosi vialetti conduce il visitatore
attraverso grandi aiuole da
cui si slanciano verso l'alto pini e magnolie secolari
e in cui sono coltivate pregiate varietà di rose,
di ortensie e
di camelie.
Villa
Marano. In mezzo alla flora rigogliosa
si erge, nel punto più elevato del parco, una bella palazzina aristocratica
in stile liberty (ex
Villa Anna), appartenuta al commendatore Marano, oggi sede della biblioteca comunale
"Francesco Guglielmino" e scenario di vari spettacoli culturali.
Nei pressi della palazzina, al termine del Viale degli uomini illustri (vi
si trovano i busti dei personaggi che hanno fatto la storia della città),
si trova una bella voliera,
anch'essa in stile Liberty.
Anfiteatro
comunale
Adiacente
a questo settore che possiamo definire il più antico, si trova quello più
moderno, in cui è possibile ammirare nelle aiuole a prato inglese delle
opere d'arte contemporanea in ferro battuto, un grande stagno con anatre e
il capiente anfiteatro comunale
“Falcone e Borsellino”. Quest'ultima struttura è sede dell'annuale
calendario di spettacoli “Etna in Scena” e può accogliere diverse
centinaia di spettatori.

Tradizioni
e folclore
-
Festa patronale della
Madonna della Provvidenza È
la festa più importante della cittadina e si svolge ogni anno nei giorni a
cavallo della seconda domenica di agosto; comprende una serie di momenti
religiosi e folkloristici molto
partecipati, in cui la cittadinanza si riunisce per rendere omaggio alla
propria patrona.
-
Festa di sant'Antonio abate Il Compatrono di
Zafferana si ricorda il 17 gennaio di ogni anno, con una santa messa solenne
e un insieme di manifestazioni collaterali che ne arricchiscono il
programma. Il culto e la festa di sant'Antonio
abate sono
stati ripristinati nel 2006,
in occasione del 1650º anniversario della morte. Con l'accrescere del culto
nei confronti della Patrona
Maria Santissima della Provvidenza,
l'attenzione religiosa nei confronti del grande santo anacoreta è
andata via via scemando, fino a quando, nel 1950 circa,
le celebrazioni religiose e folkloristiche in suo onore (benedizione degli
animali, accensione del fuoco, processioni) vennero sospese. Ad oggi è
stata ripristinata la memoria solenne del santo e l'antichissima tradizione
dei “cuddureddi” (ciambelline di pane) che vengono benedetti e
distribuiti ai fedeli. Il simulacro di
sant'Antonio abate si conserva in Chiesa
Madre,
su un altare della navata sinistra;
è una statua lignea di autore ignoto risalente alla metà del XIX secolo
che raffigura l'abate con gli abiti pontificali, mitria e pastorale.
-
Corpus Domini Dopo
la Messa della sera, esce dalla Chiesa
Madre il
Santissimo Sacramento dell'Altare contenuto in un artistico ostensorio dorato,
e coperto da un baldacchino.
La processione è preceduta dal corpo bandistico "Città di Zafferana
Etnea" e seguita da un grande numero di fedeli. Lungo le strade,
principali e di quartiere, l'eucaristia viene
accolto da un tappeto di fiori sparsi sul percorso dagli abitanti della zona
attraversata: questa tradizione è secolare, e ancora oggi viene praticata
con molta devozione in segno di decoro e rispetto a Gesù Sacramentato.
I fedeli, inoltre, allestiscono con grande cura, lungo le strade, degli altari per
la reposizione e l'adorazione del Santissimo Sacramento.
Molti
di questi altari, detti comunemente "altarini", risalgono
all'Ottocento, tramandandoci
un'antica quanto attuale devozione popolare; antichi ricami, preziosi
doselli, piccole cappelline in legno decorato,
artistici
candelieri, rimangono testimonianza di una fede che si rinnova ogni anno in
questa festa, molto sentita e partecipata.
 -
Venerdì Santo La
drammatizzazione della passione e morte di Gesù Cristo si ripete a
Zafferana Etnea da secoli, associando alla liturgia propria del giorno, riti
che giovano ai fedeli per contemplare il mistero della Morte di Cristo,
anche con gli occhi oltre che col cuore. -
Venerdì Santo La
drammatizzazione della passione e morte di Gesù Cristo si ripete a
Zafferana Etnea da secoli, associando alla liturgia propria del giorno, riti
che giovano ai fedeli per contemplare il mistero della Morte di Cristo,
anche con gli occhi oltre che col cuore.
Il
Cristo Crocifisso, "svelato" durante le celebrazioni del venerdì
santo, sovrasta l'altare maggiore della Chiesa Madre, insieme all'Addolorata
e all'apostolo Giovanni.
Al
termine della liturgia, esso viene avvolto da un lenzuolo bianco, calato
dalla Croce e deposto sul "cataletto", urna utilizzata per portare
in processione il Cristo Morto. Il corteo funebre, molto partecipato e
sentito, procede lentamente lungo le strade della cittadina, preceduto dal
Cristo Morto, dalla Madre Addolorata e da San Giovanni apostolo.
-
Il Natale La
notte tra il 24 ed il 25 dicembre, durante la cosiddetta "Messa di
Mezzanotte", nella Chiesa Madre gremita di fedeli, si partecipa alla
Santa Messa e si assiste, con grande partecipazione ed emozione, alla
svelata del Presepe.
La scena che si presenta agli occhi dei fedeli presenti è quella
tradizionale della nascita di Gesù e
dell'adorazione dei pastori, realizzata sull'altare maggiore con grandi
statue ad altezza naturale.
Ogni
anno un numeroso gruppo di volenterosi si impegnano nella preparazione di
questo monumentale Presepe, sempre diverso e sempre carico di sfumature
artistiche ed allegoriche che emozionano ed aiutano a raccogliersi in
preghiera dinanzi alla scena della Natività.
Fuori, sulla piazza Umberto
I,
brucia per tutta la notte il grande falò,
tradizionalmente chiamato u zuccu.
|