|
Cuore
di un agglomerato
urbano di circa 700 000 residenti esteso alle pendici
sud orientali del Monte Etna,
è il centro dell'area
metropolitana più densamente popolata della Sicilia, e di una
più ampia conurbazione nota
come Sistema
lineare della Sicilia orientale, che conta circa 1.700.000 abitanti
su una superficie di 2.400 chilometri quadrati. La città è inoltre il
fulcro economico ed infrastrutturale del Distretto
del Sud-Est Sicilia, istituito il 26 febbraio 2014 alla presenza
dell'allora presidente della Repubblica
Italiana Giorgio
Napolitano. È il decimo comune d'Italia per popolazione ed il più
popoloso che non sia capoluogo di regione. Principale polo industriale, logistico e commerciale della Sicilia,
è sede dell'Aeroporto
Vincenzo Bellini.
Fondata
nel 729 a.C. dai Calcidesi della
vicina Naxos,
la città vanta una storia millenaria caratterizzata da svariate dominazioni
i cui resti ne arricchiscono il patrimonio artistico, architettonico e
culturale. Sotto la dinastia aragonese fu
capitale del Regno
di Sicilia, e dal 1434 per volere di re Alfonso
V è sede della più antica Università dell'isola.
Nel corso della sua storia è stata più volte interessata da eruzioni
vulcaniche (la più imponente, in epoca storica, è quella del 1669)
e da terremoti (i
più catastrofici ricordati sono stati quelli del 1169 e
del 1693).
Catania
è stata patria, nativa o adottiva, di alcuni tra i più celebri artisti e
letterati d'Italia, tra i quali i compositori Vincenzo
Bellini e Giovanni
Pacini e gli scrittori Giovanni
Verga, Luigi
Capuana, Federico
De Roberto, Nino
Martoglio, Vitaliano
Brancati. Il barocco del suo centro
storico è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio
dell'umanità, assieme a quello di sette comuni del Val
di Noto (Caltagirone, Militello
in Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo
Acreide, Ragusa e Scicli),
nel 2002.
Secondo
lo storico greco Plutarco,
il suo nome deriva dal siculo katane (cioè grattugia, parola
di origine indoeuropea), per l'associazione con le asperità del territorio lavico su
cui sorge, od anche dal latino catinum (catino, bacinella) per la
conformazione naturale a conca delle colline intorno alla città o come
riferimento al bacino della Piana.
L'etimologia resta
comunque oscura: secondo altre interpretazioni, il nome deriverebbe
dall'apposizione del prefisso greco katà- al
nome del vulcano Etna (Aitnè,
dal greco) (in modo che ne risulti "nei pressi di" o
"appoggiata" all'Etna).
Lo
stemma della Città di Catania è costituito da uno scudo con lo sfondo
azzurro, cimato dalla corona
reale aragonese e, nella parte inferiore, la legenda che
riporta la sigla “S.P.Q.C.”, (sulla falsariga di SPQR)
che in lingua
latina significa Senatus Populusque Catanensium, mentre
tradotto in italiano: Il
Senato e il Popolo Catanese. Al centro è presente un elefante posto di
profilo di colore rosso
porpora con le zanne rivolte a sinistra (destra araldica), sopra
di esso è presente una lettera “A”
maiuscola anch'essa di colore rosso, che sta per Agata, il nome della santa
patrona.

La
collina di Monte Vergine occupa una posizione strategica fra il mare, l'Etna
e la maggiore pianura di Sicilia. Su di essa si sviluppò un vasto abitato
preistorico, intercettato in più punti ed in particolare nell'area dell'ex
Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena ed in quella di via Teatro
Greco. Nel monastero benedettino sono stati rinvenuti reperti che
coprono il periodo compreso tra il Neolitico e la fine dell'età del Rame;
agli inizi dell'Eneolitico si data una tomba a fossa polisoma rinvenuta
sempre all'interno del monastero. In via Teatro Greco sono state
individuate due fasi preistoriche. La prima, datata al radiocarbonio alla
seconda metà del VI millennio a.C., è relativa alla probabile
frequentazione di uno o più ripari sotto roccia, dagli inizi del Neolitico
medio fino a quello tardo. La seconda fase, datata al radiocarbonio alla
fine del V millennio a.C., appartiene ad una abitato con capanne degli
inizi dell'Eneolitico, cui verosimilmente spetta la tomba dei Benedettini.
Sebbene
si conoscano rinvenimenti sporadici dell'età del Bronzo e di quella del
Ferro, l'area era probabilmente disabitata quando, nel 729-728
a.C., coloni
greci provenienti da Naxos,
a sua volta fondata da Calcide in Eubea,
guidati dall'ecista Evarco vi
fondarono Kατάvη.
La città greca, conobbe la sua stagione migliore nel corso del V
secolo a.C.. Nel 476
a.C. Gerone
I di Siracusa ne fece la propria sede, sostituendo gli abitanti e
mutandone il nome in Áitna.
Di questo episodio, durato un quindicennio, cantato da Pindaro e
forse al centro di una perduta tragedia di Eschilo,
rimangono monete d'argento tra le più raffinate dell'antichità.
Riacquisiti l'antico nome e gli originari abitanti, alla fine del secolo,
durante la Guerra
del Peloponneso, la città parteggiò per Atene contro Siracusa.
Conquistata dai siracusani nel 403
a.C., dispersi i suoi abitanti e ripopolata con mercenari campani,
per la città ebbe inizio un declino che si concluse solo con la conquista
romana di Manio
Valerio Massimo Messalla nel 263
a.C.
Càtina
(o Càtana) divenne colonia augustea nel 21
a.C.. Da quel momento la città si dotò di grandi edifici pubblici
che la trasformeranno in uno dei più ragguardevoli centri dell'impero e che
nei secoli successivi, fino ad oggi, condizioneranno il suo sviluppo urbano.
La città fu sede di una precoce comunità cristiana e dal IV
secolo, se non da prima, di una cattedra vescovile. Al cristianesimo
si legano le trasformazioni di alcuni edifici e il lento processo di
sviluppo da città antica a città medievale.

Alla caduta
dell'Impero Romano la Sicilia venne conquistata nel VI
secolo dagli Ostrogoti di
re Teodorico
il Grande che si occupò della ricostruzione delle mura della
città, utilizzando le pietre che costituivano l'anfiteatro romano. Venne in
seguito conquistata dai Bizantini,
e nella prima metà del IX
secolo dai musulmani. Nel 1071 viene
conquistata dai Normanni che
provvidero a ridarle la sede vescovile, con l'approvazione del papa
Urbano II (bolla
pontificia del 9 marzo 1092);
la città sarà elevata solo nel 1859 a
sede arcivescovile. Fu poi governata dagli Svevi,
periodo in cui si eresse il Castello
Ursino e si crearono le figure amministrative che perdurarono
fino al 1817 circa.
La città fu una delle sedi della corte di Federico
II di Svevia e da qui furono emanati editti e leggi di grande
importanza. Alla fine del casato Hohenstaufen furono
gli Angioini a
prendere possesso della città, occupandola militarmente abusando spesso
della popolazione locale.
Nel 1282,
passò al ramo cadetto della Corona
d'Aragona (in quanto la moglie di Pietro
III, Costanza
di Svevia era figlia del re Manfredi) che fino a Martino
I fecero di Catania la capitale del regno
di Trinacria. Dopo l'annessione del regno all'Aragona,
la Sicilia perse l'indipendenza e passò sotto il dominio spagnolo,
poi sabaudo e
infine dei Borbone.
Nel 1622, Emanuele
Filiberto di Savoia, viceré
di Sicilia, con lettera ratificata da Filippo IV, aveva assegnato al Senato catanese
funzioni pari a quelli di Palermo e Messina, concedendole una certa
autonomia.
Le
due gravissime catastrofi naturali di fine XVII secolo (l'eruzione
dell'Etna del 1669 e il terremoto
del Val di Noto del 1693) segnano "il transito verso la modernità".
La ricostruzione post-terremoto si contraddistinse per lo stile Barocco; uno
tra i pochissimi grandi monumenti che mantenne la sua forma integra e
originale fu il Castello
Ursino. Di contro, antichi edifici furono rinnovati e riedificati con
i nuovi stili settecenteschi: grandi esempi sono la cattedrale (della
precedente rimasero integre solo le absidi normanne), il Palazzo
degli Elefanti, il Monastero
di San Nicolò l'Arena o nei vari monasteri siti in Via
dei Crociferi. Il lavoro del grande architetto Giovanni
Battista Vaccarini fu cruciale sia per i progetti che
interessarono questi particolari monumenti ma anche per il piano urbanistico
che egli stesso disegnò.
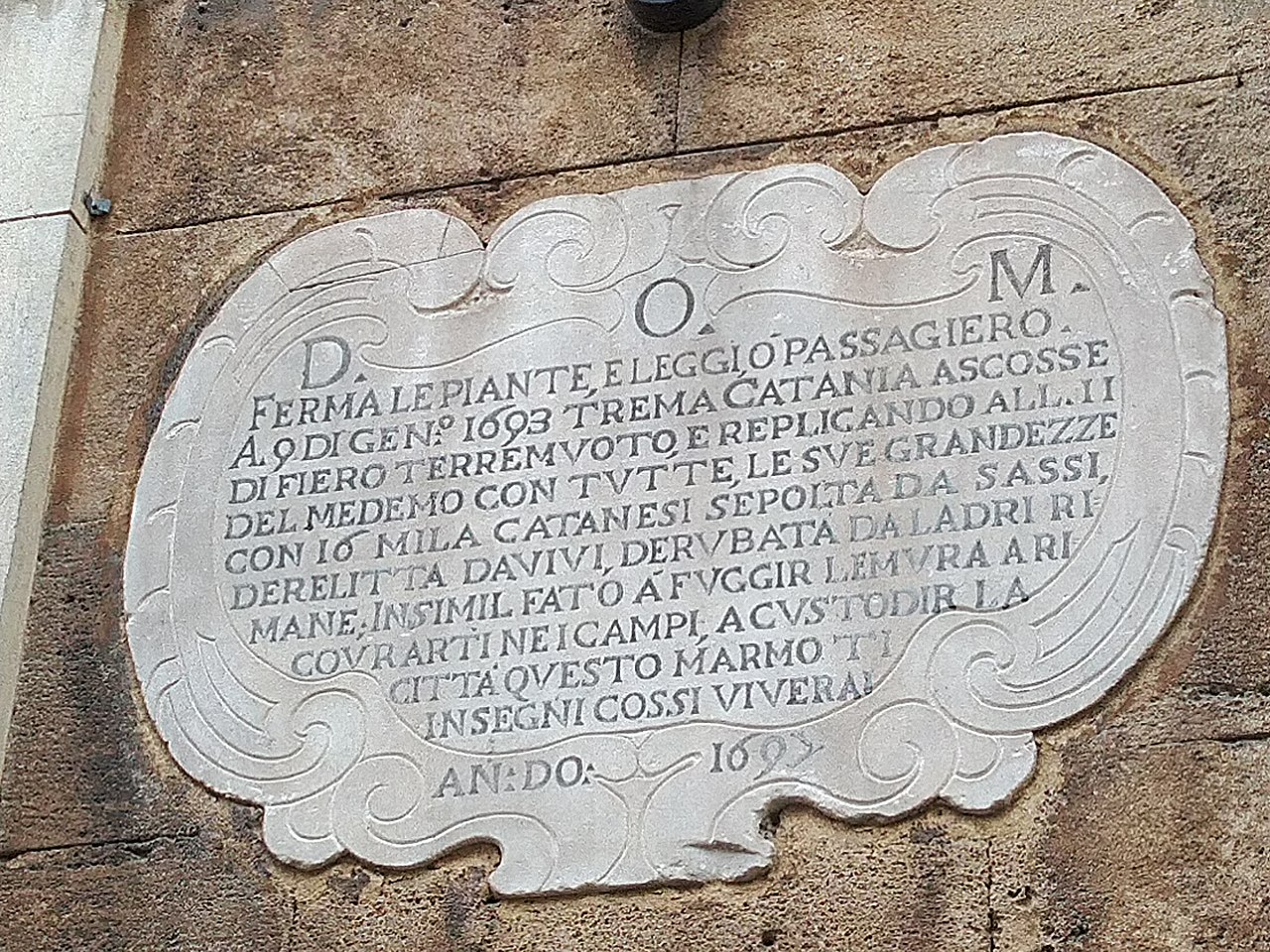
Tra
il 1816 e
il 1818 acquisì
lo status di Comune, lasciando quello di Urbs,
in modo da essere governata da un Intendente, coadiuvato dal Segretario
generale e dal Consiglio di Intendenza. Sempre nel 1818 - il 20 febbraio -
si verificò un terremoto con epicentro ad Aci
Catena o Aci
Sant'Antonio - diversi sono i pareri sul punto esatto - a causa
del quale Catania soffrì moltissimo: il Castello Ursino fu reso inabitabile
e vennero danneggiati i Conventi dei Minoriti (con l'annessa Chiesa
di San Michele Arcangelo), dei Francescani, dei Crociferi, di
Sant'Agostino, di Sant'Agata la Vetere e dei Benedettini, gli edifici
dell'Università, il Collegio Cutelli, il Seminario dei Chierici e gli
Ospedali di Santa Marta e di San Marco. Ma a differenza della provincia, che
ne risentì notevolmente anche dal punto di vista demografico, Catania
questa volta non registrò alcuna vittima.
Nel
1849, durante la riconquista
borbonica della Sicilia, la città subì pesanti distruzioni e i suoi
abitanti stupri, saccheggi e uccisioni fino a che il 7 aprile, dopo aspri
combattimenti, fu occupata dalle truppe di Ferdinando
II sotto il comando di Carlo
Filangieri, principe di Satriano. Nel 1898 la città fu insignita
della medaglia
d'oro al valor militare per le sue azioni eroiche di quei
giorni.
Nel 1860 Catania
entrò a far parte del Regno
d'Italia. Oggi è uno dei principali comuni italiani, capoluogo della
sua città metropolitana.
Città
antica
A
Catania del periodo greco non rimangono molte tracce, a causa di
vari fattori sia naturali (terremoti e colate laviche che hanno rovinato la
città) che antropici, come le ricostruzioni che spesso hanno ricoperto le
precedenti architetture. Inoltre, non sono mai state eseguite grandi
campagne di scavi e studi archeologici se non in casi sporadici della sua
storia recente. Tuttavia, secondo alcuni studiosi, gli zoccoli di alcune
costruzioni pubbliche e private tuttora esistenti sono da attribuire al
fiorente periodo della colonizzazione greca.
Gli
scavi archeologici all'interno dell'ex Monastero dei Benedettini nel 1978 (quando,
cioè, il complesso è stato acquistato e ristrutturato dal Comune) hanno
confermato un'imponente e stratificata urbanizzazione dell'area fin
dall'epoca eneolitica: sono state rinvenute strutture di edifici del VI e
del IV secolo a.C. appartenenti alla fase più antica della colonia
calcidese.
Miglior
fortuna hanno avuto i monumenti di epoca romana che hanno resistito fino ad
oggi testimoniando l'importanza della città nei tempi antichi, inoltre
numerosissimi reperti provengono dagli scavi occasionali della città (la
gran parte di questi – tra cui mosaici, statue e persino il frammento di
una colonna istoriata – sono esposti al Museo civico al Castello
Ursino).

Il Teatro
romano (del II secolo), l'Odeon (III secolo), l'Anfiteatro
romano (II secolo), le Terme
dell'Indirizzo (in
piazza Currò), le Terme
della Rotonda, le Terme
Achilliane (nei
pressi della cattedrale odierna in Piazza del Duomo), varie altre strutture
termali (Terme di Sant'Antonio Abate nella Piazza omonima, Terme dell'Itria
in Piazza Santa Maria dell'Itria, Terme dell'Acropoli in Piazza Dante
Alighieri e nel cortile del Monastero dei Benedettini), i resti di un
acquedotto presso via Grassi e alcuni sepolcri
romani (fra cui la Tomba
romana del Carmine del II
secolo), il Foro
romano (probabilmente
dove oggi è il Cortile San Pantaleone), una Domus
romana con i mosaici tardo-repubblicana
(tra gli esempi più significativi dell'attività edilizia romana in Sicilia
nel corso del II secolo d.C. sita nell'Emeroteca sotterranea del
Dipartimento di Scienze Umanistiche), le colonne di Piazza
Giuseppe Mazzini, quella
che sostiene la statua di Sant'Agata in Piazza dei Martiri, tre assi viari
(due si incrociano ortogonalmente al Monastero dei Benedettini dove sono
stati trovati ancora basolati, oggi allo scoperto), una strada che conduceva
in antico dal Teatro all'Anfiteatro corrispondente all'attuale via
dei Crociferi, sono i
maggiori resti attualmente visibili della "Catana"/"Catina"
romana. Molti di questi monumenti fanno parte dal 2008 del Parco
archeologico greco-romano di Catania (istituito
dalla Regione Siciliana) e
alcuni di essi come il Teatro romano, le Terme della Rotonda e altri
monumenti minori sono stati restaurati e resi visitabili. Anche i resti
dell'Anfiteatro sono visibili dal 1903-1907 (anni
in cui sono durati gli scavi per riportarli alla luce) dall'ingresso di Piazza
Stesicoro e dal
cortiletto di vico Anfiteatro, traversa di via Alessandro Manzoni, che
finisce a sua volta proprio in piazza Stesicoro.
Probabilmente
anche 'u
liotru, il simbolo
della città situato attualmente al centro di piazza del Duomo, è stato
scolpito in epoca romana se non prima. È un manufatto in pietra lavica
porosa, che raffigura un elefante.
Il nome deriva probabilmente dalla storpiatura del nome di Eliodoro,
mago semi-leggendario accusato di negromanzia e
grande avversario del vescovo Leone
il Taumaturgo, il quale lo
fece bruciare al rogo. L'elefante è sormontato da un obelisco egittizzante di
cronologia incerta con figure probabilmente legate al culto isideo.
Del
periodo tardo-antico rimangono i resti delle sepolture
cristiane a nord e ad
est del centro storico, come il Mausoleo circolare di Villa Modica (sito
in Viale Regina Margherita), l'Ipogèo quadrato (sito in via
Gaetano Sanfilippo, traversa di via Ipogèo, a sua volta traversa del
succitato Viale Regina Margherita), e come pure numerosi frammenti, lapidi
(tra cui l'epigrafe
di Iulia Florentina,
esposta al Museo
del Louvre), o il cippo
Carcaci, esposto sempre nel Museo civico al Castello Ursino. Sono invece
di epoca paleocristiana le cripte di Sant'Euplio,
di Santa
Maria di Betlemme, della
"Cappella dell'Albergo dei Poveri" (dedicata a "Santa Maria
della Mecca", oggi nell'Ospedale Giuseppe Garibaldi-Centro), e del Santo
Spirito, nonché gli
ambienti fra il cosiddetto Sacro
Carcere e l'ex
Cattedrale di Sant'Agata la Vetere,
prima chiesa al mondo dedicata alla Santa, dal 1933 gestita
da un ente morale.
Città
medioevale
Un
monumento di età bizantina (VI-IX
secolo) è la Cappella
Bonajuto (dal nome della famiglia nobiliare che l'aveva tenuta come
sacrario di famiglia nonché come cappella privata): si tratta di una "trichora"
bizantina (cioè un edificio con tre absidi); prima del suo restauro se ne
aveva conoscenza grazie ai disegni di Jean-Pierre
Houël.
 Del
periodo arabo (IX-XI
secolo) alcune chiese vengono trasformate in moschee, altre abbandonate,
altre ancora demolite. Del
periodo arabo (IX-XI
secolo) alcune chiese vengono trasformate in moschee, altre abbandonate,
altre ancora demolite.
Del
periodo normanno (XII
secolo) si conservano principalmente le strutture come le absidi della Cattedrale
di Sant'Agata, tesa a farla diventare "Ecclesia Munita"
("chiesa fortificata", per via delle scorrerie dei Saraceni), che
poi sarebbero state ristrutturate dopo il terremoto del Val di Noto del
1693. Oggi, vicino alla cattedrale si conservano la Vara, ovvero
il Fercolo, il busto-reliquiario e la cassa-reliquiaria di Sant'Agata,
realizzati nel 1376 dall'orafo
e scultore senese Giovanni
di Bartolo. Del periodo normanno (XII
secolo) è il portale della Chiesa
di Sant'Agata al Carcere che era il portale principale della
cattedrale normanna.
Del
periodo svevo (XIII
secolo) è il famoso Castello
Ursino, federiciano (sede
del Museo
civico, formato principalmente dalle raccolte Biscari e dei benedettini,
dal 1927)
e coevo dell'altrettanto famoso castello di Castel
del Monte ad Andria e
del siracusano Castello
Maniace.
Del
periodo Aragonese (XIII-XV
secolo) si ricordano, invece, il portale della scomparsa Chiesa
di San Giovanni de' Fleres, demolita alla fine del XIX
secolo e di cui oggi rimane solo l'arco, e il balcone del palazzo
Platamone, donato in seguito ai religiosi che lo trasformarono nel
Monastero di San Placido, che quando fu danneggiato dal suddetto terremoto
fecero rimanere le testimonianze più salienti di quando questo edificio fu
nobile.
Città
rinascimentale
Del
periodo tardo aragonese rimangono poche tracce, tra cui la chiesa
di Santa Maria di Gesù situata nella piazza omonima e costruita
nel 1498 è
forse l'esempio in migliori condizioni. La chiesa fu ristrutturata nel Settecento,
mentre il portale è del Cinquecento e
solo la Cappella Paternò mantiene l'originale struttura gotica.
 Nel 1558,
fu iniziata la costruzione del Monastero
dei Benedettini, a cui sarebbe poi stata affiancata la Chiesa
di San Nicolò l'Arena. Distrutto dalla colata lavica del 1669 e dal
terremoto del 1693, nel 1703 se
ne avviò la ricostruzione che tuttavia non è stata mai più portata a
termine. Di detto edificio permangono tutt'oggi le antiche cucine, il
chiostro occidentale, nonché la traccia dell'antico archeggiato del
corridoio di meridione. Nel 1558,
fu iniziata la costruzione del Monastero
dei Benedettini, a cui sarebbe poi stata affiancata la Chiesa
di San Nicolò l'Arena. Distrutto dalla colata lavica del 1669 e dal
terremoto del 1693, nel 1703 se
ne avviò la ricostruzione che tuttavia non è stata mai più portata a
termine. Di detto edificio permangono tutt'oggi le antiche cucine, il
chiostro occidentale, nonché la traccia dell'antico archeggiato del
corridoio di meridione.
Le
cosiddette Mura
di Carlo V, che racchiudono il centro storico, furono erette nel XVI
secolo, tra il 1550 e
il 1555 su
un progetto iniziale di Antonio
Ferramolino. Il progetto non riuscì ad essere portato a termine,
neanche dopo l'apporto di Tiburzio
Spannocchi il quale progettò l'ampliamento delle fortificazioni
verso sud-ovest e verso nord a scapito delle vecchie mura di epoca medioevale (tra
cui l'antica Torre
del Vescovo del 1302).
Venne
eretta nel 1612,
sotto il re di Spagna e di Sicilia Filippo
III, la fontana
dei Sette Canali. E nel 1621 sorsero
la fontana
di Sant'Agata e, su consiglio dell'incaricato dal luogotenente del
re, ingegnere Raffaele Lucadello, quella detta «di Gammazita», di cui oggi
resta soltanto il «pozzo» nei
pressi dell'attuale via San Calogero.
La
colata dell'eruzione
del 1669 inghiottì parte del sistema difensivo a sud e a sud-ovest
della città che, rimasta sguarnita da questo lato, riedificò in parte
sulle lave ancora calde una cortina muraria, detta popolarmente fortino,
su cui ancora si apre la porta d'accesso (Porta del Fortino Vecchio in
via Sacchero, un tempo dedicata al duca
di Ligne che qui vi passò nel 1672)
e di cui rimangono ancora sparute tracce. Su tali mura venne ricavata la porta
Ferdinandea, ancora oggi erroneamente detta u futtinu ("il
fortino").
Con
il terremoto
del 1693 e la seguente ricostruzione si volle dare alla città un
aspetto più aperto e libero dai fortilizi (i resti furono infatti inglobati
nello sviluppo della città), anche perché ormai non esisteva più il
pericolo delle incursioni piratesche che secoli prima diedero l'impulso alla
fortificazione del Regnum.
Città
barocca

Catania
è stata ampiamente trasformata dalle conseguenze dei terremoti che
hanno imperversato su questa parte della Sicilia. Il suo territorio
circostante è stato più volte coperto da colate laviche che
hanno raggiunto il mare.
Ma i catanesi caparbiamente l'hanno ricostruita sulle sue stesse macerie. La
leggenda vuole che la città sia stata distrutta sette volte durante la sua
storia, ma in realtà tali eventi disastrosi si possono sicuramente riferire
a pochi ma terribili eventi. Anche le distruzioni del centro urbano in tempi
recenti a causa delle colate laviche sono frutto di una storiografia
fantasiosa. In
epoca storica Catania venne danneggiata dai prodotti
piroclastici dell'Etna nel 122 a.C.;
le fonti antiche riferiscono di tetti crollati per il peso eccessivo delle
ceneri e di raccolti distrutti.
È testimoniata tuttavia anche dal punto di vista archeologico la presenza
di colate che giunsero a colpire parte della città antica.
La
calamità che avrebbe poi reso Catania la perla del tardo barocco siciliano
è senza dubbio il terremoto che si registrò tra le giornate del 9 e
dell'11 gennaio 1693,
quando tutto il Val di Noto fu distrutto da potenti scosse. Nella città
etnea si contarono numerose vittime, dovute soprattutto alla scarsa
larghezza delle strade principali, che non permise ai cittadini di potervisi
riversare. Durante la ricostruzione l'idea di risolvere questo problema fu
di Giuseppe
Lanza, duca di Camastra,
progettando larghe vie principali, quali le centralissime Via Etnea, Via
Vittorio Emanuele II (che all'epoca si chiamava "Corso reale"),
Via Plebiscito e Via Giuseppe Garibaldi (all'epoca conosciuta come via San
Filippo). Tutti i monumenti antichi furono inseriti nel tessuto urbano della
città ricostruita grazie a tanti artisti, anche di fama nazionale, tra cui
di certo spicca l'opera dell'architetto Giovanni
Battista Vaccarini,
che hanno dato alla città una chiara impronta barocca.
Tra gli altri che hanno aiutato la rinascita della città si ricordano Francesco
Battaglia, Stefano
Ittar, Alonzo
di Benedetto e Girolamo
Palazzotto.

Città
ottocentesca
Come
monumenti dell'Ottocento sono da segnalare teatri e fontane: per quello che
riguarda i primi, nel 1821 venne
costruito il Teatro
Pietro Antonio Coppola,
primo teatro comunale a Catania, sito nel quartiere Civita,
che fu adibito principalmente alla rappresentazione di opere
liriche.
Il teatro venne poi chiuso nel 1887 quando
fu inaugurato il teatro
Massimo Vincenzo Bellini nel 1890,
seguendo lo stile dell'Opéra
national de Paris,
in piazza Vincenzo Bellini, nel quartiere Agnonella.
Per
quello che riguarda le seconde, a Catania non c'è più traccia di quella
che aveva al centro un obelisco e che i catanesi avevano innalzato nel 1862,
in un primo tempo nell'attuale piazza Duca di Genova, per ricordare la
visita compiuta in quell'anno alla città dai tre figli del primo re
d'Italia Vittorio
Emanuele II (Umberto,
Amedeo e Oddone), poi ricollocata nella zona di piazza Mario Cutelli, sempre
alla Civita.
Nel
biennio 1863-1865,
il Comune provvide a dotare la città di fontanelle, nel quartiere Fortino,
in piazza Crocifisso della Buona Morte (poi "piazza Alfredo
Cappellini", dal 1907,
e oggi "piazza Giovanni Falcone"), nel Largo dei Miracoli, nel
Largo delle "Chianche Mortizze", nella piazza Monserrato, in
quella della Guardia, nonché nel rione della Consolazione, ormai tutte
scomparse.

Città
novecentesca
Come
monumenti del Novecento a Catania sono da segnalare fontane e palazzi: tra
le prime, la Fontana
di Proserpina,
che risale al 1904 ed
è sita in piazza Stazione Centrale (oggi "piazza Papa Giovanni XXIII"),
è stata costruita 'di getto' in pochi mesi, ed è la penultima scultura di Giulio
Moschetti.
Per
quello che riguarda i secondi, nel 1922 comincia
la costruzione del Palazzo
delle poste centrali,
con un progetto risalente a quattro anni prima per opera dell'architetto Francesco
Fichera,
ultimato nel 1929 e
inaugurato l'anno seguente.
Nel 1933 è
stato inaugurato il Palazzo
della Borsa,
costruito su progetto dell'architetto Vincenzo
Patanè coadiuvato
da Giovanni
Aiello in
uno stile tra il classico e il barocco. Nel 1937 inizia
invece la costruzione del Palazzo
di Giustizia,
che termina solo nel 1953,
e in seguito della fontana
de I Malavoglia in
piazza dell'Esposizione, l'attuale piazza Giovanni Verga.
Nello
stesso periodo sorge il Palazzo
Generali,
primo grattacielo della città, che ha 19 piani.
Sotto
il sindaco Domenico
Magrì,
agli inizi degli anni
cinquanta,
sorgono tre nuove fontane: la prima è la fontana
delle Conchiglie,
in piazza Mario Cutelli ed è stata realizzata su disegno di Domenico
Cannizzaro;
un'altra, al largo Giovanni Paisiello, è un'opera modernissima di Dino
Caruso,
in ceramica e pietra lavica; e infine viene ricollocata la fontana
dei Delfini,
in piazza Vincenzo Bellini, opera di Giovanni
Battista Vaccarini,
proveniente dal chiostro della Badia
Sant'Agata.
Il
Piano Regolatore Generale di Luigi
Piccinato diede
avvio nel 1961 anche
ai lavori di costruzione del complesso della Cittadella
Universitaria sulla
collina di Santa Sofia, previsto già da un precedente PRG degli anni
trenta,
che oggi è uno dei maggiori poli di ricerca dell'Ateneo.

La
storia di Catania è arricchita da molte leggende di
cui quattro sono state rappresentate nei rispettivi lampioni di Piazza
dell'Università realizzati
da Mimì
Maria Lazzaro e Domenico
Tudisco agli
inizi del Novecento: Colapesce,
i Fratelli
Pii, Gammazita e Uzeta.
Una
delle leggende di Colapesce narra che egli era un giovane (Nicola il
pesce) che poteva stare sott'acqua per molto tempo; non appena Federico
II ne
venne a conoscenza, lo sfidò a recuperare una coppa d'oro. Colapesce lo
fece ed ottenne in premio la coppa. Il re, allora, gli chiese di vedere cosa
c'era sotto la Sicilia. Riemerso, Colapesce informò il re del fatto che la
Sicilia poggiava su tre colonne e che una di esse era consumata dal fuoco.
Federico II gli chiese di portargli il fuoco ma Colapesce, tuffatosi
nuovamente in mare, non riemerse mai più. Secondo la leggenda è ancora in
fondo al mare e continua a reggere la colonna che stava per crollare.
I
fratelli Pii (Anfinomo ed Anapia) cercarono di salvare gli anziani genitori
portandoli sulle proprie spalle durante un'eruzione dell'Etna; mentre
stavano per essere travolti il fiume di lava si
divise per volere degli dei e tutti si salvarono.
Gammazita
era una giovane virtuosa; di lei si invaghì un soldato francese,
che fu rifiutato; un giorno Gammazita, recatasi da sola ad un pozzo,
venne raggiunta dall'innamorato e, per non cedere alle sue richieste, si
uccise gettandosi dentro la cavità.
Uzeta
è protagonista di una leggenda inventata agli inizi del Novecento: questo
ragazzo di umili origini diventò cavaliere per
la sua bravura e riuscì a sconfiggere gli Ursini, giganti saraceni che
avrebbero dato il nome al Castello.
Altre
leggende occupano invece la memoria dei luoghi di Catania – così alla
divinità fluviale Ongia si dovrebbe il nome del borgo marinaro di Ognina (secondo
alcuni studiosi piuttosto dal nome del fiume che lo bagnava, il Longane,
secondo altri dal celebre castello del re Italo a Λογγον, Longon)
– o dell'Etna, dove una tradizione attribuita a Gervasio
di Tilbury (che
era ospite della corte normanna) vuole che essa fosse l'ultima
dimora di Re
Artù,
e che quest'ultimo abbia donato Excalibur al
re Tancredi.
Legata a questa leggenda il mito del cavallo del vescovo,
attribuita piuttosto ad eventi di epoca sveva.
La nascita dell'Etna sarebbe a sua volta legata ad un evento mitologico: la
sconfitta di Tifeo da
parte di Zeus che,
con un grosso macigno che è oggi la stessa Etna, lo seppellì e quando il
gigante si dovesse muovere sarebbe egli la causa dei terremoti e delle
eruzioni etnee.
Inoltre
pure molte leggende, sempre legate alle forze della natura, hanno circondato
gli eventi del sisma del 1693, come la storia di don
Arcaloro,
e quella del vescovo Francesco
Carafa.

 Pag. 2
Pag. 2
|