|
Monastero
di
San
Nicolò
l'Arena
Il monastero
di
San
Nicolò
"la
Rena"
è
un
complesso
ecclesiastico
del centro
storico,
costituito
da
un
importante
edificio
monastico benedettino e
da una
monumentale
chiesa
settecentesca.
Intorno
alla
seconda
metà
del XII
secolo,
sulle
pendici
dell'Etna,
venne
eretta
una cappella e
un
ricovero
per
i
monaci
infermi
dei
vicini
monasteri
di Santa
Maria
di
Licodia e San
Leone
del
colle
Pannacchio,
nei
pressi
di Paternò.
In
seguito
per
volere
di Federico
III
di
Sicilia,
vi
si
costruì
il monastero,
che
venne
costituito
sede
principale
dei
cenobi,
prendendo
la
denominazione
di
"San
Nicolò
la
Rena"
per
la
devozione
dei
monaci
a San
Nicola
di
Bari e
per
la
caratteristica
terra
sabbiosa
-
la rena
rossa,
da rena o arena che
in latino indica
"sabbia"
-
che
ricopriva
la
zona.
Attorno
al
monastero
prese
ben
presto
forma
il
paese
di Nicolosi.
Il
cenobio
negli
anni
si
espanse
superando
in
importanza
quello
di
Licodia
(a
testimonianza
di
ciò
basti
ricordare
le
numerose
visite
delle
regine Eleonora
d'Angiò e Bianca
di
Navarra e
il
favore
sempre
avuto
dai
regnanti
a
partire
da
Federico
III)
e
accumulò
notevoli
ricchezze.
Nel
1483,
i
monasteri
benedettini
di San
Placido
Calonerò, San
Nicolò
l'Arena, Santa
Maria
Nuova, Santa
Maria
di
Licodia si
costituirono
in
congregazione,
la
quale
fu
chiamata
«Congregazione
dei
Monaci
di
San
Benedetto
in
Sicilia».
Essa
fu
approvata
da Papa
Sisto
IV e
furono
concessi
privilegi
simili
a
quelli
goduti
dalla
«Congregazione
di
Santa
Giustina».
Nel
1504,
con
l'annessione
dell'abbazia
di
Montecassino,
la
Congregazione
benedettina
di
Santa
Giustina
mutò
nome,
chiamandosi
appunto, Congregazione
cassinese.
Nel
1506
all'interno
di
quest'ultima
confluì
la
Congregazione
sicula.
Ma
le
scorribande
di
briganti
che
imperversavano
nella
zona
(i
cosiddetti bravi),
favorite
dal
relativo
isolamento
di
questo
come
del
cenobio
di
San
Leone,
unite
al
clima
rigido
dell'Etna,
spinsero
i
monaci
a
richiedere
insistentemente
il
trasferimento
a
Catania,
città
munita
e
dunque
più
sicura
e
in
più
molto
ben
disposta
ad
accogliere
una
congregazione
così
ricca
e
importante,
detentrice
della
reliquia
del
Santo
Chiodo,
molto
venerata
dai
catanesi,
che
avrebbe
aumentato
notevolmente
la
ricchezza
e
il
prestigio
della
città.
L'eruzione del 1536-1537,
che
distrusse
il
monastero
di
San
Leone,
accelerò
i
tempi:
i
due
cenobi
superstiti,
quello
di
Nicolosi
e
quello
di
Santa
Maria
di
Licodia,
con
i
monaci
di
San
Leone
che
vi
si
erano
rifugiati,
ottennero
il
permesso
di
trasferirsi
dentro
le
mura
della
vicina
città
demaniale.

I
monaci
Benedettini,
trasferiti
nel XVI
secolo a
Catania,
ottennero
il
permesso
di
costruire
la
nuova
sede
del
monastero
entro
le
mura
della
città,
nei
luoghi
attuali,
allora
detti
"della
Cipriana"
e
"del
Parco".
Iniziata
la
costruzione
nel 1558 alla
presenza
del viceré
di
Sicilia Juan
de
la
Cerda,
duca
di Medinaceli,
nel 1578 ancora
incompleto
fu
occupato
dai
monaci,
e,
poco
dopo,
venne
iniziata
anche
la
costruzione
della
chiesa.
Nel
corso
del XVII
secolo,
con
l'aumentare
delle
ricchezze
a
disposizione
del
cenobio,
chiesa
e
monastero
furono
dotati
di
apparati
sempre
più
fastosi,
come
nel
grande
chiostro
sistemato
nel 1608 con
colonne
di
marmo
bianco
e
ricchi
ornamenti.
Nel 1669,
a
seguito
della
devastante eruzione
dell'Etna,
la
colata
raggiunse
e
accerchiò
Catania
lambendo
le
mura
del
cenobio
e
lesionandolo,
mentre
una
lingua
di
lava,
staccandosi
dalla
principale,
distrusse
la
chiesa
di
San
Nicolò.
Per
ricostruirla
dovettero
passare
moltissimi
anni
data
la
vastità
del
monastero.
Fu
allora
che
i
benedettini
diedero
vita
ad
un'imponente
opera
di
ristrutturazione
e
completamento
(con
l'aggiunta
fra
l'altro
della
monumentale
fontana
marmorea
nel
chiostro)
e
contemporaneamente
avviata
la
ricostruzione
della
chiesa
di
San
Nicolò,
iniziata
nel 1687 su
progetto
dell'architetto romano Giovan
Battista
Contini.
L'11
gennaio 1693,
il terremoto
che
colpì
la
città provocò
anche
il
crollo
del
monastero
benedettino
e
la
morte
della
maggior
parte
dei
monaci
lasciandone
appena
tre
in
vita.
Le
strutture
della
chiesa,
ancora
in
corso
di
costruzione,
furono
risparmiate,
ma
i
lavori
furono
interrotti
per
circa
vent'anni.
Inizialmente
i
monaci
superstiti
cercarono
di
trasferire
il
cenobio
nella
vicina
località
di Monte
Vergine e
lì
cominciarono
persino
a
costruire
il
nuovo
monastero,
ma
costretti
dal
senato
cittadino
ritornarono
a La
Cipriana nel 1702 e
cominciarono
la
ricostruzione
sulle
strutture
superstiti.
Il
progetto
fu
affidato
al
messinese Antonino
Amato,
che
ideò
un
impianto
ancor
più
monumentale
del
precedente,
certo
in
sintonia
con
le
idee
di
ricchezza
e
grandiosità
dei
monaci
stessi.
L'impianto
cinquecentesco
originale
fu
ampliato
ad
oriente
con
la
costruzione
di
un
secondo
chiostro
accanto
al
più
antico,
mentre
altri
due
chiostri
avrebbero
dovuto
chiudere
simmetricamente
il
complesso
a
nord
sull'altro
fianco
della
chiesa.

Nei
successivi
venti
anni
furono
completati
gli
intagli
in
pietra
dei
prospetti
principali
ma
i
lavori
di
costruzione,
ampliamento
e
decorazione
continuarono
per
tutto
il XVIII
secolo,
prima
con
il
chiostro
dei
marmi,
o
"di
ponente",
-
dove
furono
rimesse
in
opera
le
colonne
seicentesche
e
la
fontana
-
poi
con
l'ampliamento
a
nord
ad
opera
degli
architetti Francesco
Battaglia e Giovanni
Battista
Vaccarini.
Se
al
primo
si
deve
l'avvio
del
prolungamento
settentrionale
verso
l'alto
banco
lavico
dell'eruzione
del 1669,
al
secondo
spetta
la
rottura
della
originaria
simmetria
progettuale:
le
sale
comuni
e
di
rappresentanza
del
monastero
occuparono
infatti
l'area
del terzo chiostro,
preludio
al
definitivo
abbandono
del
grandioso
progetto
originale.
L'opera
del
Vaccarini
fu
completata
dopo
il 1747 dal
Battaglia,
che
si
occupò
anche
di
altre
opere
all'interno
del
complesso:
il
ponte
verso
la
flora
benedettina
(ossia
il
giardino
dei
monaci
ricavato
sul
banco
lavico
ad
est
del
complesso
e
oggi
occupato
dall'Ospedale
Vittorio
Emanuele
II),
il
Coro
di
Notte,
la
continuazione
dei
lavori
della Chiesa
di
San
Nicolò
l'Arena (interrotti
a
causa
di
crolli
e
cedimenti
strutturali
nel 1755).
Nel 1767,
nel presbiterio della
chiesa
veniva
inaugurato
il
grande organo di Donato
Del
Piano,
ma
occorsero
ancora
molti
anni
prima
che
venisse
voltata
l'intera
navata.
Solo
nel 1780 Stefano
Ittar portò
a
termine
la
cupola
mentre
la
facciata
progettata
da Carmelo
Battaglia
Santangelo rimase
incompiuta.
Sempre
Ittar
si
occupò
anche
della
sistemazione
spaziale
del
piano
antistante
la
chiesa,
l'attuale Piazza
Dante
Alighieri,
progettando
nel 1769 la
grande Esedra con
i
tre
monumentali
palazzi,
non
solo
per
questioni
estetiche
e
religiose
(la
piazza
era
teatro
di
varie
feste
religiose,
soprattutto
la
processione
del
Santo
Chiodo)
quanto
come
avvio
del
necessario
risanamento
del
quartiere
circostante,
il
cosiddetto Antico
Corso,
fra
i
più
poveri
e
malsani
della
città.
A
questo
punto
gran
parte
del
monastero
e
della
chiesa
era
già
completata
e
i
monaci
si
dedicarono
nei
decenni
successivi
alla
decorazione
interna
degli
ambienti,
a
dotare
di
marmi
pregiati
e
dipinti
le
cappelle,
a
mettere
insieme
quelle
grandi
collezioni
artistiche,
archeologiche,
librarie,
naturalistiche
e
scientifiche,
che
lo
resero
famoso
in
tutta
Europa.

Intorno
al 1840,
venivano
affidati
all'ingegnere
Mario
Musumeci
i
lavori
di
completamento
dei
chiostri,
ultimi
interventi
architettonici
di
rilievo
prima
dell'incameramento
al demanio dell'intero
complesso
nel 1866.
Il
monastero
di
San
Nicolò
l'Arena
fu
infatti
interessato
dalle leggi
di
soppressione
delle
corporazioni
religiose e
i
monaci
furono
costretti
a
lasciare
l'edificio:
nel 1867 avvenne
il
passaggio
dell'intero
complesso
dall'ultimo
abate Giuseppe
Benedetto
Dusmet,
divenuto
quello
stesso
anno
arcivescovo
di
Catania,
alle
istituzioni
cittadine.
Negli
anni
successivi,
il
grande
complesso
fu
adibito
a
vari
usi
e
frazionato
in
più
parti.
Ospitò
caserme,
scuole
e
istituti
tecnici,
per
un
certo
periodo
anche
il Museo
civico (poi
trasferito
al Castello
Ursino),
l'osservatorio
astrofisico
del
professor Pietro
Tacchini,
nonché
il
laboratorio
di geodinamica di Annibale
Riccò oggi
sede
del museo
della
fabbrica,
ma
soprattutto
divenne
sede
della
Biblioteca
Civica
di
Catania
formatasi
a
partire
da
quella
benedettina
e,
con
i
successivi
ampliamenti,
divenuta
l'odierna
istituzione
delle Biblioteche
riunite
Civica
e
A.
Ursino
Recupero.
Danneggiato
dai
bombardamenti
durante
la Seconda
guerra
mondiale,
l'intero
complesso,
esclusa
la
chiesa
di
San
Nicolò
restituita
ai
Benedettini,
fu
infine
ceduto
all'Università
degli
Studi
di
Catania che
avviò
subito
un
vasto
progetto
di
recupero
e
restauro
condotto
dal
professore
e
architetto Giancarlo
De
Carlo.
Tale
progetto
ha
reso
possibile
l'adeguamento
dell'antico
complesso
monastico
a
sede
delle
Facoltà
di
Lettere
e
Filosofia
e
Lingue
e
Letterature
Straniere,
oggi
accorpate
nel
Dipartimento
di
Scienze
Umanistiche
(DISUM),
del
predetto
Ateneo.
|

UNA
CITTADELLA
NATA
SULLA
SABBIA
-
DALLE
PENDICI
DELL'ETNA
ALL'ACROPOLI
GRECA
Il
monastero
benedettino
di
San
Nicolo
l'Arena,
deriva
il
nome
dal
luogo
dì
fondazione.
Il
primo
nucleo
sorse
infatti
nel
XII
secolo
alle
pendici
dell'Etna,
in
una
zona
coperta
di
terra
sabbiosa
(rena);
in
origine
semplice
ricovero
per
i
monaci
infermi
dei
vicini
monasteri
di
Santa
Maria
di
Licodia
e
San
Leone
di
colle
Pannacchio,
vicino
a
Paterno,
divenne
con
il
tempo
il
potente
monastero
di
San
Nicolo
la
Rena,
che
superò
in
importanza
e
ricchezza
gli
altri
cenobi.
Nel
'500
il
pericolo
di
eruzioni
e
incursioni
banditesche
spinse
i
monaci
a
trasferirsi
in
città,
in
un
nuovo
convento,
costruito
sul
sito
dell'acropoli
greca,
inaugurato
nel
1578.
Dopo
la
rovinosa
eruzione
del
1669,
il
complesso
fu
ricostruito
secondo
un
ambizioso
progetto
dell'architetto
romano
Giovan
Battista
Contini,
ma
il
terremoto
del
1693
distrusse
il
convento
e
fermò
i
lavori,
ripresi
solo
dieci
anni
dopo
e
continuati
per
tutto
il
700.
Sull'elegante
esedra
di
piazza
Dante
(1),
disegnata
da
Stefano
Ittar,
prospetta
la
facciata
incompiuta
(2)
dì
San
Nicolo,
una
delle
chiese
più
imponenti
della
Sicilia
(105
metri
per
48),
sormontata
dalla
cupola
(3)
dello
stesso
Ittar.
Da
un
portale
barocco
(4)
si
entra
nel
cortile
a
"L"
del
monastero,
affiancato
sul
lato
lungo
dalle
ex
stalle,
oggi
aule
universitarie
(5).
Un
elaborato
portale
neoclassico
(6)
porta
allo
scalone
d'onore
e
al
complesso
benedettino
con
i
due
chiostri:
il
primo
(7),
occupato
da
un
giardino,
ha
al
centro
un
chioschetto
neogotico,
il
secondo
(8),
il
più
antico,
i
resti
di
una
fontana
del
'600.
Un
corridoio
porta
all'ala
del
convento
destinata,
nei
progetti
originari,
a
due
chiostri
mai
realizzati.
Qui
sorgono
il
grande
Refettorio
(9),
oggi
Aula
Magna
della
facoltà
di
Lettere,
le
antiche
cucine
(10)
decorate
da
vivaci
maioliche,
e
la
biblioteca
dei
monaci,
con
la
sala
Vaccarini
(11),
dai
magnifici
scaffali
in
legno
scolpito,
e
le
altre
sale
più
piccole
(12),
oggi
sede
della
Biblioteca
Unita
Ursino
Recupero.
|

MONASTERO
-
Gli
edifici
monastici
di
San
Nicolò
l'Arena
occupano
un'area
enorme,
che
cinge
su
tre
lati
la
grande
chiesa,
e
che
nonostante
i
cambiamenti
subiti
nell'ultimo
secolo
è
ancora
perfettamente
riconoscibile.
Il
Monastero
appare
infatti
diviso
dal
resto
della
città,
di
cui
costituiva
l'estremità
occidentale,
da
un
alto
muro
di
cinta
su
cui
si
aprono
i
due
portali
principali:
il
primo
a
nord,
divenuto
alla
fine
del
XIX
secolo
imbocco
di
via
Biblioteca,
è
situato
in
fondo
alla
via
Clementi,
continuazione
della
via
di
Sangiuliano,
in
origine
chiamata
via
Lanza,
in
onore
del
duca
Giuseppe
Lanza
di
Camastra
che
l'aveva
tracciata
subito
dopo
il
terremoto
del
1693;
il
secondo,
affacciato
su
piazza
Dante,
in
corrispondenza
dell'antico
monastero
cinquecentesco,
di
cui
i
monaci
avevano
cominciato
la
ricostruzione
dopo
il
grande
sisma.
Da
questo
secondo
portale
si
accede
all'enorme
corte
esterna
che
aveva
più
funzioni,
principalmente
di
filtro
tra
il
mondo
esterno
laico
e
quello
religioso
dell'edificio.
Addossati
al
muro
di
cinta
erano
vari
locali
di
servizio
comprese
le
cavallerizze
(scuderie),
le
stalle
e
le
carretterie
(rimesse
per
i
veicoli).
Circondato
da
questo
grande
cortile
sorge
in
tutta
la
sua
imponenza
il
monastero
vero
e
proprio,
celebrato
da
Patrick
Brydone,
in
viaggio
in
Sicilia
nel
1773,
che
lo
definì
Versailles
siciliana.
Esso
presenta
un
basso
piano
terreno,
con
porte
che
si
affacciano
sul
cortile,
su
cui
poggiano
i
due
piani
principali.
La
costruzione
del
piano
terreno,
non
appartenente
alla
tradizionale
modalità
costruttiva
delle
congregazioni
religiose
catanesi,
fu
dovuta
alla
volontà
di
allineare
il
secondo
piano
al
livello
del
banco
lavico
del
1669,
alto
circa
dodici
metri,
dove,
nei
progetti
dell'ambizioso
cenobio,
dovevano
sorgere
la
altre
ali
del
palazzo.
La
soluzione,
unita
al
filtro
costituito
dal
muro
di
cinta
che
isolava
il
cenobio
dalla
città,
comportò
però
anche
numerosi
accorgimenti,
tanto
funzionali
quanto
decorativi,
che
rendono
ulteriormente
originale
nel
panorama
degli
edifici
monastici
catanesi
quello
benedettino
di
San
Nicolò;
il
primo
piano
risultò
infatti
gerarchicamente
simile
al
secondo,
presentando
anch'esso
grandi
balconi
alle
finestre
e
una
maggiore
apertura
verso
l'esterno
tutt'altro
che
monastica.
Le
due
facciate
meridionale
ed
orientale
dispiegano
nelle
loro
superfici
tutto
il
repertorio
tardo
barocco
e
churrigueresco
dei
maestri
lapicidi
accorsi
a
Catania
da
tutta
la
Sicilia
per
prender
pare
alla
ricostruzione.
Una
infinita
serie
di
volute,
fiori,
frutti,
mascheroni
mostruosi,
putti,
e
ninfe
che
adornano
le
mostre
delle
finestre
e
i
balconi
mentre
le
paraste
giganti,
bugnate
a
punta
di
diamante
e
coronate
da
capitelli
corinzi,
denunciano
la
loro
natura
essenzialmente
ornamentale
nel
cornicione
sovrastante
che
non
vi
poggia
direttamente
a
causa
di
una
frangia
decorativa
fatta
di
volute
e
conchiglie
che
sembra
pendere
dal
cornicione.
Al
centro
della
facciata
principale,
ad
interrompere
la
sua
sfarzosa
teatralità
barocca,
Carmelo
Battaglia
Santangelo
verso
la
fine
del
700
inserì
il
maestoso
portale
ormai
quasi
neoclassico
nella
sua
semplice
linearità.
La
struttura
interna
dell'edificio
appare
estremamente
simmetrica
con
i
due
vasti
chiostri
quadrati
sui
cui
lati
corrono
lunghi
corridoi
che
si
intersecano
tutti
ortogonalmente
e
su
cui
si
aprono
le
porte
delle
celle
dei
monaci
e
dei
frati,
dell'appartamento
dell'abate
e
di
quello
del
re,
allineati
sulle
facciate
esterne.
I
collegamenti
verticali
sono
assicurati
da
numerose
scale,
tra
cui
la
principale
è
il
grande
scalone
a
tenaglia
di
Girolamo
Palazzotto,
adorno
di
stucchi
neoclassici.

I
chiostri
-
Il
primo
chiostro,
quello
di
levante,
è
occupato
da
un
folto
giardino
e
circondato
per
intero
di
portici
retti
da
pilastri
ed
archi
a
tutto
sesto,
con
una
terrazza
continua
soprastante.
Essi
furono
inizialmente
costruiti
da
Francesco
Battaglia
solo
sul
lato
settentrionale
a
reggere
il
corridoio
del
Coro
di
notte
al
secondo
piano.
All'ingegnere
Mario
Musumeci
furono
affidati,
nel
XIX
secolo,
i
lavori
di
completamento
del
chiostro
di
cui
coprì
con
nuovi
portici
gli
altri
tre
lati
replicando
quello
esistente,
risistemò
i
giardini
e
aggiunse
al
centro
l'originale
Caffeaos
neogotico,
decorato
di
maioliche
variopinte.
Il
secondo
chiostro
o
chiostro
di
marmo,
a
ponente,
è
il
più
antico
e
fu
infatti
costruito
sulle
rovine
del
monastero
precedente,
di
cui
sono
riconoscibili
alcuni
tratti
delle
fondazioni
cinquecentesche
nei
sotterranei.
In
origine
non
ospitava
come
l'altro
chiostro
un
giardino,
bensì
un
lastricato
monumentale
in
ciottoli
e
pietra
lavica
di
cui
ancora
si
intravedono
alcune
parti
sotto
lo
sterrato,
mentre
al
centro
sta
ancora
la
grande
fontana
marmorea
seicentesca.
Ai
lati
sono
addossati
i
portici
sorretti
da
colonne
di
marmo
bianco,
anch'esse
seicentesche
ed
appartenenti
al
primo
impianto
monastico,
rimesse
in
opera
nel
settecento.
In
questa
parte
del
monastero
particolarmente
interessante
è
la
biblioteca
universitaria
ricavata
negli
immensi
sotterranei
del
monastero
dove,
oltre
ai
resti
delle
fondazioni
cinquecentesche,
si
possono
ammirare,
nella
Emeroteca,
i
mosaici
di
un'antica
domus
romana,
tra
cui
uno
in
pregiato
opus
sectile,
rinvenuti
durante
gli
scavi
negli
anni
ottanta
e
riportati
alla
luce
e
restaurati
di
recente.
Tra
i
due
chiostri
corre
il
cosiddetto
corridoio
dell'orologio,
il
più
lungo
dell'edificio,
che
unisce
quest'ala
del
monastero,
la
parte
privata,
con
quella
di
rappresentanza,
dove
si
svolgeva
la
vita
comune
del
cenobio.
Nei
progetti
originari,
questa
nuova
ala
avrebbe
dovuto
presentare
due
chiostri
speculari
a
quelli
più
antichi
a
sud
della
chiesa,
ma
con
l'affidamento
dei
lavori
di
costruzione
al
Vaccarini
a
partire
dal
1739,
dopo
che
il
Battaglia
aveva
già
cominciato
la
costruzione
del
noviziato,
il
progetto
fu
notevolmente
modificato.
L'architetto
palermitano
prolungò
il
corridoio
dell'orologio
fino
ai
suo
limiti
ideali
già
tracciati,
ma
invece
dei
chiostri,
ai
due
lati,
costruì
l'antirefettorio,
i
due
refettori,
le
cucine,
la
grande
biblioteca
e
il
museo
senza
seguire
alcuno
schema
simmetrico
e
ingegnandosi
nella
scelta
di
forme
sempre
diverse
per
ogni
locale,
concezione
quanto
mai
barocca.

La
biblioteca
- Oggi
i
locali
del
museo,
della
biblioteca
e
del
refettorio
piccolo
sono
occupati
dalle Biblioteche
riunite
Civica
e
A.
Ursino
Recupero.
Nate
a
partire
dalle
collezioni
librarie
benedettine
confiscate
nel
1866
a
cui
si
aggiunsero
le
biblioteche
delle
altre
congregazioni
religiose
catanesi
che
formarono
la
biblioteca
comunale
nel 1869.
Ampliate
negli
anni
seguenti
con
la
Biblioteca-Museo
Mario
Rapisardi
e
soprattutto
con
il
lascito
del
Barone
Antonio
Ursino
Recupero
nel 1925 essa
oggi
possiede
circa
270.000
volumi
oltre
a
manoscritti,
pergamene,
corali,
erbari
(secchi
e
a
stampa),
cinquecentine,
libri
rari
e
di
pregio,
disegni,
stampe,
giornali
e
periodici
e
foto.
Le
antiche
sale
del
museo,
unite
assieme
da
grandi
arcate
mistilinee
furono
edificate
per
ospitare
le
vaste
collezioni
d'arte
dei
monaci,
poi
passate
al
demanio,
con
cui
fu
creato
il
primo
nucleo
del
museo
civico,
e
trasferite
negli
anni
trenta
del
XX
secolo
a Castello
Ursino.
Oggi
tutte
le
cinque
sale
del
ex-museo
contengono
libri
e
tre
di
esse
sono
destinate
alla
consultazione,
lettura,
direzione.
Il
refettorio
piccolo
è
di
forma
ovale
e
sormontato
da
un'alta
volta
adorna
di
stucchi,
ma
l'ambiente
certamente
più
grandioso
è
la
vasta
sala
della
biblioteca,
detta Sala
Vaccarini,
in
onore
del
suo
architetto,
che
sulla
porta
principale
porta
la
data
1733;
rettangolare,
su
due
piani,
rischiarata
da
grandi
finestre
ovali,
con
le
alte
scaffalature
e
il
ballatoio
in
legno
scolpito,
il
pavimento
in
maiolica
di
Vietri
e
la
volta
affrescata
da Giovanni
Battista
Piparo con
il trionfo
delle
scienze,
delle
arti
e
delle
virtù.
La
Sala
è
rimasta
immutata
dal
settecento
anche
nella
disposizione
dei
volumi,
divisi
per
facoltà.
Le
biblioteche
custodivano
il Tabulario del
monastero
e
quello
proveniente
dal Monastero
di
Santa
Maria
di
Licodia.
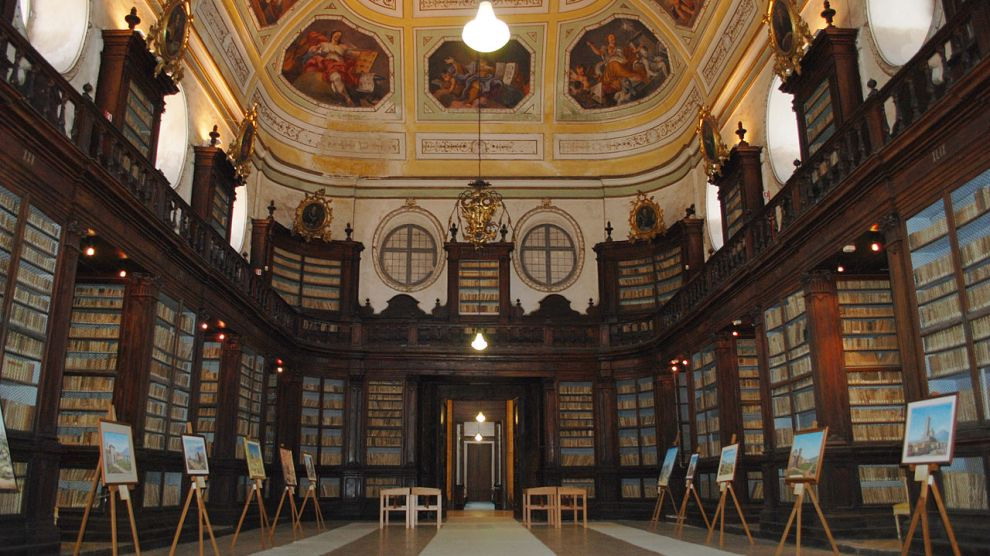
Il
seminterrato
seicentesco
- In
questa
parte
del
monastero
particolarmente
interessante
è
la
biblioteca
universitaria
ricavata
negli
immensi
sotterranei
del
monastero
dove,
oltre
ai
resti
delle
fondazioni
cinquecentesche,
si
possono
ammirare,
nella Emeroteca,
i
mosaici di
un'antica domus
romana risalente
al
II
secolo
d.C.,
tra
cui
uno
in
pregiato opus
sectile,
rinvenuti
durante
gli
scavi
negli
anni
ottanta,
riportati
alla
luce
e
restaurati.
In
particolare,
è
stata
rinvenuta
una
sezione
di
mosaico
in Opus
tessellatum
appartenente
al Peristilio della
domus
e
un Triclinio appartenente
ad
un'altra
domus
risalente
al
II
secolo
a.C.
Il
vano
che
ospita
il
triclinio
è
stato
ribattezzato
come
"stanza
della
tavola
imbandita"
poiché
le
pareti
presentano
un
affresco
risalente
al
I
secolo
d.C.
raffigurante
un
drappeggio
per
ornare
la
tavola.
Gli
studenti
possono
fruire
comodamente
degli
ambienti
della
biblioteca
e
dell'emeroteca
grazie
anche
ad
un
ponte
sospeso
sopra
l'area
archeologica
che
funge
da
corridoio.
Il
ponte
si
trova
sospeso
grazie
ad
un
sistema
di
tiranti
in
acciaio
che
spingono
tutti
i
pesi
sulle
pareti
cosicché
non
vi
sono
pilastri
che
intacchino
i
mosaici
romani.
Il
seminterrato
durante
la
confisca
si
ridusse
quasi
a
magazzino
e
durante
la
seconda
guerra
mondiale
fu
usato
come
rifugio
antiaereo;
soltanto
con
i
lavori
di
recupero
dell'università
negli anni
novanta emersero
i
resti
archeologici
sotto
il
pavimento
del
piano
cantinato.

Il
refettorio
grande
- La
costruzione
del noviziato che,
come
dice
lo
stesso
nome,
ospitava
i
novizi
del
monastero,
per
lo
più
appartenenti
alle
migliori
famiglie
aristocratiche
catanesi
e
siciliane,
fu
cominciata
da Francesco
Battaglia che
riprodusse
specularmente
l'impianto
dei
due
chiostri
esistenti
con
il
corridoio
affacciato
sul
chiostro
e
le
stanze
dei
novizi
allineate
sulla
facciata
esterna,
ma
la
costruzione
del
grande
refettorio
sull'altro
lato
del
corridoio
da
parte
del
Vaccarini
modificò
profondamente
questa
primitiva
concezione
sacrificando
la
simmetria
alla
grandiosità
e
allo
sfarzo.
L'antirefettorio
è
un'ampia
sala
rotonda
da
cui
si
accede
ai
due
refettori
e
alle
cucine;
decorato
da
massicce
colonne
tuscanine
binate,
che
reggono
una
spessa
trabeazione
e
da
statue
di
putti
e
di
personificazioni
delle
virtù
in
stucco,
è
sormontato
da
una
grande
cupola
riportata
solo
nel
1981
al
suo
livello
originario;
era
stata
infatti
rialzata
di
cinque
metri
per
ospitare
la
Specola
dell'osservatorio
astrofisico.
Il
refettorio
presenta
una
forma
allungata,
un
rettangolo
con
due
semicerchi
alle
due
estremità,
e
una
volta
altissima
illuminata
da
numerose
finestre,
che
fanno
sembrare
questo
grande
ambiente
più
una
chiesa
che
un
refettorio.
Lungo
tutto
il
perimetro
della
sala
corre
una
sorta
di
marciapiede,
in
cotto
siciliano,
(come
lo
definì Federico
De
Roberto)
dove
erano
collocati
i
tavoli
dove
i
monaci
consumavano
i
pasti,
e
al
centro
vi
è
un
grande
tappeto
di
maioliche
siciliane
decorate
a
mano,
da
qualche
anno
restaurate,
che
ridanno
vita
a
quella
che
era
l'originalità
della
grande
sala.
L'ampia
volta
fu
affrescata
al
centro
da Giovanni
Battista
Piparo,
con
una Gloria
di
San
Benedetto,
unica
decorazione
pittorica
sopravvissuta
della
sala
che
per
il
resto
oggi,
sede
dell'Aula
Magna
"Santo
Mazzarino"
del
Dipartimento
di
Scienze
Umanistiche
dell'almo
studio
catanese,
appare
uniformemente
bianca.
CHIESA
DI
SAN
NICOLÒ
-
La
chiesa
di
San
Nicolò,
una
delle
più
grandi
della
Sicilia
con
i
suoi
105
metri
di
lunghezza
e
48
di
larghezza,
fu
costruita
su
progetto
dell'architetto
romano
Giovanni
Battista
Contini
(1641-1723)
a
partire
dal
1687.
Il
progetto
rivela
gli
intenti
funzionali
e
celebrativi
dell'ordine.
Da
un
lato,
infatti,
l'enorme
superficie
occupata
dall'edificio
religioso
doveva
servire
ad
accogliere
quanti
più
fedeli
possibili
durante
le
feste
religiose,
soprattutto
quella
del
Santo
Chiodo,
in
settembre;
dall'altro,
la
grandezza
e
la
monumentalità
del
tempio
dovevano
evidenziare
la
potenza
e
la
ricchezza
raggiunte
dal
cenobio
catanese.

Ovvio
esempio
a
cui
ispirarsi
per
concretizzare
tutte
queste
premesse,
era
la
Basilica
di
San
Pietro
a
Roma,
di
cui
non
poteva
ovviamente
non
tener
conto
un
architetto
romano
come
il
Contini,
allievo
di
Carlo
Fontana
e
di
Gian
Lorenzo
Bernini,
nonché
principe
dell'Accademia
di
San
Luca.
E
i
riferimenti
alla
basilica
vaticana
sono
ben
riconoscibili:
nei
pilastri
che
reggono
le
navate,
con
le
paraste
corinzie
e
i
cornicioni
plasticamente
rilevati,
nelle
finestre,
che
riecheggiano
motivi
prettamente
romani,
e,
infine,
soprattutto
nella
pianta
a
croce
latina
e
a
tre
navate,
con
transetto
e
cupola
all'incrocio
dei
bracci,
con
cappelle
laterali
e
sulle
absidi
del
transetto,
un
coro
sopraelevato
molto
profondo
per
accogliere
gli
stalli
dei
monaci.
Le
navate
divise
da
grandi
arcate,
con
tutte
le
volte
poste
alla
stessa
altezza,
con
la
luce
forte
e
diffusa,
proveniente
dalle
alte
finestre,
sui
lati
e
in
facciata,
e
ulteriormente
accentuata
dall'alta
cupola,
permette
di
abbracciare
con
uno
sguardo
l'intera
superficie
della
chiesa
fino
all'altare
maggiore,
con
le
sole
cappelle
laterali
poco
più
in
ombra,
a
suggerire
una
spazialità
e
monumentalità
maggiori.
Le
cappelle
laterali
sono
tutte
rivestite
di
marmi
pregiati
e
di
esse,
infatti,
si
occuparono
con
particolare
attenzione
i
monaci
e
gli
abati
del
convento,
che
non
solo
fecero
arrivare
marmi
da
tutta
Italia,
ma
anche
per
le
pale
d'altare
si
rivolsero
a
pittori
non
siciliani,
o
comunque
attivi
a
Roma:
Bernardino
Nocchi
(1741-1812)
e
Stefano
Tofanelli
(1752-1812),
entrambi
lucchesi,
Vincenzo
Camuccini
(1771-1844),
romano,
Mariano
Rossi
(1731-1807),
originario
di
Sciacca
ma
di
formazione
napoletana
e
romana,
Ferdinando
Boudard
(1760-1825),
di
Parma.
Stefano
Ittar,
subentrato
al
cognato
Francesco
Battaglia
dopo
che
la
navata
destra
nel
1755
aveva
subito
alcuni
cedimenti
strutturali,
innalzò
entro
il
1780
la
grande
cupola
all'incrocio
fra
navata
e
transetto.
La
cupola
è
alta
all'interno
62
metri
e
domina
l'intera
città.
Da
alcuni
anni
è
in
restauro.
 Dal
lato
sinistro
del
transetto
si
accede
alla
sacrestia,
opera
di
Francesco
Battaglia,
e
al
Sacrario
dei
Caduti,
ricavato
in
alcuni
locali
dietro
l'abside
maggiore
e
sotto
alcune
aule
del
monastero.
Il
sacrario
ospita
le
lapidi
a
ricordo
dei
caduti
della
Prima
Guerra
Mondiale
ed
è
ornato
dagli
affreschi
di
Alessandro
Abate,
fortemente
degradati
a
causa
dell'umidità,
mentre
la
sacrestia,
con
gli
stalli
lignei
settecenteschi
e
gli
affreschi
di
Giovan
Battista
Piparo
comunica
col
chiostro
orientale
da
cui
prende
luce. Dal
lato
sinistro
del
transetto
si
accede
alla
sacrestia,
opera
di
Francesco
Battaglia,
e
al
Sacrario
dei
Caduti,
ricavato
in
alcuni
locali
dietro
l'abside
maggiore
e
sotto
alcune
aule
del
monastero.
Il
sacrario
ospita
le
lapidi
a
ricordo
dei
caduti
della
Prima
Guerra
Mondiale
ed
è
ornato
dagli
affreschi
di
Alessandro
Abate,
fortemente
degradati
a
causa
dell'umidità,
mentre
la
sacrestia,
con
gli
stalli
lignei
settecenteschi
e
gli
affreschi
di
Giovan
Battista
Piparo
comunica
col
chiostro
orientale
da
cui
prende
luce.
Confiscata
dal
governo
unitario
nel
1866,
sconsacrata
durante
l'ultima
guerra
mondiale
e
danneggiata
dai
bombardamenti,
successivamente
riconsacrata
e
dal
1989
ritornata
ai
benedettini,
la
chiesa
è
stata
oggetto
di
numerose
campagne
di
restauro
e
consolidamento,
compresi
i
lavori
di
restauro
della
cupola
tuttora
in
corso,
ma
versa
ancora
in
condizioni
di
degrado.
La
facciata
-
La
facciata
su
piazza
Dante
fu
cominciata
su
progetto
di
Carmelo
Battaglia
Santangelo,
nipote
e
allievo
di
Francesco
Battaglia,
che
aveva
vinto
il
concorso
bandito
dal
cenobio
nel
1775.
Il
progetto,
un
ibrido
un
po'
goffo
tra
l'ormai
provinciale
e
pretenzioso
tardo
barocco
siciliano
e
il
più
lineare
neoclassicismo
che
trovava
sempre
più
largo
consenso
anche
nell'élite
isolana,
appare
piuttosto
freddo,
con
le
otto
poderose
colonne
libere
che
scandiscono
la
facciata,
i
tre
grandi
portali
con
le
finestre
balaustrate
soprastanti
e
il
timpano
centrale,
tutto
elaborato
in
una
scala
grandiosa
che
non
ha
eguali
in
città
e
che
si
adegua
alle
dimensioni
altrettanto
grandiose
della
stessa
chiesa.
Complici
i
problemi
tecnici
che
la
costruzione
comportava
e
la
precaria
situazione
finanziaria
dei
monaci,
più
inclini
a
render
maggiormente
comodi
e
sfarzosi
gli
ambienti
del
monastero
e
la
vita
che
vi
si
conduceva,
piuttosto
che
la
loro
chiesa,
la
facciata
fu
innalzata
solo
parzialmente
lasciando
le
colonne
a
metà
e
il
tutto
privo
della
trabeazione
di
coronamento
con
un
timpano
al
centro,
prevista
dal
progetto.
Nel
1796,
l'architetto
firmava
il
finestrone
centrale,
ma
a
quel
punto
i
lavori
venivano
interrotti
definitivamente.
L'organo
-
L'area
presbiteriale
con
l'abside
è
caratterizzata
dal
grande
altare,
dagli
stalli
lignei
del
coro
scolpiti
dal
palermitano
Nicolò
Bagnasco
e
dal
grande
organo
di
Donato
del
Piano
(1704-1785)
in
fondo
all'abside.
Questi
lavorò
per
dodici
anni
(dal
1755
al
1767)
a
questo
enorme
strumento
con
2916
canne
in
legno
e
lega
di
stagno,
sei
mantici,
cinque
tastiere
e
settantasei
registri
che
poteva
riprodurre
qualsiasi
strumento
musicale
ed
essere
suonato
in
contemporanea
da
tre
organisti.
Rimasto
in
funzione
fino
ai
primi
decenni
del
XX
secolo,
l'organo
attraversò
poi
un
periodo
di
totale
abbandono,
ulteriormente
aggravato
dai
bombardamenti
alleati
del
1943,
che
danneggiarono
la
chiesa.
Fu
solo
nel
1998
che
con
decreto
ministeriale
furono
stanziati
i
fondi
necessari
al
restauro,
operato
dalla
ditta
organaria
Mascioni
e
rivelatosi
fin
dall'inizio
molto
difficile
e
lungo
a
causa
tanto
dell'incuria
dell'uomo
e
dei
saccheggi
subiti,
quanto
dei
materiali
in
cui
era
stato
fatto
lo
strumento,
facilmente
degradabili.
Gli
interventi
si
protrassero
fino
al
2004
quando,
rimontato
nell'abside
di
San
Nicola,
tornò
nuovamente
a
suonare
dopo
oltre
cinquant'anni
di
silenzio.
La
meridiana
-
Nel
transetto
si
trova
la
grande
meridiana
che
due
famosi
astronomi,
il
tedesco
Wolfgang
Sartorius
von
Waltershausen
e
il
danese
Christian
Peters
tracciarono
sulla
pavimentazione
a
partire
dal
1839.
In
realtà,
già
da
molto
tempo
si
pensava
a
dotare
la
chiesa
di
una
meridiana,
ma
i
progetti
precedenti
patrocinati
da
vari
abati
non
riuscirono
ad
andare
in
porto
e
fu
solo
con
l'abate
Giovan
Francesco
Corvaja
che
la
meridiana
fu
effettivamente
realizzata.
Grandi
furono
le
lodi
che
ricevette
quest'opera
al
suo
completamento
nel
1841,
tanto
per
le
dimensioni
quanto
per
il
valore
dei
materiali
e
delle
finiture,
ma
soprattutto
per
la
precisione
ed
arditezza
dei
calcoli;
si
disse
infatti
che
essa
spaccava
il
secondo.
Lo
gnomone,
ossia
il
foro
praticato
sulla
volta
del
transetto,
sta
a
23
metri,
91
centimetri
e
7
millimetri
di
altezza,
mentre
sulla
fascia
marmorea,
il
cui
tracciato
si
estende
per
circa
40
metri
tra
le
due
cappelle
di
San
Benedetto
da
Norcia
e
San
Nicola
di
Bari
alle
due
estremità
del
transetto,
sono
segnate
le
ore,
i
giorni
e
i
mesi,
nonché
i
segni
zodiacali
e
varie
iscrizioni
che
forniscono
notizie
sull'opera,
sui
suoi
ideatori,
sull'interpretazione
corretta
di
tutti
i
dati,
sui
rapporti
tra
le
varie
unità
di
misura
in
uso
al
tempo.
 La
Meridiana
si
estende,
trasversalmente
alla
navata
principale,
dalla
cappella
di
S.
Benedetto
alla
cappella
di
S.
Nicola,
per
una
lunghezza
complessiva
di
metri
40,92. La
Meridiana
si
estende,
trasversalmente
alla
navata
principale,
dalla
cappella
di
S.
Benedetto
alla
cappella
di
S.
Nicola,
per
una
lunghezza
complessiva
di
metri
40,92.
Il
foro
gnomonico
è
realizzato
a
Sud,
in
alto
all'interno
della
cappella
di
S.
Benedetto.
Esso
è
a
un'altezza
di
m.
23,92
dal
pavimento.
Le
lunghezze
progressive,
dalla
perpendicolare
del
foro
gnomonico
all'estremo
del
solstizio
invernale,
ai
punti
equinoziali
ed
al
solstizio
estivo,
sono
rispettivamente
m.
43,06,
m.
18,35
e
m.
5,98.
La
distanza
misurata
tra
i
punti
solstiziali,
e
dunque
la
lunghezza
della
Meridiana
vera
e
propria,
è
di
m.
37,07.
La
Meridiana
di
S.
Nicolò
l'Arena
è
certamente
la
più
ricca
di
dati
geografici,
astronomici,
fisici,
geodetici
e
metrici,
che
sono
riportati
il
latino
su
due
strisce
longitudinali
ai
lati
della
linea
meridiana.
La
linea
meridiana
è
suddivisa,
con
delle
tacche,
in
365
parti
distanziate
in
rapporto
alla
variazione
giornaliera
della
declinazione
del
Sole,
in
modo
da
segnare
giorno
per
giorno
il
cammino
del
Sole
durante
l'anno.
Ai
lati
della
Meridiana,
dodici
riquadri
riportano
al
loro
interno
le
figure
stilizzate
dei
segni
zodiacali
che
sono
delle
autentiche
opere
d'arte.
Alle
estremità
della
Meridiana,
due
riquadri
riportano
alcuni
dati
caratteristici
della
stessa.
Il
riquadro
di
Sud,
lato
cappella
di
S.
Benedetto,
riporta
il
nome
dei
costruttori,
dello
scultore,
dell'abate
che
ne
auspicò
il
completamento
e
l'anno
di
costruzione.
Il
riquadro
di
Nord,
lato
cappella
di
S.
Nicola,
riporta,
mediante
delle
astine
di
metallo
incastonate
nel
pavimento,
i
cinque
principali
campioni
di
misure
che
a
quell'epoca
erano
in
uso,
commercialmente,
negli
scambi,
sia
con
paesi
lontani
che
localmente.
Come
prima
misura
figura
il
"metro
francese"
che
riproduce
esattamente
la
lunghezza
del
metro
campione
costituito
da
una
sbarra
di
platino-iridio
conservata
presso
gli
"Archives
du
Bureau
International
des
Poids
et
Misures"
a
Parigi.
E'
il
nostro
metro.
Seguono
i
"piedi
parigini"
rappresentati
da
un
segmento
diviso
in
tre
sezioni,
di
lunghezza
complessiva
di
97,7
cm.
Abbiamo
quindi
i
"piedi
inglesi",
rappresentati
da
un
segmento
lungo
91,44
cm.,
corrispondenti
esattamente
ad
una
"yarda".
E'
diviso
in
tre
sezioni;
ogni
sezione
corrisponde
alla
lunghezza
di
un
piede
inglese
(m.
0,3047997).
Si
passa
quindi
alle
misure
nostrane.
I
"palmi
siciliani";
segmento
lungo
103,24
cm.
diviso
in
4
sezioni
ciascuna
lunga
m.
0,258098
corrispondente
ad
un
"palmo
palermitano".
Il
segmento
è
così
lungo
complessivamente
4
"palmi
palermitani"
equivalenti
a
"mezza
canna".
Per
finire
sono
riportati
i
"palmi
napoletani"
con
un
segmento
lungo
105,46
cm.
Il
segmento
e'
suddiviso
in
4
sezioni,
ciascuna
delle
quali
corrisponde
ad
1
"palmo
di
Napoli"
che
equivale
a
m.
0,263670.
Da
segnalare
inoltre
che
in
un
libretto
dell'epoca
si
trovano
alcune
preziosissime
tavole
che
riportano:
il
nascere
ed
il
tramontare
del
sole
in
"ore
vere";
la
lettura
diretta,
in
ore
e
minuti,
del
tempo
medio
civile
al
mezzogiorno
vero
locale
(e
dunque
tengono
conto
dell'equazione
del
tempo);
i
tempi
del
nascere
e
del
passaggio
del
Sole
in
meridiano
espressi
in
"ore
e
minuti
italici".
Tutti
questi
dati
sono
stati
perfettamente
calcolati
all'epoca
da
Francesco
Caruso
per
tutti
i
giorni
dell'anno.
Teatro
romano

Il teatro
romano
di
Catania è
situato
nel centro
storico della città
etnea.
Il
suo
aspetto
attuale
risale
al II
secolo ed
è
stato
messo
in
luce
a
partire
dalla
fine
del XIX
secolo.
A
est
confina
con
un
teatro
minore,
detto odeon.
Il
Teatro
greco
-
Di
un
teatro
a
Catania
si
fa
riferimento
nelle
fonti
classiche
in
merito
alla consultazione
delle
polis
siceliote da
parte
di Alcibiade,
che
tenne
nel 415
a.C. un
discorso
all'assemblea
civica
riunita
appunto
nel
teatro.
Di
questo
teatro
però
non
era
chiara
l'ubicazione
e
la
tradizione
tendeva
a
identificarlo
con
il
teatro
di
età
romana
oggi
visibile.
Tale
associazione
diede
adito
a
numerose
fantasticherie
sull'edificio,
al
punto
che
è
ancora
oggi
chiamato Tiatru
grecu dalla
comunità
locale,
mentre
la
strada
che
lo
costeggia
a
nord
è
chiamata via
Teatro
Greco.
Ciò
che
ha
dunque
mosso
gli
studiosi
dell'edificio
sin
dai
primi
lavori
di
sgombero
delle
strutture
antiche
è
stato
anche
il
quesito
se
il
teatro
delle
fonti
fosse
il
medesimo
che
si
ammira
oggi,
ossia
se
su
una
preesistente
struttura
greca
possa
essere
nata
la struttura
romana.
Per
un
certo
periodo
venne
persino
messo
in
dubbio
che
potesse
esistere
davvero
un
teatro
in
epoca
greca
a
Catania
e
che
si
trattasse
di
una
errata
traduzione
delle
fonti
ad
aver
generato
la
credenza
di
detto
edificio.
Diverse
quindi
le
ipotesi
a
favore
dell'identificazione
del
teatro
romano
con
quello
greco:
la
posizione
alla
base
di
una
collina
a
differenza
dell'usanza
romana
di
edificare
in
pianura
o
la
scena
rivolta
verso
il
mare.
Sul
monumento
però
le
fonti
sono
piuttosto
silenti
e
ne
tacciono
le
vicissitudini
storiche:
per
capirne
quindi
la
storia
si
fa
ricorso
ai
ritrovamenti
archeologici
che
gettano
un
po'
di
luce
sull'edificio.
Le
fasi
più
antiche
testimoniano
la
presenza
di
un
edificio
teatrale
costruito
con
grossi
blocchi
di pietra
arenaria con
lettere
in
greco
in
pianta
rettangolare,
un
tipo
di
planimetria
più
diffusamente
ellenistica.
Tale
struttura,
già
identificata
negli
anni
1884
e
1919 e
attribuita
a
un
teatro
greco
di V-IV
secolo
a.C.,
potrebbe
essere
propriamente
il
teatro
in
cui
Alcibiade
tenne
il
discorso
ai Katanaioi per
convincerli
ad
allearsi
con Atene contro Syracusae.
Il
Teatro
romano
-
Il
teatro
di
epoca
greca
venne
dunque
restaurato
nel
corso
del I
secolo,
probabilmente
a
seguito
dell'elezione
a
colonia
romana
di
Catania,
avvenuta
ad
opera
di Augusto.
A
questo
periodo
appartengono
un
rifacimento
della
cortina
quadrangolare
con
la
sostituzione
dei
blocchi
in
arenaria
mancanti
con
conci
lavici
squadrati,
l'aggiunta
della
scena
e
le
gradinate
più
antiche
dell'edificio.
Nel
corso
del II
secolo,
si
assiste
a
un
progressivo
processo
di
monumentalizzazione
dell'area
che
coinvolge
anche
le
vicine
strutture
termali e
numerosi
edifici
cittadini
(tra
cui
anche
l'anfiteatro).
A
questo
periodo
risale
il
plinto
conservato
nel museo
civico
al
Castello
Ursino,
in
cui
è
rappresentata
una
vittoria
che
incorona
un
trofeo
su
un
lato
e
dei
barbari
resi
schiavi
a
lato;
tale
plinto
potrebbe
rappresentare
una
vittoria
sui Germani di Marco
Aurelio o
di Commodo.
Le
tracce
della
monumentalizzazione
si
notano
anche
nell'assunzione
di
una
pianta
emiciclica
dell'edificio,
la
realizzazione
di
un
proscenio
decorato
da
lussuosi
marmi,
l'ampliamento
della
scena
e
la
realizzazione
di
due
massicce
torri
laterali,
atte
a
ospitare
le
scale
d'accesso
ai
diversi
piani
dell'edificio.
La
struttura
si
dota
in
questo
periodo
di
numerosissimi
elementi
architettonici,
tra
fregi,
statue,
bassorilievi
e
colonne,
in
passato
spesso
trafugati
o
raccolti
ed
usati
come
materiale
da
costruzione
per
gli
edifici
della
città
barocca.

Quartiere
Grotte
-
Caduto
in
declino
e
abbandonato
nel
corso
del VI e
del VII
secolo come
per
molti
altri
edifici
monumentali
di
età
classica,
venne
presto
sfruttato
per
ricavarne
modeste
abitazioni
già
dall'Alto
Medioevo.
L'area
dell'orchestra
fu
interessata
da
una
macelleria
bovina,
mentre
lentamente
e
inesorabilmente
le
strutture
venivano
intaccate
e
scavate
per
ricavarne
nuovi
edifici.
Nonostante
le
dure
manipolazioni
nel
corso
dei
secoli,
tra
cui
l'aggiunta
nel XVI
secolo di
piccole
stradelle
che
tagliavano
il
monumento
da
parte
a
parte,
l'emiciclo
dell'ultimo
ambulacro
era
perfettamente
leggibile
dall'esterno
e
tale
veniva
riprodotto
dai
cartografi cinque e secenteschi.
Il terremoto
del
Val
di
Noto
del
1693 rovinò
molte
abitazioni
che
erano
nate
sulla
cavea,
le
cui
macerie
vennero
sfruttate
per
realizzare
le
fondamenta
di
nuove
abitazioni.
Nel XVIII
secolo viene
eretta
la via
Grotte,
i
cui
archeggiati
sono
ancora
visibili
a
testimonianza
della
sua
esistenza,
che
tagliava
in
senso
sud-nord
l'edificio,
mettendo
in
comunicazione
la
strada
del
corso
(oggi
via
Vittorio
Emanuele
II)
con
lo
spiazzo
alle
spalle
del
teatro.
La
strada,
come
si
nota
da
alcune
fotografie
precedenti
al
suo
abbattimento,
era
in
comunicazione
con
alcune
stradelle
minori
e
persino
una
piazza,
ricavate
sulla
cavea
tra
il
XVIII
e
il XIX
secolo.
Monumento
archeologico
-
Sul
finire
del
XIX
secolo
il
proprietario
del
palazzo
che
si
addossa
all'adiacente
odeon,
il
barone
Sigona
di
Villermosa,
fece
abbattere
l'ultimo
fornice
per
ampliare
il
suo
immobile.
Questo
increscioso
avvenimento
mobilitò
la
Soprintendenza
alle
Antichità
per
la
Sicilia
Orientale,
all'epoca
diretta
da Paolo
Orsi,
che
adottò
il
pugno
duro
nei
confronti
di
chi
abitava
sopra
i
due
teatri
e
avviò
una
campagna
di
esproprio
e
liberazione
delle
antiche
strutture
mai
del
tutto
completata.
Da
un
primo
sgombero
della
fine
dell'Ottocento
che
interessò
quasi
esclusivamente
l'odeon,
si
riprese
solo
negli anni
cinquanta del XX
secolo in
misura
massiccia
l'opera
di
sgombero,
interrotta
dopo
una
ventina
d'anni.
Una
campagna
di
scavo
venne
condotta
nei
primissimi anni
ottanta che
restituì
nel 1981 l'ingresso
orientale
degli
attori,
costituito
da
una
scaletta
e
un
accesso
trabeato,
realizzato
in
grossi
blocchi
di pietra
lavica.
Descrizione
-
Del teatro
romano,
di
circa
80
metri
di
diametro
e
con
una
capienza
di
circa
7.000
spettatori,
oggi
si
conservano
la
cavea
(ossia
la
gradinata),
l’orchestra
e
alcune
parti
della
scena:
non
è
difficile
immaginarlo
come
doveva
essere
in
tutta
la
sua
eleganza,
ornato
da
statue,
nicchie
e
colonne,
e
impreziosito
dall’alternanza
cromatica
del
bianco
e
del
nero
nei
sedili
in
marmo
e
nelle
scale
in
pietra
lavica
che
salivano
lungo
la
gradinata
separandola
in
settori.
Lo
spazio
antistante
la
scena
è
attualmente
sommerso
dalle
acque dell’Amenano,
il
fiume
coperto
dall’eruzione
del
1669 e
che
da
allora
scorre
sotterraneo,
le
cui
acque
in
età
romana
erano
convogliate
nel
teatro
per
consentire
spettacoli
con
giochi
d’acqua
e
per
muovere
gli
ingranaggi
meccanici
delle
scenografie.
Odeon

L'Odéon è
situato
nel
centro
storico
della
città
etnea,
accanto
al Teatro
Romano.
Risale
al
II
secolo
d.C.
Venivano
qui
rappresentati
spettacoli
musicali
e
di
danza
e
qui
si
tenevano
le
prove
degli
spettacoli
che
si
tenevano
nel vicino
teatro.
Ancora
oggi
è
utilizzato
per
spettacoli
estivi.
La
costruzione
semicircolare
aveva
una
capacità
di
circa
1500
spettatori.
È
caratterizzato
da
diciotto
muri
che
formano
cunei
stretti
e
lunghi
all'interno
dei
quali
ci
sono
diciassette
(ne
restano
sedici)
vani
coperti.
L’orchestra
è
pavimentata
in
marmo.
Anfiteatro
romano
L'anfiteatro
romano,
di
cui
è
visibile
solo
una
piccola
sezione
nella
parte
occidentale
della piazza
Stesicoro,
è
una
imponente
struttura
costruita
in
epoca
imperiale
romana,
probabilmente
nel II
secolo,
ai
margini
settentrionali
della
città
antica,
a
ridosso
della
collina
Montevergine
che
ospitava
il
nucleo
principale
dell'abitato.
La
zona
dove
sorge,
ora
parte
del
centro
storico
della
città,
in
passato
era
adibita
a necropoli.
Esso
fa
parte
del Parco
archeologico
greco-romano
di
Catania.
Il
monumento
fu
probabilmente
costruito
nel II
secolo;
la
data
precisa
è
incerta,
ma
il
tipo
di
architettura
fa
propendere
per
l'epoca
tra
gli
imperatori Adriano e Antonino
Pio.
Appare
evidente
un
ampliamento
datato
intorno
al III
secolo che
ne
triplicò
di
fatto
le
dimensioni.
Una
leggenda
popolare
infondata
vuole
che
l'eruzione
dell'Etna
del
252 lo
abbia
raggiunto
senza
però
distruggerlo.
Tale
tradizione
si
basa
sulla
vita
di Sant'Agata riportata
negli Acta
Sanctorum del Bollando,
dove
è
riportato
che
ad
un
anno
esatto
dalla
morte
della
santa
(251)
un
fiume
di
fuoco
si
diresse
alle
porte
della
città,
e
i
villani
-
preoccupati
per
le
loro
campagne
-
giunsero
alla
tomba
di
Sant'Agata
per
prelevarne
il
velo
mortuario,
usandolo
per
arrestare
l'avanzata
della
lava.
Tale
fonte,
del
tutto agiografica,
indusse
persino
autorevoli
vulcanologi
come
il Gemmellaro ad
interpretare
erroneamente
l'anfiteatro
(il
quale
si
trovava
alle
porte
della
città)
quale
punto
in
cui
si
arrestò
la
lava.
Recenti
studi
stratigrafici
e
di
datazione
hanno
dimostrato
chiaramente
che
la
cosiddetta
"colata
lavica
di
Sant'Agata"
del
252
ebbe
origine
dal
cono
del Monpeloso,
e,
riversandosi
quasi
per
intero
nel
territorio
di Nicolosi,
si
fermò
nel
territorio
di Mascalucia,
a
450
m s.l.m.,
in
direzione
di
Catania,
ma
senza
mai
raggiungerla.
L
'unica
traccia
di
una
colata
presso
l'anfiteatro
è
una
sporgenza
lavica
che
si
affaccia
da
uno
dei fornici murati
dell'edificio;
quando
però
nel
'900
fu
compiuto
un
carotaggio
sulle
pareti
dell'ambulacro
interno
per
cercare
di
capire
cosa
vi
fosse
al
di
là,
da
esso
fluirono
liquami
"a
vagonate",
segno
evidente
che
il
corridoio
è
vuoto:
il
frammento
di
roccia
vulcanica
sporgente
è
con
tutta
probabilità
materiale
di
riempimento
per
la
gittata
delle
fondazioni
della
facciata
della
sovrastante chiesa
di
San
Biagio.

Secondo
quanto
riferisce Cassiodoro,
nel V
secolo Teodorico,
re
degli Ostrogoti,
concesse
agli
abitanti
della
città
di
utilizzarlo
quale
cava
di
materiale
da
costruzione
per
l'edificazione
di
edifici
in
muratura a
motivo
dell'abbandono
del
monumento
"per
lunga
vetustà".
Secondo
alcuni
autori,
nell'XI
secolo anche Ruggero
II
di
Sicilia ne
trasse
ulteriori
strutture
e
materiali
per
la
costruzione
della cattedrale
di
Sant'Agata,
tra
cui
le
colonne
in
granito
grigio
che
decorano
il
prospetto e
le
absidi,
su
cui
si
riconoscerebbero
ancora
le
pietre
perfettamente
tagliate usate,
forse,
anche
nel Castello
Ursino in età
federiciana.
Nel XIII
secolo,
secondo
la
tradizione,
furono
adoperati
i
suoi vomitoria (gli
ingressi)
da
parte
degli Angioini per
accedere
alla
città
durante
la
cosiddetta guerra
dei
Vespri.
Nel
secolo
successivo
gli
ingressi
furono
murati
e
il
rudere
venne
inglobato
nella
rete
di
fortificazioni
Aragonese
(1302).
Nel
1505
il
senato
cittadino
fece
concessione
a
Giovanni
Gioeni
di
usare
le
pietre
del
monumento
per
la
costruzione
di
abitazioni
e
per
usarne
l'arena
quale
giardino.
Una
messa
in
sicurezza
del
rudere
si
ebbe
con
il piano
di
costruzione
delle
mura
della
città nel 1550;
vennero
abbattuti
il
primo
e
il
secondo
piano
e
con
le
stesse
macerie
avvenne
il
riempimento
delle
gallerie.
Dopo
il terremoto
del
1693 fu
definitivamente
sepolto,
per
poi
essere
trasformato
in
piazza
d'armi.
In
seguito
vennero
sfruttati
gli
estradossi
delle
gallerie
superstiti
come
fondamenta
per
le
nuove
abitazioni,
nonché
per
la
facciata
neoclassica
della chiesa
di
San
Biagio,
nota
anche
come 'A
Carcaredda,
cioè la
fornace.
Dalla
seconda
metà
del XVIII
secolo l'anfiteatro
fu
oggetto
di
scavi
archeologici,
che
tuttavia
non
ne
preservarono
gli
ambienti
ormai
ipogei:
i
fornici
vennero
murati
e
sfruttati
come
pozzi
neri
per
i
palazzi
della
ricostruenda
città.
Tale
uso
sembra
essere
la
causa
dell'indebolimento
della
struttura
di
cui
nel 2014 è
stato
denunciato
il
pericolo
di
collasso
in
un'interrogazione
parlamentare
del
1º
aprile
di
quell'anno,
in
cui
venne
ripreso
ciò
che
già
era
stato
portato
all'attenzione
dell'opinione
pubblica
a
seguito
di
una
videoinchiesta
di
una
testata
giornalistica.
Il
24
aprile
dello
stesso
anno
si
è
costituito
un
primo
tavolo
tecnico
per
stabilire
un
programma
di
recupero
del
monumento,
mettendo
contemporaneamente
in
sicurezza
il
quartiere
sorto
nei
secoli
sopra
le
sue
strutture.
In
precedenza,
solo
nei
primissimi
anni
del XX
secolo si
era
operato
un
lavoro
di
ricostruzione
atto
all'apertura
per
le
visite,
con
la
realizzazione
dello
scavo
di piazza
Stesicoro e
la
creazione
di
un
percorso
poi
sfruttato
solo
occasionalmente.
Nel 1943,
durante
il
bombardamento
degli Alleati che
ridusse
parte
della
città
in
cumuli
di
macerie,
la
struttura
(tanto
l'ambulacro
interno
quanto
gli
stessi
pozzi
neri)
venne
adoperata
a
mo'
di
rifugio.
Successivamente
si
sono
susseguiti
periodi
di
interesse
e
di
abbandono;
per
molti
anni,
i
suoi
cunicoli
sotterranei
sono
rimasti
chiusi
per
generici
"problemi
di
sicurezza"
a
seguito
di
presunti
episodi
tragici
legati
alla
curiosità
di
visitatori
che
provavano
ad
esplorarli.
Ristrutturato
nel 1997,
fu
aperto
solo
durante
la
stagione
estiva
e
poi
richiuso
per
infiltrazioni
di
reflui
delle fognature delle
case
limitrofe
all'interno
dell'anfiteatro.
Parzialmente
risanato,
nel
luglio 1999 è
stato
riaperto
al
pubblico,
per
poi
essere
chiuso
nuovamente
poco
tempo
dopo
a
causa
di
peggioramenti
delle
sue
condizioni.
I
suoi
resti,
rappresentanti
quasi
un
decimo
dell'intero
anfiteatro,
sono
visitabili
dall'ingresso
di piazza
Stesicoro e
dal
vico
Anfiteatro,
dove
se
ne
vede
l'altezza
fino
a
parte
del
terzo
piano.
Fino
al 2007 era
possibile
vederne
una
porzione
del
secondo
piano
da
Via
del
Colosseo;
oggi
è
interamente
coperto
dal
nuovo
terrazzo
di villa
Cerami.
In
quest'ultimo
edificio,
sede
oggi
della
Facoltà
di
Giurisprudenza
dell'Università
degli
Studi
di
Catania,
è
ancora
possibile
vedere
parte
del
sistema
d'archi
che
collegava
l'Anfiteatro
alla
collina
Montevergine
(probabilmente
l'antica acropoli della
città).
La
restante
parte
dell'anfiteatro
è
ancora
interrata
sotto
le
zone
di
via
Neve,
via
Manzoni
e
via
Penninello.

L'edificio
presentava
la
pianta
di forma
ellittica,
l'arena
misurava
un
diametro
maggiore
di
70
m
ed
uno
minore
di
circa
50
m.
I
diametri
esterni
erano
di
125
x
105
m,
mentre
la
circonferenza
esterna
era
di
309
metri
e
la
circonferenza
dell'Arena
di
192
metri,
e
si
è
calcolato
che
poteva
contenere
15.000
spettatori
seduti
e
quasi
il
doppio
di
quella
cifra
con
l'aggiunta
di
impalcature lignee per
gli
spettatori
in
piedi.
Addossato
alla
vicina collina ne
era
separato
da
un
corridoio
con
grandi archi e
volte
che
facevano
da
sostegno
per
le
gradinate.
Era
probabilmente
prevista
anche
una
copertura
con
grandi
teli
per
il
riparo
dal
forte sole o
nel
caso
di
pioggia.
La cavea presentava
14
gradoni.
Venne
costruito
con
la pietra
lavica dell'Etna ricoperta
da marmi ed
aveva
trentadue
ordini
di
posti.
Secondo
una
tradizione
incerta
e
priva
di
riscontri
si
vuole
vi
si
svolgessero
anche
le naumachie,
vere
battaglie
navali
con navi e
combattenti
dopo
averlo
riempito
di acqua mediante
l'antico acquedotto.
L'anfiteatro
di
Catania
è
strutturalmente
il
più
complesso
degli
anfiteatri
siciliani
e
il
più
grande
in Sicilia.
Appartiene
al
gruppo
delle
grandi
fabbriche
quali
il Colosseo,
l'anfiteatro
di
Capua,
l'Arena
di
Verona.
Presenta
una
struttura
realizzata
con
muri
radiali
e
volte
non
addossata
al
terreno,
dove
la
facciata
non
si
appoggia
direttamente
ai
muri
radiali,
bensì
a
una
galleria
di
distribuzione
periferica.
La
tecnica
edilizia
prevede
l'uso
dell'opera
vittata
per
le
parti
interne
e
quadrata
per
l'esterno.
Le
testate
dei pilastri sono
in
opera
quadrata
con
piccoli
blocchi
di
pietra
lavica.
I
paramenti
denotano
una
certa
trascuratezza:
i
blocchetti
dell'opera
quadrata
sono
a
taglio
irregolare
e
appaiono
in
buona
parte
di
riporto.
Gli
archi
sono
realizzati
esternamente
con
grossi mattoni rettangolari
dal
taglio
regolare
e
uniti
da malta di
buona
qualità,
mentre
internamente
sono
fatti
in
opera
cementizia
a
grosse
scaglie
radiali.
Singolare,
nonostante
la
complessiva
sobrietà
dell'edificio,
doveva
apparire
il
contrasto
cromatico
tra
la
scurissima
pietra
lavica
dei
paramenti
e
il rosso dei
mattoni
delle
ghiere
degli
archi.
Una
nota
di
prestigio
era
rappresentata
dall'utilizzo
del
marmo,
non
solo
per
il
rivestimento
del
podio,
ma
anche
per
alcune
decorazioni
come
le
erme
ai
lati
dell'ingresso
principale
dell'arena.
Molto
probabilmente
le
gradinate
dovevano
essere
in
pietra
calcarea
realizzando
un
forte
gioco
cromatico
tra
il
bianco
dei
sedili
e
il
nero
delle
scalette,
così
come
supponibile
dalle
costruzioni
coeve.

Allo
scavo
dell'Anfiteatro
si
accede
mediante
una
porta
di
ferro
decorata
ad
archetti
traforati
nel
registro
superiore
e
totalmente
liscio
nel
registro
inferiore.
A
decorazione
del
portone
metallico
vennero
recuperati
nel
1906
alcuni
frammenti
di
colonne marmoree che
in
origine
dovevano
costituire
parte
del loggiato superiore,
due capitelli
ionici frammentari
e
parte
di
un
architrave
su
cui
fu
incisa
la
scritta AMPHITHEATRVM
INSIGNE.
L'ingresso
è
così
formato:
al
centro
il
portone
metallico
i
cui
stipiti
sono
le
colonne
con
capitello,
coronato
dall'architrave;
le
restanti
due
colonne
sono
situate
nelle
due
estremità
laterali
e
inserite
tra
queste
e
quelle
centrali
vi
sono
due
pareti
in
pietra
recanti
gli epitaffi simbolici
di
due
illustri
personaggi
di epoca
greca legati
a
questa
zona
- Caronda a
sinistra,
ricordato
anche
dall'omonima
via; Stesicoro a
destra,
che
diede
nome
in
antico
alla via
Etnea -
composti
dal
poeta Mario
Rapisardi.
La
tradizione
vuole
che
il
sepolcro
di
costoro
fosse
propriamente
nella
zona
prossima
all'anfiteatro.
Pag.
1

 Pag.
3
Pag.
3
|