|
Terme
Sono
tre
sono
le
terme
del
periodo
romano
che
si
trovano
a
Catania:
le
terme
Achilliane,
sotto
l'attuale
Piazza
Duomo
che
risalgono
al
IV
e
V
secolo,
le
terme
dell'Indirizzo
(che
sorgono
nella
zona
settecentesca
della
città)
e
che
sono
datate
all'incirca
al
II
secolo
e
le
terme
della
Rotonda
(II-III
secolo)
che
si
trovano
vicino
all'Odeon.
Le Terme
dell'Indirizzo,
un
monumento
del Parco
archeologico
greco-romano
di
Catania,
si
trovano
nella
parte
settecentesca
della
città.
Il
complesso
evidenzia
un calidarium ed
un frigidarium,
oltre
alle
fornaci
per
il
riscaldamento
dell'acqua
e
dell'aria
e
tutte
le
canalizzazioni
per
l'approvvigionamento
dell'acqua
e
quelle
per
lo
scarico.
Altri
ambienti
accessori
sono
evidenziati
a
livello
di
fondamenta.
La
dizione Indirizzo si
riferisce
al
vicino
settecentesco
convento
carmelitano
di
Maria
santissima
dell'Indirizzo
(demolito
negli
anni
trenta
per
far
posto
ad
una
scuola
comunale,
l'attuale
istituto
comprensivo
"Amerigo
Vespucci") e
all'omonima
chiesa, così
denominati
-
come
recita
una
delle
lapide
della
chiesa
(lato
sud)
-
per
un miracolo che
avrebbe
salvato
il viceré di
Sicilia, Pietro
Girone,
duca
di
Ossuna,
nel 1610.
Sorpreso
da
una
tempesta
mentre
si
avvicinava
alla
costa
durante
la
notte,
venne
salvato
da
una
luce
votiva
di
detto
convento
che
lo
"indirizzò"
al
porto.

Le Terme
della
Rotonda sono
un
vasto
complesso
monumentale
comprendente strutture
termali di
epoca
romana,
datate
al I-II
secolo d.C.
trasformate
in chiesa in
epoca bizantina dedicata
alla Vergine
Maria.
Il
nome Rotonda deriva
dalla
singolare
struttura
architettonica
della
chiesa,
formata
da
una
grande cupola a
tutto
sesto
circondata
da contrafforti,
posta
su
un
edificio
a
perimetro
quadrato
culminante
in
un'aula
centrale
circolare.
L'edificio
è
spesso
indicato
col
toponimo
de La
Rotonda nelle
vedute
cittadine
del Cinquecento e
del Seicento.
In
passato,
l'edificio
era
noto
anche
con
il
nome
di Pantheon che
gli
antiquari
secenteschi
locali
(quali Giovanni
Battista
de
Grossis e Ottavio
D'Arcangelo)
ritenevano
essere
stato
il
modello
del più
celebre
edificio
di
Roma.
Secondo
recenti
studi,
frutto
di
campagne
di
scavo
condotte
nel 2004-2008 e
nel
2015,
la
struttura
termale,
risalirebbe
nel
suo
primitivo
impianto
al
I-II
secolo
d.C.,
conobbe
una
fase
di
monumentalizzazione
intorno
al III
secolo d.C.,
durante
un'epoca
di
notevole
arricchimento
della città
di
Catania,
per
poi
essere
abbandonata
e
quindi
trasformata
in
chiesa
verso
la
fine
del VI d.C.
La
chiesa
-
probabilmente
sin
dal
suo
sorgere
dedicata
al
culto
della
Madonna
-
venne
orientata
in
senso
nord-sud.
Dal
IX
secolo,
addossata
alla
chiesa
e
tra
le
rovine
delle
terme,
sorse
un'ampia
area
cimiteriale,
intensamente
utilizzata
fino
al
secolo XVI
secolo.
Al
terremoto
del
1169,
che
danneggiò
il
presbiterio
bizantino,
risale
il
cambio
di
orientamento
(dal
senso
nord-sud
al
senso
est-ovest),
l'apertura
dell'ingresso
con portale
ad
ogiva e
la
realizzazione
di
un'abside ad
esso
contrapposto.
La
chiesa
venne
successivamente
adeguata
a
cappella
funebre
per
figure
alto-borghesi,
forse
cappella
cavalleresca
della
guardia
di Federico
II.
L'orientamento
tornò
ad
essere
nel
senso
nord-sud
nel
Cinquecento,
con
la
realizzazione
di
un
nuovo
ingresso
con
portale
rinascimentale.
Il
più
antico
ricordo
storico
risale
ai
frammenti
dell'opera
di Lorenzo
Bolano sulle
antichità
di
Catania
per
il
tramite
del Carrera.
L'edificio,
ritenuto
il
più
antico
tempio
di
culto
a
Catania,
era
stimato
come
un Pantheon pagano
riconvertito
in
luogo
di
culto
cristiano, e
consacrato
a
Maria
nel
44
d.C.
Tale
tradizione,
seppur
errata,
mantenne
per
quasi
tre
secoli
il
suo
fascino,
almeno
fino
a D'Orville e
agli
studi
del Principe
di
Biscari, il
quale
identificò
per
primo
l'edificio
quale
ambiente
termale
di
epoca
imperiale
romana.

Il bombardamento
aereo
del
1943 devastò
la
vicina
chiesa
di
Santa
Maria
della
Cava,
risalente
al
Settecento, e
rovinò
pesantemente
la
struttura.
Tra
gli
anni
quaranta
e
cinquanta si
operarono
quindi
una
serie
di
lavori
di
consolidamento
delle
strutture.
La
direzione
dei
lavori
fu
affidata
a
Guido
Libertini il
quale
tuttavia
non
risparmiò
le
strutture
ecclesiastiche,
né
alcuni
preziosi
affreschi,
per
mettere
in
luce
le
strutture
romane.
Nell'opera
di
sbancamento
venne
abbattuta
anche
una
monumentale
tomba
cavalleresca
che
faceva
da
altare
durante
il
XIII
secolo
e,
sulla
base
dei
resti
superstiti
ospitati
presso
il
Castello
Ursino,
si
deve
identificare
quale
sepolcro
di
un
cavaliere
membro
della
guardia
personale
di
Federico
II,
forse
un
membro
della
famiglia
Alagona,
seguendo
quanto
affermato
dal
Ferrara.
Nell'arco
di
anni
dal
2004
al
2008
l'edificio
e
l'area
ad
esso
orbitante
furono
interessati
da
un
nuovo
ciclo
di
scavi
atti
alla
preservazione,
allo
studio
e
alla
fruizione
della
struttura.
In
questa
campagna
di
scavo
si
rinvenne
una
gran
quantità
di
tombe,
si
poterono
identificare
con
certezza
nove
ambienti
termali
e
ipotizzarne
molti
altri
che
si
estendono
al
di
sotto
delle
vicine
Via
Rotonda
e
Via
della
Mecca,
venne
messa
in
luce
l'abside
di
età
sveva
e
si
misero
in
luce
diversi
affreschi
precedentemente
coperti
da
un
anonimo
intonaco
monocromo.
Lo
studio,
oltre
a
rivelare
le
diverse
fasi
di
vita
dell'edificio,
ha
anche
permesso
il
riconoscimento
del
ciclo
di
pitture
che
decoravano
gli
interni
della
chiesa,
riconducendo
a
datazioni
più
corrette
quelle
più
antiche.
Nel
2015
è
stato
espropriato
e
sottoposto
a
scavi
e
restauri
tutto
l'isolato
a
nord
della
chiesa,
anch'esso
danneggiato
dai
bombardamenti
del
1943.
Durante
questa
campagna
di
lavori,
che
hanno
liberato
la
visuale
della
cupola
dal
lato
nord,
permettendone
la
vista
da
via
dei
Gesuiti,
è
stato
messo
in
luce
un
imponente castellum
aquae collegato
ad
un
ramo
dell'acquedotto
romano
di
Catania,
trasformato
in
edificio
al
servizio
della
chiesa
verso
la
fine
del
VI
secolo,
ed
una
corte
quadrangolare
circondata
da
esedre
che
costituiva
l'originario
ingresso
alla
Rotonda
in
epoca
romana.

La
struttura
termale,
sorta
fra
I
e
II
secolo
d.C.
e
più
volte
rimaneggiata
fino
alla
tarda
antichità,
è
un
grande
complesso
di
ambienti
quadrangolari,
circolari
e
misti,
connessi
tra
loro.
Il
principale
è
una
grande
sala
absidata
-
forse
un frigidarium -
orientata
in
direzione
nord-sud,
databile
alla
prima
fase
vitale
delle
terme,
cui
si
giustappone
sul
lato
est
un
grande
ambiente
ad ipocausto,
caratterizzato
da
numerose suspensurae che
in
origine
sorreggevano
un
pavimento
a
mosaico
di
cui
si
è
rinvenuta
qualche
traccia,
identificato
come calidarium che
in
un
secondo
momento
venne
suddiviso
in
più
ambienti
di
minori
dimensioni.
Ad
ovest
della
grande
sala
absidata
si
apre
un
vasto
ambiente
pavimentato
con
grandi
lastre
marmoree,
su
cui
si
rinvennero
diverse
tombe
di
epoca
medievale,
alcune
realizzate
distruggendo
il
pavimento
stesso.
A
sud
si
aprono
diversi
altri
ambienti
appartenenti
alla
fase
di
II-III
secolo,
come
due
pavimenti
ad ipocausto,
pertinenti
a
piccoli
ambienti
circolari
adibite
a
saune,
e
forse
un tepidarium.
Altri
ambienti
quadrangolari
si
trovano
a
nord,
all'interno
dell'edificio
della
chiesa,
che
in
parte
si
appoggia
a
queste
strutture.
Appartengono
al
complesso
termale
anche
le
strutture
che
si
trovano
a
nord
della
chiesa,
costituite
da
un
imponente castellum
aquae e
da
una
corte
circondata
da
esedre
che
fungeva
da
ingresso
principale
alle
terme.

La
struttura
più
appariscente
è
tuttavia
quella
dell'ex Basilica
di
Santa
Maria
della
Rotonda,
ricavata
riadattando
il
complesso
verso
la
fine
del VI
secolo.
L'edificio,
a
pianta
quadrata,
presenta
due
ingressi
-
una
a
sud,
con
un
portale
in
calcare
del Cinquecento,
l'altro
a
ovest,
con
portale
di
stile
gotico
in
pietra
lavica
del Duecento -
e
due
aree
presbiterali
ad
essi
corrispondenti:
un
presbiterio in
forma
di triclinium,
circondato
da
angusti
corridoi
che
fungono
da deambulacro si
apre
verso
nord,
mentre
a
est
un
piccolo
catino
absidale
di
cui
rimane
una
porzione
dell'alzato.
Al
centro
dell'edificio
quadrato
si
apre
un
ambiente
circolare,
del
diametro
di
11
metri,
coperto
da
una
cupola
a
tutto
sesto.
L'ambiente
circolare
è
circondato
da
grandi
arcate
che
danno
accesso
a
nicchie
ed
esedre
che
fungevano
da cappelle.
Sopra
la
cupola,
un
lucernaio
ad
archetto
fungeva
da
campanile,
mentre
a
decorazione
dell'esterno
si
poteva
osservare
fino
agli anni
quaranta una
merlatura
tutto
intorno
al
perimetro.
A
est
della
chiesa
si
aprivano
alcuni
ambienti,
usato
come sagrestia,
danneggiati
dai bombardamenti
aerei e
oggi
usarti
come
atrio
d'ingresso
al
complesso
monumentale.
Le
più
antiche
tracce
di
affreschi
risalgono
al
VII
secolo.
Appartengono
al
XII
- XIV
sec. alcune
rappresentazioni
di
stile
bizantino,
con
le
figure
dei
Santi
vescovi Leone e Nicola,
negli
stipiti
dell'arco
ovest
del
presbiterio;
una
Madonna
in
Trono
sulla
parete
orientale
dello
stesso
ambiente;
una
Madonna
in
Trono
con
Bambino.
Al
XVIII
secolo
appartiene
il
ciclo
più
recente:
nel
presbiterio
sono
rappresentati
l'Annunciazione e
la Natività e,
sulla
volta,
l'Assunzione
della
Vergine
al
cielo;
nei
triangoli
d'imposta
della
cupola
sono
i
Santi Pietro, Paolo, Agata, Lucia e
gli
Evangelisti Luca, Matteo, Marco, Giovanni;
sulle
pareti
che
chiudevano
le
arcate
pure
vi
erano
diverse
figure,
rimosse
durante
i
restauri
degli
anni
'40
del Novecento,
delle
quali
sopravvive
ancora
l'immagine
di Sant'Omobono.
Alla
base
della
cupola
una
lunga
iscrizione
anulare
in latino recita:
«QUOD
INANI
DEORUM
OMNIUM
VENERATIONI
SUPERSTITIOSÆ
CATANENSIUM
EREXERAT
PIETAS
IDEM
HOC
PROFUGATO
EMENTITÆ
RELIGIONIS
ERRORE
IPISIS
NASCENTIS
FIDEI
EXORDIIS
DIVUS
PETRUS
APOSTOLORUM
PRINCEPS
ANO
GRATIÆ
44
CLAUDII
IMPERATORIS
II.
DEO.
OP.
MAX.
EIUSQUE
GENITRICI
IN
TERRIS
ADHUC
AGENTI
SACRAVIT
PANTHEON.»
«Ciò
che
la
pietà
dei
Catanesi
aveva
eretto
all'inutile
superstiziosa
venerazione
di
tutti
gli
dei
questo
stesso
tolto
l'errore
della
falsa
religione
negli
stessi
primordi
della
nascente
fede
San
Pietro
Principe
degli
Apostoli
consacrò
nell'anno
di
grazia
44
a
Dio
Ottimo
Massimo
e
alla
sua
genitrice
ancora
vivente
nell'anno
II
di
Claudio
Imperatore»
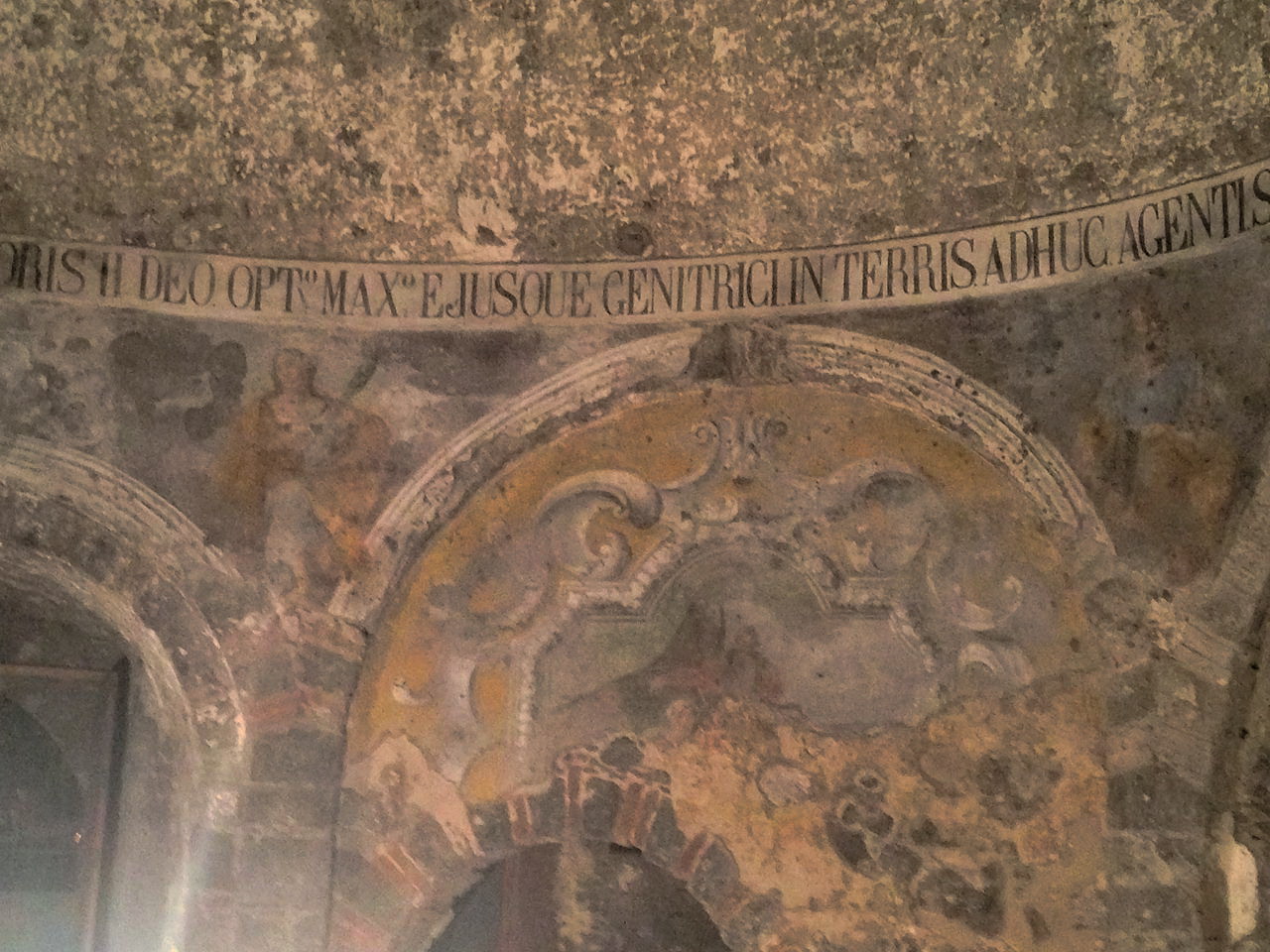
Per terme
Achilliane si
intendono
delle
strutture
termali
sotterranee
databili
al IV-V
secolo di
cui
rimane
appena
una
piccola
porzione
visibile
sotto piazza
del
Duomo.
Si
accede
all'ambiente
termale
passando
da
un
corridoio
con
volta
a
botte
ricavato
nell'intercapedine
tra
le
fondamenta
della
cattedrale
il
cui
accesso
è
preceduto
da
una
rampa
in
discesa
a
destra
della
facciata
della
stessa.
Il
nome
dell'impianto
è
dedotto
da
un'iscrizione
su
lastra
di
marmo
lunense
ridottasi
in
sei
frammenti
principali
,
databile
alla
prima
metà
del V
secolo,
oggi
esposta
all'interno
del Museo
civico
al
Castello
Ursino.
L'epoca
di
fondazione
dell'edificio
è
ancora
discussa,
ma
si
ritiene
probabile
che
fosse
costruito
nel IV
secolo
d.C.:
l'esistenza
dell'edificio
sotto Costantino
I è
ipotizzata
in
base
al reimpiego all'interno
della cattedrale
di
Sant'Agata di
un
gruppo
di capitelli del
periodo,
che
potrebbero
provenire
da
questo
edificio.
Le
strutture
però
potrebbero
essere
anche
precedenti,
databili
al III
secolo,
sulla
base
degli
studi
del
Wilson.
Sulla
base
di
una
lunga
iscrizione
i
cui
pezzi
furono
ritrovati
in
più
epoche,
si
è
supposto
che
intorno
al 434 l'edificio
fu
ridimensionato
per
ottenere
un
risparmio
di
legna.
Nel 1088 l'area
occupata
dalle
terme
viene
scelta
dal
vescovo Ansgerio per
ricavarne
la
Cattedrale
(completata
ed
inaugurata
nel 1094)
e
il
relativo
monastero
benedettino
(in
seguito
sede
della
badia
femminile
di
Sant'Agata),
mentre
nel 1508 viene
completata
la Loggia
Senatoria che
vi
si
addossava
per
la
sua
lunghezza.
Sepolti
dai
terremoti
del
4
febbraio 1169 e
dell'11
gennaio 1693,
i
resti
di
parte
delle
terme
-
già
noti
in
antico
-
furono
dapprima
liberati
dal
Museo
del principe
di
Biscari e
riportati
nella
loro
attuale
collocazione.
Nel 1856,
durante
la
realizzazione
della
galleria
che
passa
sotto
al
Seminario
dei
chierici
destinata
ad
essere
la Pescheria
di
Catania,
si
trovarono
dei
ruderi
che
pure
furono
attribuiti
allo
stesso
edificio,
pertinenti
forse
ad
un calidarium,
in
quanto
vi
erano
presenti
tracce
di
un
pavimento
ad ipocausto.
La
struttura
doveva
estendersi
fino
alla
via
Garibaldi,
dove
si
trovarono
altri
avanzi.
Secondo
la
ricostruzione
planimetrica
ottocentesca
del
complesso,
la
parte
attualmente
visitabile
comprendeva
probabilmente
solo
uno
dei frigidaria.
Nella
planimetria
della
città
di
Catania
rilevata
da Sebastiano
Ittar nel 1833 è
messo
in
evidenza
anche
il
muraglione
di
cinta
delle
terme,
che
raggiungeva
l'attuale Fontana
dell'Amenano a
ovest
e
l'Arcivescovato
a
est,
occupando
un'area
molto
estesa
della
città.
Dal 1974 al 1994 furono
chiuse
perché
considerate
insicure.
Furono
riaperte
dopo
un
restauro
del
comune
(1997)
e
nuovamente
richiuse
per
problemi
di
allagamento.
Dopo
i
lavori
di
pavimentazione
della
piazza
del
Duomo
(2004-2006)
-
nel
corso
dei
quali
si
è
ritenuto
di
coprire
l'impianto
con
una
poderosa
piastra
d'acciaio
per
rinforzare
l'impiantito
della
piazza
stessa
-
l'edificio
termale
è
stato
nuovamente
riaperto
al
pubblico e
alla
realizzazione
di
eventi.

Poco
si
conosce
delle
reali
dimensioni
del
grande
complesso
termale
e
quanto
oggi
è
visitabile
è
appena
una
piccola
porzione
della
sua
estensione.
Una
ipotesi
molto
fantasiosa
relativa
alle
dimensioni
delle
terme
la
fece
nel 1633 il D'Arcangelo,
erudito
di
storia
locale,
il
quale
fece
realizzare
una
planimetria
priva
di
elementi
reali
e
riconoscibili,
sebbene
abbia
il
merito
di
essere
il
primo
lavoro
avanzato
in
tal
direzione,
ispirandosi
palesemente
alla
planimetria
delle terme
di
Diocleziano.
Molto
più
accurata
è
la
planimetria
resa
da Sebastiano
Ittar nella
pianta
generale
della
città
di
Catania.
In
essa
viene
attribuita
alle
terme
una
cortina
muraria
che
correva
a
sud
della
piazza
Duomo,
identificata
quale
muro
perimetrale
dell'area
termale.
Diversi
scavi
occasionali
hanno
fatto
ipotizzare
il
rinvenimento
di
tracce
dell'impianto
in
altre
parti
dell'areale
oltre
a
quanto
noto,
facendo
desumere
che
esso
costituiva
l'area
oggi
occupata
dagli
edifici
compresi
tra
le
piazze
Duomo,
Università
e
San
Placido.
All'interno
della
cinta
che
circondava
l'edificio
si
ricavò
per
intero
la
Cattedrale
e
il
primo
impianto
monastico
benedettino
fondato
dal
vescovo
Ansgerio.
Alle
mura
di
cinta
sul
lato
occidentale
si
addossò
anche
la Loggia
Senatoria,
distrutta
durante
il terremoto
del
Val
di
Noto
del
1693,
e
si
aprì
la Porta
di
Eliodoro.
Dall'ingresso
sinistro,
il
quale
conduceva
originariamente
a
due
ambienti,
è
possibile
oggi
ammirare
i
resti
del Tepidarium,
una
sala
curvilinea
riscaldata
attraverso
un
sistema
di
canalizzazione
dell'aria;
questa
si
serviva
inoltre
di
una
scala
a
due
rampe
che
la
collegava
con
il
primo
piano
delle terme.
In
prossimità
della
parte
finale
del
corridoio,
gli
scavi
recentemente
condotti
in
profondità
hanno
permesso
di
individuare
un
canale
con
andamento
a
“S”,
il
quale
si
immette
sulla
sala
centrale
a
pilastri;
questi
ultimi
in
origine
percorrevano
il
corridoio
stesso.
Si
tratta,
probabilmente,
di
un
condotto
che
serviva
a
convogliare
l'acqua
e
a
distribuirla
per
i
servizi
delle terme.

Dell'impianto
originale
del
Frigidario
(o "Sala
dei
Pilastri")
si
conserva
una
camera
centrale
il
cui
soffitto a
crociere è
sorretto
da
quattro
pilastri
a
pianta
quadrangolare.
Al
vano
si
accede
tramite
un
corridoio
con volta
a
botte che
corre
in
direzione
est-ovest e
terminante
in
una
porta
che
si
apre
su
una
serie
di
vasche
parallele
tra
loro,
facenti
parte
di
un
complesso
sistema
di
canalizzazione,
drenaggio
e
filtrazione
dell'acqua
che
si
estende
verso
nord.
Anche
il
vano
principale
si
apre
con
tre
ingressi
ad
arco
sulle
vasche,
ad
ovest
del
vano
stesso.
L'ambiente
misurerebbe
11,00
metri
di
larghezza
e
11,90
metri
di
lunghezza,
mentre
le
stanze
di
decantazione
sarebbero
lunghe
in
tutto
18,65
metri.
Il
corridoio
misurerebbe
2,50
metri
in
larghezza
per
una
lunghezza
di
18
metri.
Inoltre,
l'unico
pilastro
di
cui
si
può
considerare
attendibile
la
misura
dell'altezza
è
alto
1.
85
metri.
Anticamente
i
pavimenti
(di
cui
oggi
non
rimangono
che
labili
tracce)
erano
in marmo,
come
dimostrano
alcuni
lacerti
tra
cui
i
resti
di
una
vasca
posta
al
centro
dell'aula
ed
assumevano
la
disposizione
dell'opus
sectile; mentre
alle
pareti
e
sul
soffitto
vi
erano
stucchi sicuramente
dipinti
ispirati
al
mondo
della
vendemmia,
con eroti e
tralci
di
vite,
grappoli
d'uva,
i
quali
furono
sapientemente
rappresentati
in
un
acquerello
di Jean
Houël,
il
quale
credeva
le
terme
il
tempio
di
Bacco;
tali
stucchi,
sebbene
ben
leggibili
nel
XVIII
secolo,
oggi
appaiono
molto
logori
e
in
ampie
parti
lacunosi.
Al
centro
della
sala
si
conserva
una
vaschetta
quadrata,
originariamente
rivestita
in
marmo,
sulla
quale
doveva
erigersi
una
colonnina
di
cui
si
conserva
l'impronta
della
base.
La
presenza
di
acqua
corrente
costantemente
filtrata,
l'assenza
di
aperture
al
di
là
dei
tre
accessi
alle
stanze
di
decantazione,
la
presenza
di
una
vasca
(piscina)
al
centro
della
sala
e
i
rivestimenti
marmorei
dimostrano
l'uso
a
frigidario
dell'ambiente.
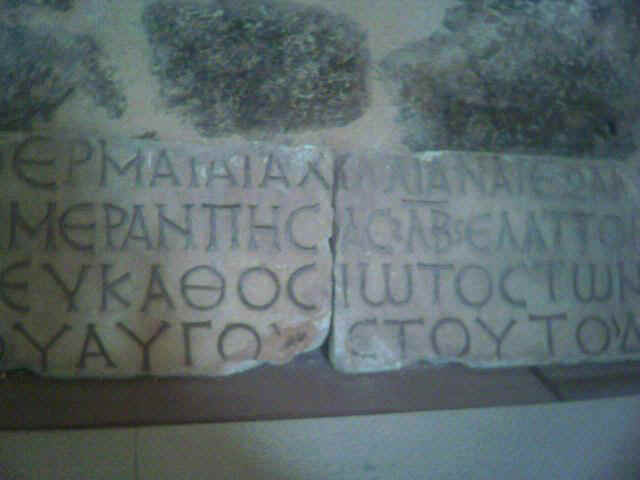 L'epigrafe che
diede
il
nome
all'impianto
è
in
lingua
greca e
usa
caratteri
greci
piuttosto
tardi
in
scriptio
continua,
è
posta
su
quattro
linee
ed
è
formata
da
diversi
frammenti
di
lastra
incisi,
con
lacune
sebbene
non
gravi,
ritrovati
in
diverse
epoche,
ma
originariamente
facenti
parte
di
un
unico
lastrone
in
marmo
lunense,
risalente
al
V
sec.
I
frammenti
misurano
0,30
metri
in
altezza
ed
hanno
una
lunghezza
complessiva
di
quasi
4,30
metri.
Essendo
state
rinvenute
quasi
tutte
nello
stesso
perimetro,
si
è
supposto
che
l'intera
incisione
facesse
originariamente
parte
dell'edificio
termale
fin
qui
descritto. L'epigrafe che
diede
il
nome
all'impianto
è
in
lingua
greca e
usa
caratteri
greci
piuttosto
tardi
in
scriptio
continua,
è
posta
su
quattro
linee
ed
è
formata
da
diversi
frammenti
di
lastra
incisi,
con
lacune
sebbene
non
gravi,
ritrovati
in
diverse
epoche,
ma
originariamente
facenti
parte
di
un
unico
lastrone
in
marmo
lunense,
risalente
al
V
sec.
I
frammenti
misurano
0,30
metri
in
altezza
ed
hanno
una
lunghezza
complessiva
di
quasi
4,30
metri.
Essendo
state
rinvenute
quasi
tutte
nello
stesso
perimetro,
si
è
supposto
che
l'intera
incisione
facesse
originariamente
parte
dell'edificio
termale
fin
qui
descritto.
Viene
menzionata
da
diversi
autori
anche
la
presenza
di
quattro
lapidi
riportanti
la
scritta Q.
LUSIUS/
LABERIUS/
PROCONSUE/
THERMAS,
che
confermerebbe
ulteriormente
l'attribuzione
della
lapide
ad
un
grande
impianto
termale
sito
al
di
sotto
della
Cattedrale,
un
tempo
forse
esposte
all'ingresso
delle
terme
e
in
seguito
murate
sulla
base
di
quattro
dei
pilastri
che
dividono
le
tre
navate
della
cattedrale.
Prima
del terremoto
del
1693,
i
primi
tre
frammenti
che
costituivano
la
lapide
furono
murati
nella
facciata
della
cattedrale,
poi
spostati
in
una
parete
del
vescovato secentesco e
da
qui
vennero
trasportati
nell'antica Loggia.
Nel 1702 si
ritrovarono
altri
due
frammenti
che
l'abate Vito
Maria
Amico unificò
con
gli
altri
e
tradusse.
In
seguito
furono
esposti
al
Museo
del
principe
Biscari
e
da
qui
all'attuale
collocazione
presso
il museo
civico
del
Castello
Ursino,
dove
è
stata
ricomposta
utilizzando
tutti
i
frammenti
conosciuti.
Nell'interpretazione
che
ne
dà
Francesco
Ferrara le
terme
sono
chiamate Achillianai e
non Achellianai,
come
invece
riportato
da
Holm
e
dal
Kaibel
e
tratterebbe
di
un
ipotetico
incendio
che
rovinò
la
struttura,
restaurata
da
Flavio
Felice
Eumazio.
Qui
inoltre
si
farebbe
riferimento
a
Massimo
Petronio,
preceduto
da
un
non
ben
identificato Julium
filium
Augusti.
Nella
traduzione
che
ne
dà
Giacomo
Manganaro,
la
lapide
si
potrebbe
datare
al
434
sulla
base
della
successione
dei
governatori.
Sempre
secondo
il
Manganaro
in
essa
si
celebrerebbe
l'opera
di
ristrutturazione
(forse
un
ridimensionamento)
esplicitamente
tendente
a
economizzare
legna
da
ardere
negli
ipocausti,
conclusa
dal
neo
governatore
di
Sicilia,
Flavio
Felice
Eumazio,
già
avviata
dal
suo
predecessore
Flavio
Liberalio, consularis
Siciliae secondo
la
sua
interpretazione,
sotto
l'imperatore
d'Oriente
Teodosio
II.
Tale
ricostruzione
permetterebbe
dunque,
sempre
secondo
l'ipotesi
del
Manganaro,
di
dare
almeno
due
nomi
ai
proconsoli
Siciliani
della
prima
metà
del V
secolo:
Eumazio
e
Liberalio.
Inoltre
avrebbe
riconosciuto
il
nome
di Leone quale
architetto
artefice
del
restauro.
Bastioni
di
Catania

I bastioni
di Catania sono
delle
fortificazioni cinquecentesche distribuite
lungo
quelle
che
furono
le mura
di
Carlo
V.
Le mura
di
Carlo
V erano
un
complesso
murario
che
venne
fatto
realizzare
a
Catania
dall'imperatore Carlo
V
di
Spagna a
difesa
della
città
e,
oltre
ad
avere
undici
bastioni
erano
munite
di
otto porte per
l'accesso
alla
città.
Nel
1551,
rottasi
la
tregua
fra Carlo
V
d'Asburgo e Solimano,
sultano
dei
Turchi,
gli
ottomani
tornarono
a
infestare
i
mari
siciliani:
minacciata
Messina
si
diressero
verso
Catania;
la
flotta
turca
fu
però
sospinta
al
largo
da
un
impetuoso
vento
di
tramontana
che
la
allontanò
dalle
rocce
dell'Armisi
(sotto
l'attuale stazione
ferroviaria
di
Catania)
e
dovette
desistere
dall'attacco.
I
turchi
si
diressero
quindi
verso Agosta che
saccheggiarono
e
misero
a
fuoco.
Lo
scampato
pericolo
mise
in
grande
allarme
la
popolazione
e
il
viceré Juan
de
Vega che
programmò
la
costruzione
di
robuste
mura
di
difesa,
o baluardi,
che
rinforzassero
le
mura
antiche.
I
lavori
furono
commissionati
all'architetto
e
ingegnere
militare Antonio
Ferramolino con
lo
scopo
di
edificare
una
cinta
muraria
in
pietra
lavica
dotata
di porte e
di
bastioni.
Il
30
novembre
1553
fu
gettata
la
prima
pietra
del
bastione
grande
detto del
Salvatore.
In
pochi
anni
Catania
venne
quindi
munita
di
nuove
mura
a
est,
sud
e
nord,
mentre
a
ovest
rimanevano
le
vecchie
mura. Vennero
eretti
otto
forti
e
aperte
otto
porte.
Il
costo
dei
lavori
fu
interamente
accollato
all'erario
civico
che
impose
nuove
tasse
e
mutui.
Le
mura
e,
conseguentemente,
i
bastioni
e
le
porte,
in
seguito
alle
devastazioni
di
fine
Seicento
(colata
lavica
nel
1669
e
terremoto
nel
1693),
furono
quasi
interamente
distrutte
ma
la
loro
scomparsa
definitiva
si
deve
al
piano
di
rinnovo
urbano
del
XVIII
secolo
quando,
agli
inizi
del XVIII
secolo,
il
duca
di
Camastra
fece
allargare
un'apertura
vicina
alla piazza
del
Duomo,
facendo
realizzare
la porta scenografica
che
venne
intitolata
al
viceré
duca
di
Uzeda.
Sopra
questo
tratto
di
mura
e
contro
il
parere
del
duca
di
Camastra,
vennero
edificati
il
prestigioso Palazzo
Biscari,
l'Arcivescovado
ed
il Palazzo
del
Seminario
dei
Chierici che
si
affaccia
sulla
piazza
del
Duomo
di
fronte
alla
sede
del municipio (il palazzo
degli
Elefanti).
Ad
oggi
comunque,
del
sistema
fortilizio
rimangono
ancora
cospicue
tracce
e
sono
visibili
i
baluardi
inferiori
delle
mura,
riconoscibili
per
la
tipica
struttura
scoscesa,
così
come
in
alcune
zone
dello
storico
quartiere
della Civita o
dell'Antico
Corso.

Ancora
oggi
è
evidente,
lungo
il
tratto
nord
della Via
Plebiscito,
il
percorso
della
cinta
tra
il
Bastione
degli
Infetti,
sito
all'Antico
Corso,
e
il
Bastione
del
Tindaro,
sul
cui
tratto
-
senza
porte
-
si
addossava
il complesso
monastico
di
San
Nicolò
l'Arena con
l'omonima
chiesa;
in
queste
zone
sorgevano
anche
il
Bastione
San
Giovanni
(nei
pressi
dell'omonimo
vico)
e
il
Bastione
Sant'Euplio
(in
piazza
Sant'Antonio
Abate).
Andarono
invece
completamente
inghiottiti
dalla
lava
il
Bastione
San
Giorgio
e
il
Bastione
Santa
Croce,
nei
pressi
del
Castello
Ursino;
alla
Civita,
si
trovavano
il
Bastione
Don
Perrucchio
(nei
pressi
dell'attuale
via
del
Vecchio
Bastione)
e
il
Bastione
del
Salvatore,
detto
anche
Bastione
Grande
o
di
Porto
Puntone,
eretto
nel 1552 e
sito
fra
via
Cardinale
Dusmet
e
via
Porta
di
Ferro
(dall'omonima
porta).
Il
Bastione
San
Giuliano
sorgeva,
invece,
sul
terreno
dell'odierno Convitto
Cutelli,
mentre
il
Bastione
San
Michele
(sito
nei
pressi
di
piazza
Turi
Ferro,
anticamente
piazza
Spirito
Santo)
e
il
Bastione
del
Santo
Carcere,
accanto
all'omonima
chiesa
di
Sant'Agata,
nella
parte
alta
di
via
dei
Cappuccini,
chiudevano
il
cerchio
difensivo
attorno
alla
città.
Gli
undici
bastioni;
Bastione
San
Giorgio,
Bastione
Santa
Croce,
Bastione
Don
Perrucchio,
Bastione
Grande
(del
Salvatore),
Bastione
San
Giuliano,
Bastione
San
Michele,
Bastione
del
Santo
Carcere,
Bastione
degli
Infetti,
Bastione
del
Tindaro,
Bastione
San
Giovanni,
Bastione
Sant'Euplio.
Esistono
altri
edifici,
al
di
fuori
delle
mura
cinquecentesche,
che
hanno
avuto
la
funzione
di
fortificazione
e
sorveglianza
per
la
città
di
Catania
e
possono
quindi
essere
considerati
bastioni
a
tutti
gli
effetti.
Ne
sono
esempio
la
Garitta
di
guardia
in
pietra
lavica
presente
al
centro
di
piazza
Europa
e
la
Torre
del campanile della
Chiesa
di
Santa
Maria
di
Ognina.
Porta
Ferdinandea

La porta
Ferdinandea,
dopo
il
1860
intitolata porta
Garibaldi,
è
un arco
trionfale costruito
nel 1768 su
progetto
di Stefano
Ittar
e
Francesco
Battaglia per
commemorare
le
nozze
di
re Ferdinando
III
di
Sicilia e Maria
Carolina
d'Asburgo-Lorena.
Si
trova
tra
piazza
Palestro
e
piazza
Crocifisso,
alla
fine
di via
Giuseppe
Garibaldi,
nel
quartiere Fortino,
in
dialetto
catanese Futtinu.
La
zona
è
chiamata 'u
Futtinu in
ricordo
di
un fortino costruito
dal
viceré Claudio
Lamoraldo, principe
di
Ligne,
dopo
l'eruzione
lavica
del
1669 che
colpì
la
città
su
tutto
il
lato
occidentale,
annullandone
le
difese
medievali.
Dell'opera
di
fortificazione
avanzata
che
sorgeva
a
sud
di
piazza
Palestro,
ormai
scomparsa,
rimane
solo
una
porta
in
via
Sacchero.
Alcuni
palazzi
collegati
alla
porta
furono
demoliti
negli anni
trenta,
altri
oggi
sono
abbastanza
poveri
e
tutt'altro
che
simmetrici.
La
riqualificazione
della
piazza
ha
dato
sicuramente
un
altro
aspetto
alla
porta,
ma
è
comunque
tutt'altro
rispetto
ai
progetti
originari.
Castello
Ursino
Il castello
Ursino fu
costruito
da Federico
II
di
Svevia nel XIII
secolo.
Il maniero ebbe
una
certa
visibilità
nel
corso
dei Vespri
siciliani,
come sede
del
parlamento e,
in
seguito,
residenza
dei
sovrani aragonesi fra
cui Federico
III.
Oggi
è
sede
del Museo
civico
della della
città
etnea,
formato
principalmente
dalle
raccolte Biscari e
dei Benedettini.
Sul
sito
dove
sorge
l'edificio
attuale
è
testimoniato
uno
dei
nuclei
più
antichi
dell'abitato
catanese,
risalente
alla
prima
fase
abitativa
della polis greca
di Katane.
Sebbene
in
passato
sia
stata
qui
ipotizzata
la
presenza
di
una
torre
di
età
normanna
-
la
Torre
di
Don
Lorenzo -
di
essa
non
solo
non
resta
traccia
alcuna,
ma
gli
studiosi
tendono
a
ritenere
l'ipotesi
di
una
preesistenza
normanna
sul
sito
del
castello
Ursino
priva
di
fondamenta
scientifiche
e
tendono
a
ricercarla
in
altro
sito
del
centro
storico
cittadino.
Sulle
origini
dell'edificio,
sebbene
non
vi
siano
prove
concrete
che
lo
associno
a
Federico
II,
gli
studiosi
tendono
ad
identificarlo
con
il castrum menzionato
nella
lettera
indirizzata
al
suo
architetto, Riccardo
da
Lentini,
il
cui
cantiere
doveva
ancora
avviarsi
nel 1239.

Il
castello
Ursino
fu
probabilmente
voluto
da
Federico
II
di
Svevia
e
costruito
non
prima
del 1239.
L'imperatore
aveva
probabilmente
pensato
il
maniero
all'interno
di
un
più
complesso
sistema
difensivo
costiero
della Sicilia orientale
(fra
gli
altri
anche
il castello
Maniace di Siracusa e
quello
di Augusta sono
riconducibili
allo
stesso
progetto)
e
come
simbolo
dell'autorità
e
del
potere
imperiale
svevo
in
una
città
spesso
ostile
e
ribelle
a
Federico.
Il
progetto
e
la
direzione
dei
lavori
furono
affidati
all'architetto
militare Riccardo
da
Lentini.
Nei
primi
anni
del XV
secolo l'edificio
è
circondato
dalla
città
e
diverse
casupole
vi
si
addossano.
Re Martino
I
di
Sicilia nel 1405 sgomberò
lo
spazio
intorno
al
maniero,
per
ricavare
una
piazza
d'arme,
demolendo
tra
gli
altri
il
convento
di
San
Domenico,
lì
ubicato
dal 1313.
Fu
probabilmente
dotato
anche
di
un
ponte
levatoio.
Secondo
il Correnti sarebbe
stato
costruito
sulla
riva
del
mare
per
volontà
di Federico
II e
il
nome
"Ursino"
dato
al
castello
deriverebbe
da Castrum
Sinus
ovvero
il
"castello del golfo".
All'interno
del
castello
si
vissero
alcuni
dei
momenti
più
importanti
della
guerra
del
Vespro.
Nel 1295 vi
si
riunì
il
Parlamento
Siciliano,
che
dichiarò
decaduto Giacomo
II ed
elesse
Federico
III
a
re
di
Sicilia.
Nel
corso
del 1296 il
castello
fu
preso
da Roberto
d'Angiò e
successivamente
espugnato
nuovamente
dagli
aragonesi.
Re
Federico
abitò
a
partire
dal
1296
il
maniero,
facendone
la
corte
aragonese
e
così
fecero
anche
i
successori Pietro,
di Ludovico, Federico
IV e Maria.
Inoltre
la
sala
dei
Parlamenti
fu
nel
1337
anche
la camera
ardente per
la
salma
di
re
Federico
III.
Nel 1347 all'interno
del
castello
venne
firmata
la
cosiddetta Pace
di
Catania fra Giovanni
di
Randazzo e Giovanna
d'Angiò.
Il
castello
Ursino
fu
dimora
reale
dei
sovrani
del
casato
Aragona
di
Sicilia
(ramo
parallelo
siciliano
del
casato
di
Barcellona)
e
ospitò
tutti
i
re
da
Federico
III
e
tutti
i
suoi
discendenti
fino
al
1415
ospitò
la
regina
Bianca
d'Evreux
di origine
normanna ma
ereditaria
del
regno
di
Navarra
sposa
di
Martino
I
di
Sicilia
(deceduto
nel
1409).
Finiti
i Vespri,
il
castello,
dimora
di
Maria
di
Sicilia,
fu
teatro
del
rapimento
della
regina
da
parte
di Guglielmo
Raimondo
Moncada
nella
notte
del
23
gennaio 1392,
per
evitare
il
matrimonio
con Gian
Galeazzo
Visconti.
Con
l'avvento
di Martino
I
di
Sicilia il
castello
divenne
nuovamente
corte
del
regno.
Alfonso
il
Magnanimo riunì
il
25
maggio
del 1416,
nella
sala
dei
Parlamenti
del
castello
i baroni e
i
prelati
dell'isola
per
il
giuramento
di
fedeltà
al
Sovrano
e
fino
al
30
agosto
vi
si
svolsero
gli
ultimi
atti
della
vita
politica
che
videro
Catania
come
città
capitale
del
regno.
Nel 1434 lo
stesso
re
Alfonso
firmò
nel
castello
l'atto
con
cui
concedeva
la
fondazione
dell'Università
degli
Studi
di
Catania.


Nel 1460 si
riunirà
nel
castello
Ursino
il
primo
Parlamento
del
periodo
aragonese-castigliano
presieduto
dal
viceré Giovanni
Lopes
Ximenes
de
Urrea.
Inoltre
al
suo
interno
morì
nel 1494 don Ferdinando
de
Acuña viceré
di
Sicilia.
Verrà
sepolto
in Cattedrale,
nella
cappella
di Sant'Agata.
Nel
XVI
secolo
venne
costruito
un bastione
detto
di
San
Giorgio a
difesa
del
castello
ed
eseguite
alcune
modifiche
in
stile
rinascimentale.
Dal XVI
secolo,
con
l'introduzione
della polvere
da
sparo,
il
castello
vide
sempre
più
indebolito
il
suo
ruolo
militare,
diventando
temporaneamente
dimora
di
viceré,
e
più
costantemente
del
castellano,
mentre
una
parte
di
esso
fu
adibito
a prigione.
L'11
marzo
1669 da
una
frattura
sopra
Nicolosi
cominciò
la
più
imponente
eruzione
dell'Etna di
epoca
storica,
che
dopo
aver
distrutto
orti
e
casali,
giunse
alle
mura
della
città,
che
riuscì
a
superare
da
Nord-Ovest,
nella
zona
del Monastero
di
San
Nicolò
l'Arena,
per
poi
dirigersi
verso
il Bastione
di
San
Giorgio.
Il
16
aprile
la lava arrivò
attorno
al
castello
e
pur
non
intaccandone
le
strutture
colmò
il
fossato,
coprì
i
bastioni
e
spostò
per
alcune
centinaia
di
metri
anche
la
linea
di
costa.
Qualche
tempo
dopo
anche
il terremoto
del
1693 provocò
una
serie
di
danni
alle
strutture,
compromettendo
definitivamente
il
ruolo
militare
del
castello.
Ristrutturato,
continuò
ad
ospitare
le
guarnigioni
militari
prima piemontesi (1714)
e
quindi borboniche,
assumendo
anche
il
nome
di Forte
Ferdinandeo.
Rimase
tuttavia
prigione
fino
al 1838,
quando
il
governo
borbonico
riconoscendone
il
ruolo
come
fortilizio,
vi
apportò
restauri
e
vi
aggiunse
nuove
fabbriche
che
finirono
con
l'occultare
sempre
più
l'originaria
struttura
sveva.
In
tale
stato
il
maniero
rimase
fino
agli
anni
30
del
Novecento,
quando
fu
oggetto
di
un
radicale
restauro,
in
vista
della
sua
trasformazione
in
Museo.
Acquisito
nel 1932 dal
comune
e
sottoposto
a
restauri,
oggi
il
castello
si
trova
in
pieno
centro
storico
e,
dal
20
ottobre 1934,
è
adibito
a
museo
civico
di
Catania.
Nel
mese
di
novembre
del
2009
sono
stati
ultimati
i
lavori
di
restauro.

La
costruzione,
è
a
pianta
quadrata,
ogni
lato
misura
circa
50
metri.
I
quattro
angoli
sono
dotati
di
torrioni
circolari
con
diametro
poco
superiore
ai
10
metri
e
altezza
massima
di
30,
mentre
le
due
torri
mediane
sopravvissute
(in
origine
erano
quattro)
hanno
un
diametro
di
circa
7
metri.
Le
mura
sono
realizzate
in opus
incertum di
pietrame
lavico
e
presentano
uno
spessore
di
2.50
metri.
Originariamente
il
castello
presentava
alle
basi
delle
scarpate
che
lo
slanciavano
dandogli
un
aspetto
decisamente
imponente.
Esse
sono
visibili
nel
fossato
del
lato
sud
del
castello
grazie
agli
ultimi
scavi
effettuati.
Il
lato
settentrionale
è
quello
principale
ed
è
ben
conservato
con
quattro finestre anche
se
originariamente
non
presentava
aperture
per
renderlo
meno
vulnerabile
agli
attacchi
nemici,
qui
l'entrata
del
castello
era
difesa
da
un ponte
levatoio e
da
mura
difensive
i
cui
resti
sono
ancora
visibili
nel
fossato
di
fronte
all'entrata.
Una
base
a
scarpa
rafforza
la
struttura
del
castello.
Il
lato
sud
è
molto
cambiato
nel
tempo,
data
la
scomparsa
della torre mediana
e
delle
numerose
finestre
aperte
nel
tempo.
Qui
troviamo
una
porta
secondaria
detta
"porta
falsa"
che,
per
mezzo
di
uno
scivolo
(che
probabilmente
era
in
legno
e
pietra),
conduceva
all'imbarcadero
a
mare
ricavato
oltre
il
bastione;
il
lato
sud
del
castello
infatti
fino
alla
metà
del XVI
secolo era
direttamente
prospiciente
la
spiaggia
e
le
acque
del mar
Jonio.
Poi
la
realizzazione
del
bastione
di
San
Giorgio
e
della
piattaforma
di
Santa
Croce
lo
allontanarono
dal
mare,
ma
lo
resero
efficiente
per
l'uso
dei
cannoni.
Il
definitivo
allontanamento
dal
mare
e
l'innalzamento
del
livello
del
terreno
circostante
al
castello
fu
dovuto
alla
colata
lavica
del 1669 che
lo
cinse
quasi
totalmente
e
sommerse
i
bastioni.
Il
lato
est
non
presenta
la
semi
torre
ma
vi
si
trova
una
meravigliosa
finestra
di età
rinascimentale con
un
pentalfa
in
pietra
nera
lavica.
I
moderni
lavori
di
restauro
hanno
portato
alla
luce
fino
ad
ora
parte
dei
bastioni
cinquecenteschi,
una garitta perfettamente
conservata
e
gli
originari
basamenti
a
scarpa
che
oggi
restituiscono
l'originaria
maestosità
alle
torri
angolari
del
castello.
Il
progetto
originale
probabilmente
non
prevedeva
una merlatura,
rara
nei castelli
federiciani.
Ma
successive
modifiche
e
ricostruzioni
della
parte
sommitale
di
alcune
torri,
hanno
probabilmente
previsto
l'inserimento
di
merlature.
La
pianta
originale
si
basa
sulla
relazione
tra
quadrato
e
ottagono,
con
possibile
riferimento
alla
cabala.
L'ingresso,
semplice,
si
trova
nel
prospetto
nord
ed
ha
sopra
in
una
nicchia
una scultura raffigurante
un'aquila sveva che
afferra
una lepre simbolo
del
potere
del
sovrano Federico
II sulla capitale
etnea,
erroneamente
scambiata
talora
per
agnello.
Al
suo
interno
si
sviluppava
la corte e
vi
rimane
un
bel
cortile
con
scala
esterna
in stile
gotico costruita
in
età
rinascimentale.
Attorno
al
cortile
interno
c'erano
le
quattro
grandi
sale
fiancheggiate
da
sale
minori,
dalle
quali
si
accede
alle
torri
angolari.
Ogni
grande
sala
è
divisa
da
tre
campate,
coperte
da
volte
a
crociera
costolonate
che
si
dipartono
da
semicolonne con capitelli ornati
a
foglie.

Dal
piano
inferiore
al
piano
superiore
si
accedeva
attraverso
le scale
a
chiocciola posizionate
all'interno
delle
semi
torri
nord
e
sud.
Funzionalmente
combinò
sia
la
funzione
di reggia (palatium)
che
quella
di maniero (castrum).
L'aspetto
complessivo
del
castello
nel
suo
ambiente
circostante
è
notevolmente
cambiato
nel
tempo,
era
prossimo
al mare nei
lati
sud
ed
est,
probabilmente
in
una
vasta
area
aperta
ridottasi
ad
uso
agricolo
dopo
il
progressivo
abbandono
dei
quartieri
meridionali
nel
corso
della tarda
antichità.
In
seguito,
forse
lungo
il
corso
del XIV
secolo durante
l'espansione
della Giudecca
di
Catania,
la
campagna
su
cui
sorgeva
venne
occupata
da
fabbricati
e
conventi,
tra
cui
quello
di
San
Domenico,
eretto
nel
1313.
Dal
1405
la
città
che
ormai
lo
soffocava
venne
sventrata
e
intorno
all'edificio
fu
ricavata
un'ampia
piazza
d'arme.
In
seguito
la
struttura
fu
circondata
da
bastioni
e
dotata
di
un
fossato
e
venne
reso
imponente
dalle
scarpate.
Dopo
la colata
lavica del 1669 e
il terremoto
del
1693,
il
castello
vide
allontanare
la
linea
di
costa
di
centinaia
di
metri
e
rialzarsi
il
livello
del
terreno
di
una
decina
di
metri
così
che
la
sua
imponenza
e
la
sua
magnificenza
venne
occultata
per
sempre.
Il
lungo
periodo
durante
il
quale
il
castello
fu
adibito
a
carcere
comportò
notevoli
modifiche
strutturali,
poiché
il
maniero
federiciano,
nonostante
la
sua
ampiezza,
non
aveva
un
numero
sufficiente
di
locali
che
si
prestassero
ad
essere
usati
come
prigione.
Così
le
grandi
sale
del
piano
terra
furono
suddivise
da
nuovi
muri
e
solai,
che
crearono
ambienti
minori
in
cui
i
prigionieri
stavano come
l'anime
dannate nei
cosiddetti dammusi,
cioè
piccole
celle,
oscure
e
infestate
da
topi,
scorpioni
e
tarantole.
Una
traccia
di
questa
pagina
della
storia
del
castello
si
trova
nelle
centinaia
di
graffiti
che
riempiono
i
muri
e
gli
stipiti
di
porte
e
finestre
di
tutti
gli
ambienti
del
piano
terra
(ad
eccezione
di
quelli
sul
lato
nord)
e
anche
il
cortile
interno.
Disegni:
si
tratta
di
stemmi,
ma
anche
di
teste
e
volti
generalmente
disegnati
di
prospetto,
talvolta
con
intento
caricaturale.
Fra
le
rappresentazioni
figurate,
quelle
di
maggiore
interesse
si
trovano
nel
cortile.
Si
tratta
di
una
torre
merlata
e
di
quattro
imbarcazioni
a
tre
alberi,
tipi
di
galeoni
in
voga
fra
cinque
e
settecento,
descritti
con
grande
precisione.
Molto
frequenti
anche
i
simboli
di
carattere
religioso,
in
particolare
la
Croce
e
gli
strumenti
della
Passione,
nella
cui
rappresentazione
il
carcerato
ravvicinava
la
propria
sofferenza
a
quella
di
Cristo.
L'esempio
più
interessante
si
trova
nel
cortile,
una
grande
croce
con Nodi
di
Salomone ai
vertici,
con
la
scala,
la
spugna,
le
tenaglie
e
il
martello.
Iscrizioni:
spesso
si
tratta
solo
di
un
nome,
una
data
(la
più
antica
riporta
il
1526)
e
la
frase Vinni
carceratu.
Ma
il
repertorio
è
vastissimo
e
comprende
riferimenti
alla
colpa
attribuita
al
prigioniero,
rispetto
alla
quale
egli
si
dichiara
innocente,
vittima
di
complotti
o
tradimenti,
e
poi
sentenze
o
riflessioni
dettate
dalla
durezza
della
vita
in
carcere.
Fra
queste
un
tale
Don
Rocco
Gangemi,
che
scrive: Miseru
cui
troppu
ama
e
troppu
cridi.
Particolarmente
interessanti,
sul
portale
del
lato
sud
del
cortile,
due
lunghe
frasi
che
mostrano
dei
precisi
e
puntuali
riferimenti
con
la
contemporanea
produzione
dei
poeti Antonio
Veneziano e
Antonio
Maura,
ed
una
lapidaria
incisione
sul
senso
della
vita: Mundus
rota
est.
La
lingua
di
queste
iscrizioni
è
per
lo
più
il
siciliano,
ma
con
uso
anche
del
latino,
dello
spagnolo
e
di
un
misto
di
siciliano
e
latino.

Pag.
2

 Pag.
4
Pag.
4
|