|
Situata a
circa 300 metri s.l.m., Caronia occupa la sommità di un duplice colle,
affacciato sul mare e sulla foce (ricoperta di agrumi) della fiumara che da
essa prende il nome. Oltre a costituire il cuore del Parco dei Nebrodi, è
anche il comune più boscato della Sicilia e uno dei più verdi d'Italia. I
suoi boschi hanno da sempre segnato e dominato il paesaggio dei monti
Nebrodi, al punto che per molto tempo queste montagne hanno portato il nome
di Caronie. Il borgo costiero di Caronia Marina offre spiagge belle e
pulite.
Le origini
di Caronia risalgono al 448 a.C. anno in cui Ducezio fondò la città
di Calacte, che in greco significa bella costa, stabilendovi una colonia
mista siculo-greca, con l’idea di farne la capitale di una federazione di
città sicule indipendenti. Il fallimento del progetto politico di Ducezio
non consentì a Calacte di interpretare il ruolo per cui era stata
concepita. Nondimeno essa continuò a svolgere per tutta l’antichità
le funzioni di importante scalo marittimo sulla rotta tirrenica che
collegava il nord Africa con l’Italia e la Magna Grecia e come tale è
citata da Strabone e dagli Itinerari tardo-antichi.
Dopo la
conquista romana,
all'inizio del II
secolo a.C., la città iniziò a battere una serie di monete di
bronzo, la più importante con la raffigurazione di Dioniso e di un grappolo
d'uva. Durante l'impero romano fu rilevante centro agricolo e commerciale:
esportava soprattutto vino, trasportato in anfore.
Probabilmente esportava anche tonno e Silio
Italico nel I secolo d.C. parlava del "litus piscosa
Calacte" (14, 251). Anfore vinarie
del IV
secolo d.C. prodotte a Caleacte sono state trovate a Roma.
A partire
dal III secolo a.C. coniò moneta propria. In epoca romana è menzionata da
Cicerone come vittima delle estorsioni di Verre e da Plinio per la pescosità
del mare. Suoi cittadini illustri furono Sileno, lo storico di Annibale, e
Cecilio, retore tra i più apprezzati della corrente atticista, autore di
un’opera andata perduta sulle rivolte servili.

I recenti
scavi archeologici a Caronia e Marina
di Caronia hanno mostrato che la città ellenistica sul sito
dell'odierna Caronia fu distrutta verso la fine del I
secolo d.C. da un incendio o un terremoto e fu forse
abbandonata, mentre gli abitanti si spostarono sul mare, in corrispondenza
dell'odierna Caronia Marina. Poco dopo la metà del IV secolo d.C.,
l'abitato portuale di Calacte a Caronia Marina fu distrutto, probabilmente
da un terremoto. La vita dell'abitato continuò, ma dopo il V
secolo d.C. su scala molto ridotta.
L’attuale
insediamento fu fondato dai normanni che edificarono il castello. Attorno a
quest’ultimo si sviluppò l’abitato.
Nel
Medioevo fu feudo dei Ventimiglia,
che lo sfruttarono come scalo commerciale, per poi divenire nel corso della
dominazione spagnola, nel 1630,
feudo in qualità di marchesato dei Pignatelli Aragona
Córtez, la cui presenza è attestata dal vessillo comunale che presenta tre
pignatte in campo senape.
Nel 2004 le
abitazioni della frazione Canneto furono
oggetto di apparenti e inspiegati fenomeni di autocombustione, che
interessarono soprattutto gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici. Tali
incendi si sono poi dimostrati, ad una successiva e più approfondita
indagine, di natura dolosa.
Intorno
alla metà del XII sec. Edrisi così la descrive: “A Caronia ha inizio il
territorio dei Demenni (Valdemone). E’ essa una rocca antica, sulla quale
è stata elevata una nuova fortezza. Il paese possiede giardini, fiumi,
vigne, alberi, e un porto di mare dove si tende la rete per pescare il tonno
grande. La rocca è distante all’incirca un miglio dal mare”. La nuova
fortezza di cui parla Edrisi è il Castello che ancor oggi domina Caronia,
costruito durante il regno di Ruggero II, probabilmente come residenza di
caccia dello stesso re. Nel 1178 le chiese di S. Nicola e dell’Annunziata
alla Marina furono concesse dall’arci-vescovo di Messina all’abbazia
benedettina di S. Maria di Maniace. In epoca sveva il Castello (con il bosco
e la tonnara) fu infeudato ai Ventimiglia, che, dopo la parentesi angioina,
lo riebbero dai sovrani aragonesi.
Tra il 1338 e il 1354 Caronia fu
posseduta prima da Matteo Palizzi e poi da Blasco d’Alagona, capi
rispettivamente della fazione latina e catalana della feudalità siciliana;
quindi da Enrico Rosso (1408-1411) e dai Cardona (1444-1595). Da questi
ultimi l’ebbe nel 1595 Ettore Pignatelli. I suoi discendenti la
manterranno fino alla fine della feudalità in Sicilia (1812).
Visitare
il borgo
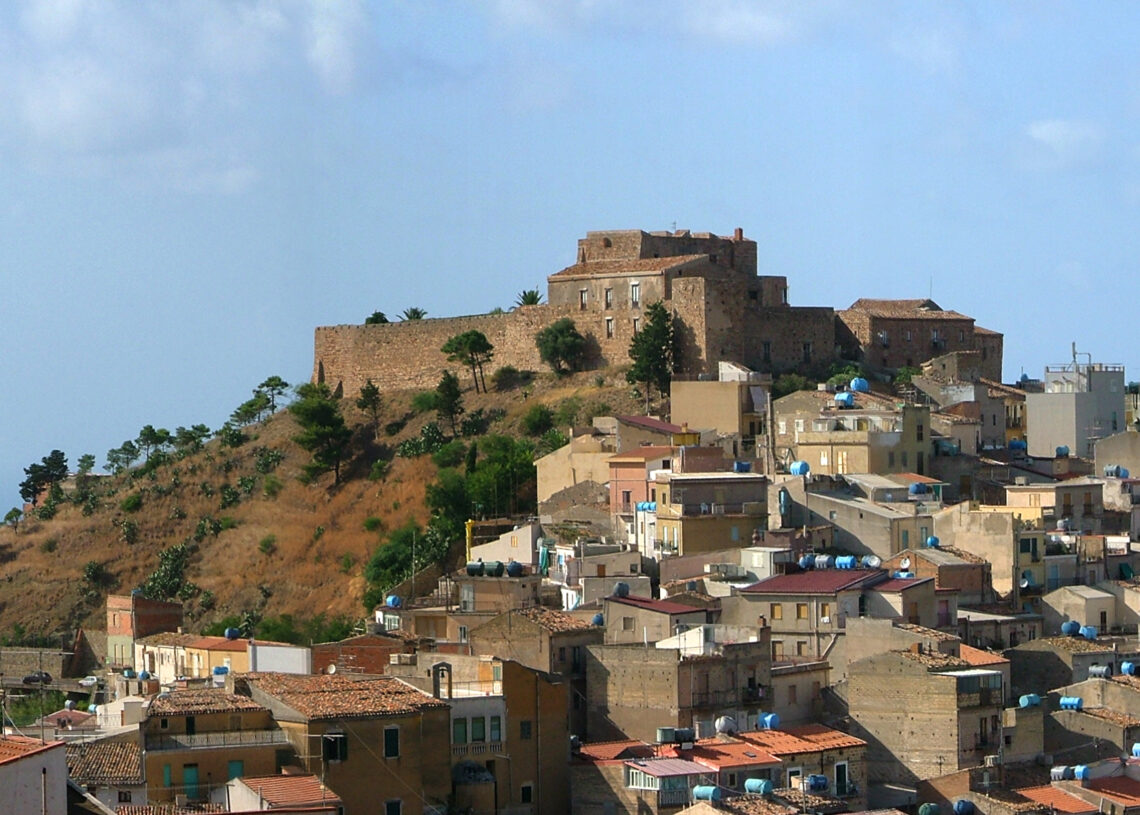
Il nucleo originario
del paese, che insiste sul medesimo sito dell’antica Calacte, è
costituito da un borgo (un tempo murato) aggrappato al castello normanno e
delimitato a sud da Porta Torre e dalla piazza Idria, dove oggi si trova il
Municipio. Presenta alcuni scorci pittoreschi, come la Porta Torre
dall’arco ogivale della fine del XIII secolo; il cortile Contino,
circondato da edifici costruiti a ridosso delle mura antiche; la torre
Sansiveri, dov’è un gruppo di case insediate sopra un preesistente
bastione.
Chiesa
Madre San Nicolò di Bari
La
chiesa Madre di Caronia, dedicata a San Nicolò di Bari, Vescovo di Mira
(nel vicino Medio Oriente) fu edificata dagli abitanti caronesi nel 1178 e
riedificata nel 1685.
 Nel
1753 il pittore Michele Latino decorò in stile "Rococò" la volta
dell'Abside, e nel 1754, il pittore Biagio Ferro, iniziò la pittura della
volta che fu poi completata dal pittore Antonio Petringa. Nel
1753 il pittore Michele Latino decorò in stile "Rococò" la volta
dell'Abside, e nel 1754, il pittore Biagio Ferro, iniziò la pittura della
volta che fu poi completata dal pittore Antonio Petringa.
All'interno
della Chiesa vi sono custoditi nr. 5 quadri su tela, di pregevole fattura
che risalgono al 1700 e, in nessuno di essi, vi è apposta la firma
dell'autore. Essi raffigurano (da sinistra a destra entrando):
1.
San Francesco di Paola nell'atto di attraversare lo stretto di Messina sul
suo mantello;
2.
la Sacra Famiglia e San Gioacchino e Anna;
3.
la Gloria di San Nicolò di Bari;
a
destra:
1.
la Sacra Famiglia con Gesù e San Giovanni Battista;
2.
Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco Saverio, con in alto l'Arcangelo
Gabriele nell'atto di precipitare nell'inferno gli Angeli ribelli. In basso,
a sinistra, si intravede uno scorcio di Caronia.
Vi
è anche un quadro della Madonna di Pompei, di fattura recente.
In
questi ultimi anni sono stati eseguiti interessanti lavori che hanno
riportato i muri perimetrali all'originale pietra viva, ed è stata rifatta
per intero, la copertura esterna, onde evitare infiltrazioni di acqua che in
passato hanno danneggiato la volta. Tali lavori sono stati finanziati
dall'assessorato ai lavori pubblici di Palermo, sotto la direzione
dell'architetto Liuzzo. Anche il pavimento è stato rifatto dando alla
Chiesa un aspetto nuovo e dignitoso.
Castello
Il Castello
di Caronia fu costruito in epoca normanna (XII
secolo) probabilmente al tempo di re Ruggero. Il castello, oggi di
proprietà privata, è uno degli edifici meglio conservati dell'architettura
normanna in Sicilia.
Il
complesso castrale fonda le ragioni della sua collocazione
sull’eccezionale valore paesaggistico e strategico di un colle che,
scosceso su tre lati, si eleva appena 350 m s.l.m., dista dal litorale poco
più di un chilometro, vanta buone potenzialità visive e gode di condizioni
climatiche permanentemente miti; solo nel versante orientale, questa cresta
digrada più dolcemente prestando la situazione più favorevole al nucleo
medievale, ancora fortemente connotato dalla fitta trama del tessuto
edilizio e dai tracciati viari che lo innervano adattandosi alle curve di
livello e culminando alla fortezza; da quest’ultima si diramavano le mura
che circondavano l’insediamento, cortina di cui permane una significativa
porta urbica con arcata a sesto acuto.
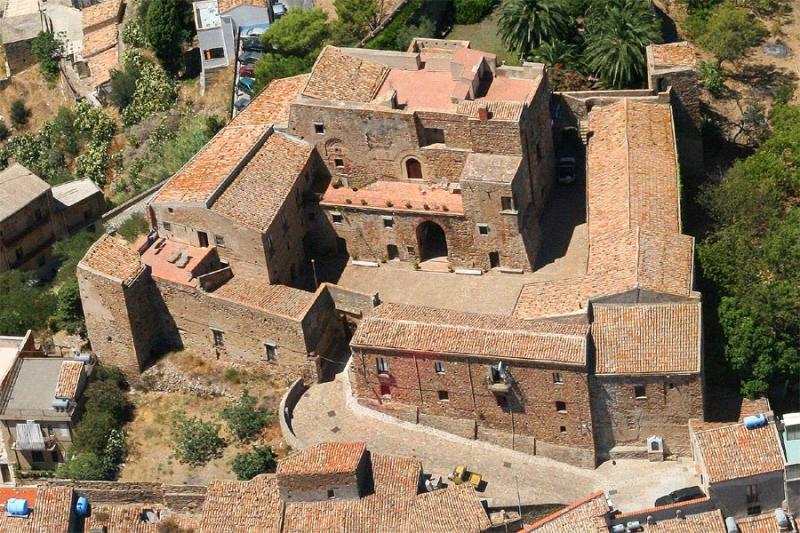 La mole del
castello ancora prevarica l’abitato sottostante, malgrado alcune
deprecabili soprelevazioni di edifici che si trovano nell’immediato
intorno; essa domina sulla vicina fiumara, naturale via di comunicazione
verso l’entroterra boschivo, sul probabile sito di kale Akte,
insediamento greco-romano, e su un vasto territorio costiero frequentato da
secolari attività marinare; rapporti visivi sicuri potevano intrattenersi
con la Croce di Santo Stefano, con i castelli di Motta d’Afferm, Marina di
Tusa, Serravalle e San Marco d’Alunzio. La mole del
castello ancora prevarica l’abitato sottostante, malgrado alcune
deprecabili soprelevazioni di edifici che si trovano nell’immediato
intorno; essa domina sulla vicina fiumara, naturale via di comunicazione
verso l’entroterra boschivo, sul probabile sito di kale Akte,
insediamento greco-romano, e su un vasto territorio costiero frequentato da
secolari attività marinare; rapporti visivi sicuri potevano intrattenersi
con la Croce di Santo Stefano, con i castelli di Motta d’Afferm, Marina di
Tusa, Serravalle e San Marco d’Alunzio.
La
disposizione d’insieme del complesso segue la sommità triangolare del
colle che si rastrema in modo più pronunciato verso ovest. Questa giacitura
è stata perimetrata da mura e torri; sul fronte orientale, raggiungibile da
via Castello, si apre l’unico accesso con un portale neoclassico
sovrapposto all’originaria arcata ogivale e mentre nella parte più
meridionale del medesimo fronte svetta la cosiddetta “torre
dell’orologio”, all’angolo nord gli alti muraglioni celano una
cappella a tre navate, plausibilmente subentrata alle strutture di una
seconda torre aggettante rispetto al filo delle mura; tale aggetto
odiernamente è stato assorbito dall’avanzamento (5 m ca.) di altri corpi
di fabbrica addossati all’originaria cortina.
Di contro,
la torre situata al centro del lato settentrionale è la meglio conservata
poiché reca tracce di ammorsature murarie, di varchi tompagnati aperti
sugli originari camminamenti di ronda e, soprattutto, di tre finestrelle a
tutto sesto contornate con mattoni di laterizio, composte in un elegante
motivo piramidale che si ritrova solo nella facciata occidentale del palazzo
normanno; tratti murari di un’ultima torre rimaneggiata a seguito di
consistenti crolli si trovano alla cuspide occidentale; il recinto murario
appare sporadicamente rifatto o riparato in età posteriore al XII secolo e
nel tratto subito ad ovest della torre settentrionale; fino alla torre
occidentale, essendo crollato, è stato riproposto a mo’ di parapetto.
In
posizione baricentrica rispetto alla cinta, è situato un edificio normanno
a due livelli, avente pianta rettangolare con asse maggiore nord-sud (m
21,80 x 9,35); ai suoi lati sono stati addossati in epoche diverse alcuni
avancorpi che rivestono completamente il pianterreno e una piccola parte del
piano superiore; essi, con gli ultimi restauri (1965 – 1970) hanno subito
una rimodulazione mirata ad evidenziare le fabbriche normanne; l’avancorpo
addossato alla facciata orientale è diviso in due piani; quello terreno è
attraversato da un andito con volta a botte ogivale, in asse con il portale
del nucleo originario; quello superiore è composto da un solo vano,
giustapposto all’estremità settentrionale, con un’elegante bifora
angolare che alla base del piantone reca l’arme Pignatelli, signori di
caronia dopo il 1544.
Al
pianterreno del medesimo fronte si apre l’accesso principale del palazzo,
dato da un grande portale ad ogiva con doppio archivolto scandito dalla
bicromia di conci calcarei e di mattoni in laterizio; analogo trattamento è
reperibile superiormente in due archivolti quadripartiti da fasce a tutto
sesto, progressivamente incassate fino al vano delle rispettive monofore
appena ogivali; allo stesso livello si apre una porta finestra, plausibile
accesso sublime del piano nobile, sormontata da una ghiera di conci
addentellati congiunti a seggiola.

Lo schema
distributivo del palazzo si organizza in entrambi i piani attorno a due sale
centrali, aperte verso ovest in ampie nicchie ed affiancate simmetricamente
verso nord e sud, da altri ambienti; le coperture dei locali al pianterreno
sono costituite da volte a botte; negli spessori murari sono stati
individuati pozzi di comunicazione con i livelli superiori e canalizzazioni
per cisterne. Il piano nobile presenta una più marcata caratterizzazione
degli spazi attraverso peculiari soluzioni adoperate nella tecnica muraria,
nelle volte e nelle aperture; al centro della sala principale (m 7,70 x
5,54) si apre una grande nicchia (sala cum miniano), dove si staglia il
profilo curvilineo dei piedritti e di un’arcata trasversa, posta
esattamente al contatto fra l’avancorpo occidentale e il parallelepipedo
del palazzo; le sale minori collegate a quella centrale sono sostanzialmente
diverse poiché quella a sud è un semplice vano rettangolare (m 4,70 x
7,10) mentre quella a nord si assimila ad un “iwan” sovrastato da una
rociera e desinente in una nicchia centrale con catino a muqarnas ed
in due laterali con calotte scanalate da fasce ombrelliformi.
Nell’angolo
nordorientale del complesso si trova una cappella orientata, divisa in tre
navate da pilastri rettangolari che sorreggono archi a sesto acuto;
l’edificio, in senso trasversale, si sviluppa in tre campate, con quella
più orientale introdotta da arcate e conclusa da absidi in asse con le
navate; le due campate occidentali della navata centrale sono coperte da
volta a crociera su base quadrata, sistema ribadito e sdoppiato nelle
rispettive campate dell’adiacente navatella destra; il santuario è
coperto da un rustico tetto ligneo che, spiovendo verso il muro delle
absidi, attualmente intercetta l’archivolto del catino centrale, soluzione
scaturita dal crollo dell’originaria copertura; sotto la campata
orientale, con dimensioni che si approssimano ad essa, si trova una cisterna
sormontata da una volta a botte; la datazione della cappella è tutt’oggi
materia controversa (Kronig 1977, XII secolo; Bellafiore 1990, Ciotta 1993,
post XII secolo).
Tra gli
oggetti mobili si segnalano rilievi, statuette e frammenti marmorei di
incerta provenienza, opere comunque databili dal XIII al XV secolo.
Tutte le
murature consistono di pietrame e di blocchi in arenaria e calcare ma,
soprattutto, le pristine strutture e le membrane di maggiore impegno
costruttivo sono connotate dalla diffusa utilizzazione di grossi mattoni in
laterizio, accorgimento tecnologico e figurativo adoperato anche nelle
fabbriche dei monasteri bizantini del Val Demone.
Ponte
Aureliano

Il Ponte
Aureliano, che si erge sul torrente Caronia, testimonia una importante
presenza romana di epoca tardo imperiale. L'arcata centrale è crollata. In
località Torre di Lauro vi è una torre
costiera (detta anche torre di passo del Lauro), sita
lungo il litorale.
Attestata per la prima volta nel 1583,
è oggi adibita ad abitazione privata.
Aveva superato tutte le avversità del tempo cronologico e del tempo
meteorologico, sembrava un gigante della storia, destinato a durare nel
tempo illimitatamente se lo spirito distruttivo della guerra non lo avesse
avvolto nelle sue spire per segnarne la fine. Il Ponte Romano sul Fiume
Caronia era una delle opere architettoniche più belle della provincia di
Messina, un’infrastruttura di grande utilità e di indescrivibile fascino.
Oggi del ponte resta ben poco, ma quanto basta per immaginarne la bellezza
originaria e per rivivere un pezzo di storia. Il ponte è a tre campate di
cui due sono ancora presenti, mentre quella centrale è scomparsa del tutto.
Un grande vuoto invade quella che per millenni era stata la sede
dell’arcata principale, un vuoto che si estende a tutta la valle, la
risale e raggiunge il cuore dei Caronesi. Dall’alto del centro nebroideo
la visone del ponte era sicuramente motivo di vanto storico ed economico
oltre che elemento rassicurante che conferiva fierezza e sicurezza a tutti
gli abitanti. La perdita della campata centrale in un certo senso ha segnato
l’inizio di un declino che ha coinvolto la vita del paese in tutte le sue
multiformi espressioni.
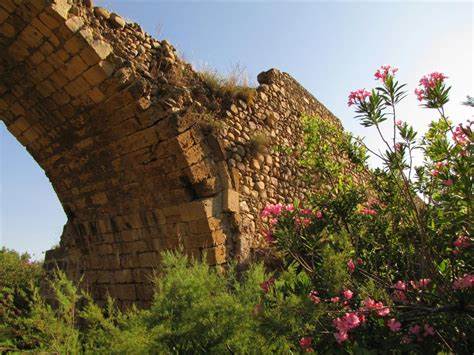 La campata della sponda di levante è quella
che versa in migliori condizioni e che permette di comprendere la bellezza
originaria della struttura, la sua architettura, lo stile e la tecnologia
utilizzati nella costruzione del ponte. Il ponte ovviamente è in muratura
di pietra, la sua struttura poggia su imponenti pilastri da cui, come ali
spiegate nel cielo, si innalzano le campate ad arco. Nella struttura del
ponte sono evidenti tre tipologie di pietre. La prima è costituita da
blocchi a forma di parallelepipedo, presumibilmente di travertino, di
evidente fattura antica, la seconda da pietrame di fiume di misura varia, in
parte squadrato, in parte utilizzato nella forma naturale, la terza da
blocchi di pietra arenaria, del tipo locale, reperita quindi sul posto, di
evidente fattura recente. Le tre tipologie di pietra occupano spazi e parti
differenti della struttura. Il travertino è presente negli archi, nelle
spalle, nelle volte, nei basamenti di protezione. La campata della sponda di levante è quella
che versa in migliori condizioni e che permette di comprendere la bellezza
originaria della struttura, la sua architettura, lo stile e la tecnologia
utilizzati nella costruzione del ponte. Il ponte ovviamente è in muratura
di pietra, la sua struttura poggia su imponenti pilastri da cui, come ali
spiegate nel cielo, si innalzano le campate ad arco. Nella struttura del
ponte sono evidenti tre tipologie di pietre. La prima è costituita da
blocchi a forma di parallelepipedo, presumibilmente di travertino, di
evidente fattura antica, la seconda da pietrame di fiume di misura varia, in
parte squadrato, in parte utilizzato nella forma naturale, la terza da
blocchi di pietra arenaria, del tipo locale, reperita quindi sul posto, di
evidente fattura recente. Le tre tipologie di pietra occupano spazi e parti
differenti della struttura. Il travertino è presente negli archi, nelle
spalle, nelle volte, nei basamenti di protezione.
La pietra di fiume
è presente nei piloni e nella formazione del segmento carrabile che si
appoggia sugli archi e sulle volte, con funzione più di riempimento che
portante. I blocchi di arenaria formano un plinto di fondazione, la cui
fattura sembra recente, aggiunto a sostegno del plinto originario, scavato
dalla erosine della corrente fluviale. Lo stile e l’architettura di questo
plinto testimoniano la sua presunta diversa epoca di realizzazione.
Il travertino non è una pietra locale, ma una pietra del Lazio,
ampiamente utilizzata nell’Impero Romano per la costruzione di grandi
opere architettoniche.
Magnifica
è la collocazione paesaggistica del ponte. Esso funge contemporaneamente da
ingresso per due realtà ambientali diverse e opposte ma entrambe
affascinanti. Guardando verso la costa il ponte apre il campo ottico verso
gli sconfinati orizzonti di un fantastico e azzurro Tirreno. Guardando verso
l’entroterra, invece, esso immette il visitatore all’interno di una
delle vallate più suggestive dei Nebrodi, la vallata del Torrente Caronia.
La sua posizione sembra quasi segnare il confine tra queste due differenti
nature. L’ambiente circostante il ponte è ricco di vegetazione
spontanea e di colture agricole.
Nel greto del fiume abbondano coloratissimi
oleandri e aromatici tamerici, entrambi confinati sulle sponde esterne, come
eleganti siepi naturali che fanno da cornice al passaggio dell’acqua.
Sulle attigue colline si estendono, invece, antichi uliveti e quello che
resta della coltivazione del limone. Il ponte, nonostante le sue gravi
mutilazioni, spicca in mezzo a questo giardino naturale come un antico
monumento di segreta bellezza.
Avvicinandosi ad esso e
osservandolo con attenzione il mistero delle sue sembianze è rivelato dai
grandi conci di pietra che ne compongono le strutture, ne disegnano le forme
e ne proiettano l’evoluzione tridimensionale completa. Le parti
ancora presenti, anche se ridotte a ruderi, lanciano nelle direzioni dello
spazio vuoto linee immaginarie che compongono le parti mancanti, completando
nella mente del visitatore la struttura originaria.

|