|
Il
centro abitato principale del comune, Castroreale, sorge sul colle Torace,
un rilievo dei monti Peloritani nord-occidentali ai cui piedi, presso le
sponde del torrente Longano, Gerone II re di Siracusa nel 265
a.C. sconfisse i Mamertini.
Il
tessuto urbano è d'impronta medievale con strade e viuzze strette e ripide,
lastricate con una caratteristica pavimentazione in pietra (jacatu nel
dialetto locale), che si aprono su piazze-belvedere dalle quali si può
godere dei molteplici panorami che si dispiegano tutt'intorno al paese.
La
cittadina fa parte del circuito dei borghi
più belli d'Italia.
Un
centro denominato Cristina o Crizzina risalente al periodo normanno-svevo
costituì l'insediamento originario del centro. I territori ricadevano
nella primitiva definizione del Vallo
di Milazzo.
Le
prime notizie storiche certe si rinvengono in un diploma datato 1324 con
cui il re di Sicilia Federico
III d'Aragona ordina la ricostruzione di un (preesistente)
castello. L'abitato che si sviluppò intorno al fortilizio venne
rinominato Castro (dal latino castrum= castello, fortezza) e in seguito
Castroreale (perché residenza preferita del re Federico III d'Aragona) e
rimase sempre città demaniale accrescendo nel corso dei secoli la propria
importanza, prosperità economica ed estensione territoriale grazie anche
alla posizione strategica che rivestiva sia nel sistema di fortificazioni
poste sul versante tirrenico a difesa della Piana di Milazzo che nel sistema
dei collegamenti con i centri fortificati del litorale ionico, tramite i
percorsi interni alla catena dei Peloritani.
Per
matrimoni combinati dettati da logiche dinastiche Federico
III d'Aragona è pronipote di Federico
II d'Hohenstaufen per ramo materno (quest'ultimo è pronipote di Ruggero
I d'Altavilla tramite la madre Costanza
d'Altavilla). A onta dei legami e vincoli di parentela tra esponenti
di case regnanti i toni nell'annosa disputa tra fazione
latina e catalana che
caratterizzano i Vespri
Siciliani, assumono caratteri aspri. A fomentare e complicare lo
scenario il casato di ceppo latino degli Angioini che
perora la causa nella prosecuzione dinastica dopo gli Altavilla e Hohenstaufen.
I
componenti di Casa
d'Aragona, invisi alla potentissima famiglia Chiaramonte,
sono costretti a dimorare nelle fedeli roccaforti di Messina e Catania, e
governare con sessioni itineranti del Parlamento
Siciliano tenute anche a Siracusa (1233, 1322, 1398), Milazzo
(1295), Randazzo (1366), Castronovo (1391), Taormina (1410), Caltagirone (1458), Cefalù (1774). In
questo tumultuoso contesto, grazie alla posizione geografica e al sistema
viario di cui è dotata, Castroreale funge da crocevia, cerniera fra la
pianura, le coste tirreniche, e l'ampia area etnea a mezzogiorno, offrendo
itinerari alternativi per le comunicazioni tra centri nevralgici del Regno.
In
ambito peloritano le baruffe tra contendenti degenerarono in guerra civile
grazie anche alle posizioni altalenanti di personalità che parteggiavano e
tramavano ora per l'una, ora per l'altra fazione. Negli anni successivi re Ludovico
di Sicilia inviò l'esercito regio contro i Chiaramonte,
sfidandoli sulla piana di Milazzo. Solo nel 1350 si arrivò a un compromesso
di pace. Dal 1352 con
l'assedio cittadino attuato da Enrico
III Rosso, ammiraglio ribellatosi alla corona, la situazione
cominciò a vacillare. Il breve regno di Ludovico culminò
con la morte del sovrano causa epidemia di peste nera. Le sorti della castellania e capitania di
Castroreale furono rette dalla vicaria abadessa Eufemia
d'Aragona, reggente del Regno a favore del fratello Federico
IV di Sicilia.
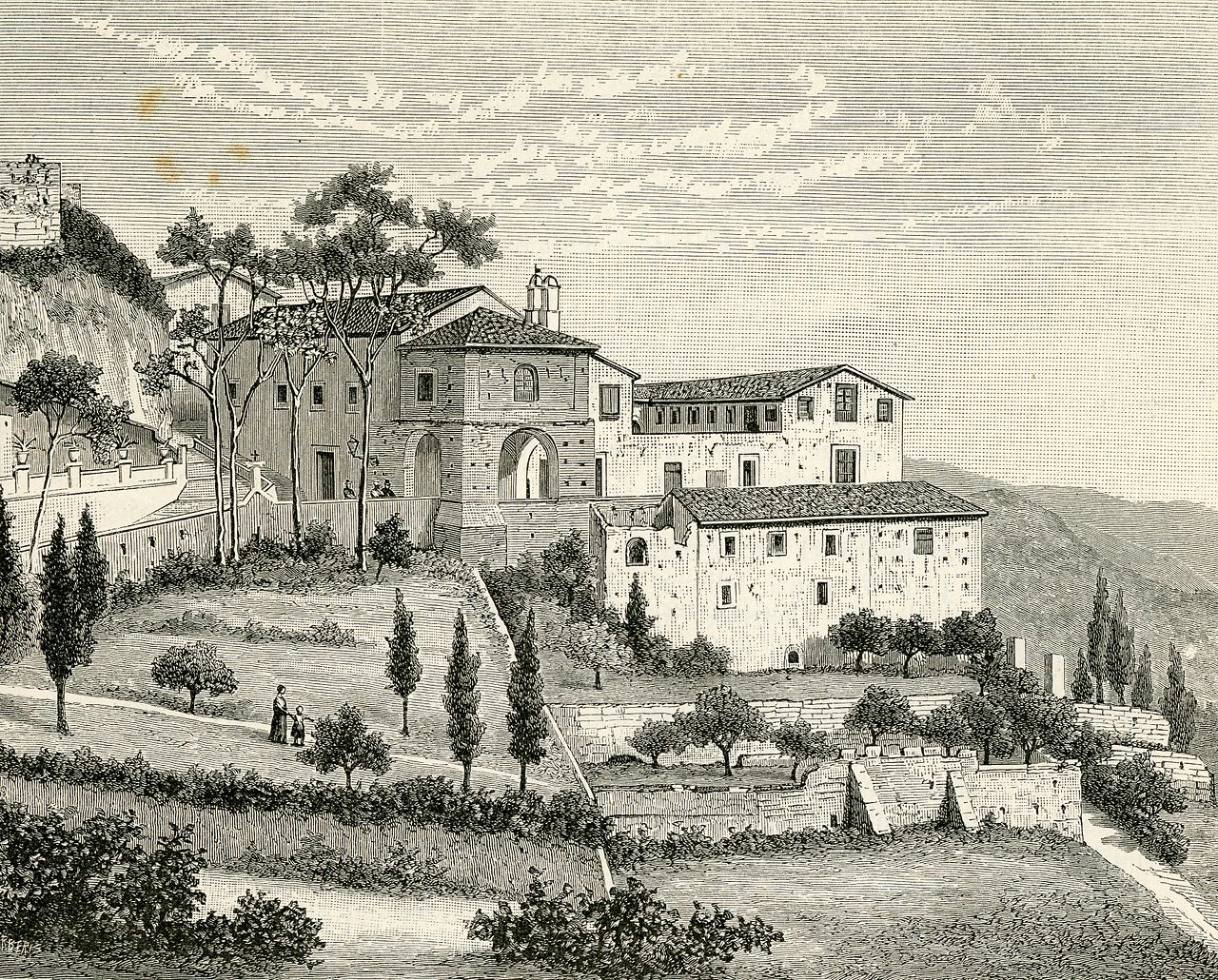
Le
tensioni tra Chiaramonte, Palizzi e Aragona, Alagona,
si allentarono solo con l'uccisione e morte del filo angioino Nicolò
Cesareo, e con esse si concluse la temporanea egemonia di Milazzo sugli
altri centri del Vallo (Monforte, Santa
Lucia), la castellania di Castroreale fu affidata a Vinciguerra
d'Aragona.
Per
l'impegno profuso alla causa aragonese la città fu insignita del titolo di Fedelissima.
Il rappresentante cittadino occupa il 37º posto nel Parlamento
siciliano.
Causa
epidemia di peste nel 1411 fallisce la sessione del Parlamento
siciliano indetta dalla vicaria Bianca
di Navarra, vedova di Martino
I di Sicilia, per la successione al trono, evento poi dirottato a Taormina.
Nel 1435 Alfonso
V d'Aragona il Magnanimo visita la cittadina per
ricambiare la generosità per l'aiuto ricevuto, consistente nell'invio di
contingenti armati intervenuti per osteggiare l'assedio di Tropea e
nell'attacco all'Isola
delle Gerbe. Per l'occasione il sovrano concede il permesso per la
realizzazione della «Fiera di Santa Maria Maddalena». Gli eventi si
inseriscono nel piano di contrasto delle scorrerie corsare e pirate che
imperversano nell'antistante specchio del Tirreno.
All'economia
del centro contribuì fino alla fine del XV
secolo un'attiva e numerosa comunità ebraica della cui sinagoga,
ampliata nel 1487, resta solo un arco moresco collocato oggi alle spalle del
Monte di Pietà. La cittadina annoverava una folta comunità ebraica,
documentata nel 1382, ma già ampiamente attestata nel XIII
secolo, gruppo sociale formato da cittadini operanti nella
macellazione delle carni e conceria delle pelli, nel lavoro di tintori
di tessuti e pellame, nel crescente sviluppo del settore agricolo e
nell'esercizio della professione medica.
Nel
periodo di transizione tra la Corona
d'Aragona con gli esponenti dei Trastámara e
la Casa
d'Asburgo - Castiglia,
diversi provvedimenti sanzionatori furono comminati dal papa
Callisto III d'intesa con il sovrano Alfonso
V d'Aragona, disposizioni volte a colpire le comunità ebraiche delle
vicine cittadine di Taormina, Savoca.
Le persecuzioni e le tragiche
espulsioni della comunità dalla città e dall'isola avvennero a
partire dal 18 giugno 1492 in ottemperanza dell'editto noto come Decreto
dell'Alhambra emanato da Ferdinando
il Cattolico e Isabella
di Castiglia.
Le
rappresentanze temporaneamente rifugiate nell'Italia meridionale, trovarono
protezione sotto Ferdinando
I di Napoli. Dal 31 marzo 1504 con Ferdinando
III, re
di Napoli, la condizione peggiorò. Il 23 novembre 1510 il sovrano
emise un ulteriore atto di espulsione da tutta l'Italia del Sud evitabile
solo con il pagamento di un consistente tributo. Nel maggio 1515 un altro
atto costrinse anche gli ebrei convertiti al cristianesimo ad abbandonare il
regno.

La
continua caccia ai fratelli Ishak, Elias, ʿArūj e Khayr
al-Din Barbarossa, al temibile Dragut,
sono eventi che anticipano la Conquista
di Tunisi e la trionfale campagna culminata con la Battaglia
di Lepanto.
Le
scorrerie su isole, coste e insediamenti interni, si susseguono a ritmi
incalzanti. Come si evince dal Registro delle attività militari
di Milazzo dell'anno 1554, per tale motivo la cittadina di Castroreale
insieme a quelle di Tripi, Montalbano, Novara
di Sicilia, Santa Lucia del Mela, Condrò, San Pier Niceto, Monforte San
Giorgio, Rometta, Rocca, Maurojanni, Venetico, Bauso, Saponara,
doveva inviare un contigente di milizie al Castello
di Milazzo e predisporre guardie lungo il litorale di
competenza. Infatti, all'avvistamento di imbarcazioni non identificate,
tanto nel golfo
di Patti che nel golfo
di Milazzo, il capitano d'armi
dava disposizioni al sergente
maggiore di fare segnali di fuoco e fumi, al castellano spettava
il compito di sparare tre colpi di cannone. Le procedure rientravano
nel complesso sistema d'azioni di prevenzione e difesa del territorio
attraverso la fitta rete di castelli e torri
d'avvistamento costiere e collinari.
Sul
finire del 1538 le truppe spagnole ammutinate lasciate a custodia de La
Goletta dopo la Presa
di Tunisi, si ribellarono per questioni di mancati pagamenti. Gran
parte delle guarnigioni abbandonarono il presidio e navigarono alla volta
della vicina Sicilia. A titolo preventivo, per motivi di sicurezza
furono confinati sull'isola di Lipari, ma contravvenendo alle disposizioni
impartite dal viceré
di Sicilia Ferrante
I Gonzaga, gli ammutinati sbarcarono a Messina per essere
immediatamente respinti. Dopo disordini provocati a Castania e Faro si
impossessarono e depredarono i centri di Monforte e Santa
Lucia del Mela, per poi commettere ulteriori razzie a Castroreale,
che a dispetto delle ingenti perdite, non sortirono l'effetto sperato per
l'inclemenza del tempo. Con il tentativo di mediazione svoltosi a Milazzo e
dopo il giuramento convenuto con il patto siglato a Linguaglossa,
nonostante i pagamenti effettuati a saldo dei compensi pattuiti, il viceré
chiamò in rassegna con pretesti vari i capi dei sediziosi, facendoli
strangolare rispettivamente a Messina, Militello, Vizzini, Lentini e
altre località. A quest'assalto sventato il 31 dicembre 1538 si attribuisce
l'intercessione e conseguente elezione a patrono cittadino di San Silvestro
Papa.
Città
demaniale con un vasto territorio, ottenne a partire dai sovrani
aragonesi numerosi privilegi che le consentirono di raggiungere e mantenere
una discreta floridezza economica. Subì il fascino e le contaminazioni
artistiche della vicina capitale del regno Messina,
con la quale condivise le prime espressioni dello stile rinascimentale introdotte
dalle varie correnti lombardo-ticinesi, veneto-dalmate, toscano-carraresi in
ambito architettonico, pittorico, scultoreo, e in tutte le multiformi
manifestazioni del genio artistico. La fase di avvicendamento tra case
regnanti (Aragona/Asburgo-Castiglia) fu periodo in cui la cittadina accolse
numerose comunità monastiche, le cui attività incisero profondamente sul
tessuto sociale, generando uno sviluppo edilizio e committenze artistiche
che mutarono profondamente la configurazione cittadina e l'arredo urbano.
Il viceré
di Sicilia Marcantonio
Colonna, con dispaccio datato Palermo 20 marzo 1579, concesse il
privilegio per la realizzazione di un caricatore nella marina di località
Cantoni, odierna Barcellona
Pozzo di Gotto. Tale struttura non fu mai realizzata. Nonostante
ciò gli intensi traffici e i commerci marittimi furono assicurati pur senza
strutture portuali idonee e fabbricati adibiti a magazzini, sfruttando lo
stazionamento delle navi mercantili al largo e l'imbarco di merci e
passeggeri per il tramite di scialuppe. Con la nuova suddivisione
amministrativa del territorio del Regno attuata dallo stesso viceré, il 13
aprile 1583, è istituita la «Comarca
di Castroreale» in Val
Demone. Con un impianto d'impronta militare, ma ingentilita da
dettami e stilemi che spaziano dall'aragonese alle infinite sfumature di
stili di matrice iberica, dal rinascimento al nascente barocco,
il centro non fu indenne da periodiche carestie, immancabilmente
accompagnate da mortifere epidemie, da sporadici eventi militari, il tutto
costellato da una consistente serie di eventi
sismici che hanno messo a dura prova il fortissimo spirito
comunitario, quanto il fragile sistema ambientale.

1465 - 1522 - 1615.
Nel contesto appena più ampio si registra una politica di arrogante
vessazione fatta di scontri, animosità, dissidi, compromessi, fra i
governatori di stanza a Milazzo e gli amministratori dei territori
adiacenti. Litigiosità e acredini fondati sulla corruzione dilagante, la
sottomissione e il perenne ricatto, elementi che condussero a definire
l'atto di divisione delle terre fra Milazzo e Castroreale, evento che
coinvolse territorialmente la vicina Santa Lucia, determinò la costituzione
della città e del territorio di Pozzo
di Gotto, tutti segnali premonitori delle frequenti rivolte
antispagnole culminate con gli eventi del 1674 e 1678.
1717,
22 aprile. Terremoto con
effetti distruttivi in città e nell'immediato circondario.
Dal 1718 al 1720 come
comarca e futuro distretto, il territorio è teatro di numerosi scontri
culminati con la Battaglia
di Milazzo e quella di
Francavilla, combattimenti inseriti nel contesto dei conflitti contro
la Quadruplice
alleanza combattuti dal regno di Spagna contro Inghilterra, Francia, Austria e Paesi
Bassi per il predominio sul mar
Mediterraneo.
Nel
1812 come capoluogo di distretto, Castroreale annovera
il circondario medesimo e quelli di Barcellona, Francavilla, Novara, Savoca,
Taormina comprende 26 comuni e
36 villaggi.
Il territorio spazia dal Tirreno allo Jonio,
comprende gli ultimi rilievi dei Peloritani che fronteggiano i Nebrodi,
a sud è delimitato dalla riva sinistra del fiume
Alcantara. Pertanto fu sede di importanti uffici sino alla metà
circa del XIX
secolo.
Tuttavia
già nel corso dell'Ottocento inizia la decadenza con l'impoverimento
economico e demografico della parte montana del territorio; il processo di
disgregazione territoriale che ne è conseguito ha dato luogo alla
costituzione nel 1815 del
comune di Barcellona,
in seguito unito alla vicinissima città di Pozzo
di Gotto, unione amministrativa volta a formare un'unica grande
conurbazione.
Completano
la frammentazione del territorio l'istituzione delle unità amministrative
di Rodì
Milici nel 1947 e
di Terme
Vigliatore nel 1966.
Negli
anni molta importanza ha rivestito la presenza dell'Istituto Magistrale XXIV
Maggio, l'unico istituto magistrale statale della provincia di Messina oltre
all'Ainis e al Bisazza della città, celebre per la sua serietà, che ha
attirato a Castroreale numerosi docenti e allievi, residenti o pendolari
dalle zone vicine.
2008.
11 dicembre. Sono stati registrati 320 mm di pioggia in città e 254 mm
a Barcellona, le precipitazioni determinano l'esondazione del torrente
Longano a valle.
2011.
22 novembre. La pioggia è caduta incessantemente per 11 ore, dalle prime
ore del giorno fino alle 15:00, con quantitativi cumulati di 351 mm in
città (record storico giornaliero, per il comune) e di 208 mm a
Barcellona. Esondazione del torrente Longano e alluvione dei territori a
valle.
Visitare
il borgo

Il
paese conta meno di 3000 anime e il suo antico splendore si riverbera ancora
tra le sue vie e le sue mura, coinvolgendo i visitatori in un'atmosfera
medievale davvero indimenticabile.
Il territorio
di Castroreale è denso di storia e leggende avvincenti. Una di queste
narra che una primitiva versione di Castroreale fu fondata da un re
proveniente dal Medio Oriente, Artenomo, il quale costruì nella zona dove
oggi sorge l'attuale borgo una città dedicata alla figlia, Artemisia. Il
nucleo divenne poi un insediamento dal nome Kastros, per volere dello sposo
della stessa Artemisia, Castroreo: nome poi declinato in Crastina e in
seguito Cristina.
Le
prime notizie storiche certe del borgo risalgono però al XIV
secolo, quando il paese assunse importanza storica e strategica in seguito
agli ampliamenti voluti da Federico II d’Aragona: egli ordinò qui la
costruzione di un castello, attorno al quale prese vita un nucleo
fortificato rinominato Castro, dal latino castrum, in seguito chiamato
Castroreale. Il borgo di Castroreale conobbe nei secoli momenti di
prestigio ed una notevole prosperità economica, artistica e culturale,
passando di mano in mano tra le popolazioni che qui vissero e lasciarono
tracce ancora oggi visibili: tra di esse arabi, normanni, aragonesi,
spagnoli e borboni. Le ricche vicende che hanno coinvolto Castroreale lo
portano ad essere oggi un piccolo gioiello della Sicilia, che svetta fiero
affacciato sulle vallate che lo circondano lambendo il Tirreno.
Molti
sono gli edifici religiosi che caratterizzano Castroreale, simboli di
una fede fortemente sentita dalla popolazione locale di ieri, e di oggi.
Sono proprio i luoghi di culto ad essere spesso simboli e narratori silenti
delle vicende storiche di un territorio, e le chiese di Castroreale
raccontano parecchio dell’autenticità del paese. Il Duomo di
Santa Maria Assunta, o Duomo di Castroreale, è la costruzione religiosa
principale del borgo, e risale al secolo XV. E’ splendida la sua facciata
con portale marmoreo, fiancheggiata dall’adiacente Torre Campanaria. Al
suo interno vengono custodite opere davvero degne di nota, come ad esempio
le magnifiche sculture in marmo di artisti quali Antonello Gagini e Rinaldo
Bonanno, o i dipinti cinquecenteschi di Criscuolo. Completano gli interni di
pregio della chiesa la sua ricca fonte battesimale in marmo, ed il pavimento
marmoreo con tracciata una delle sette meridiane costruite in Sicilia nel
corso del XIX secolo: quella ospitata nel duomo in particolare è una
meridiana a camera oscura opera di Nicolò Perroni Basquez, realizzata nel
1854. Il Duomo si affaccia inoltre sulla splendida Piazza delle
Aquile, imperdibile belvedere del paese.

La Chiesa
di S. Agata non è di minore bellezza e importanza. Basti pensare
che qui è conservato il gruppo marmoreo dell’Annunciazione, pregevole
opera di Antonello Gagini del 1519, oltre che il simulacro in cartapesta del
Santissimo Crocifisso, conosciuto anche come Cristo Lungo o U Signuri Longu
in dialetto locale. Risalente al XVII secolo, il simulacro è portato in
processione tre volte l’anno ed è considerato con immenso rispetto e
venerazione dagli abitanti del paese.
Da
vedere anche la Chiesa della Candelora, meravigliosa opera
trecentesca, custode di opere di grande valore artistico come la Tribuna di
legno e oro zecchino opera di Giovanni Siracusano. Meritano una visita anche
la Chiesa di Santa Maria del Gesù, risalente al 1424, e l’annesso convento
francescano dell’Ordine dei Frati Minori Osservanti, oltre che la Chiesa
del Santissimo Salvatore del XV secolo e la Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, databile nel 1566.
Per
quanto riguarda le architetture civili di Castroreale, quella di
maggior interesse è la Torre di Federico II, un’imponente
fortificazione, parte di ciò che oggi resta dell’antico Castello di
Castroreale, voluto da federico D’Aragona. Il Palazzo Peculio
inoltre è l’elegante sede del Comune e fu eretto nel 1924 sul perimetro
del vecchio Peculio Frumentario che fungeva da deposito per le derrate
alimentari. Su piazza Peculio si affaccia anche il Monte di Pietà,
fondato nel 1581. Non mancano a Castroreale i musei, come ad esempio il Museo
Civico ospitato nell’ex Convento dei Filippini, che conserva numerose
opere d’arte, e la Pinacoteca di Santa Maria degli Angeli,
allestita nei locali della chiesa omonima, dove si conservano quadri e
sculture dal Trecento al Settecento. Una delle principali attrazioni di
Castroreale è poi il suo meraviglioso Planetario, realizzato
dall’associazione Andromeda nell’ambito di un magistrale intervento di
promozione turistica del territorio. Un planetario astronomico digitale,
situato proprio nel cuore del paese e fondato da un gruppo di astrofili
entusiasti guidati dal presidente Paolo Faranda, con l’obiettivo divulgare
la scienza e l’astronomia.
Si
tratta di un simulatore della volta celeste che proietta su una
cupola una fedele ricostruzione della cielo e dei suoi abitanti, ricostruita
con immagini reali. Aiutati dagli esperti operatori del planetario è
possibile riconoscere osservare corpi celesti e riconoscere le principali
costellazioni, oltre che osservare il cielo come si presentava migliaia di
anni fa o come apparirà in futuro. Si può inoltre scoprire come si vede il
cielo osservato da diversi punti della terra, come all’equatore, al polo
nord o al polo sud, ed esplorarne tutti i segreti. Un’esperienza unica,
che in pochi istanti riesce a fare completamente dimenticare di essere
chiusi in una stanza, e proietta invece con il cuore e la fantasia verso l’universo
più affascinante e misterioso.
Duomo
di Santa Maria Assunta

Il Duomo
di Castroreale o Duomo di Santa Maria Assunta, sorge in piazza
Duomo e il prospetto principale si affaccia su piazza Duomo e Corso Umberto
I.
Nella
struttura sono identificabili innumerevoli ricostruzioni, ristrutturazioni,
ampliamenti, restauri, migliorie apportate nel corso dei secoli ma, è
spesso difficile risalire alle cause che hanno determinato tali interventi.
L'edificio è un monumento longevo,
ubicato in un contesto intriso di storia millenaria.
A
parte rari e lievi eventi bellici o imprevedibili incendi di carattere
prettamente locale, la stragrande maggioranza delle calamità che hanno
interessato il centro abitato di Castroreale è
costituita da eventi
sismici che nel corso dei secoli hanno interessato vasti
comprensori o province o zone della Sicilia,
molte volte estese aree dell'Italia
meridionale. Nello scorso millennio nell'isola
sono stati documentati decine di terremoti distruttivi, quello del 22 aprile 1717 ad
esempio, è conosciuto proprio come terremoto di Castroreale,
pertanto navate, absidi, campanili e manufatti per quanto massicci, sono
stati continuamente sottoposti a sollecitazioni e crolli.
Le
fonti non sempre provate e certificate, quasi sempre ad appannaggio di soli
cronisti storici nobiliari o d'istituzioni religiose, limitate
territorialmente, andavano sistematicamente perdute a ogni disastro.
Anche
i vari contagi ed epidemie di peste e colera caratterizzano nel tempo molti
aspetti religiosi e sociali della vita cittadina, eventi che si inseriscono
in un contesto più ampio di quello costituito dalla sola realtà locale.
Per
gli storici locali il titolo di "Chiesa Madre" deriva dalla chiesa
di Gesù e Maria, luogo di culto trecentesco eretto entro le mura
della città col titolo di San Nicolò, sede dell'omonima
"Confraternita di Gesù e Maria".
Sulla
data di avvio dei lavori della sua costruzione gravano molte incertezze per
la mancanza di notizie fondate e documentate, è certamente anteriore al 1400.
Infatti, sulla controfacciata è
incastonata l'arcata absidale a sesto acuto dell'edificio quattrocentesco
originariamente orientato in senso inverso rispetto alla costruzione
seicentesca. Dedicato a Santa
Maria Assunta, fu ricostruito tra la fine del XVII e l'inizio XVIII
secolo su modello della cattedrale
di Messina. Maestranze messinesi sull'impronta e dettami di Giovanni
Angelo Montorsoli, traducono le cappelle marmoree del tempio
peloritano, in un altrettanto splendido esempio, qui realizzato in tufo
locale dalle calde tonalità ambrate.
I
lavori riguardanti il ribaltamento dell'asse abside - prospetto si
collocano a ridosso di due disastrosi terremoti: quello del 25 agosto 1613 conosciuto
come "terremoto di Naso"
che ha interessato l'intera costa settentrionale messinese e il sisma noto
come terremoto
della Calabria del 27 marzo 1638.

Dopo
il terremoto
del Val di Noto del 1693 i lavori di restauro assumono
connotazioni e contaminazioni di stile tardo barocco come la gran parte
delle costruzioni cittadine. Col sisma conosciuto come terremoto
della Calabria meridionale del 1783 tutto il patrimonio
artistico della giurisdizione di Castroreale, compreso il casale di
Barcellona e della vicina Pozzo di Gotto, subisce notevoli danni,
nell'archivio parrocchiale dell'arcipretura del tempo della chiesa
di San Vito per il tragico evento è spesso citata l'espressione
di "violenti, continui e distruttivi tremuoti". In seguito al
terremoto del 1783 molti
abitanti preferirono trasferirsi sulla costa, l'evento dettò l'inizio di
una lenta decadenza del centro aggravata dalla perdita progressiva di
territorio in seguito all'acquisizione dell'autonomia da parte dei comuni di Barcellona
Pozzo di Gotto (1815), Rodì
Milici (1947)
e Terme
Vigliatore (1966).
Il terremoto
della Calabria meridionale del 1894 è documentato, si salvano
dai crolli il pavimento e la meridiana su essa tracciata ma, il resoconto
trascura di dettagliare tutto il resto. In una foto storica del 1903 il
campanile presenta un quarto ordine semidiruto, oggi inesistente, inoltre la crociera e
il presbiterio occupano
volumetricamente il doppio dello spazio absidale attuale, con tamburo
ottagonale e copertura in tegole d'altezza superiore a quella dell'attuale transetto.
La chiesa subisce le gravissime offese del terremoto
di Messina del 1908 che comportano la ricostruzione del nuovo
corpo absidale e del transetto che sono completamente riedificati.
1932,
24 agosto. Consacrazione del tempio ricostruito, rito presieduto dal
delegato Luigi
Bensaia in rappresentanza dell'arcivescovo e archimandrita Angelo
Paino.
Il
sisma del 16 aprile 1978 del Golfo
di Patti procura altri gravi danni che comportano una lunga
chiusura per urgenti lavori di consolidamento seguiti da una radicale opera
di restauro che riconsegnano il duomo alla bellezza originale.
2004,
27 giugno. Nuova consacrazione e dedicazione del tempio, rito presieduto da Giovanni
Marra.
Odierni
eventi filatelici mostrano,
attraverso raccolte di cartoline illustrate,
i mutamenti della fisionomia del monumento nei vari decenni. L'interno del
duomo, anteriormente il sisma del 1908, si presenta con la successione
dell'arco trionfale e quello absidale che racchiude un vasto vano occupato
dall'altare maggiore sovrastato da un esteso dipinto racchiuso in una
fastosa cornice lignea: Assunzione della Vergine, di Antonino
Alberti detto il «Barbalonga», opera perduta a causa del sisma
(quadro documentato nella chiesa di Gesù e Maria). Istantanee
post-terremoto immortalano un tozzo campanile a due ordini sormontato da una
cella campanaria aperta e coronata da una cinta di merli,
per cui si deduce che l'attuale terzo ordine è stato ricostruito a
posteriori, abbandonando l'idea di ripristinare il primitivo quarto ordine
già gravemente compromesso. Altre immagini mostrano un corpo ecclesiale
tronco alle sole navate, dal quale si evince che le attuali aree del
transetto e dell'abside sono state riedificate solo in epoca contemporanea.
 PROSPETTO
- Facciata tipica
del manierismo con
decorazioni di stile classico e barocco.
Il lato destro è occupato dalla massiccia mole del campanile che occupa
parzialmente la piccola spianata frontale, sulla sinistra è presente un
poderoso e animato contrafforte.
La facciata è incentrata su un maestoso portale marmoreo,
una breve scalinata consente l'accesso attraverso l'unica porta del prospetto principale. PROSPETTO
- Facciata tipica
del manierismo con
decorazioni di stile classico e barocco.
Il lato destro è occupato dalla massiccia mole del campanile che occupa
parzialmente la piccola spianata frontale, sulla sinistra è presente un
poderoso e animato contrafforte.
La facciata è incentrata su un maestoso portale marmoreo,
una breve scalinata consente l'accesso attraverso l'unica porta del prospetto principale.
La cornice
interna del portale è sormontata da architrave festonato con testa d'angelo
alata. Un fregio centrale
sostenuto da putti reca l'iscrizione "MONSTRA TE ESSE MATREM
MDCCXXV" (1725).
Sotto
l'elaborato cornicione è
incastonata una targa posta sotto il regno di Filippo
IV di Spagna MDCXXXIII (1633).
Colonne ioniche dai capitelli corinzi reggono
un doppio timpano sovrapposto,
la parte aggettante spezzata e simmetrica ad arco. Le sime reggono
due figure femminili col corpo reclinato e lo sguardo rivolto al centro
della facciata.
La fascia
del frontone reca
l'iscrizione "SANCTA MARIA ADVOCATA POPULI CASTRENSIS ORA PRO
NOBIS". All'interno del timpano spezzato una coppia di erme con
volti maschili sostiene una trave con
testa d'angelo scolpita, a sua volta sormontata da timpano ad arco intero
con vasi inghirlandati di frutta posti sugli spioventi. Sopra una targa
riportante la data MDCCLXXVI (1776)
è collocato uno stemma coronato
con putti e
motivi a foglie d'acanto recante
la dicitura "SPES NOSTRA SALVE".
Al centro,
la nicchia con volta a
conchiglia, ospita la statua della Vergine su un basamento d'angeli alati.
Il contrafforte richiama il caratteristico cornicione mistilineo con lobo
centrale sormontato da croce con banderuola, pinnacolo piramidale
sul lato estremo a sinistra.
Nella
controfacciata è incassato l'arco
a sesto acuto dell'antica abside,
chiaro segnale dal quale si evince il ribaltamento degli ambienti altare
maggiore e ingresso principale. Sopra l'arco
a sesto acuto è presente un elaborato stemma raffigurante aquila
reale.
Controfacciata
destra - Fonte
battesimale del 1634 di autore ignoto, collocato dentro una
nicchia con volta a conchiglia, simbolo allegorico del pellegrinaggio inteso
come cammino sacramentale terreno che nel sacramento del battesimo trova
la sua prima tappa. Posto logisticamente all'ingresso del tempio perché
costituisce la "porta" dei Sacramenti che introduce nella comunità.
Manufatto decorato e intarsiato in marmi policromi sormontato dalla
statuetta raffigurante San
Giovanni Battista.
- Accanto
alla seconda colonna, acquasantiera marmorea
opera di Antonello
Gagini commissionata nel 1530 e
consegnata nel 1534.
- Cappella
delle Sante Reliquie con accesso ubicato accanto al primo altare
della navata destra ma, inglobata nel vano terra del campanile. L'ambiente
presenta un altare con paliotto settecentesco
sormontato da Crocifisso in legno policromo della stessa epoca e
una vetrina contenente reliquie dei Santi.
Controfacciata
sinistra - Monumento commemorativo
posteriore al 1869 in
stile neoclassico,
in memoria di Antonino
Donato dei Baroni di Migliardo,
deputato al Parlamento
Siciliano.
- Accanto
alla seconda colonna, acquasantiera marmorea
opera di Sebastiano
Ferrara del 1629,
scolpita ad imitazione di quella del Gagini.
- Altare
dedicato al patrono San
Silvestro Papa, statua in stucco policromo inizi 1900.
 NAVATA
CENTRALE - L'impianto
è a croce
latina con ampia navata centrale e copertura a capriate.
L'aula è articolata in tre navate divise da sedici colonne culminanti con
variegati capitelli
corinzi sui quali poggiano e si aprono sette grandi archi
a tutto sesto su ogni lato, lungo le pareti di ciascuna navata
minore sono disposti sei altari e un ingresso laterale. Peculiarità
dell'impianto ecclesiale è la presenza di un cornicione in
pietra locale sulle pareti laterali interne, manufatto sorretto da pilastri
paraste scanalati
con capitelli corinzi atto a formare delle navatelle ad arco poco profonde,
dove sono incassati gli altari minori. Entrambe le composizioni sono
finemente e riccamente decorate con fregi floreali, antropomorfi e
geometrici in rilievo; sui contrafforti sono presenti numerosi vasi
ornamentali e stemmi di casate nobiliari o famiglie illustri. NAVATA
CENTRALE - L'impianto
è a croce
latina con ampia navata centrale e copertura a capriate.
L'aula è articolata in tre navate divise da sedici colonne culminanti con
variegati capitelli
corinzi sui quali poggiano e si aprono sette grandi archi
a tutto sesto su ogni lato, lungo le pareti di ciascuna navata
minore sono disposti sei altari e un ingresso laterale. Peculiarità
dell'impianto ecclesiale è la presenza di un cornicione in
pietra locale sulle pareti laterali interne, manufatto sorretto da pilastri
paraste scanalati
con capitelli corinzi atto a formare delle navatelle ad arco poco profonde,
dove sono incassati gli altari minori. Entrambe le composizioni sono
finemente e riccamente decorate con fregi floreali, antropomorfi e
geometrici in rilievo; sui contrafforti sono presenti numerosi vasi
ornamentali e stemmi di casate nobiliari o famiglie illustri.
In
prossimità delle ultime arcate a ridosso del grande arco del transetto, sul
lato destro è possibile ammirare un pregevole pergamo marmoreo
del 1646,
commissionato dai Giurati di Castroreale sul modello cinquecentesco di Andrea
Calamech documentato nel duomo
di Messina. Al centro dei lati del capitello corinzio sono riprodotti
i volti dei quattro Evangelisti (verosimilmente i volti di eresiarchi: Maometto, Giovanni
Calvino, Martin
Lutero, Zuinglio),
lungo la stele raffinatissimi
motivi floreali e antropomorfi, nei riquadri dell'ottagono della
navicella del pulpito,
scolpite sugli intarsi delle formelle in marmo, le figure della Vergine,
di santi e sante. Nelle immediate vicinanze, su una penisola aggiunta al
pavimento del transetto, è sistemato l'ambone di
moderna fattura. Nella campata diametralmente opposta è collocata la cattedra.
NAVATA
DESTRA - LATO EST
- Prima
campata: Altare della Madonna del Rosario. Sull'altare la pala del
pittore castrense Filippo
Jannelli datata 1655.
Dipinto raffigurante la Madonna
del Rosario ritratta fra San
Domenico, Santa Caterina da Siena, i Santi
Cosma e Damiano e San
Cono Abate.
- Seconda campata: Altare di San Giacomo Maggiore. Sulla mensa è
collocata la statua di San
Giacomo Maggiore attribuita allo scultore carrarese Andrea
Calamech, artista attivo a Messina e
provincia dal 1565 al 1589,
opera proveniente dalla chiesa dell'Annunziata. Trasferita nella chiesa di
San Nicolò nel 1872, fu collocata in questa sede nel 1919.
- Terza
campata: Altare di San Domenico. Costituisce pala d'altare il quadro
centinato su tela suddiviso da cornici dorate, dipinto raffigurante San
Domenico ispirato all'evento miracoloso avvenuto a Soriano
Calabro, con episodi della vita del Predicatore e il Padre
Eterno, opera di un pittore locale del 1622.
Opera proveniente dalla chiesa di San Vito dopo il terremoto del 1908.
- Quarta
campata: Ingresso laterale lato est corrispondente al belvedere di Piazza
delle Aquile. All'ingresso è presente un'acquasantiera in
stile manieristico del 1625,
opera dell'artista genovese Sebastiano
Ferrara.
- Quinta
campata: Altare di Tutti i Santi. Sull'altare campeggia la pala
centinata raffigurante Tutti
i Santi, dipinto su tavola attribuito allo spagnolo Francesco
Roviale e al messinese Jacopo
Vignerio, allievi di Polidoro
da Caravaggio, entrambi artisti documentati a Messina intorno al 1535.
L'elaborata cornice lignea è opera di Giuseppe Parisi del 1722,
opera proveniente dalla chiesa del Santissimo Salvatore.
- Sesta
campata: Altare di San Pietro. Sulla mensa è collocata la statua
marmorea di San
Pietro del 1586,
opera dello scultore manierista Rinaldo
Bonanno, proveniente dalla chiesa di San Pietro.
- Settima
campata: Altare delle Anime del Purgatorio. Sull'altare la pala
raffigurante le Anime Purganti, opera attribuita a Filippo
Jannelli e databile al 1660.


NAVATA
SINISTRA - LATO OVEST
- Prima
campata: Altare della Madonna dei Miracoli. Pala d'altare del pittore Gaspare
Camarda datata 1629 raffigurante
la Madonna
dei Miracoli ritratta fra San
Placido e San
Francesco di Paola.
- Seconda
campata: Altare di Santa Caterina d'Alessandria. Sulla mensa è
collocata la statua raffigurante Santa
Caterina d'Alessandria, lo scanello reca
tre storie del martirio in rilievo. Opera di Antonello
Gagini del 1534,
proveniente dalla chiesa di San Nicolò.
- Terza
campata: Altare della Pietà. Costituisce pala d'altare il quadro
centinato su tela raffigurante la Pietà nel pannello centrale, il Transito
di San Giuseppe e Storie della Passione nei pannelli laterali
e nella predella,
il pannello centrale fu dipinto nel 1603 dall'artista castrense Francesco
Cardillo, artista attivo a Messina nei primi anni del XVII secolo.
-
- Quarta
campata: Ingresso laterale lato ovest. All'ingresso è presente un'acquasantiera in
stile manieristico del 1625,
opera dell'artista genovese Sebastiano
Ferrara.
- Quinta
campata: Altare della Dormitio Virginis. Sull'altare è collocato il
dipinto su tavola dei primi decenni XVI secolo, opera d'artista di cultura
bizantineggiante (Dormitio
Virginis) e un artista formatosi alla bottega di Antonello
da Messina. Nelle cimase sono
riprodotti l'Incoronazione
della Vergine, l'Arcangelo
Gabriele, la Vergine
Annunziata. Dipinto documentato nella chiesa di Gesù e Maria.
- Sesta
campata: Altare di Santa Maria di Gesù. Sulla mensa è collocata la
statua raffigurante Santa Maria di Gesù (1500 - 1501)
dello scultore Antonello
Gagini, opera giovanile proveniente dal convento dell'Ordine
dei frati minori osservanti di Santa Maria del Gesù.
- Settima campata: Altare della Madonna degli Agonizzanti. Sull'altare
è collocato il dipinto su tela raffigurante la Madonna degli
Agonizzanti, opera autografa di Filippo
Jannelli datata 1680.


TRANSETTO
Absidiola
navata destra: Cappella dell'Assunta. Artistico altare con sei
colonne sormontate da cupola sovrastata da aquila, all'interno è collocato
il simulacro raffigurante la Madonna
Assunta, opera di Matteo
Mancuso del 1848,
artista messinese sepolto nello stesso duomo.
-
Transetto destro: Cappella della Vergine e Polittico di San
Nicolò. Sull'altare il polittico raffigurante la Madonna in trono ritratta
tra San
Pietro e San
Nicolò nel registro principale, La Pietà tra San
Girolamo e Sant'Agostino nel
registro superiore, e l'Apostolato (Evangelizzazione)
incompleto nella predella, opera d'ignoto. L'autore è stato definito il
"Maestro del Polittico di Castroreale", attivo a Messina nel 1630.
che attua una fusione di elementi di cultura Antonelliana ed elementi di
cultura lombarda. Opera proveniente dalla chiesa di San Nicolò.
Absidiola
navata sinistra: Cappella del Santissimo Sacramento. Altare
marmoreo con tabernacolo ligneo dedicato al Santissimo
Sacramento proveniente dalla chiesa di Santa Maria dei Martiri
dell'Ordine
benedettino, oggi distrutta. Bellissima opera lignea raffigurante il
prospetto di un tempio con colonne e capitelli. Nei vani laterali le
pregevoli statuette raffiguranti gli apostoli San
Pietro e San
Paolo, il primo identificabile per la chiave, il secondo dai
trascorsi guerrieri per la spada. Nella nicchia centrale è collocato il
tabernacolo. Tre cupole coronano il manufatto dalle estese decorazioni in oro
zecchino che richiamano alla mente la fastosa e grandiosa
tribuna lignea custodita nella vicina chiesa
della Candelora.
-
Transetto sinistro: Cappella della Natività. Sull'altare dedicato alla Natività
di Gesù domina il polittico raffigurante la Natività tra San
Francesco d'Assisi e San
Giovanni Battista nel registro principale, l'Annunciazione riprodotta
nei due tondi, il Padre
Eterno nella lunetta e l'Apostolato nella predella. Autore Giovanni
Filippo Criscuolo e bottega del 1550,
dipinto commissionato da monsignor Ottaviano
Preconio per la chiesa della Santissima Annunziata dell'Ordine
dei frati minori conventuali. Uno dei pannelli della predella,
mancante dal 1731, fu ripristinato da Michele
Panebianco. Trasferito nel 1872 nella chiesa
di Santa Maria degli Angeli fu collocato in questa sede
nell'anno 2000.


ALTARE
MAGGIORE .- L'altare versus populum occupa la parte centrale
del transetto, il paliotto del 1754 eseguito
dall'artista barcellonese Melchiorre
Greco proviene dall'Altare di San Giovanni Battista della chiesa
del Santissimo Salvatore. Sotto l'arcata absidale in posizione più
elevata l'altare maggiore in marmi policromi, ai lati due volute o
riccioli con statue allegoriche della Fede e
della Speranza,
al centro l'elegante tosello o edicola riproducente
un tempietto circolare colonnato sormontato da una artistica corona
marmorea. Il Crocifisso sull'altare è attribuibile al messinese Gerobino
Pilli, artista attivo alla fine del XV e l'inizio del XVI secolo,
opera proveniente dalla chiesa
di Santa Marina.
CORO
- La cantoria o
tribuna intagliata, il prospetto dell'antico organo e
il coro in
legno di noce a doppio ordine di stalli occupano
i tre lati del vano absidale. Il coro, riferisce Gioacchino
di Marzo è opera di Giorgio
Veneto (Georgivs Venetvs), autore tra l'altro della
medesima installazione nella basilica
cattedrale protometropolitana della Santa Vergine Maria Assunta di Messina.
Intagli e statuette della cantoria parzialmente reintegrati e ricollocati
dopo il terremoto del 1908, tra essi spicca la figura centrale
dell'Onnipotente benedicente nell'atto di reggere in mano le sorti del Mondo
e dell'Universo. Tutti e tre gli elementi cantoria, coro, organo concorrono
oltre ad arredare l'abside,
a creare l'insieme della complessa scenografia che costituisce l'intero
altare maggiore.
ORGANO
A CANNE - Anche lo strumento musicale subisce i danni delle calamità,
ricostruito sul modello dell'antica cassa lignea risalente al 1612 ad
opera del maestro organaro Giovanni
Vito Adragna, già rimaneggiato e ampliato nel XIX secolo, subisce le
distruzioni del terremoto del 1908, ad eccezione del prospetto anteriore.
Fino al 1998 il monumentale manufatto era addossato alla controfacciata
occultando l'arco trionfale della costruzione medievale. Pochi
documenti storici scampati alla distruzione permettono di ricostruire lo
strumento con le caratteristiche basilari quali dovevano essere nel 1612,
cioè di uno strumento di base 16' e quindi di potenza sonora notevole ma,
di ampliarlo dotandolo di 2 tastiere e di estensione do1 – fa5 (54 tasti).
 PROSPETTO
DI LEVANTE - All'estrema sinistra a sud è presente la mole del
campanile, a destra le mura esterne del transetto e dell'abside. Al centro
un grazioso portale marmoreo, la cornice interna del portale è sormontata
da architrave con testa d'angelo alata. Un fregio centrale reca l'iscrizione
"MONSTRA TE ESSE MATREM" fra festoni di frutta e colombe. Sopra
l'elaborato cornicione è incastonata una targa posta sotto il regno di Filippo
IV di Spagna MDCXXVIII (1628). Colonne doriche dai capitelli
corinzi reggono un timpano spezzato, simmetrico ad arco. Sopra
gli spioventi sono murati stemmi con aquile dalle ali dispiegate, due volute
simmetriche fanno ala ad una mensola incassata dove poggia, protetta da una
nicchia spartana, una Vergine Coronata orante poggiante sulle teste di tre
putti alati e una mezzaluna, identificabile con l'Immacolata
Concezione. PROSPETTO
DI LEVANTE - All'estrema sinistra a sud è presente la mole del
campanile, a destra le mura esterne del transetto e dell'abside. Al centro
un grazioso portale marmoreo, la cornice interna del portale è sormontata
da architrave con testa d'angelo alata. Un fregio centrale reca l'iscrizione
"MONSTRA TE ESSE MATREM" fra festoni di frutta e colombe. Sopra
l'elaborato cornicione è incastonata una targa posta sotto il regno di Filippo
IV di Spagna MDCXXVIII (1628). Colonne doriche dai capitelli
corinzi reggono un timpano spezzato, simmetrico ad arco. Sopra
gli spioventi sono murati stemmi con aquile dalle ali dispiegate, due volute
simmetriche fanno ala ad una mensola incassata dove poggia, protetta da una
nicchia spartana, una Vergine Coronata orante poggiante sulle teste di tre
putti alati e una mezzaluna, identificabile con l'Immacolata
Concezione.
Incastonate
nella parete alcune targhe munifiche, i memoriali dei due ultimi conflitti
mondiali, teste di putti e la targa del 1639 di
Filippo IV di Spagna elogiante i Giurati Castrensi, quest'ultima sormontata
dai resti di tre meravigliose aquile marmoree scampate ai rovinosi
terremoti.
PROSPETTO
DI PONENTE - Rampe simmetriche di scale contraddistinguono la facciata
ovest causa dislivello naturale, consentono l'accesso attraverso un elegante
portale ad arco in tufo. Un altissimo contrafforte sostiene la parete
laterale in prossimità del transetto.
CRIPTA
- Una scalinata marmorea ubicata nel braccio destro del transetto
conduce alla cripta,
una serie di ambienti costituiti da stanze e cunicoli. I locali ricavati in
corrispondenza della crociera e della navata centrale ospitavano un
complesso di cisterne, botole, colatoi utilizzati per il trattamento e la
corretta conservazione dei cadaveri. Un corridoio ha sbocco esterno sul
piano stradale collocato sotto l'ingresso laterale sinistro.
MERIDIANA
- Sul seicentesco pavimento marmoreo è tracciata una tra le meridiane delle
otto esistenti in Sicilia, l'unica funzionante della città metropolitana di
Messina, realizzata nel 1854 dal
professore Nicola
Perroni Basquez docente di lettere classiche. Non un astronomo o
un matematico ma,
un professore di lettere
antiche appassionato di astronomia.
Non è un caso isolato, la meridiana di Santa
Maria degli Angeli di Roma fu
realizzata dal Francesco
Bianchini, avvocato e studioso di matematica ed astronomia.
La
linea meridiana parte dalla seconda colonna della navata sinistra entrando
dall'ingresso principale e corre trasversalmente lungo il pavimento fino a
interessare la mezzeria della navata centrale, indicando la direzione Sud -
Nord del meridiano terrestre del luogo. Non i rovinosi terremoti precedenti,
quelli del 1894,
del 1908 e
del 1978 hanno
danneggiato la meridiana che
è giunta a noi quasi del tutto integra. La Sicilia può vantare su tutte le
regioni italiane il primato per il numero di meridiane a camera
oscura realizzate. La sua presenza testimonia il fervore
culturale di una comunità che primeggiava con quella di Messina dove vivaci
intelletti come Francesco
Maurolico e Antonio
Maria Jaci, contribuirono nel XVIII e XIX secolo all'affermarsi delle
scienze e dell'astronomia.
L'elenco
dei siti ospitanti le installazioni di meridiane a camera oscura: la cattedrale
di Maria Santissima Annunziata di Acireale,
la Scuola Tecnica Regia di Caltanissetta,
la chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo di Castiglione
di Sicilia, il duomo di Santa Maria Assunta di Castroreale,
la chiesa di
San Nicolò l'Arena di Catania,
la basilica
cattedrale protometropolitana della Santa Vergine Maria Assunta di Messina,
il duomo di
San Giorgio di Modica,
la cattedrale
metropolitana della Santa Vergine Maria Assunta di Palermo.

SACRESTIA
-
?, Fonte, antica vasca lustrale, manufatto verosimilmente
dismesso da ambiente arabo o ebreo e proveniente dalla sacrestia della
Chiesa della
Candelora.
-
?, San Michele Arcangelo, dipinto d'autore anonimo ispirato
all'opera di Guido
Reni, proveniente dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie del
convento dell'Ordine
dei frati minori cappuccini.
-
XVII secolo, Bottega di Nazaret, dipinto d'autore anonimo
proveniente dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie del convento dell'Ordine
dei frati minori cappuccini.
-
XVI secolo, Ottaviano Preconio, ritratto dell'arcivescovo, opera
proveniente dal monastero
di Santa Maria degli Angeli.
-
?. Ciclo, dipinti raffiguranti i ritratti dei preti della chiesa
di San Filippo Neri.
-
?. Ciclo, dipinti su tela provenienti dalle raccolte della Pinacoteca
di Santa Maria degli Angeli.
Quasi
tutte opere provenienti da altri luoghi di culto sono state esposte presso
le istituzioni museali cittadine, alcune sono state in deposito o prestate
per mostre tematiche al Museo
regionale di Messina.
Chiesa
di Sant'Agata


La chiesa
di Sant'Agata Vergine e Martire, sorge assieme alla chiesa di Santa Marina
nella parte bassa del comune di Castroreale.
Non
è nota l'epoca della fondazione della chiesa di Sant'Agata, il cui culto a
Castroreale introdotto quasi certamente durante la dominazione spagnola ma,
sicuramente esistente già nei primi anni del XV
secolo, quando l'omonima confraternita commissionò la bella
tavola che raffigura la santa tra dodici storie del martirio, oggi
conservata nel museo pinacoteca parrocchiale allestito nella chiesa
di Santa Maria degli Angeli.
-
1717, 22
aprile. Terremoto con
effetti distruttivi in città e nell'immediato circondario. L'evento
determina lavori di consolidamento delle strutture.
-
1854, Il
concorso di popolo al primo corteo processionale del Crocifisso determinò
la trasformazione del luogo di culto. L'icona custodita nella profonda
cappella della parete destra, fu collocata sull'altare maggiore. L'ambiente
temporaneamente murato, oggi presenta la luce con visione sul primitivo
alloggiamento. L'arcata ospita la Madonna del Naccherino.
Per
le opere statuarie custodite, la chiesa costituisce un piccolo museo ove è
rappresentato il genio del rinascimento
siciliano e ben quattro artisti di elevata statura artistica.
Nella controfacciata è
ricavato il coro con
organo di Michele Polizzi di Modica del
1907. Nel sottocoro è presente un'acquasantiera marmorea del XVII
secolo incassata alla parete, opera di Sebastiano Ferrara.

all'interno
è collocato il gruppo marmoreo dell'Annunciazione, squisita opera
realizzata da Antonello
Gagini nel 1519,
tra le poche firmate dall'artista, e il simulacro in cartapesta del
Santissimo Crocifisso risalente al XVII secolo. L'immagine è oggetto
della tradizione religiosa del Cristo Lungo (U Signuri Longu).
Essa viene fissata su di un palo lungo circa 13 metri che viene poi
assicurato tramite un pesante canapo e inalberato (per mezzo di un
complicato gioco di lunghe pertiche munite di forcine maneggiate dai maestri
di forcina) su una vara lignea, del peso di tre quintali circa, la
quale viene poi trasportata a spalla per le vie strette e in pendenza del
paese. La croce inalberata svetta su tutti gli edifici a eccezione della
torre campanaria della chiesa del Santissimo Salvatore e del Duomo.
Il
simulacro è portato in processione tre volte l'anno: durante la settimana
santa e nel mese di agosto nei giorni del 23 e 25. In quest'ultima occasione
si commemora il miracolo della liberazione della cittadina dal colera
nell'anno 1854.
Chiesa
della Candelora


Risalente
alla fine del secolo XIV era probabilmente la cappella del castello di
Federico II d’Aragona. Rimaneggiata in epoche successive è caratterizzata
da una cupoletta emisferica di influenza araba che sormonta l’abside e da
un portale costruito tra la fine del ‘400 e i primi del ‘500.
Questo
tempio fino alla fine del 1800 era ricco di pregevoli opere lignee, di
quadri e pale d’altare dipinti su tavola e su tela, statue in stucco e
carta pesta. Inoltre aveva un bellissimo pavimento maiolicato del
sei/settecento. I danni provocati dal terremoto del 1908 furono notevoli e
la chiesa fu solo parzialmente sistemata. Il restauro è avvenuto nel 2003 e
la chiesa è stata riaperta al culto l’8 giugno dello stesso anno.
Il
fiore all’occhiello del tempio è sicuramente la grandiosa Tribuna di
legno riccamente intagliata e indorata d’oro zecchino, architettata a
forma di tempio, della prima metà del XVII secolo, attribuita a
Giovanni Siracusano. Nell’edicola centrale tra sei angeli musici vi è la
madonna in atto di presentare il Bambino Gesù al Tempio.
Nella
Tribuna vi sono due coppie di colonne dove si trovano sei tavolette
raffiguranti la storia e la devozione a Maria e il culto delle candele
benedette. Sui quattro altari si trovano la statua di San Tommaso del 1606;
la statua di Santa Maria di Loreto di Francesco Antonio Molinaro del sec.
XVII; la statua di San Liberale Vescovo del 1607; la statua di San Guiovanni
Battista di Andrea Calamech del 1568. All’interno si trovano dipinti
raffiguranti la Madonna dell’Idria del XVII secolo; la Strage degli
Innocenti di Frate Simpliciano da Palermo del XVI secolo, La Natività della
Vergine Maria di Giuseppe Bonfiglio del 1611 e la Madonna delle Grazie tra
S.Antonio e S.Diego dei primi del secolo XIX.
Chiesa
del Santissimo Salvatore
La
Chiesa del SS Salvatore sorse probabilmente verso la fine del sec.XV, nel
cuore del quartiere ebraico o Giudecca, e fu ingrandita ed ornata di stucchi
barocchi negli ultimi anni del sec. XVII.
 Il
portale archiacuto sulla facciata è l'elemento architettonico più notevole
dell'assetto originario della chiesa. Il
portale archiacuto sulla facciata è l'elemento architettonico più notevole
dell'assetto originario della chiesa.
La
chiesa e la torre campanaria sono state semidistrutte dal terremoto del 1978
e durante i lavori di consolidamento è stato rinvenuto dal rivestimento
tardo seicentesco, un brano della decorazione lapidea cinquecentesca di uno
degli altari della parete destra.
L'interno
ornato da stucchi barocchi, custodisce un pregevole altare marmoreo del
messinese Antonino
Amato.
Accanto
alla chiesa, ma da essa staccata, si innalza un campanile a forma di torre
quadrata costruita nel 1560.
Chiesa
di Santa Maria del Gesù e annesso convento francescano

La
Chiesa e l’annesso Convento Francescano dei Frati Minori Osservanti la cui
fondazione si fa risalire al 1424 alla predicazione del beato Matteo
d’Agrigento 1424, uno dei compagni di Bernardino da Siena, è situata ai
piedi di una collinetta poco distante dalla città.
Nel
1866 con le leggi di confisca la Chiesa e il Convento passarono al Demanio
Comunale e il terreno adiacente fu usato per la costruzione del nuovo
cimitero.
Davanti
alla chiesa vi è un portico a tre arcate, sostenuto da due colonne, di
costruzione settecentesca; a sinistra si conserva l’antica Cappella della
famiglia Rosso con un portale di tipo durazzesco, risalente alla fine del
sec. XV. Rimangono i pilastri di pietra intagliata del portico laterale che
è adibito a colombario mortuario.
Il
portale della Chiesa è di tipo gotico–catalano; l’interno si presenta
ad unica navata con otto altari laterali ed uno maggiore.
Molte
delle opere in essa custodite si trovano oggi esposte nel Museo Civico; tra
le più importanti: il sarcofago di Geronimo Rosso di Antonello Gagini
(1506) ed il Ciborio ligneo della fine del XVII secolo. Altre opere, quali
la Statua della Madonna col Bambino, di fattura gaginiana, sono state
trasferite al Duomo di Castroreale
Chiesa
di Santa Maria delle Grazie e annesso convento dell'Ordine
dei frati minori cappuccini
La
storia della chiesa ha inizio nel 1566, anche se la sua edificazione avvenne
nel 1618.
 E'
infatti nel 1566 che nella contrada Fondacarso sorge il primo convento dei
Cappuccini, vicino al torrente Longano, in una valle non molto salubre. A
causa di questo, le condizioni dei frati erano poco agevoli per cui i
castrensi, affezionati e devoti ai fraticelli di San Francesco decisero di
costruire un convento entro le mura della città. E'
infatti nel 1566 che nella contrada Fondacarso sorge il primo convento dei
Cappuccini, vicino al torrente Longano, in una valle non molto salubre. A
causa di questo, le condizioni dei frati erano poco agevoli per cui i
castrensi, affezionati e devoti ai fraticelli di San Francesco decisero di
costruire un convento entro le mura della città.
Dopo
il terremoto del 1616 che arrecò numerosi danni a quel convento, si scelse
il luogo e l'8 settembre del 1625 i frati presero dimora del nuovo luogo
sacro.
Accanto
sorse la chiesa che fu dedicata a Santa Maria delle Grazie, composta da una
sola navata, di stile molto semplice. Sull'Altare Maggiore si trovava una
tela dipinta ad olio raffigurante la Madonna degli Angeli con San Francesco
e Santa Chiara del sec.XVI attribuita al pittore Scipione Pulzone da Gaeta,
oggi esposta al Museo Civico. Anche questo convento a causa delle leggi
eversive del 1866 fu abbandonato dai frati e consegnato al Comune, che lo
adibì ad ospedale.
Nel
1933 fu dato alla Congregazione dei Padri Redentoristi che rimasero fino al
1993. Oggi la chiesa è aperta al culto ogni anno solo l'8 settembre per
celebrare la Natività di Maria Santissima, festa a cui erano devoti i frati
Cappuccini e che è rimasta viva nella tradizione religiosa locale.
Chiesa
di Santa Marina
La
Chiesa di Santa Marina, il cui assetto attuale risale agli inizi del secolo
XVI, fu costruita forse nel periodo svevo.
Essa
ripropone soluzioni ed elementi di gusto romanico e ingloba strutture
appartenenti al sistema fortificatorio della città, come la torre nella
quale è stata inserita la cappella dedicata a S. Lorenzo, concessa nel XVII
secolo alla famiglia Muscianisi dei Baroni di Centineo.
La
cappella contiene ancora il suo apparato decorativo in marmi policromi del
sesto decennio del seicento. Un esempio di barocco locale è la cappella
della Consolazione, decorata nel 1678 con stucchi di tale "mastro
Isidoro" e con affreschi da Filippo Jannelli.
La
chiesa custodiva importanti opere di pittura, oggi conservate nel Museo
Parrocchiale, quali una Croce dipinta del '300/'400, un Trittico fiammingo
del 1544/1545 e una Tavola raffigurante S. Lorenzo e storie del martirio di
frate Simpliciano da Palermo.
Sull'altare
maggiore oggi è stata ricollocata la Tavola raffigurante Lo Spasimo;
dipinta nella seconda metà del sec. XVI da un seguace del napoletano
Deodato Guinaccia.
Chiesa
di Santa Maria degli Angeli e monastero
di Santa Maria degli Angeli retto dalle Clarisse
 La
Chiesa di S. Maria degli Angeli è stata edificata nel 1566 dal castrense
Mons. Ottaviano Preconio, arcivescovo di Palermo. La
Chiesa di S. Maria degli Angeli è stata edificata nel 1566 dal castrense
Mons. Ottaviano Preconio, arcivescovo di Palermo.
Accanto
alla chiesa fu costruito un monastero di suore di clausura che osservavano
la regola di Santa Chiara. Il monastero sorse nel cuore del quartiere
ebraico, probabilmente utilizzando edifici appartenenti alla comunità
ebraica, quali la sinagoga.
Nel
1860 la chiesa fu restaurata ed abbellita con stucchi. Sull'altare centrale
si trovava una bella tela con i Santi Fondatori dell'Ordine: la
"Madonna degli Angeli fra i SS. Francesco e Chiara" del sec. XVI.
In seguito alle leggi del 1866 la Chiesa e il Monastero furono incamerati
dal Demanio e successivamente, agli inizi del 1900 ceduti alle suore del
Buon Pastore che rimasero per pochi anni.
 Nel
XX sec. l'edificio del Monastero fu adibito ad usi scolastici dopo aver
subito trasformazioni quali la distruzione del chiostro e del portale
quattrocentesco. Nel
XX sec. l'edificio del Monastero fu adibito ad usi scolastici dopo aver
subito trasformazioni quali la distruzione del chiostro e del portale
quattrocentesco.
Negli
anni '70 si pensò di istituire una Pinacoteca castrense e si scelse come
sede questa Chiesa ormai non più aperta al culto, per la sua ubicazione
centrale e per il suo migliore stato di conservazione. Ma il terremoto del
1978 fece si che l'edificio fosse utilizzato come deposito per le molte
opere provenienti dalle chiese danneggiate o distrutte.
Solo
dopo l'apertura del Museo Civico nei locali dell'ex Oratorio dei PP.
Filippini, la chiesa S. Maria degli Angeli potè essere adibita a Pinacoteca
consentendo l'esposizione di numerose opere. In seguito alla
ristrutturazione di alcune chiese, molte di queste opere sono state
collocate in esse.
Dal 20 agosto 2005 la chiesa è stata adibita a
"Museo Parrocchiale degli Arredi Sacri".
 Architetture
civili e militari Architetture
civili e militari
CASTELLO
DI CASTROREALE O TORRE DI FEDERICO II - Il Castello di Castroreale ha
una storia articolata in varie fasi. Il primo nucleo della fortificazione
certamente può essere fatto risalire al periodo normanno, probabilmente in
età sveva.
Inizialmente
si trattava di una semplice fortificazione che serviva per avvistare la
presenza di nemici nei territori circostanti, poi nel corso dei secoli si
andarono aggiungendo altre costruzioni per accogliere non solo i soldati e
le loro famiglie ma anche i contadini della zona, le provviste e molto altro
ancora.
Sulla
torre più alta, quella che è conosciuta con il nome di Torre di
Federico II, c'è un'iscrizione che data la sua edificazione al 1537 ma non
è chiaro se faccia riferimento esclusivamente a questa parte oppure
all'intera costruzione: secondo le fonti storiche Federico II sovvenzionò
la costruzione del forte per ringrazia la popolazione della fedeltà
dimostrata.
Nel
corso dei secoli, poi, il castello fu al centro di alcune vicende molto
importanti come nel Cinquecento quando gli abitanti del luogo, asserragliati
all'interno di esso, resistettero all'assedio degli spagnoli.
In
epoca garibaldina, invece, il castello fu trasformato in prigione.
Un
tempo la struttura complessiva del castello di Castroreale doveva essere
molto imponente e comprendere diverse zone, tutte racchiuse all'interno
delle mura medievali. Oggi, invece, restano solo pochi ruderi e in
particolare proprio la Torre di Federico II che è una costruzione
a pianta circolare alta circa 9 metri. Al suo interno è suddivisa su due
piani, ha delle mura molto spesse che raggiungono quasi i due metri e sono
state realizzate con laterizi e pietrame d'arenaria.
L'ingresso
della torre è singolare perché avviene attraverso una porta caratterizzata
da un arco ad ogiva che si trova al primo piano e alla quale si accede
percorrendo due rampe di scale. All'interno di questo primo piano c'è una
sola finestra con una grata in ferro mentre il soffitto ha una volta a
crociera. Con una seconda rampa di scale, poi, si accede al piano inferiore
che ha una volta emisferica e una finestra rettangolare, anch'essa dotata di
grata.

ARCO
MONUMENTALE - Rudere di primitiva sinagoga ubicato
alle spalle del Monte di Pietà, testimonianza della comunità ebraica
locale. Insieme al quartiere della Giudecca, via
della Giudecca, via della Moschita (già via degli Uffici e
oggi intitolata a Guglielmo Siracusa, corruzione o improprio richiamo a moschea araba),
retaggio architettonico e antica toponomastica riferiti
approssimativamente al territorio della giurisdizione parrocchiale della
chiesa del Santissimo Salvatore, con particolare riferimento all'antico
aggregato francescano delle clarisse di
Santa Maria degli Angeli.
MONTE
DI PIETA' - All'istituzione è associata la Confraternita di San
Leone, detta degli «Azzurri» o del «Monte di pietà», in seguito fusa
con la Confraternita del Santissimo Sacramento attestata presso la
chiesa madre.
PORTA
RAINIERI - varco d'accesso posto a tramontana.
Uno dei quattro varchi d'accesso documentati assieme alla Porta delle
Legna, Porta del Castello, Porta di Cristino.
PALAZZO PECULIO - sede degli uffici comunali.

- Fonte
- https://it.wikipedia.org
|