|
La
cittadina è sita su un monte tra gli 850 e i 1100 metri sul livello del
mare, nei boscosi monti Nebrodi,
ricchi di selvaggina e famosi fin dall'antichità.
La
cittadina, detta anche la "Sella dei Nebrodi" per la
particolare conformazione, si trova a metà strada tra Palermo e Messina.
Gli
studi non hanno ancora chiarito le origini di Mistretta. Certo è che l'area
era già abitata nell'età protostorica, come dimostra il ritrovamento di un
ripostiglio dell'età del bronzo finale avvenuto alla fine del XIX secolo e
dal quale Paolo
Orsi riuscì ad
acquistare una cuspide di lancia conservata a Siracusa nel museo
archeologico regionale a
lui intitolato. Sempre riferibile all'età protostorica è una oinochoe
geometrica conservata
nel locale museo "Ortolani" appartenente allo stile di Polizzello. Materiali ascrivibili alla presenza greca compaiono a partire dal VI
secolo a.C., periodo in cui l'area incominciò a essere di passaggio per i calcidesi in
movimento tra Zancle, Pizzo
Cilona e Himera.
Non
è chiaro quale fosse il nome di Mistretta tra V e III secolo a.C. A partire
da Adolf Holm nacque una disputa riguardante ciò. Si è sempre ritenuto che
a Mistretta fossero riferibili sia il toponimo Mytistraton sia
quello Amestratos, ma presunti rinvenimenti di monete
mytistratine nell'area del monte Castellazzo di Marianopoli fecero pensare
che il primo dei due toponimi potesse appartenere a quel sito, cosa non
ancora accertata. La sconosciuta Mytistraton, dotata della facoltà di
battere moneta, secondo il racconto di Polibio, ereditato da Filino di
Agrigento, si ribellò alla conquista romana e venne assediata tra il 263 e
il 258 per ben tre volte, prima sotto i consoli Ottacilo e Valerio e
poi, con successo, da parte dei consoli Attilio
Calatino e Caio
Sulpizio.
Certo
è che nel III secolo a.C., la città antica sorgente dove ora è Mistretta,
facente parte del gruppo di civitates decumanae col nome di
Amestratos, batteva moneta (si conoscono due emissioni in bronzo, di cui una
con l'iscrizione ΛΕΥ ΑΜΗΣΤΡΑΤΙΝΩΝ),
ebbe un certo sviluppo e probabilmente il suo nome è identificabile alla
riga 113 della lista dei theorodokoi di Delfi. Fece parte di una symmachia
insieme con le città di Halaesa, Kalè Aktè e Herbita con le quali
sconfisse i pirati provenienti dalle Eolie. Fu inoltre attraversata dalla
strada romana Halaesa-Agyrion-Katane, che, distaccandosi dalla Valeria,
giungeva sulla costa ionica siciliana, divenendo punto di riferimento
imprescindibile per chi viaggiava tra il cuore della Sicilia e il Tirreno.

Silio
Italico nel suo
poema storico in versi "Punica" ci presenta Mistretta come un
centro che forniva ai romani oltre al grano anche soldati ben addestrati.
Tracce storiche inerenti alla città di Mistretta si trovano nelle
"Verrine" di Cicerone in
cui si narra dei soprusi commessi dal governatore Caio
Verre in varie città
siciliane, tra le quali anche Amestratos, che condivideva con Calacte decime
esose che venivano depositate nel locale tempio di Venere sotto protezione
del servo Bariobale. A partire dall'età imperiale le fonti citano di rado
Amestratos, che verrà comunque continuata a essere abitata e produttiva
come può testimoniare la villa del III sec. d.C. ritrovata in contrada
Vocante. Testimonianze paleocristiana sono presenti in contrada Francavilla,
dove piccole catacombe sono impiantate all'interno di megaliti
quarzarenitici. Risalenti all'età bizantina sono una necropoli ritrovata in
contrada Santa Maria La Scala e alcuni rinvenimenti sul monte del castello.
Dopo
la caduta dell'impero, Mistretta divenne preda dei Vandali,
invasa poi dai Goti e
infine ritorna ai domini imperiali con Bizantini che conquistarono l'intera
Sicilia nel 535
d.C. In questo
periodo, Mistretta dovette sostenere una forte fiscalizzazione e il suo
territorio fu in seguito sottoposto a ruberie e saccheggi da parte islamica.
Gli Arabi dominarono
il paese tra l'827 e
il 1070 e
ristrutturarono il Castello bizantino edificato nel punto più alto della
città. Dopo il dominio dell'impero romano d'oriente, la conquista dei
musulmani, guidati da Ibrahim
Ibn Ahmed, rappresenta
un momento di incontro con le culture e le economie del Nord Africa; vi
erano, tra gli invasori, mercanti e coltivatori che introdussero la
coltivazione del dattero e numerosi palmeti. Dal punto di vista religioso
veniva garantita la libertà di culto, a coloro che non volevano convertirsi
all'islam, con il pagamento di una imposta. Per ciò che concerne gli
aspetti sociali e politici e l'introduzione di nuove tecniche costruttive in
edilizia o l'introduzione di nuove colture e tecniche di coltivazione, la
presenza araba ha arricchito ulteriormente la cittadina mistrettese.
Alla
dominazione araba succedette quella normanna durante
la quale il castello fu ulteriormente ampliato. Con i Normanni,
i grandi latifondi, smembrati dagli Arabi,
si ricostituirono e si rafforzò ancora di più il baronaggio. Il re
normanno Ruggero I
d'Altavilla, nel 1101, donò
Mistretta con le sue chiese, i suoi splendori e con tutto il suo territorio
al fratello Roberto, Abate della Santissima
Trinità in Mileto
Calabro e dall'atto
di donazione si possono ricavare notizie storiche sul paese che in quel
periodo si stava ampliando lungo le falde del monte su cui sorgeva il
castello arabo-normanno ed entro le mura di difesa di cui resti sono
visibili nel Vico Torrione e lungo la Strada Numea dove si apre la Porta
Palermo, una delle due antiche porte della città.

Oltre
all'insediamento urbano circondato dalle mura, vi erano numerosi bagli,
aggregati sociali e produttivi circondati da orti, ed è proprio dagli
antichi bagli che hanno avuto origine i quartieri medioevali di Mistretta
ricalcati ancora nel tessuto urbano del centro storico. Il castello è più
volte al centro di operazioni militari, come nel 1082,
quando Giordano,
figlio illegittimo di Ruggero, approfittando dell'assenza del padre recatosi
nelle Calabrie,
tenta con la complicità dei suoi cortigiani di usurpare il potere,
insediandosi stabilmente al governo della Sicilia, o ai tempi di Guglielmo
il Malo, quando Matteo
Bonello, ricevuta nel
1160 l'investitura della città, si fa promotore di una cospirazione contro
il monarca, che diede i risultati sperati (ebbe come unico effetto
l'uccisione del ministro Maione
di Bari).
La
città fu insignita da Federico
II di Svevia del titolo di "Città imperiale", l'imperatore procede a una
serrata lotta contro i briganti musulmani in tutta la Sicilia, sradicando
totalmente ogni resistenza. Mistretta fu successivamente infeudata a Federico
d'Antiochia e quindi a
suo figlio Corrado.
Fu in questo periodo che nacque lo stemma
della città raffigurante
un'aquila, stemma degli Hohenstaufen nel
Regno di Sicilia.
Finita
la dominazione sveva, vi fu l'occupazione angioina. Carlo
I d'Angiò importò
in Sicilia il feudalesimo danneggiando l'economia di molti importanti
centri, tra cui Mistretta che fondava la sua prosperità sull'agricoltura e
sul commercio. La città di Mistretta insorse e, nel 1282,
i cittadini di Mistretta si unirono alla rivolta dei Vespri
siciliani. Per il gran
contributo apportato nella lotta contro i francesi, la città fu inserita
tra quelle demaniali ed accolta nel Parlamento del Regno di Sicilia con
capitale Palermo,
sotto gli Aragonesi.
Nel 1447,
re Alfonso d'Aragona, sancì la demanialità di Mistretta ed i suoi Casali
e, nel consentire al ceto artigiano di entrare a far parte del governo della
città, creò i presupposti affinché, nel XVI
secolo, la città si
arricchisse di numerosi monumenti religiosi e civili. Notevoli testimonianze
del Cinquecento,
fase storica di splendore per Mistretta, ci sono date dalla magnificenza dei
lavori con i quali gli scalpellini del paese arricchirono la Chiesa Madre,
aggiungendoli ai raffinatissimi interventi dei Gagini. Di questo periodo è
pure la fondazione dell'Ospedale e della "Casa dei Pellegrini",
edifici ancora esistenti con le loro originarie caratteristiche. La città,
tuttavia, mentre si arricchiva di arte (il barocco,
le chiese, i palazzi, tele, sculture, …), subiva la stessa sorte del resto
della Sicilia, la perdita del peso politico, dominata dai re
di Castiglia.

Il
Settecento fu anch'esso periodo di benessere per i mistrettesi, per la
crescita economica dovuta all'esportazione di prodotti agricoli ed allo
sfruttamento dei boschi comunali. Mistretta diviene quindi importante centro
commerciale e sede d'uffici e magazzini che consentivano una efficiente
lavorazione e commercializzazione dei prodotti. A questa ricchezza
corrisponde l'affermarsi di una ricca borghesia che, grazie alle proprie
commesse, consentì il fiorire di una serie di attività artigianali per la
lavorazione del ferro e del legno. Questa ricca classe sociale provvide a
far edificare palazzi signorili e urbanizzò l'area di proprietà della
chiesa di Santa
Caterina d'Alessandria ai
confini del bosco che sovrasta la cittadina.
Nel 1713 (Trattato
di Utrecht), la Spagna cedette
i suoi possedimenti in Italia all'Austria,
ma il principe Vittorio
Amedeo di Savoia cui
spettava la Sicilia la barattò in cambio della Sardegna e
l'isola passò a Carlo
VII di Baviera e più
tardi a Carlo III di
Borbone; per i mistrettesi e tutti i siciliani iniziava la dominazione
borbonica.
Sotto
i Borbone,
assunse un ruolo ancora più centrale in quanto elevata nel 1812 a capoluogo
dell'omonimo distretto. La borghesia locale si preoccupò di abbellire a
ampliare la città e durante l'Ottocento furono
costruiti palazzi, fu messo in opera un poderoso riassetto urbanistico,
culminante con l'apertura del corso Libertà nel 1848, furono abbellite le
chiese con numerose opere d'arte, fu aperta la biblioteca comunale. La città
riacquistò così l'antica importanza e divenne il punto di riferimento
commerciale e culturale per tutti i centri vicini.

Il
malcontento diffusosi a Mistretta presso la nascente classe media costituita
da professionisti, artigiani e massari, che sfociò nella rivolta di San
Sebastiano del 1859, fecero sì che la cittadina mistrettese fosse tra le
prime ad insorgere contro i borboni dopo Palermo nel 1860,
contribuendo alla causa dell'unità
d'Italia.
Successivamente Mistretta subì le vicende di tutta la Sicilia nell'Italia
post-unitaria fino ai giorni nostri. Nel 1860 fu soppresso l'omonimo distretto
amministrativo, immediatamente sostituito però dall'ente analogo del Circondario
di Mistretta, governato dal Sottoprefetto.
All'inizio
del ‘900 la Sicilia aveva quasi del tutto consumato l'immagine forte che
il secolo appena concluso le aveva permesso di costruire e consegnare, la
sua storia regionale superava in varietà e prestigio quella delle altre
regioni. Mistretta, come molte altre città sicule in quel periodo, aveva
raggiunto l'apice del suo splendore economico, artigianale, artistico e
culturale, ma dietro ai palazzi nobiliari, ai circoli culturali, alle fiere,
alle feste di paese, si nascondevano le sorti infauste che hanno segnato le
vicende di numerose cittadine della Sicilia. Il 31 ottobre del 1967 il
centro nebroideo, unitamente ai comuni di Capizzi e Nicosia,
fu colpito da un sisma di magnitudo 5.6 sulla scala
Richter, evento che
provocò il danneggiamento di edifici storici, nonché il crollo di parte
della chiesa dedicata al patrono san
Sebastiano, resa
inagibile e riaperta al culto solo nel 1994.
Non si registrarono né morti né feriti, tuttavia fu necessario dislocare
diversi nuclei familiari dai quartieri maggiormente colpiti. Sebbene il
sisma possa considerarsi di secondario interesse se paragonato a catastrofi
naturali sia posteriori quanto anteriori, il fenomeno ebbe un impatto
notevole sulla vita cittadina di Mistretta, poiché incentivò l'abbandono
di parte del centro storico del paese.
La
cittadina ha seguito il destino di gran parte dei centri di montagna
siciliani nel Novecento,
ha subito i colpi inferti dalla disoccupazione fino allo spopolamento per
emigrazione (dai 20 000 abitanti dell'Ottocento, poi circa 5.000),
subisce la fuga dei più giovani che per motivi di studio o per cercare
nuove opportunità lasciano il centro nebroideo, vede scomparire ogni giorno
parte del suo patrimonio artistico-culturale per negligenza e
vandalismo.
Chiesa
di Santa Lucia

La chiesa
di Santa Lucia è la chiesa
madre. Le
prime notizie del tempio cristiano, verosimilmente edificato su preesistente
luogo di culto o edificio pagano, risalgono al 1170,
anno in cui il vescovo Bosone
de Gorram la
donò con tutti i suoi arredi e patrimoni ad un canonico della sua
cattedrale. Della struttura normanna orientata ad est, e del suo arredo, non
è rimasto nulla.
Nel
1490 fu ricostruita nelle forme attuali con l'orientamento abside -
prospetto ribaltato.
Nel 1521,
fu edificata la possente torre campanaria. Nel 1552,
in piena epoca
rinascimentale l'edificio
è stato arricchito con il portale di Giorgio
Brigno, l'ancóna dei
fratelli Vincenzo e Antonino
Gagini mentre
col fiorire del barocco
siciliano nel XVII
secolo, è
realizzato il ricchissimo portale principale e quello meridionale, entrambi
opere in pietra arenaria di scalpellini locali. Più contemporanea è la
commissione e realizzazione di opere d'arte figurative e decorative per
mezzo di manodopera locale abile in manufatti in pietra e legno, botteghe
palermitane specializzate in marmi e argenti, maestranze dei centri vicini
esperte in tele, stucchi ed affreschi.
Nel
1630 fu
ampliata con l'innalzamento dell'abside e del transetto, la costruzione del tiburio ottagonale
rivestito di maioliche verdi cristalline e le due cappelle mariane
simmetriche: Cappella della Madonna dei Miracoli e Cappella
di Santa Maria Odigitria. Nella nuova zona presbiteriale ad
ovest, il coro e
le due absidiole laterali: Cappella del Santissimo Sacramento e Cappella
di Santa Lucia.
Questi
lavori sono realizzati a ridosso del sisma del 25 agosto 1613 o
"terremoto di Naso". Sono molti altri gli eventi
sismici che
nelle devastazioni su scala regionale, hanno provocato danni contenuti
all'integrità complessiva del monumento come il terremoto
del Val di Noto del 1693 e
il terremoto
della Calabria meridionale del 1783.
Ad
ulteriori lavori di ampliamento e abbellimento seguì la nuova dedicazione
nel 1775 e
l'erezione a parrocchia nel 1790.
Negli
ultimi anni, soprattutto dopo il "terremoto di Capizzi e
Mistretta" del 31 ottobre 1967, la chiesa è stata sottoposta a
radicali opere di restauro che hanno portato alla luce parte degli sfarzi
che il tempo aveva celato.
Il
31 ottobre 2016 la chiesa madre è stata elevata a santuario della Madonna
dei Miracoli.


L'edificio
aveva originariamente un’unica ampia navata ed era orientata all’opposto
rispetto ad oggi, con l’accesso principale sull’attuale via Numea, che
conduce alla ‘Porta di Palermo’. Importanti modifiche strutturali
intervennero tra XIII e XV per trasformarla in basilica a tre navate, ma,
tra fine XVI e prima metà del XVII secolo, si soprelevò la fabbrica, con
l’inversione dell’orientamento, la costruzione del transetto con
tiburio. ottagonale e, soprattutto, del profondo presbiterio pensile, su un
arco che cavalca la via pubblica.
La
torre campanaria cinquecentesca (1521-1562), che affiancava l’antica zona
absidale, fu inglobata nella nuova facciata barocca che prevedeva
l’edificazione di una seconda torre gemella, iniziata alla fine del XVIII
sec. e mai completata.
Il
superbo portale principale (metà del XVII sec) e quello meridionale, detto
‘di S. Gaetano’ (1626), sono opere di scalpellini in arenaria locale,
quello che si apre a Nord (Giorgio da Milano o Andrea Mancino e Antonio
Vanella, 1494), verosimilmente smontato e rimontato più in alto, presenta
invece una mostra marmorea rinascimentale: l’architrave con stemma reale
aragonese e i Santi Pietro e Paolo entro medaglioni e la sovrastante lunetta
con la Madonna e il Bambino tra le Sante siciliane Lucia ed Agata,
l’Annunciazione e il Salvatore benedicente.
Tra
le poche tracce visibili del periodo medievale sono i resti
dell’originaria facciata (cantonali e portale dentro i locali
dell’attuale museo parrocchiale) la pavimentazione in terracotta, la base
intagliata e porzione di una colonna affrescata nel 1488 con figure di
Santi, recentemente ritrovati, nonché le mostre tardogotiche e
rinascimentali delle finestre aperte sulle navate e poche suppellettili
liturgiche superstiti.
Il
secolo XVI vede giungere da Palermo la ‘cona’ per l’altare maggiore
con gli Apostoli nella predella, il Risorto tra i Santi Pietro e Paolo,
l’Annunciazione e il Padre Eterno (1552), nonché il fonte battesimale e
la statua della titolare Santa Lucia (1575), tutti in marmo bianco di
Carrara scolpito dai Gagini, ed il monumentale ostensorio architettonico in
argento di Nibilio Gagini (1601-1604).
Botteghe
di marmorari palermitani del ‘600 producono gli altari della Madonna
dei Miracoli e della Madonna
dell’Itria, alle due estremità del transetto, per conciliare
all’interno della Matrice l’anima latina con quella greca ancora molto
viva nella popolazione fino alla metà del XVII sec. Abili intagliatori
messinesi, locali e palermitani realizzano gli stalli e il leggio del nuovo
coro (1665-1809) che sostituiva quello più antico.
I
complessi decorati a commesso marmoreo, con altorilievi e statue, delle
cappelle della Madonna
dei Miracoli, SS.
Sacramento e SS. Crocifisso sono dovuti alla bottega
catanese di Domenico Battaglia (1732 - post 1750),
mentre i rilievi in marmo bianco statuario dell’altare maggiore
neoclassico sono di Francesco Ignazio Marabitti (1771).
Il
monumentale organo a canne con cassa barocca intagliata e dorata –
ricollocato dall’ingresso principale al presbiterio nel 1875, occultando
la nicchia in stucco dove era il Risorto gaginesco - è sorretto da una
ricca cantoria (1657), con dipinti l’Immacolata, il Redentore e gli
Apostoli. Gli stucchi di maestranze locali, palermitane e catanesi (fine
‘700) che ricoprono pareti e volte danno all’edificio il prevalente
aspetto rocailles,
completato da bei lampadari neoclassici coevi in legno dorato di
intagliatore catanese.
Ogni
anno, per tutto il tempo di Quaresima, un enorme ottocentesco telo di lino,
dipinto con Cristo
davanti ad Anna e simboli della passione, oscura il
presbiterio e si fa cadere tradizionalmente solo durante la veglia pasquale.
L’archivio storico e la biblioteca annessi al sacro edificio conservano
materiali a partire dal XVI secolo. Gli ambienti restaurati sotto il
transetto sono sede del museo parrocchiale.
|
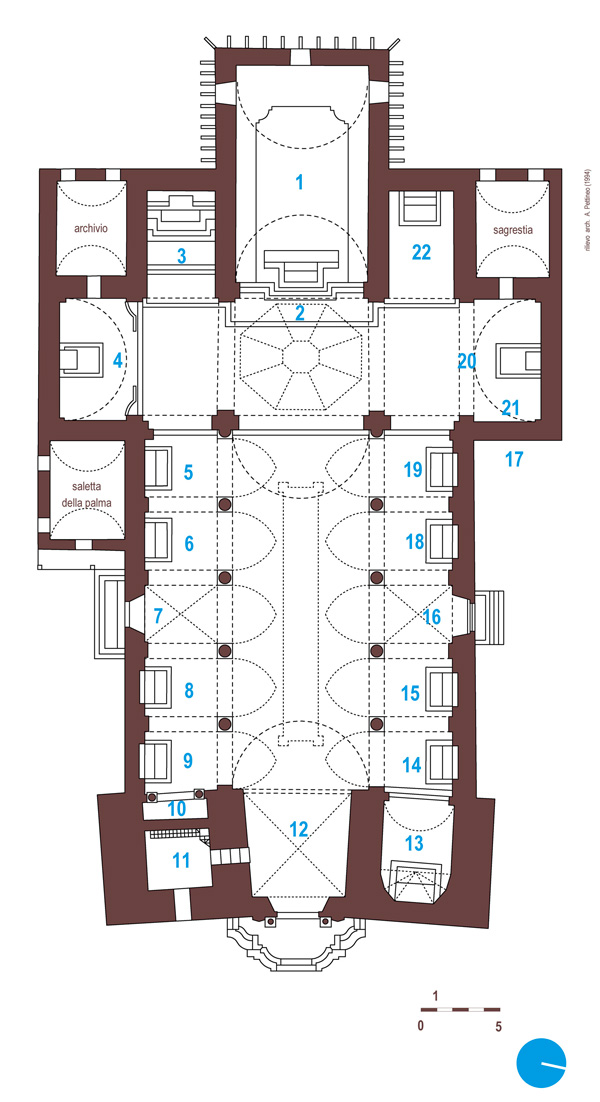 1.
Presbiterio: organo a canne di Onofrio La Gala (1656-1664) e
Giuseppe Lugaro (1874-1888); cantoria di Paolo La Cristina (1657);
coro ligneo delle botteghe dei Li Volsi (ante 1598), Ramfardi
(1671), Allò (1685-1710), di Giovanni Biffarella e Antonino
Azzolina da Mistretta (1712-1726), Ciro Bagnasco (1803); leggio
centrale di Angelo Messina a Carmelo Barone (1809); al centro del
coro: lapide con figura del sac. Giacomo Scaduto (sec. XVI). 1.
Presbiterio: organo a canne di Onofrio La Gala (1656-1664) e
Giuseppe Lugaro (1874-1888); cantoria di Paolo La Cristina (1657);
coro ligneo delle botteghe dei Li Volsi (ante 1598), Ramfardi
(1671), Allò (1685-1710), di Giovanni Biffarella e Antonino
Azzolina da Mistretta (1712-1726), Ciro Bagnasco (1803); leggio
centrale di Angelo Messina a Carmelo Barone (1809); al centro del
coro: lapide con figura del sac. Giacomo Scaduto (sec. XVI).
2.
Altare Maggiore: marmoraio palermitano Angelo Gabriele, con parti a
rilievo di Francesco Ignazio Marabitti (1771-1772); balaustra di
Domenico Battaglia (post 1750).
3.
Cappella del SS. Sacramento: ciborio architettonico (1739) e
balaustra, decorazioni a commesso marmoreo e altorilievi di Domenico
Battaglia (post 1750); ninfa in argento e rame dorato di Bonaventura
Caruso (1770-1771); decorazioni della volta del XIX secolo.
4.
Cappella della Madonna dei Miracoli: statua e plinto marmorei
attribuiti ad Andrea Mancino e Antonio Vanella (1495); altare e
monumento del barone Pietro Scaduto di Giuseppe Musca, (1639-1646);
decorazioni a commesso marmoreo e altorilievi di Domenico Battaglia
(1732); balaustra della stessa bottega (1753).
5.
Altare della Deposizione o ‘delle cinque piaghe’: olio su tela
di Antonino Manno (1771).
6.
Altare del Cristo Risorto: statua marmorea di Antonino Gagini
(1552), un tempo al centro della “cona” oggi nella cappella di
S. Lucia, nel sec. XVII entro una nicchia sul fondo del presbiterio,
nell’attuale sito dal 1875.
7.
Portale meridionale: maestranze locali (1626); statua marmorea di S.
Lucia di scultore palermitano. È detto ‘di S. Gaetano’ per il
motto inciso sull’architrave.
8.
Altare dei Santi Ausiliatori: olio su tela di Benedetto Berna
(1692).
9.
Altare di S. Anna: olio su tela di Antonino Manno (1771).
10.
Cappella del Fonte battesimale: intagli lapidei e decorazioni murali
dipinte (sec. XVI); fonte marmoreo di Vincenzo Gagini (1575);
copertura lignea e statue di Giovanni Biffarella, (1732). Prima
dell’inversione della chiesa, la cappella ospitava la statua di S.
Lucia.
11.
Torre campanaria: maestranze locali e palermitane (1521, 1562).
12.
Pronao: acquasantiere marmoree di Ambrogio Schillaci (1667); portale
principale in arenaria locale con rilievi e statue, al posto
dell’antica zona absidale (metà del XVII secolo).
13.
Cappella della Madonna di Pompei: decorazioni in stucco, altare in
marmo e dipinto su tela entro cornice neogotica (1922), voluti dalla
famiglia Seminara – Ortoleva.
14.
Altare delle Anime Purganti: olio su tela di Giuseppe Tomasi da
Tortorici (1651), commissionato dalla confraternita, che di lì a
qualche anno si trasferirà nella vicina chiesa con lo stesso
titolo.
15.
Altare di S. Gaetano da Thiene: olio su tela di Giuseppe Tomasi da
Tortorici (1651). Alla base del dipinto è riprodotta per la prima
volta l’immagine della città.
16.
Portale settentrionale: mostra marmorea di Giorgio da Bregno o
Andrea Mancino e Antonio Vanella (1494).
17.
Portale gotico dalla chiesa di S. Antonio abate (XIV-XV sec.), in
cui è incisa la significativa scritta: “1575 FU LA PESTA”.
18.
Altare dell’Ecce Homo: statua lignea del XVII secolo.
19.
Altare del Crocifisso della Provvidenza: commesso marmoreo con
altorilievi di Domenico Battaglia (ante 1750); Crocifisso ligneo di
Vincenzo Genovese (1866), che sostituisce l’antico, fino al 1598
esposto su un’alta trave a metà della navata centrale.
20.
Cappella della Madonna dell’Itria: altare in marmi mischi di
Giuseppe Musca, Luigi Geraci e Bartolomeo Travaglia (1649-1654),
commissionati con i lasciti del sacerdote Filippo Mongiovì.
21.
Statua lignea di San Sebastiano (metà del XVI sec.), proveniente
dall’omonima chiesa.
22.
Cappella di Santa Lucia: statua marmorea di Vincenzo Gagini, (1575)
e ‘cona’ con Apostoli, SS. Pietro e Paolo, Annunciazione e Padre
eterno di Antonino Gagini (1552); decorazione marmorea delle pareti
del XIX secolo e dipinti della volta di Salvatore e Giovanni La
Cugnina (1875); balaustra di Ambrogio Schillaci (1667). Al posto di
S. Lucia la cona comprendeva il Cristo Risorto. |
Altri
edifici religiosi
La
CHIESA DELLA SS. TRINITA' è un gioiello di storia e arte. Le
sue radici risalgono all’epoca normanna, ma ciò che la rende veramente
unica è la sua struttura ellittica combinata con elementi barocchi. Il
prospetto attuale, risalente al XVII secolo, è impreziosito da due
campanili che culminano in guglie coniche, rivestite da tessere policrome in
ceramica che brillano al sole. Un dettaglio particolarmente affascinante è
l’Angelo sulla bara, una scultura di Noè Marullo.
LA
PARROCCHIA SAN NICOLO' DI BARI è un luogo affascinante. Il suo
portale, con elementi in stile gotico-catalano tardivo, accoglie con un
senso di storia e bellezza.
All'interno,
si trova il simulacro dell'Immacolata. un'opera che unisce l'umano e il
divino, attribuita all'artista Marullo. Ma ciò che cattura l'attenzione è
la pala dell'altare maggiore, un capolavoro artistico che raffigura San
Nicola.

La
CHIESA DEL PURGATORIO è adornata da affreschi e statue policrome. Al
suo interno custodisce il crocifisso ligneo dei Li Volsi del 1608 e
affreschi del 1720-1729, tra cui il Giudizio Universale e la Gloria del
Paradiso.
  La
CHIESA DI SAN
SEBASTIANO è
un affascinante mix di stili e storia. Iniziata nella seconda metà del 500,
vanta un portale gotico-catalano e un campanile a quattro ordini con una
cupola a bulbo. Durante l’800, la chiesa ha subito una trasformazione in
stile neoclassico, e ha poi subito ulteriori modifiche a seguito del
terremoto del 1967. La facciata, con un rilievo che raffigura San
Sebastiano. La
CHIESA DI SAN
SEBASTIANO è
un affascinante mix di stili e storia. Iniziata nella seconda metà del 500,
vanta un portale gotico-catalano e un campanile a quattro ordini con una
cupola a bulbo. Durante l’800, la chiesa ha subito una trasformazione in
stile neoclassico, e ha poi subito ulteriori modifiche a seguito del
terremoto del 1967. La facciata, con un rilievo che raffigura San
Sebastiano.
La
CHIESA DEL SS.
SALVATORE è
un luogo che ti avvolge con la sua storia. All’interno, nel catino
absidale, troverai un affresco bizantino che raffigura un Cristo
Pantocratore, un’opera che ti riporta alle antiche chiese normanne
siciliane.
La
CHIESA DI SAN
GIOVANNI,
costruita nel 1534 su un antico tempio pagano, si fonde armoniosamente con
l’architettura della Piazza dei Vespri. L’accesso alla chiesa è reso
maestoso da una doppia scalinata semicircolare. Il portale, sormontato da
una lunetta ogivale, è un bell’esempio di fusione tra elementi
rinascimentali e gotico-catalani.

La
CHIESA DI SAN
FRANCESCO,
già annessa al monastero delle benedettine, fu rimaneggiata dai Frati
Cappuccini nel 1569. L’altare maggiore rappresenta uno dei maggiori
capolavori in legno esistenti in Sicilia, fu eseguito dallo scultore,
intagliatore, sacerdote Giovanni Biffarella e da Frate Bernardino da
Mistretta. Tutte le tele sono inserite in cornici lignee che sovrastano gli
altari anch’essi in legno. L’ex convento annesso alla chiesa è adibito
a penitenziario.
 CHIESA
DI SANTA CATERINA, in origine piccola chiesa rurale, in seguito ampliata
a tre navate dagli archi leggeri, con colonne monolitiche che poggiano su
basamenti istoriati che alludono alla lotta fra il bene e il male. CHIESA
DI SANTA CATERINA, in origine piccola chiesa rurale, in seguito ampliata
a tre navate dagli archi leggeri, con colonne monolitiche che poggiano su
basamenti istoriati che alludono alla lotta fra il bene e il male.
E'
rinascimentale l'altare maggiore su cui è collocata la statua della Santa,
attribuita a Giorgio da Bregno (1492). Le pitture a guazzo sulla volta
absidale di ignoto, rappresentano i quattro Evangelisti, il Pantocratore e
gli angeli musici.
Altre
chiese presenti a Mistretta sono: la Chiesa
di Maria Santissima del Rosario, la Chiesa
di San Biagio, la Chiesa
di San Giuseppe, la Chiesa
di San Giovanni Battista, e la Chiesa
di Sant’Antonio. Ogni edificio sacro racconta una storia, pronta ad
essere scoperta da te.

Castello
Sul
punto più alto della città si trovano i resti del Castello, edificato dai
bizantini e ristrutturato e ampliato prima dagli arabi e poi dai normanni.
Nei secoli successivi l'edificio subì diversi crolli che lo hanno portato
allo stato di degrado.
Le
prime notizie sulla fortezza si hanno da un privilegio del 1101 con il quale
il conte Ruggero dona al Demanio Regio e infeuda a se stesso Mistretta con
il suo castello. Questo fu teatro di grandi avvenimenti per circa 300 anni,
infatti lì si rifugiò Matteo Bonello durante la rivolta contro Guglielmo
Re dei Normanni, vi si stabilì Federico D’Antiochia durante la rivolta
contro Re Pietro D’Aragona nel 1337.
Nel
1360 vi si trattenne Re Federico D’Aragona prima del matrimonio con
Costanza. Altre notizie si riferiscono al 1474, quando era castellano regio
Sigismondo De Luna, che aveva il compito della riscossione delle gabelle e
che lasciò nell’incuria il castello.
Nel
1520 il castello era già in rovina e ridotto a carcere. Il personale era
costituito da due sole persone, il castellano e il portiere.
Nel
1608, il castello era completamente in rovina. Nel 1633 i mistrettesi
distrussero quanto rimaneva del castello simbolo delle angherie del potere
regio.
Nel
1686 una grande frana, che interessò tutta la vallata, distrusse il
versante nord-est della rocca del castello che cambiò per sempre la sua
morfologia. Dall’epoca della sua distruzione, i ruderi del castello e le
rocce vicine vennero usati come cava di pietra per la costruzione delle case
dei mistrettesi.
Nel
1863 il Sindaco proibì con una ordinanza di "fare pietra al
castello".
Di
tale complesso oggi rimangono i ruderi delle mura perimetrali, e sul lato
nord si configura ancora uno degli ingressi. Inoltre sono riconoscibili i
ruderi delle mura di cinta nonché di strutture sussidiarie.
Con
gli scavi archeologi effettuati nell’area sottostante i ruderi, negli anni
’80, sono stati rinvenuti le fondamenta di una piccola chiesa triabsidata,
di probabile epoca normanna impiantata in uno strato di materiale bizantino.

Porta
Palermo
Nel Settecento le
mura della città avevano perso la loro funzione difensiva e anche le
maestose porte della città costruite con la dura pietra locale non venivano
più sorvegliate.
 Le
prime notizie certe sull'esistenza di porte a Mistretta risalgono al 1475 perché
vengono menzionate in alcuni documenti dell'epoca, ma da altri documenti
successivi sappiamo che avevano perso la loro funzione principale, tanto che
nel 1771 venne
concessa al Barone Giaconia l'autorizzazione a costruire sulle mura. Le
prime notizie certe sull'esistenza di porte a Mistretta risalgono al 1475 perché
vengono menzionate in alcuni documenti dell'epoca, ma da altri documenti
successivi sappiamo che avevano perso la loro funzione principale, tanto che
nel 1771 venne
concessa al Barone Giaconia l'autorizzazione a costruire sulle mura.
Il
Barone costruì sulla porta da cui partiva la strada che conduceva a Palermo
rafforzandone i contrafforti, trasformando così la maestosa porta in una
struttura portante dei suoi palazzi.
Nel
corso del Novecento il monumento è stato deturpato dall'innesto di
strutture abusive, una su tutte un locale adibito a toilette che occlude la
volta dell'arco.
Passando
attraverso la porta che sorregge i palazzi del Settecento si accede alla
ripida "via Porta Palermo" che s'immette nel cuore del centro
storico creando uno scorcio unico nel suo genere.
Architetture
civili
Tra
le cose da vedere a Mistretta non possono mancare i palazzi storici, ognuno
con una storia particolare
PALAZZO
TITA - Sito
nel Quartiere della SS. Trinità, di fronte alla chiesa omonima (chiamata
anche chiesa di San Vincenzo), il Palazzo Tita fu ricostruito nel 1885 con
la facciata in stile bugnato.
I balconi sono decorati con putti scolpiti
da Noè
Marullo. Il portale
principale è in forma di arco sulla cui chiave di volta è scolpita la Medusa,
mentre l'estradosso è arricchito da bassorilievi di
mostri marini. È uno dei più bei palazzi di Mistretta e prende il nome da
una delle antiche famiglie signorili di Mistretta.
PALAZZO
SCADUTO -
Palazzo
Scaduto è uno dei più antichi di Mistretta. Venne edificato nel 1660,
in stile barocco, il cui portale principale è arricchito da due maestose
sculture laterali e da bassorilievi; all'interno il palazzo conserva tra le
più rilevanti "scale
alla trapanese"
di Sicilia.
Costruito
dal Barone Pietro Scaduto, Giurato della Città, diventò di proprietà dei
Baroni Bosco, alla fine del Settecento, in via ereditaria. Nel 1816,
il Barone Biagio Lipari costruisce un corpo di casa fra il vicolo Cuscè e
la via Catania, a fianco del Palazzo Bosco. Il Barone Antonino, figlio di
Biagio, acquista dai Bosco il palazzo e l'area circostante e inoltre diventa
proprietario della casa beneficiale Cuscè, attigua al palazzo. Nel 1826,
amplia il palazzo inglobandovi la casa costruita dal padre e la casa Cuscè
costituendo un nuovo corpo, in via Cairoli.
Lo
stemma della famiglia Lipari, il leone rampante ai piedi di un albero, è
scolpito nella chiave di volta della porta d'ingresso della via Cairoli. Il
palazzo viene ereditato dal nipote Giuseppe, che nel 1891 lo
ristruttura in occasione del matrimonio della figlia con il Barone Giaconia.
 PALAZZO
RUSSO - Il
Palazzo Russo è un esempio di architettura del Settecento, con portale ad arco
a tutto sesto in
pietra arenaria con
alla sommità l'aquila rampante dello stemma nobiliare. All'interno vi è
una loggia che risale sicuramente ad un'epoca precedente. Il palazzo fu
ultimato nel 1775 come
testimonia la data incisa su una pietra sottostante il tetto. L'edificio fu
costruito dal Barone Armao e acquistato dal Cavalier Giovanni Russo in
occasione del suo matrimonio con Remigia Catania, circa un secolo dopo. PALAZZO
RUSSO - Il
Palazzo Russo è un esempio di architettura del Settecento, con portale ad arco
a tutto sesto in
pietra arenaria con
alla sommità l'aquila rampante dello stemma nobiliare. All'interno vi è
una loggia che risale sicuramente ad un'epoca precedente. Il palazzo fu
ultimato nel 1775 come
testimonia la data incisa su una pietra sottostante il tetto. L'edificio fu
costruito dal Barone Armao e acquistato dal Cavalier Giovanni Russo in
occasione del suo matrimonio con Remigia Catania, circa un secolo dopo.
PALAZZO
SALAMONE-GIACONIA - Il
Palazzo Salamone-Giaconia, esistente già nel Seicento e
ristrutturato nel 1865,
è caratterizzato da sculture e bassorilievi in mensole, chiavi di volta e
lo stemma della famiglia nel portale. Si affaccia sulla Piazza Concordia,
totalmente in muratura, con un'alta scala in monoblocchi di pietra arenaria.
PALAZZO
FAILLACI, nato
nella prima metà dell’800, colpisce per il suo rapporto con la via Libertà
e le quattro lunette sulla facciata, arricchite da Noè Marullo, che
raffigurano le allegorie delle arti.
Ogni
palazzo racconta una storia unica, unendo l’arte e la storia in
un’esperienza affascinante.
PALAZZO
PASSARELLO - Il
Palazzo Passarello, situato sulla via principale, è stato edificato nel 1865 dalla
famiglia Passarello Giaconia, con un pregevole portale neoclassico.
PALAZZO
GALLO si
distingue per i suoi balconi fregiati con maschere teatrali, simbolo della
cultura nobiliare.
FONTANA
SAN VINCENZO - Adiacente
alla chiesa di San Vincenzo nello spiazzale denominato "Largo
Progresso", nel 1875 fu
costruita una fontana in pietra, dal mastro scalpellino Vincenzo Arcieri, il
quale appaltò i lavori di costruzione dell'acquedotto. Dalla fontana non
sgorga più acqua, ma è possibile ammirare il mirabile lavoro realizzato
dall'artigiano mistrettese.
FONTANA
PALO - La
città di Mistretta essendo in montagna è ricca di acqua che sgorga in
molte fontane e confluisce nell'acquedotto comunale. Nel quartiere
"Palo" chiamato così perché nel "Largo Buonconsiglio"
durante il Seicento venivano
"messi al palo", cioè impiccati i dissidenti, vi è una maestosa
fontana.
Questa
fontana venne costruita nel 1860 dai
maestri scalpellini locali e dai fratelli Pellegrino. Oggi si alimenta
tramite l'acquedotto comunale, ma in passato era e collegata attraverso un
sistema idraulico alle sorgenti dette "Virdicanne".
FONTANA
DEL SANTISSIMO ROSARIO - Vicino
alla chiesa del Santissimo Rosario, definita e pavimentata tra il 1868 e
il 1870 in
seguito ad un riassetto urbanistico della città, vi era una fontana in
pietra, eseguita dagli scalpellini Giaimo e Cannata riutilizzando pezzi
provenienti dalla "Fontana del Fruscio", prima sita nella P.zza
Vittorio Veneto.
La
fontana negli anni
sessanta fu
spostata di qualche centinaio di metri per facilitare il percorso delle
macchine che diventavano sempre più numerose.
Villa
Garibaldi

Nel 1873,
il terreno antistante al monastero dei Padri
Cappuccini trasformato
in carcere, divenne di proprietà del comune che ne delimitò il perimetro
con mura di cinta in pietra ed inferriate in ferro battuto. La Villa fu
dedicata a Garibaldi,
collocandovi un suo busto marmoreo scolpito dall'artista mistrettese Noè
Marullo.
La
"Villa Garibaldi" s'ispira allo stile italiano che deriva dal
modello del giardino medievale, circondato da alte siepi di disegno
geometrico. Il comune acquistò a Palermo numerose piante, anche rare e
particolari, che andarono ad affiancare quelle già presenti sul posto e
curate dai frati. Vi sono anche alberi secolari che imponenti spiccano in
questa oasi di verde nel cuore della cittadina.
Luoghi
d'interesse naturalistico
La valle delle cascate di
Mistretta è un angolo di paradiso,
situato a pochi chilometri dal centro di Mistretta che accoglie con il suono
rilassante dell’acqua che scorre tra le rocce.
Qui,
tre torrenti hanno dato vita a una serie di cascate di varie dimensioni,
creando uno scenario davvero unico. La più grande di queste cascate,
situata in contrada Pietrebianche, raggiunge addirittura i 33 metri di
altezza. E non è l’unica: nel raggio di meno di 500 metri, potrai
ammirare altre sei cascate, ognuna con la sua particolare bellezza.
Ma
la valle delle cascate di Mistretta non è solo questo. Più a valle, dove i
due torrenti principali si uniscono, si trovano altre due cascate che formano
alla base delle ampie vasche. Un vero spettacolo da non perdere!
La
primavera è il momento migliore per visitare la valle: l’acqua invernale
ha lasciato il segno e la natura si risveglia in tutto il suo splendore.

URIO
QUATTROCCHI - Posto
a quota 1.030 metri sul livello del mare, in zona “B” all'interno del
parco dei Nebrodi. Si tratta di un laghetto che ricade nel territorio di
Mistretta, alle pendici del monte
Castelli. Si trova
in una posizione strategica, in quanto collocato all'inizio della dorsale
dei monti Nebrodi, in un percorso di circa 70 chilometri che unisce il
territorio di Mistretta con quello di Floresta.
Il
laghetto è circondato da distese di boschi di faggio (Fagus sylvatica).
Nelle zone limitrofe, dalla primavera sino al tardo autunno, si rivestono di
colori lussureggianti e di diverse essenze. Alla tipica vegetazione xerofila
si aggiungono specie appartenenti alle graminacee, leguminose e alle
composite, tra cui l'endemico cardo di Valdemone.
 Piccoli
mammiferi, donnole, martore e volpi predano occasionalmente nei dintorni del
laghetto. L'avifauna nebroidea è una delle più ricche di Sicilia. Tra le
specie più curiose annoveriamo cicogne bianche e nere e cormorani, attirati
dall'abbondante presenza di pesce. Morette, fischioni, marzaiole e codoni
fanno da cornice al paesaggio del lago. Piccoli
mammiferi, donnole, martore e volpi predano occasionalmente nei dintorni del
laghetto. L'avifauna nebroidea è una delle più ricche di Sicilia. Tra le
specie più curiose annoveriamo cicogne bianche e nere e cormorani, attirati
dall'abbondante presenza di pesce. Morette, fischioni, marzaiole e codoni
fanno da cornice al paesaggio del lago.
CASCATE
DI CIDDIA - Queste
cascate, ben nove, sono maggiormente visibili nel mese di Marzo, quando lo
scioglimento della neve ne alimenta il corso. La più alta, la
Pietrebianche, di ben 35 metri, è la maggiore, insieme con la Cascata
Occhialino di Caronia,
presente sui Nebrodi. Le cascate di Ponte Ciddia e Cuttufa scorrono anche in
estate.
Feste
FESTA
DI SAN SEBASTIANO - La
festività di san
Sebastiano è
celebrata dal mondo occidentale il 20 gennaio e dal mondo orientale il 18
dicembre. A Mistretta il culto del santo sembra sia stato introdotto
nell'anno 1063,
ma la devozione a san Sebastiano si accrebbe tra 1625 e
il 1630,
quando s'invocò la sua intercessione per fermare la terribile epidemia di
peste che affliggeva tutta la Sicilia. La festa di San Sebastiano di
Mistretta è considerata una delle più belle, suggestive e sentite
processioni di tutta la Sicilia.
 A
Mistretta la festa del santo si svolge due volte l'anno, proprio il 20
gennaio, la data in cui la chiesa ricorda la morte di San Sebastiano e il 18
agosto per ricordare la liberazione dalla peste di Mistretta avvenuta per
intercessione di San Sebastiano nel Diciassettesimo Secolo. A
Mistretta la festa del santo si svolge due volte l'anno, proprio il 20
gennaio, la data in cui la chiesa ricorda la morte di San Sebastiano e il 18
agosto per ricordare la liberazione dalla peste di Mistretta avvenuta per
intercessione di San Sebastiano nel Diciassettesimo Secolo.
A
gennaio la festa si svolge in tono minore, ma si tratta ugualmente di un
giorno solenne, molto sentito. La statua del santo esce dalla chiesa e viene
portata in giro per le vie del paese nel prezioso fercolo (vara), di
corsa in diversi tratti, sulle spalle di decine di uomini, che vestono in
abiti tradizionali, pantaloni in velluto e gilet, con il tipico fazzoletto
rosso.
Invece, è in agosto che la processione raggiunge gli apici di
folklore e religiosità. La pesante vara in legno massiccio
e oro su cui è posta la statua del Santo è portata a piedi scalzi da circa
80 devoti che ricevono il privilegio di portare il fercolo per eredità,
tramandato dai padri, ed è preceduta nella sua corsa per tutta la
processione, dalla varetta, un fercolo in cui due angeli,
circondati da ceri votivi, sorreggono le reliquie di San Sebastiano che
vengono portate in processione dai devoti più giovani. La processione tocca
i luoghi più significativi della città con diverse tappe in essi.
Tutto
il popolo corre dietro San Sebastiano per le vie del centro storico. In
occasione del 18 agosto la città si riempie di gente venuta da fuori per
vedere la festa, attirata dallo sfarzo e dalla grandiosità.
La
festa si chiude la notte quando il santo viene ricollocato nella sua chiesa
dopo una lunga corsa, tra applausi, pianti, invocazioni e musica che lo
salutano. La serata si chiude sempre con giochi pirotecnici suggestivi e
spettacolari. Moltissime persone dopo la processione si recano al Castello
Saraceno, situano nell'omonimo molte, ad aspettare "l'Alba",
simbolo della fine della festa e dell'estate.
FESTA
DELLA MADONNA DELLA LUCE - La
festa si celebra ogni anno per due giorni nelle date del 7 e dell'8
settembre. La modalità di svolgimento della festa è curiosa e
caratteristica, una coppia di guerrieri giganti chiamati "Cronos"
e "Mitia" seguono la statua della Madonna trasportata per le vie
della città. I giganti sono di cartapesta e vengono portati a spalla per le
vie del paese già molti giorni prima della festa ballando e raccogliendo le
offerte. La statua della Madonna è custodita nella Chiesa del cimitero,
fuori città, dove vi è un'antichissima immagine dipinta su una roccia
sopra la quale è stata costruita la chiesa. La leggenda narra che per caso
venne scoperta l'immagine sacra e che vicino ad essa vi fossero delle ossa
umane di dimensioni fuori dal comune, appunto i giganti posti a guardia
della Madonna.
Il
primo giorno la statua della Madonna "esce" dalla chiesa per
salire nel paese incontrandosi ad un certo punto con i giganti che
l'affiancano facendole la guardia per tutto il tempo. Emozionante l'incontro
tra i giganti e la Madonna, infatti nel momento dell'incontro i giganti si
inginocchiano e fanno un inchino a Maria in segno di riverenza.
La
Madonna e i giganti vanno poi nella Chiesa Madre di Mistretta e sul piazzale
antistante alla Chiesa, i giganti ballano per festeggiare l'arrivo della
Madre Santa.
Il
giorno dopo, Mitia e Cronos si affiancano alla statua della Madonna portata
anch'essa in spalla da uomini robusti e la scortano per tutto il percorso
della processione. Il simulacro risale al Seicento e raffigura Sant'Anna che
regge in mano la Madonna bambina. Il popolo in massa prende parte alla
processione.
Alla
sera, dopo avere attraversato le vie del paese illuminate da luci colorate,
la processione si avvia lungo la strada di campagna che porta alla Chiesa
del Cimitero dove si arriva in tarda serata. Giunti in Chiesa, dopo la lunga
processione, la statua rientra per essere ricollocata al suo posto e i
giganti ballano per l'ultima volta illuminati da un grande falò,
ritirandosi infine tra gli applausi di tutti.

- Fonte
- https://it.wikipedia.org
|