|
Sorge
su un colle bivertice roccioso prospiciente il litorale
ionico e
conserva vestigia di origine medievale, rinascimentale e barocca.
Il
comune di Savoca ha un'estensione di circa 8 km². L'abitato è
costituito da un centro
storico e da
tante frazioni più o meno piccole immerse nella campagna.
Sulle
origini della cittadina di Savoca esistono varie congetture.
1.
Secondo la prima, proposta da Agatino Ajello, il primitivo centro abitato di
Savoca ebbe origine in epoca
tardo-antica, IV-V
secolo d.C. In
quegli anni le prime incursioni
barbariche dei Vandali resero insicura la vita sul litorale ionico,
ove sorgeva Phoinix, villaggio ubicato presso la foce del torrente
Agrò (ove
sorge Santa
Teresa di Riva)
abitato da agricoltori e pescatori, che, nell'estate del 36 a.C. aveva dato
ospitalità all'esercito di Sesto
Pompeo prima
della battaglia
contro Ottaviano. Quindi sembrerebbe che, tra il 365 e il 410 d.C., il villaggio di Phoinix si spopolò fino a scomparire e i suoi abitanti diedero origine al più
sicuro sito di Pentefur, che fu il primo nucleo abitativo di Savoca.
2.
La seconda teoria vuole che l'origine di Savoca/Pentefur sia ascrivibile
sempre agli abitanti di Phoinix,
ma nel I
secolo a.C. Parrebbe
che Ottaviano abbia distrutto Phoinix per punire l'ospitalità data da questa alle armate di Sesto
Pompeo; gli abitanti
superstiti avrebbero deciso di fondare uno nuovo abitato in un sito
collinare più salubre, ubicato ove oggi sorgono le rovine dell'omonimo
castello e il
quartiere del centro storico ancora nominato "Pentefur". Potrebbe
sembrare condivisibile anche l'opinione di alcuni storici locali moderni,
secondo la quale Pentefur sarebbe stata l'arx, cioè l'acropoli,
della città di Phoinix.
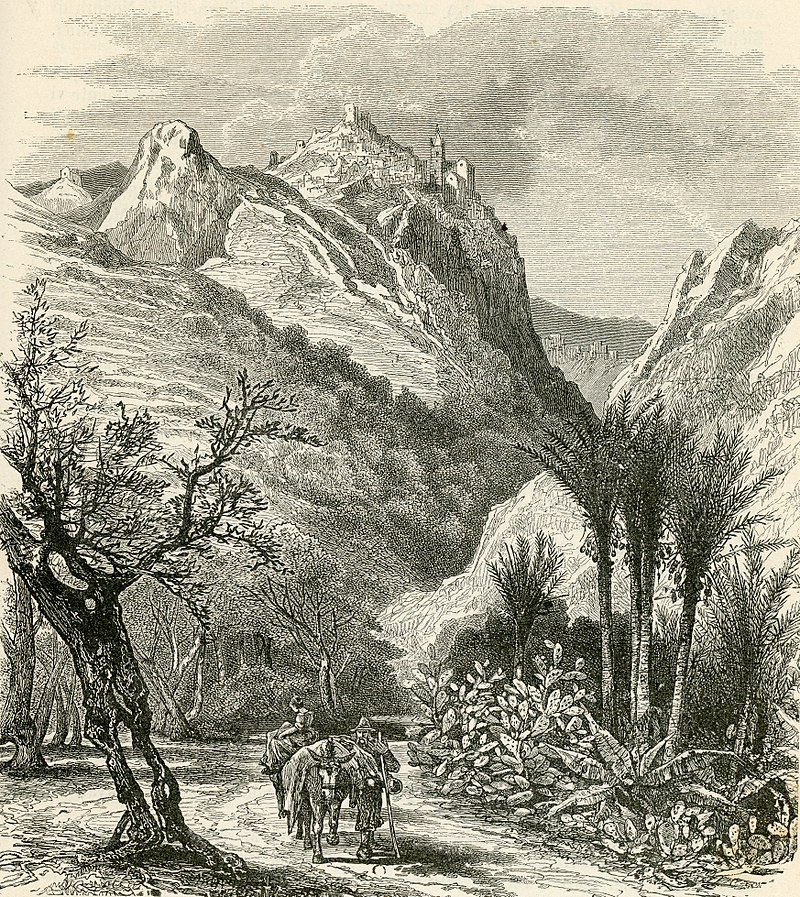 3.
Nel 1936, padre Basilio Gugliotta da Naso e
padre Giampietro Rigano da Santa Teresa di Riva, frati cappuccini che
abitarono nel convento
di Savoca,
sostenevano che i Pentefur fossero un gruppo di persone
venuto dalla città di Phoinix, in un periodo in cui, per un motivo o per un altro, la vita sul litorale
non era più sicura e agevole. Il toponimo Pentefur deriverebbe quindi dal
patronimico Punctifur che stava probabilmente a indicare il
nome di un eroe o capopopolo o di un qualche gruppo sociale. 3.
Nel 1936, padre Basilio Gugliotta da Naso e
padre Giampietro Rigano da Santa Teresa di Riva, frati cappuccini che
abitarono nel convento
di Savoca,
sostenevano che i Pentefur fossero un gruppo di persone
venuto dalla città di Phoinix, in un periodo in cui, per un motivo o per un altro, la vita sul litorale
non era più sicura e agevole. Il toponimo Pentefur deriverebbe quindi dal
patronimico Punctifur che stava probabilmente a indicare il
nome di un eroe o capopopolo o di un qualche gruppo sociale.
4.
Secondo lo storico siciliano Tommaso
Fazello, Savoca ebbe
origine solo nel XII
secolo, quando Re Ruggero
II di Sicilia,
"accozzando insieme alcuni villaggi saraceni" istituì un
nuovo feudo, fondandone dal nulla il capoluogo sul colle bivertice di
Pentefur.
5.
Una poco verosimile leggenda popolare, di origine medievale, narra che
Savoca venne fondata da cinque ladroni (pente dal greco cinque,
e fur dal latino ladro) che evasi dal carcere della vicina
Tauromoenium, trovarono sicuro rifugio sul colle bipartito ove sorge il centro storico
di Savoca, e da lì iniziarono le loro scorrerie per le contrade vicine.
6.
Infine, secondo recenti studi, in toponimo "Pentefur" deriverebbe
da "pente" = cinque e "fulè" = quartiere, quindi cinque quartieri,
per il fatto che l'originario abitato di Savoca, attorno all'VII
secolo era
ripartito in cinque quartieri. Detta recente teoria collocherebbe la nascita
di Pentefur alias Savoca ad un periodo compreso tra la tarda
età antica e
il IX
secolo d.C. A
tutt'oggi, l'assenza di ritrovamenti archeologici non consente di stabilire
quale delle suesposte teorie sia corrispondente alla realtà storica dei
fatti.
La
rocca di Pentefur venne conquistata
dagli islamici nell'827
e successivamente fu annessa all'Emirato
di Sicilia,
rimanendovi fino al 1072. Sembrerebbe che il nome Siculo
arabo dato al piccolo centro fosse "Kalat Zabut" (Rocca del sambuco, dal nome della pianta che cresce rigogliosa su quelle alture) anche se in
alcune mappe e documenti risulta la denominazione "Balm",
da Palma. Venne riadattata l'antica
fortezza di Pentefur che
mantiene ancora il primitivo nome. Dal momento in cui Savoca entrò a far
parte dell'Emirato
di Sicilia, conobbe
il suo primo periodo di sviluppo, vennero introdotte le coltivazioni degli agrumi, della melanzana, della canna
da zucchero, del cotone e
dell'albicocco e
l'allevamento del baco
da seta.
Lo
sviluppo di Savoca aumentò a partire dall'XI
secolo, quando la
cittadina entrò a far parte prima della Contea
di Sicilia e
poi del Regno
di Sicilia. Venne
rinominata "Sàbuca" (termine tardo-latino che sta ad indicare la
pianta del sambuco) e munita di una cinta muraria dotata di due porte d'accesso di cui una
ancora esistente. In anni recenti, qualche studioso di storia locale ha
voluto dare una diversa origine etimologica del toponimo "Savoca",
sostenendo che esso derivi dal Siculo
arabo "As-Sabuqah"
che andrebbe tradotto come "sella" oppure come "luogo difficilmente accessibile".
Nel
1139,
il re
di Sicilia Ruggero
II istituì una Baronia,
detta "Universitas Sabucae" o "Terra di Savoca", ponendo
sotto la sua giurisdizione politica, religiosa e giudiziaria tutti i centri
abitati compresi tra il torrente
Agrò ed il
torrente Pagliara (inclusi i villaggi di Misserio, Locadi e Pagliara) e tra il mare
Jonio e la linea spartiacque della catena dei monti Peloritani.
Tale territorio, venne donato in feudo all'Archimandrita
di Messina, il quale
possedeva personalmente 24 dei 48 feudi in cui la Terra di Savoca era
ripartita e, da signore feudale, vi esercitava i poteri di "mero
e misto imperio",
nominando e facendo eleggere alle cariche
di governo della
città persone
di sua fiducia; inoltre gli abitanti di Savoca erano obbligati a diverse
prestazioni a vantaggio del loro signore feudale, come il pagamento di una
tassa annua sulla casa.
Il primo signore della Terra di Savoca fu l'archimandrita
messinese LucaI,
abate basiliano.
Nella prima metà del XII
secolo si
edificò, su preesistente struttura, la Cattedrale
siculo-normanna dedicata alla Madonna Assunta,
la quale si conserva ancora pur avendo subito una consistente modifica
strutturale nel XV
secolo.
Al
1150 risale la prima citazione ufficiale dell'abitato di Savoca, ad opera
del geografo siculo-arabo Idrisi col nome di "Sant'ili". Altri documenti coevi o più
risalenti appellano questo centro abitato col nome di Balm (=
Palma: Phoinix). Un altro antico documento che parla di Savoca risale al XII
secolo, è custodito
nell'Archivio
Vaticano, si tratta
di un documento fiscale denominato "Collectoria".
Nel
corso del Duecento Savoca
si arricchì di almeno due edifici sacri (la Chiesa
di San Michele e
la Chiesa
di San Nicolò);
prese parte alla Quinta
Crociata e, nel 1282, partecipò ai Vespri
siciliani. Durante
la Guerra
del Vespro, contro i
nemici angioini, Savoca fornì al Regno
Siciliano venti arcieri per la difesa della strada tra Messina e Taormina.

Nell'autunno
del 1347 anche a Savoca (proveniente da Messina) si propagò il flagello della peste
nera che cagionò
gravissime perdite tra la popolazione residente e frenò l'ascesa economica
della città. Nel corso (o alla fine) di questo frangente
epidemico, il 30
novembre 1355, pochi mesi dopo la sua ascesa al trono, re Federico
IV di Sicilia, elevò
il Castello
di Pentefur a
"Castello Regio",
sottraendolo di fatto al controllo politico degli Archimandriti
messinesi e
attribuendolo al nobile messinese Guglielmo Rosso Conte d'Aidone; con
"lettera patente", il giovane monarca siciliano ordinò, all'archimandrita Teodoro
e ai sindaci
e giurati della città di
recarsi al Palazzo della Curia di Savoca per giurare fedeltà al nuovo capitano
del castello;
secondo documentate testimonianze i suddetti notabili e ufficiali si
rifiutarono di obbedire al re.
Nel periodo in cui il Pentefur fu "Castello Regio", si avvicendarono come castellani alcuni esponenti della nobiltà militare siciliana. Successivamente, a
partire dal 1386, con l'Archimandrita Paolo III, il Castello
di Pentefur tornò
definitivamente sotto il controllo dell'Archimandritato
messinese, non
risultando più nel novero dei "Castelli Regi".
Per sopperire alle gravi perdite umane dovute alla peste
nera, la città, durante tutta la seconda metà del XIV
secolo, fu soggetta
a un lento ma costante ripopolamento che fu alla base della ripresa che
caratterizzò i due secoli successivi.
All'inizio
del Quattrocento,
la cittadina di Savoca entrò in una nuova
fase di sviluppo economico
e demografico. In questo periodo si stabilirono nella cittadina collinare,
provenienti da Messina, esponenti della piccola nobiltà e dell'alta borghesia, come i Bucalo, i
Trimarchi, i Crisafulli e i Trischitta. Provenienti dal Catanese erano le ricche famiglie dei Toscano e dei Nicòtina.
Lo
stesso Archimandrita
messinese Luca
IV de Bufalis, tra il 1421 e il 1450, accompagnato da tutta la sua corte, si
trasferì in Savoca, ritenuta più salubre di Messina.
Nel 1468, papa
Paolo II istituì
una minuscola diocesi
archimandritale, con
capoluogo Savoca, comprendente i territori di Casalvecchio, Pagliara, Locadi, Antillo, Misserio, Forza
d'Agrò, Mandanici, Alì, Itala, San Gregorio e Sant'Angiolo.
Nella seconda metà del Quattrocento la
cittadina conobbe, su iniziativa dell'Archimandrita Leonzio II Crisafi, un certo incremento edilizio. Venne ampliata e
ristrutturata, per opera dell'architetto savocese messer Pietro Trimarchi
(1465-1534), la Chiesa
di Santa Maria in Cielo Assunta.
Subirono analoghi interventi di ampliamento anche la chiesa
di San Nicolò e
la chiesa
di San Michele.
Il Castello
di Pentefur venne
restaurato e ampliato; l'abitato, che fino allora era abbarbicato al colle
bivertice di Pentefur,
si espanse sensibilmente. Nacquero così, fuori dalla cinta muraria, due
nuovi quartieri: "lu Burgu" (il Borgo) con svariate ed eleganti
abitazioni appartenenti alle famiglie più agiate, e
"Sant'Antonio", con l'omonima chiesetta oggi scomparsa.
Infine, tra il 1444 e il 1456, presso piazza Fossìa, si eressero la chiesa
dedicata a Santa
Lucia e
l'annesso convento Domenicano (crollati
per una frana nel 1880) ove prese i voti e studiò il religioso savocese
mons. Domenico
Casablanca che
fu poi vescovo
di Vico Equense.
Nel
1487, a dimostrazione della vitalità dei commerci, venne istituita a Savoca
la "Fiera annuale della Beata Vergine Maria della Misericordia",
presso la quale gli scambi commerciali avvenivano senza il pagamento del
consueto sistema daziario. Fu in quegli anni che la cittadina collinare
superò i quattromila abitanti.
Durante il XIV e il XV secolo nell'area di Savoca (e di buona parte del
messinese) era diffusa, da almeno quattro secoli, la coltivazione della canna
da zucchero il
cui (allora raro e prezioso) frutto veniva esportato dal Regno
di Sicilia nella penisola
italica e in
Europa; lo zucchero siciliano impressionò anche Lorenzo
il Magnifico che
lo ritenne, insieme con l'ambrosia, una delle due cose più dolci del mondo .

Fino
al 1492, nella Terra di Savoca era presente una consistente comunità
ebraica: non sono
ben chiare le origini di detta comunità nel territorio, esistono però
documenti, risalenti al 1409 e al 1470, dai quali si evince che, in quegli
anni, vi dimoravano circa
250/300 ebrei, ripartiti in circa 50/60 famiglie.
I giudei savocesi erano soprattutto abili tessitori e tintori e non
mancavano quelli dediti alla lavorazione del ferro e della seta e
alla coltivazione della canna
da zucchero e
della vite.
Il gruppo più numeroso di ebrei era dislocato nel centro abitato di Savoca
e in quello vicino di Casalvecchio, ove esiste ancora una via del centro storico nominata "Strada della
Judeca". Di tale comunità giudaica facevano parte anche persone
economicamente agiate, ciò si evince dal fatto che, nel marzo 1492, quando
venne emanato l'editto
di espulsione da
parte di re Ferdinando
II, i notabili savocesi del tempo non si fecero scrupoli per accaparrarsi più
ricchezze possibili tra quelle confiscate agli ebrei.
Nel centro storico, accanto alla duecentesca chiesa
di San Michele,
esistono ancora i ruderi di quella che fu la Mischita, ossia la sinagoga di Savoca. Anche nella toponomastica e nei cognomi
locali sono rimaste evidenti tracce di questa presenza ebraica.
Tra
i primi anni del XV
secolo e la fine del XVII, Savoca era nella sua fase di maggior sviluppo e
prestigio, essendo (insieme a Taormina) la città più importante nel territorio compreso tra la Scaletta e
il fiume
Alcantara: arrivò a
contare, nel censimento del 1540, 4.969 abitanti. Catania, nello stesso censimento, non superò i trentamila.
La cittadina godeva di una rilevante vitalità politica nel territorio del Val
Demone, ne sono
prova le ambizioni di autonomia da Messina che,
nel 1567, sfociarono in una controversia di competenza territoriale sull'esercizio
della giurisdizione civile e penale nel Territorio di Savoca tra lo Strategoto
messinese e la Corte
Capitanale savocese.
A partire dal 1583, Savoca venne inserita nella comarca di Taormina, mettendo a disposizione del Regno
di Sicilia una
legione di 72 fanti e 2 cavalli.
Notevole era lo sviluppo delle attività agricole, commerciali e artigianali
come la coltura della vite e del baco
da seta (in quegli anni erano censite nella Terra di Savoca circa venti
filande per la lavorazione della seta). Il vino,
l'olio
d'oliva, e le sete
locali erano famosi e ricercati in tutta la Sicilia e non solo, nel 1541, re Carlo
V ricevette in dono dal Senato
Messinese cento
botti di rosso vino savocese.
Dal
1589 il litorale
costiero sotto la giurisdizione savocese assunse
rilevanza strategico-militare, tanto da essere presidiato da
una guarnigione
militare. Nel 1652, in Savoca erano censite 1.156 case, sorgevano 17 chiese, tre conventi, un
ospedale (ubicato, a detta dello storico Giuseppe
Trischitta, nel
quartiere San Giovanni) e diversi eleganti palazzotti signorili appartenenti
alle famiglie più ricche del paese.
Tra
gli archimandriti messinesi che nei secoli si distinsero per lo sviluppo di
Savoca, spiccano Leonzio II Crisafi (in cattedra dal 1468 al 1503), che
restaurò il Castello
di Pentefur e
la chiesa
matrice, promuovendo la realizzazione di altre opere e Alfonso
d'Aragona (in
cattedra dal 1503 al 1510), che per primo avviò il popolamento e lo
sfruttamento delle allora desolate contrade rivierasche.
Nella
fase di massima espansione territoriale (XVII secolo), sotto la
giurisdizione politico-amministrativa della Terra di Savoca, erano compresi
gli attuali comuni di Savoca, Santa
Teresa di Riva, Furci
Siculo, Casalvecchio
Siculo, Antillo, Roccalumera (in parte) e Pagliara.
Nel 1603 gli abitanti di Casalvecchio riuscirono a conseguire l'autonomia municipale per il loro villaggio
con decreto del Viceré
di Sicilia; tuttavia
le autorità savocesi, grazie al prestigio di cui godevano a Palermo e Messina,
ottennero la cancellazione di detto decreto vicereale e, su decisione della Deputazione
del Regno di Sicilia e
della Corte
Straticoziale, il
casale di Casalvecchio, nel 1608, tornò alle dipendenze di Savoca.

A
partire alla seconda metà del XVI
secolo, il Regno
di Sicilia subì
una progressiva
erosione della sua indipendenza politica,
entrando a far parte di quello che era sempre più un Impero universale, l'Impero
spagnolo; la Sicilia rimaneva pur sempre indipendente, soprattutto da un punto di vista
amministrativo, giudiziario e finanziario, ma la politica estera e quella
militare la sottoponevano alla Spagna.
Dal
canto suo, la Corona di Spagna,
titolare del Trono
dell'Isola, al fine
di neutralizzare il nazionalismo
siciliano acuì
le discordie e le divisioni tra le due maggiori città, soffiando sul fuoco
delle dispute municipalistiche che esistevano tra Palermo e Messina. Era un periodo in cui molti giuristi e intellettuali siciliani auspicavano
la necessità di avere un sovrano
siciliano per
l'isola, al fine di risollevarne le sorti politiche. In buona sostanza i
monarchi spagnoli, prendendo le parti di Messina contro Palermo e viceversa,
non facevano altro che indebolire entrambe le città. Era
questo il clima politico che si respirava in Sicilia nel corso del Seicento e,
nonostante il discreto sviluppo agricolo, artigianale e mercantile, Savoca
subiva questa difficile congiuntura e la sottomissione alla città di
Messina, da cui era, dal 1435, costretta a dipendere per
l'approvvigionamento del grano; quindi i savocesi, non potendosi più rifornire a Randazzo, per far fronte alla carenza di grano, erano costretti a fare affidamento
solo sulle non floride scorte della città dello Stretto.
Nel 1641 il campanile della Chiesa
Matrice cittadina venne
dotato di un mirabile orologio a una lancetta (per le sole ore) che aveva la
particolare e molto rara caratteristica di ruotare in senso antiorario. La
presenza di questo singolare meccanismo di misurazione del tempo non ha
eguali in Sicilia e nel Mezzogiorno d'Itali a.
Negli
anni 1645-1646, la Sicilia fu colpita prima da una gravissima siccità e poi
da piogge fuori stagione che causarono un brusco calo dei raccolti e una
conseguente crisi granaria in tutta l'Isola, le autorità imposero la
diminuzione della pezzatura standard del pane che inevitabilmente portò a
un drastico aumento del prezzo di questo genere di prima necessità. La
popolazione mal tollerò questo provvedimento e, tra la primavera e l'estate
del 1647, scoppiarono a Palermo, Catania e altre città, vasti moti di protesta, capeggiati da Giuseppe
D'Alesi, che
assunsero un carattere prettamente nazionalista. Messina, dotata di una certa autonomia che ne faceva una sorta di
"Repubblica mercantile", essendo in continua disputa
municipalistica con Palermo, non si unì a detti moti. I savocesi, al
contrario, cercarono di prendere parte alle rivolte in chiave indipendentista, antispagnola e antimessinese. Stando a quanto narra Caio
Domenico Gallo,
all'alba di domenica 14 luglio 1647, era prevista un'insurrezione,
capeggiata da tre capipopolo locali: si dovevano prendere d'assalto e
depredare le case dei "cittadini più doviziosi", i cui magazzini
erano pieni di olio, farina, vino e altri generi alimentari. Tuttavia, il
giorno prima della rivolta, una spia mise in guardia le autorità militari e
i promotori vennero catturati e giustiziati nel castello
di Pentefur poche
ore prima dello scoppio del tumulto. Continua ancora Caio
Domenico Gallo scrivendo
che nella "nobile città di Messina" si sparse voce che i "paesani savocesi erano gente audace e
facinorosa"; da allora, su ordine del Senato
Messinese, durante
la notte, le strade e i quartieri di Savoca erano sorvegliati da ronde
continue di soldati.
In occasione della Rivolta
di Messina del 1674, Savoca rimase fedele al re Carlo
II per tutta la prima fase del conflitto; antiche cronache riferiscono
che, il 25 febbraio 1675 le
milizie savocesi, dopo una giornata di combattimenti, riuscirono a
respingere l'attacco sferrato dai ribelli messinesi al territorio municipale
di Savoca.
Tuttavia, il 3 novembre 1676, due mesi dopo la caduta
di Taormina e Scaletta in mano francese e, dopo le devastazioni perpetrate dai messinesi
nella vicina Fiumedinisi; i savocesi, volendo scongiurare un violento assalto nemico alla loro città,
si arresero ai francesi e alla ribelle Messina (che a questi ultimi aveva
chiesto aiuto contro la Corona di Spagna) concludendo con questi una
vantaggiosa capitolazione. Questo trattato venne stipulato tra una
delegazione di diciassette notabili savocesi, guidata dal Capitano
giustiziere cittadino
don Stefano Trischitta, e il visconte di Vivonne Louis
Victor de Rochechouart de Mortemart,
comandante del contingente transalpino. In base a detta capitolazione i francesi accordarono a Savoca svariati
privilegi politici ed economici, quali l'erezione a capoluogo della Comarca di Taormina (che aveva un territorio che si estendeva dal Capo Scaletta al Fiume
Alcantara e ai paesi
della sua Valle) e
migliori condizioni di vita per i ceti meno abbienti. Tuttavia, dopo la pace
di Nimega, i
francesi si ritirarono da Messina l'8
aprile 1678; gli spagnoli, dopo aver sedato le rivolte e riconquistato la
città dello Stretto, ne decretarono la morte civile e, conseguentemente,
revocarono a Savoca gli effimeri, privilegi concessi dai francesi.
Nel
1693 un catastrofico
terremoto devastò
la Sicilia
sud-orientale,
Savoca venne colpita solo marginalmente; tuttavia, secondo antiche cronache
il terremoto cagionò danni al castello di Pentefur e alla Chiesa
di San Nicolò. Nel
1695, Savoca perse il dominio sui villaggi di Pagliara e Locadi, che divennero municipalità autonome dotate di ufficiali propri.

Con
il trattato
di Utrecht, nel
1713, il Regno di Sicilia cambiò, dopo due secoli, dinastia regnante,
passando dagli Asburgo
di Spagna
ai Savoia, i quali, nel 1718, lo cedettero agli Asburgo
d'Austria; tale
situazione produsse una grave crisi politica sull'isola, che si protrasse
fino al 1734. Nel corso del XVIII
secolo, dal punto di
vista sociale e culturale, Savoca mantenne sempre il suo prestigio,
arrivando a toccare il picco massimo, mai raggiunto prima, di popolazione
residente: 5.145 abitanti nel 1713 e
dando i natali e la prima formazione, a diverse personalità di
intellettuali e artisti come il pittore Filippo
Giannetto; i teologi Padre Antonio da Savoca (n. ? - m. 1751) dell'Ordine
dei Cappuccini e
l'Abate Sac. don Giuseppe Nicòtina (1715-1795) professore di sacra Teologia
in Messina e Palermo;
il Sac. Don Antonino Garufi (1775-1842), poeta di epigrammi in latino e
professore di Filosofia presso il Seminario di Palermo; i
quattro giuristi Filippo Fleres (1686-1750), autore di pubblicazioni in materia
amministrativa e fiscale e giudice del Tribunale
del Concistoro
del Regno
di Sicilia nell'anno 1743, Giuseppe Trimarchi (1729-1784), giudice della Corte Pretoriana di Palermo
nel 1767-68, del Tribunale del Concistoro negli anni 1775-76-77 e della Gran
Corte civile nel 1784,
Filippo Trischitta (1761-1826), Giudice del Tribunale della Regia Udienza di
Messina e Pasquale Cicala (1769-1826) che oltre a ricoprire le cariche di
Giudice della Gran Corte Civile di Messina e docente universitario, ebbe
fama di "celebre letterato";
il filologo sac. don Antonino
Puliatti, Accademico
dei Pericolanti,
fondatore e docente, di una scuola di latino e belle lettere a
Savoca;
il prof. Matteo
Procopio, Docente di
letteratura presso l'Accademia Carolina di Stoccarda e
traduttore di numerosi autori tedeschi;
il poeta in lingua
siciliana Vincenzo
Cardile; il medico e
accademico prof.
Carmelo
Pugliatti e il
di lui fratello, il sacerdote e filosofo don Vincenzo Pugliatti (1785-1861).
Lo
sviluppo economico, sociale e culturale consentì anche a Savoca la
costituzione di enti sociali di beneficenza: il sac. don Vincenzo Giannetto
(1698-1758) con testamento datato
28 marzo 1758 istituì un Monte
frumentario con
un capitale di cento onze;
qualche decennio più tardi, nel 1838, Vincenzo Maria Trischitta (1772-1852)
istituì un altro Monte
frumentario a
sostegno dei contadini poveri del paese.
Nell'estate
del 1743, un'epidemia di peste,
propagatasi da Messina, infettò anche Savoca e le sue contrade cagionando numerosi decessi. Nel
1795 il grosso centro di Casalvecchio si emancipò dal dominio savocese, costituendosi comune autonomo. Alla
fine del Settecento iniziò il declino della cittadina collinare, che iniziò
lentamente a spopolarsi a favore dei centri rivieraschi.

Nel
1810, sul proprio territorio comunale, sulla riva sinistra della fiumara
d'Agrò, Savoca ospitò un campo militare dell'Esercito
britannico avente
il compito di impedire, nel Regno
di Sicilia, alleato
della quinta
coalizione antinapoleonica,
possibili sbarchi e invasioni degli eserciti nemici provenienti dal Regno
di Napoli di Gioacchino
Murat.
Nel 1812 venne promulgata la nuova
Costituzione del Regno
di Sicilia che,
all'avanguardia nel panorama giuridico europeo, abolì il feudalesimo nell'isola: ciò comportò la fine del mero
e misto imperio degli Archimandriti
messinesi sulla
cittadina di Savoca.
Tuttavia,
l'8 dicembre 1816, dopo più di sei secoli di indipendenza, il Regno di
Sicilia venne soppresso da Ferdinando
III di Borbone e
accorpato al Regno
di Napoli, generando
il Regno
delle Due Sicilie;
ciò produsse un'onda di forte malcontento nel popolo siciliano. Nel 1817,
con la soppressione delle Comarche
siciliane, il nuovo
Stato stravolse l'antica ripartizione amministrativa della Sicilia e Savoca venne inglobata nel distretto
di Castroreale,
diventando capoluogo dell'omonimo
circondario: uno dei
27 circondari in
cui la
neonata Provincia
di Messina era
ripartita. Nonostante tutto ciò, cominciava la decadenza economico-politica
di Savoca. Dal 1º ottobre 1818 la Terra di Savoca diventò il Comune di Savoca governato da un sindaco di nomina governativa (l'ultimo Archimandrita a
esercitare il mero
e misto imperio fu Emanuele
II De Gregorio).
In
occasione dei moti
siciliani del 1820-1821,
in Savoca si registrarono dei gravi tumulti popolari promossi e organizzati
da alcuni
nazionalisti antiborbonici appartenenti alla borghesia e al notabilato locali, come
Angelo Caminiti, Nunzio Cuglitore, il notaio Luigi Trischitta e l'abate don
Antonino Garufi. Dette sommosse si verificarono tra il 23 e il 30 luglio
1820 e videro una consistente partecipazione popolare. In quell'occasione,
gli abitanti delle borgate rivierasche, soprattutto contadini, operai e
pescatori, esasperati anche dalla pesante pressione fiscale imposta
dall'amministrazione savocese, assalirono il centro storico, devastarono il
Palazzo municipale e la sede del Regio Giudicato, espugnarono il carcere
liberando i detenuti, incendiarono l'antico archivio cittadino e misero a
soqquadro le residenze private del sindaco Domenico Scarcella, del giudice
circondariale, del cassiere
comunale e
degli arcipreti del paese. Il processo che ne seguì si concluse con la
totale assoluzione (per carenza di prove) degli organizzatori, ma vide la
condanna a pene severe nei confronti di diversi popolani che con convinzione
avevano partecipato alle sommosse.
Tra
il 1820 e il 1830, in Savoca, si esercitavano ancora ben 25 mestieri, i più
diffusi erano: tintore, murifabbro, mulattiere, mugnaio, ferraio, calzolaio,
bracciale, bottaio, aromatorio; nello stesso periodo, esistevano, altresì,
alcune professioni femminili, quali filandaia, tessitrice, levatrice e
faticatrice; nel 1831 la popolazione era scesa a 3.285 unità.
Dal 1846, anche il villaggio di Antillo si separò da Savoca, diventando comune autonomo.
La
mattina del 25 dicembre 1847, per le vie di Savoca, comparvero affissi dei
manifesti che recavano il seguente proclama: "Fratelli, l'ora è
sonata! All'armi! All'armi!", poche settimane dopo, il 12 gennaio 1848,
la Sicilia intera si sollevò contro il Regno delle Due Sicilie, autoproclamandosi
indipendente e
restaurando l'antico Parlamento
siciliano. Anche
Savoca prese parte alla Rivoluzione
siciliana del 1848;
sotto la guida di alcuni personaggi del notabilato locale, come Giuseppe
Caminiti (figlio del succitato Angelo Caminiti), il sacerdote Vincenzo
Trimarchi, il notaio Carmelo Salvadore, il sacerdote Domenico Altadonna, il
notaio Vincenzo Saverio Fleres, il chirurgo Innocenzo Fleres, il medico
Vincenzo Toscano e il possidente Giuseppe Cacopardo, i quali, oltre
all'intento rivoluzionario
e nazionalista,
erano decisi a scalzare dal potere le vecchie famiglie aristocratiche e
filo-borboniche presenti a Savoca.
Detta Rivoluzione indipendentista venne violentemente repressa dall'Esercito
del Regno delle Due Sicilie dopo
16 mesi di guerra, tuttavia i promotori poterono godere di generale amnistia.
Il
17 marzo 1851, il decurionato savocese, convocato a Messina presso la sede dell'Intendenza
Provinciale Messinese,
deliberò a maggioranza (6 voti contro 4) il nulla
osta all'autonomia
comunale di Santa
Teresa di Riva.

Anche
se in misura ridotta rispetto al passato, durante tutto il XIX
secolo la
cittadina di Savoca continuò a godere di un discreto prestigio sociale e culturale; tra
gli intellettuali di maggior rilievo di questo periodo il medico prof. Santi
Scarcella (1817-1878), allievo e successore di Anastasio
Cocco nella
cattedra di Farmacologia presso l'Università di Messina; il prof. Michele
Crisafulli
Trimarchi (1826-1903)
primo preside della Facoltà di Medicina dell'Ateneo
messinese e il
prof. Giuseppe Crisafulli Trimarchi (1819-1887) che fu maestro di Tommaso
Cannizzaro e
poi preside della Facoltà di Lettere della stessa Università.
Nel
1854 le borgate rivierasche di Furci, Bucalo, Porto Salvo e Barracca si
separarono dall'amministrazione savocese dando origine al comune di Santa
Teresa di Riva. Allo
stesso periodo risale la crisi della viticoltura e
della bachicoltura,
quest'ultima causata dall'annessione della Sicilia al neonato Regno
d'Italia nel
1861: la costruzione della strada rotabile sul litorale ionico (oggi Strada
statale 114 Orientale Sicula) nel
1828 e la realizzazione della ferrovia
Messina-Siracusa nel
1867 tagliarono Savoca fuori dalle principali vie di comunicazione. Tra il
1796 e il 1863 l'arciprete della Chiesa Madre savocese perse, dopo secoli,
la supremazia su chiese, parrocchie e
cappelle dei comuni circostanti. Nel 1855 Savoca cessò di essere capoluogo
del suo
circondario, perdendo le sedi del Regio
Giudicato e del
Carcere che vengono trasferite a Santa
Teresa di Riva,
nuovo capoluogo di Circondario; nello stesso anno chiuse i battenti l'ultima filanda. Tutti questi fattori ebbero come conseguenza l'emigrazione verso i comuni
rivieraschi (soprattutto verso Santa Teresa di Riva), ma anche verso il Nord
Italia o
l'estero; tali flussi spopolarono quasi completamente questo antico centro
collinare.
Ad
aumentare la decadenza influirono anche fattori di carattere naturale. Nel
gennaio 1880, dopo tredici giorni di pioggia intensa, un grande movimento
franoso provocò la distruzione di quasi tutto il quartiere di Sant'Antonio
con l'omonima chiesetta del XVI
secolo e della monumentale chiesa di Santa Lucia con l'annesso convento dei Domenicani del
1465.
A
quanto pare a Savoca non ci furono vittime, ma senza dubbio si verificò una
diminuzione degli abitanti del paese che si trasferirono altrove.
Nel
1884 si procedette alla soppressione della minuscola diocesi archimandritale
di Savoca, costituita nel 1468.
Nel XX
secolo, anche il terremoto
del 1908 contribuì
alla decadenza di Savoca, provocando il crollo del palazzo municipale
(l'antica Curia del XIV
secolo) e
danneggiando la chiesa
madre e la chiesa
di San Nicolò. Nel
1929, si procedette alla soppressione, per opera del regime
fascista, del comune di Savoca e al suo accorpamento a quello di Santa Teresa di
Riva. L'antico paese venne spogliato per mano di una classe politica senza
scrupoli, lo stesso palazzo municipale venne venduto all'asta. Tale
situazione amministrativa si mantenne fino al 1948, allorquando, grazie
all'interessamento del deputato
regionale savocese
avv. Rosario
Cacopardo e a
un provvedimento della Regione
Siciliana, Savoca
riconquistò l'autonomia comunale.
Solo
negli ultimi quarant'anni Savoca sta lentamente vivendo un nuovo periodo di
sviluppo, grazie anche al fatto che dal 1970 è stata scelta come set di
numerosi film e fiction, in primis Il
Padrino di Francis
Ford Coppola. Il
centro storico si sta sviluppando urbanisticamente mediante dei precisi
parametri che mirano a valorizzare il patrimonio architettonico e
paesaggistico presente e numerose strutture ricettive hanno aperto i
battenti. Dal 1997 a Savoca è stato istituito un comando stazione del Corpo
forestale della Regione siciliana.
Dal 2008 Savoca è inserita tra i
borghi più belli d'Italia.
Nel mese di luglio del 2010, il Ministero
per i beni e le attività culturali ha finanziato un
progetto che prevede la ricostruzione virtuale del borgo medievale di Savoca
dalle origini ai giorni nostri, ripercorrendone tutte le fasi storiche.
Visitare il borgo

L'antico e caratteristico centro storico, ricco di antichi monumenti di
origine medioevale, si caratterizza per la presenza di stretti e tortuosi
vicoli ed è suddiviso in sette quartieri:
Sant'Antonio,
quartiere situato nelle immediate vicinanze di piazza Fossìa, limitrofo con
quello del Borgo e con quello dei Cappuccini. Questo quartiere, un tempo
vasto e popoloso, nacque verso la fine del XV secolo, quando il centro
abitato si espanse fuori dalla cinta muraria. Prese il nome dall'antica
omonima chiesa presente al centro del quartiere. Questa borgata, insieme
alla chiesa di Sant'Antonio Abate, venne distrutta da una frana nel 1880.
Rimane ben poco di questo quartiere, tuttavia le porzioni rimaste sono
ancora ben popolate. Dal 1997 vi ha sede il comando stazione del Corpo
forestale della Regione siciliana.
Cappuccini,
è ubicato poco sopra il quartiere Sant'Antonio, prende il nome dal vicinissimo
convento dei padri cappuccini, edificato nel 1603. Conserva
vari edifici di antica origine ed è discretamente popolato.
Borgo,
il cuore nevralgico del centro storico, sorge attorno alla piazza Fossìa,
in tale quartiere si trova il Municipio, il Palazzo Trimarchi del XVIII
secolo, il Bar Vitelli ed altri piccoli e caratteristici esercizi
commerciali. Anche questo quartiere si formò verso la fine del XV
secolo, quando il centro abitato si sviluppò anche al di fuori della cinta
muraria; è caratterizzato dalla presenza di eleganti edifici signorili di
indubbio interesse storico e artistico di epoca compresa tra il XVI ed il XX
secolo.
San
Michele, è ubicato dentro la cinta muraria, tra la Porta della Città e
la chiesa di San Nicolò. Prende il nome dalla chiesa di San
Michele che sorge nel bel mezzo del quartiere. Durante il Medioevo ed
il Rinascimento, questo quartiere aveva una grande importanza in quanto ivi
sorgevano il Palazzo della Curia, il Giudicato, il carcere, la Sinagoga
di Savoca e vi si trovava un'importante fontana per
l'approvvigionamento di tutto l'abitato; insomma qui avevano sede le magistrature
amministrative e giudiziarie della cittadina. Vi ha sede il Museo comunale
ed è caratterizzato per i suoi stretti vicoli e la presenza di ruderi di
molti antichi edifici.
San
Rocco, sito anch'esso dentro le mura cittadine, era il quartiere dei
pescatori. È alquanto vasto, nei secoli passati era densamente popolato
soprattutto dal ceto popolare. Oggi è quasi completamente disabitato.
Presenta una conformazione caratterizzata dalla presenza di stretti e
tortuosi vicoli e umili case plebee. Degni di nota sono i ruderi della chiesa
di San Rocco del 1593 e il panorama suggestivo che vi si
gode. In questo quartiere sono stati realizzati un resort ed un villaggio
turistico.
Pentefur,
antichissimo quartiere, è il nucleo originario della città di Savoca.
Alcuni storici locali ritengono sia di origine tardo romana o bizantina.
Sorge ai piedi dell'omonimo castello, in una zona compresa tra la Chiesa
Madre e il Borgo. Anche questa borgata, ancora abbastanza popolata,
presenta un'urbanistica prettamente medioevale.
San
Giovanni, situato all'estremità sud del centro storico è, come
Pentefur, il più antico quartiere di Savoca, popolato già in epoca
anteriore all'invasione araba del IX secolo. Vi si trovava la
porta di ingresso meridionale del paese, più imponente di quella tuttora
visibile nel quartiere San Michele. È caratterizzato da edifici signorili
tipicamente medioevali, come la Casa della Bifora del XV secolo. Vi si
trovano la Chiesa Madre del XII secolo e i ruderi della
chiesa di San Giovanni del XII secolo. Nei secoli scorsi, in virtù di
quanto riferisce lo storico Giuseppe Trischitta, in questo quartiere
era ubicato l'antico Ospedale di San Giovanni, non più esistente; tuttavia,
è possibile ammirare l'edificio a due elevazioni che ospitava detto
ospedale.
Chiesa
di Santa Maria in Cielo Assunta

Chiesa
di Santa Maria in Cielo Assunta, è la chiesa
matrice di Savoca ed è un monumento
nazionale italiano dal 1910.
Secondo consolidate fonti storiche, la chiesa venne eretta verso il 1130 su
una preesistente struttura di incerta origine, durante il regno del Re Ruggero
II di
Sicilia, il monarca avrebbe personalmente contribuito alle spese di
edificazione.
Tuttavia, secondo un recente parere di alcuni esperti, la chiesa venne
costruita nei primi anni del IX
secolo, pochi decenni prima della conquista
islamica della Sicilia, ciò sembrerebbe desumersi dall'epigrafe di
un'antica pietra su cui si distinguerebbero tre numeri: 802, ad ogni modo,
non è al momento possibile dare certezze sull'attendibilità di questa
retro-datazione.
Tra
la fine del XV
secolo e l'inizio del successivo, venne ristrutturata ad opera di
messer Pietro Trimarchi (1465-1534),
facoltoso architetto savocese, con tale intervento si invertì
l'orientamento del tempio (la struttura originaria era con le absidi rivolte
verso Est, adesso sono rivolte verso Ovest) si edificarono le attuali abside
e facciata e si realizzarono, ai lati del tempio, due ampie cappelle; si
diede quindi alla chiesa madre una struttura tipicamente siculo-rinascimentale,
abbandonando il preesistente stile
siculo-normanno. A memoria di tale posticcio rifacimento, il portale
centrale reca la seguente iscrizione marmorea: HOC OPUS M. PETRUS
TRIMARCHI FIERI FECIT.
Tra
il 1555 ed
il 1736 venne
edificato il campanile, sul quale vedasi approfondimento.
Negli anni'
50 del Settecento,
alla destra dell'edificio sacro, venne edificato, a spese dell'allora arciprete della
città di Savoca, don Giuseppe Nicòtina (1715-1795),
il palazzotto a due elevazioni della canonica,
che, al piano primo è da sempre adibito a sagrestia e
al piano terra ospitò la sede del Monte
frumentario, istituito nel 1758 col
capitale di onze 100
donate per testamento dal
sacerdote savocese don Vincenzo Giannetto. All'interno del primo piano di
detto edificio erano custodite ed esposte opere pittoriche di grande pregio,
oggi quasi interamente perdute.
In
questo importante edificio di culto celebravano ben dodici sacerdoti ed è
stato, per secoli, sede periferica dell'archimandrita
di Messina e sede di arcipretura dalla
quale dipendevano tutte le chiese delle frazioni e dei comuni contigui.
Il terremoto
del 1908 causò alcuni danni come il crollo di parte del tetto e
della caratteristica cuspide del campanile. La chiesa, proclamata monumento
nazionale nel 1910, venne riparata dai danni del terremoto nel 1911.
Oggi
il territorio
parrocchiale della chiesa madre di Savoca comprende, oltre al
centro storico, le frazioni di Cucco, Santa domenica, Romissa, Mancusa e
Rogani.


La
facciata a doppio spiovente presenta il portale centrale, di impostazione siculo-rinascimentale,
spinto verso l'alto da paraste laterali che guidano lo sguardo verso il rosone in
pietra a cinque bracci (che non trova eguali in nessuna chiesa del Messinese)
opera di maestranze locali, scultori e scalpellini che diedero prova della
loro notevole abilità, operando ai limiti della capacità di resistenza dei
materiali lavorati. La chiesa è a tre navate, divise tra loro da colonne
monolitiche, sormontate da pregevoli capitelli romanici.
Al
suo interno sono presenti antiche opere di indubbio valore storico e
artistico. Nel 2002,
in occasione di lavori di restauro, vennero casualmente scoperti due
affreschi murali del XII
secolo di sapore
squisitamente siculo-normanno, raffiguranti San
Giovanni Crisostomo e San
Basilio Magno. Ancora visibile, all'altare maggiore, l'antica cattedra
lignea dell'archimandrita
di Messina e pregevole risulta il quattrocentesco soffitto ligneo a
capriate; degni di nota gli affreschi cinquecenteschi,
che adornano le pareti ed il catino dell'abside, raffiguranti l'Assunzione
di Maria Vergine al Cielo (nel catino) e i Dodici
Apostoli, nelle pareti. Caratteristico risulta il pulpito ligneo
barocco.
La
chiesa, oltre all'Altare maggiore in marmo pregiato, del 1795,
posto al centro dell'abside, è dotata di altri sei altari marmorei: a
destra dell'abside, il rinascimentale altare
dedicato al Santissimo Crocifisso, dotato di antica croce lignea seicentesca e paliotto in
marmo raffigurante San
Nicola di Bari; a sinistra dell'abside si trovano l'altare e la statua
dedicati alla Madonna del Fervore entrambi del XVI
secolo. Alle pareti laterali della navata si trovano: a destra, il cinquecentesco altare
di San
Giuseppe e a sinistra l'altare in stile barocco
siciliano dedicato a Santa
Rita da Cascia, con antica pala raffigurante la Santa che benedice
Savoca e la sua chiesa matrice. Si ammirano infine, un quadro raffigurante
la pietà ed una grande tela che riproduce la Sacra
Famiglia, entrambi risalenti al secolo
XVII e restaurati nel XX secolo a spese di tre cittadini savocesi.
Come
già detto, la chiesa è dotata di due ampie cappelle laterali, risalenti al
grande restauro operato ai primi del XVI secolo da Pietro Trimarchi. La
cappella di destra, dotata di pregevole altare barocco siciliano è dedicata
al Santissimo
Sacramento e venne realizzata a spese della potente famiglia
savocese dei Trimarchi; quella di sinistra (che immette nella sagrestia) è,
dal 2002,
dedicata Madonna
di Fátima, su detto altare è posizionato un grande complesso statuario
benedetto da Papa
Giovanni Paolo II.
Nella
sottostante cripta,
ubicata sotto l'abside,
è presente il Putridarium ove,
nei secoli passati, si procedeva alla mummificazione delle
salme dei notabili del paese.
Nella
zona del portale centrale di ingresso, recentemente, sono venute alla luce
tracce dell'antica pavimentazione risalente al XII
secolo.
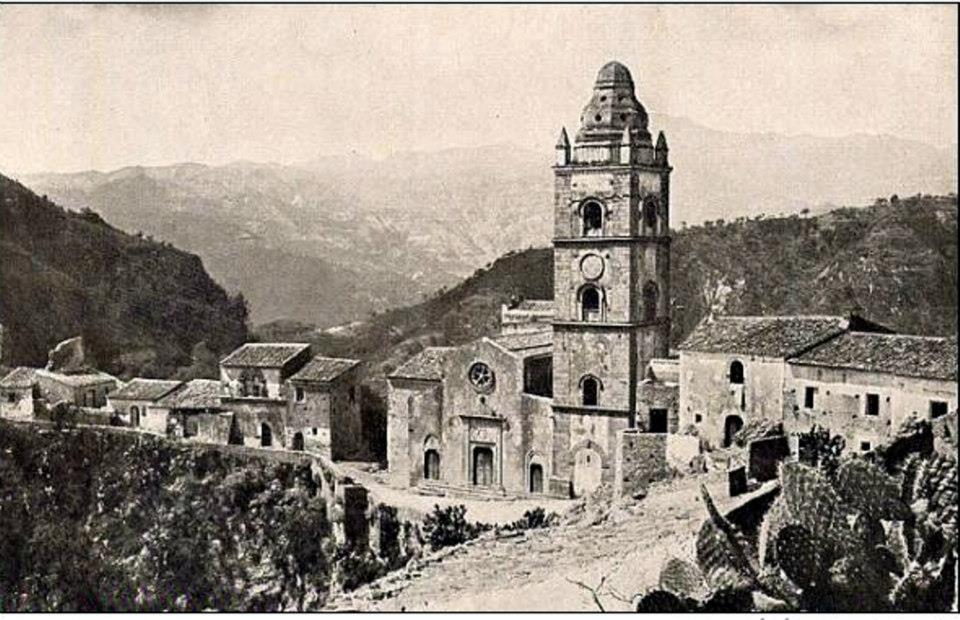
Il
Campanile e l'orologio antiorario - Come
riportato dall'evidente incisione su una pietra angolare, il campanile della
Matrice di Savoca venne
edificato a partire dall'anno 1555,
inizialmente su tre ordini, con un'architettura tipicamente
siculo-rinascimentale e manierista.
Nel 1641,
su iniziativa dell'allora Arciprete Sac.
Mazzullo e a spese dei Giurati Salvo
Cuglituri, Antonio Vinci, Giovan Domenico Cuglituri e del Sindaco
di Savoca Antonio
Crisafulli, venne posizionata, all'interno dell'ordine sommitale della
torre, una grande campana bronzea, detta in siciliano "lu
Campanuni", realizzata a Tortorici da
mastro Gregorio Zumbo. Fu probabilmente nello stesso periodo che il
campanile venne dotato di un mirabile orologio ad una lancetta (per le sole
ore) che aveva la particolare e molto rara caratteristica di ruotare in
senso antiorario. Esso funzionava secondo il metodo dell'Ora
italica e, in base a recenti studi, è unico in Sicilia e
nel Meridione
d'Italia: altri soli 5 esemplari sono presenti in Lombardia, Veneto, Toscana e Marche.
Dopo essere stato lesionato dal terremoto
del 1693, il campanile venne restaurato e, nel 1736,
fu sopraelevato mediante costruzione di un quarto ordine e di una pregevole
e caratteristica guglia a
cipolla sullo stile di altre simili progettate dal noto architetto messinese Filippo
Juvarra. Detta sopraelevazione scaturiva dall'esigenza di rendere più
percepibili e a distanze sempre maggiori, i rintocchi delle campane che
scandivano il succedersi delle ore regolando la vita lavorativa dei
savocesi. L'orologio antiorario di Savoca smise di funzionare non molto dopo
il 1875, di esso rimane solo il pregevole grande quadrante lapideo che fa
mostra di sé in cima alla vetusta torre campanaria. Degli ingranaggi
meccanici, che nel corso dei secoli venivano regolati e manutenuti da
persone esperte all'uopo preposte, non rimane più nulla. Il campanile subì
ancora gravi danni a causa del terremoto
del 1908, che richiesero la demolizione dell'ordine sommitale
settecentesco e della caratteristica guglia a cipolla, riportando il
manufatto all'altezza che aveva prima del 1736.
Chiesa
di San Michele

Chiesa
di San Michele, costruita attorno al 1250,
per volere degli Archimandriti, era la chiesa del castello
di Pentefur. Edificata anteriormente al 1250 per
volontà degli archimandriti
messinesi, era la chiesa del Castello
di Pentefur. Inizialmente l'edificio era di esigue dimensioni e, secondo
un antico manoscritto datato 1308,
vi celebravano la Divina
Liturgia numerosi sacerdoti di rito
greco.
Verso
il 1420 la
chiesa venne ampliata e si procedette ad impreziosirla con i due
attuali portali in stile gotico-siculo-chiaramontano. Durante tutto il Medioevo ed
oltre, il non credente che si convertiva al Cristianesimo,
secondo una documentata tradizione, doveva salire ginocchioni, in atto di
penitenza, i suoi sette gradini, per poi ricevere il sacramento del battesimo.
Fino
a tutto il secolo XVIII, secondo fonti archivistiche del 1748,
la chiesa era parrocchiale anche
se non appare chiaro su quali quartieri si estendesse il suo territorio.
Documenti
storici risalenti al 1624 testimoniano
la chiusura al culto, causa inagibilità, di questa chiesa; le celebrazioni
sacre avevano luogo nella vicinissima chiesa di Gesù e Maria. Negli ultimi
anni del Seicento (su
iniziativa dell'allora cappellano della
chiesa, don Vincenzo Miuccio) gli interni del sacro edificio vennero
sontuosamente restaurati seguendo lo stile del barocco
siciliano; detti lavori si conclusero nel 1701 con
la realizzazione di un ricco ciclo pittorico di affreschi tuttora esistenti
ma in precarie condizioni di conservazione. Nel 1761,
poi, si procedette al rifacimento della copertura lignea a capriate che
ancora oggi sorregge il tetto;
nello stesso periodo vi esercitò le funzioni di parroco il
letterato don Antonino
Puliatti.
Nel 1996 vennero
restaurati il tetto ed il soffitto ligneo interno.
Questo
prezioso edificio fu dichiarato monumento
nazionale nel 2002.
Nel
mese di agosto 2015,
su iniziativa di alcuni giovani savocesi, dell'arciprete don
Agostino Giacalone, dell'amministrazione comunale e di varie associazioni,
è partito il crowdfunding finalizzato
a reperire i fondi necessari a salvare dal degrado gli interni barocchi
della chiesa.
Dopo
essere rimasta chiusa al culto per decenni, il 29 settembre 2020, solennità
di San
Michele Arcangelo, conclusi i lavori di restauro degli interni, con
solenne celebrazione eucaristica la chiesa è stata riaperta al culto.


All'interno
della chiesa, a navata unica, è possibile ammirare un imponente ciclo
pittorico costituito da:
-
un
prezioso affresco del 1701 raffigurante
il Battesimo
di Gesù al Fiume
Giordano;
-
un
piccolo affresco che reca l'immagine della Madonna
della Lettera risalente al 1701;
-
due
antichi quadri del 1701 raffiguranti San
Michele Arcangelo e i Santi
Cosma e Damiano;
ed
altre preziose opere quali:
-
tre
altari barocchi dedicati
rispettivamente ai Santi Cosma e Damiano, a Santa
Maria dell'Idria e a San Giovanni;
-
un
pregevole pulpito ligneo
settecentesco.
-
le
tombe di alcuni notabili locali, come quella dei Crisafulli,
realizzata nel 1581,
e quella della famiglia di Onofrio Cicala, del 1749.
-
la
torre campanaria.
La
chiesa è stata riaperta al culto, dopo decenni, nel settembre 2020, ma nel
corso degli anni ha ospitato mostre ed altre iniziative culturali. Presso
questa chiesa, ogni anno, il giorno prima della festa agostana di Santa
Lucia, avviene una sorta di "passaggio delle consegne" tra le
"Lucie"; infatti la bambina che l'anno precedente ha impersonato
Santa Lucia, consegna a quella dell'anno corrente il ramoscello di palma
d'oro; fatto ciò, iniziano i grandi festeggiamenti.
Una
lapide, nell'antistante piazzetta, ricorda che in tale luogo venivano
tumulati i bambini morti senza battesimo.
A breve distanza da questa antica chiesa, si vedono ancora le rovine di
quella che, fino al 1470,
fu la sinagoga
di Savoca.


Chiesa di
San Nicolò
Chiesa
di San Nicolò, edificata nel XIII secolo, fino a tutto il XVII secolo era
riccamente adornata con affreschi in stile bizantino.
Venne
edificata nel XIII secolo e, come testimonia un antico documento
datato 1308, vi officiarono la Divina Liturgia numerosi cappellani
greci. Originariamente, gli interni erano riccamente adornati con affreschi
in stile siculo-normanno risalenti al XIII secolo. Nei secoli
scorsi (fino alla fine del XIX secolo) era chiesa parrocchiale,
sotto la cui giurisdizione erano poste anche le piccole cappelle di quella
che fu (fino al 1854) la Marina di Savoca. Secondo fonti archivistiche
risalenti al 1676, all'interno di questa chiesa, ogni anno, l'ultima
domenica di agosto, si tenevano le elezioni dei Giurati e del
Sindaco di Savoca. È infine documentato, in questa chiesa, il
culto di Santa Barbara, di cui oggi non resta traccia alcuna.
È
stata oggetto di due importanti restauri: il primo alla fine del XV
secolo (effettuato, secondo la tradizione orale, ad opera
dell'architetto savocese messer Pietro Trimarchi (1465-1534) ma non vi sono
fonti attendibili) e il secondo nei primi anni del XVIII secolo (forse
perché danneggiata dal terremoto del 1693) che ne hanno profondamente
modificato la fisionomia originaria; di conseguenza l'edificio sacro
presenta oggi un'architettura settecentesca. La chiesa di San Nicolò ha
avuto una grande valenza storico-sociale anche perché, a partire dal Medioevo e
fino al XIX secolo, al suo esterno (nell'area del sagrato frontale e
laterale) hanno trovato sepoltura i cittadini savocesi appartenenti ai ceti
popolari. Ancora oggi, sotto il piano di calpestio della piazzetta che
circonda la chiesa, esistono (ma non sono visibili) le cripte-ossuario
che contengono i resti mortali di centinaia di popolani savocesi vissuti e
deceduti tra il XIV ed il XIX secolo. Il terremoto del
1908 danneggiò la chiesa, che dovette subire un ulteriore restauro.
Nel mese di agosto del 1970, sul sagrato di questo edificio sacro
vennero girate alcune celebri scene del film Il Padrino di Francis
Ford Coppola. L'ultimo restauro della chiesa risale al 1981.
Ha
un caratteristico stile merlato che la fa somigliare ad una fortezza. Sorge
in una posizione panoramica, protesa in direzione di un profondo dirupo.
Accanto alla chiesa sono visibili i resti della cripta, crollata a causa di
una frana verso il 1943. La costruzione è a tre navate con colonne di
granito sormontate da capitelli; è dotata di altari di marmo pregiato e
opere di scultura e di pittura di indubbio valore artistico e storico.

Questa
chiesa ospita alcune importanti opere scultoree e pittoriche provenienti
dalla seicentesca Chiesa dell'Immacolata (oggi centro filarmonico)
e dalla quattrocentesca Chiesa di Santa Lucia con annesso convento
domenicano crollati a causa di una frana nel 1880; proprio per
tale motivo quest'edificio sacro oggi viene comunemente appellato chiesa
di Santa Lucia.
L'opera
più antica, è sicuramente la trecentesca tavola raffigurante San
Michele Arcangelo, che, secondo una leggenda, verso la fine del XV
secolo, venne rocambolescamente rubata dai savocesi agli abitanti di Forza
d'Agrò. Fino al secolo scorso era custodita all'interno
dell'omonima chiesa savocese.
Degna
di attenzione è un'antica grande tela (366x242), opera di Gaspare
Camarda del 1623, raffigurante la Madonna del Parto,
commissionata dalla famiglia Trischitta; originariamente posta nella
vicina Chiesa dell'Immacolata (oggi centro filarmonico), venne qui collocata
durante il secolo scorso, quando questa andò in rovina.
Interessante
risulta la statua lignea di san Vincenzo Ferreri, realizzata dallo
scultore gangitano Filippo Quattrocchi nella seconda metà
del XVIII secolo, anche detta opera scultorea era custodita nel
convento domenicano, venendo qui trasferita dopo il crollo di questo nel
1880.
Di
valore inestimabile risulta il preziosissimo simulacro in argento cesellato
raffigurante santa Lucia da Siracusa, realizzato nel 1666, su
commissione della Confraternita di Santa Lucia, da ignoto argentiere messinese.
Pregevoli appaiono le statue lignee della Madonna del Carmelo (anch'essa
opera di Filippo Quattrocchi) di sant'Antonio Abate e di san
Michele Arcangelo, risalenti al XVIII secolo. Un piccolo busto marmoreo quattrocentesco,
raffigurante la Martire siracusana troneggia al centro della
facciata, sull'architrave del portale centrale.
Recentemente
il monumento è stato arricchito con opere d'arte del maestro Licinio Fazio
(dipinti su legno aventi per oggetto episodi biblici), dell'artista tedesco
Siegmund Wagner (dipinti su tela raffiguranti santa Lucia ed il
suo martirio) e dell'artista savocese Carmelo Salemi Scarcella (1937-2019)
(riproduzioni in terracotta delle stazioni della Via Crucis). Da non
dimenticare la statua lignea di Santa Lucia eseguita dallo scultore
Reginaldo D'Agostino. A destra della chiesa sorge una torre campanaria
sormontata da orologio.


 Pag.
2 Pag.
2
|