|
La
lunga storia della città e il succedersi di numerose civiltà e popoli
le hanno regalato un notevole patrimonio artistico e architettonico. Il
sito seriale Palermo
arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, di cui
fanno parte più beni monumentali situati in città, nel 2015 è
stato dichiarato Patrimonio
dell'umanità dall'Unesco. Numerosi
edifici, tra chiese e palazzi, sono riconosciuti monumenti
nazionali italiani.
La
città di Palermo ha cambiato spesso nome nel corso delle epoche:
Zyz (che
in fenicio significa il
fiore): il nome non è accertato, ma molte monete provenienti da Palermo
di periodo punico portavano la dicitura Zyz e visto che Palermo era una
delle tre città puniche della Sicilia molto probabilmente aveva una
propria zecca. Il nome sembrerebbe derivare dalla conformazione della
città che tagliata da due fiumi ricordava il profilo di un fiore.
Panormos (dal Greco tutto-porto):
i Greci chiamavano
Palermo così perché i due fiumi che la circondavano (il Kemonia e
il Papireto)
creavano un enorme approdo naturale. Questo nome andò diffondendosi
grazie al rafforzamento dell'influenza greca sull'isola.
Panormus:
i Romani mantennero,
con una lieve modifica di pronuncia, la denominazione greca con
la quale avevano conosciuto la città.
Balarm:
il nome arabo della
città è un semplice cambiamento di pronuncia del nome precedente.
Balermus:
evoluzione del precedente nome sotto il periodo normanno.
Palermo:
il nome definitivo della città che viene acquisito in età
moderna.

La
presenza umana a Palermo è attestata sin dall'epoca preistorica come
una delle più antiche di tutta la Sicilia,
con interessanti graffiti e pitture rupestri, ritrovati nelle grotte
dell'Addaura nel 1953 dall'archeologa Jole
Bovio Marconi: figure danzanti in un rito magico propiziatorio,
forse “sciamani”
di un popolo che abitò l'isola.
Palermo
fu fondata dai Fenici con
il nome Zyz. Fino a quel momento l'area era stata un emporio
commerciale e base d'appoggio per la Sicilia nord-occidentale. Zyz:
il nome non è ancora accertato, ma molte monete provenienti da Palermo
di periodo punico portavano la dicitura Zyz e visto che Palermo era una
delle tre città puniche della Sicilia molto probabilmente aveva una
propria zecca. Il nome sembrerebbe derivare dalla conformazione della
città che tagliata da due fiumi ricordava il profilo di un fiore.
Acquisita
una certa importanza commerciale grazie alla sua posizione ma
soprattutto ai due fiumi (il Kemonia ed
il Papireto),
si trovò a combattere in diverse occasioni contro i Greci di Sicilia,
in quanto rappresentava un'importante alleata di Cartagine nelle guerre
greco-puniche.
Panormos, così
i Greci chiamavano Palermo, così perché i due fiumi che la
circondavano (il Kemonia e
il Papireto)
creavano un enorme approdo naturale. Questo nome andò diffondendosi
grazie al rafforzamento dell'influenza greca sull'isola.
La
città rimase sotto il controllo fenicio fino
alla Prima
guerra punica (264-241
a.C.), a seguito della quale la Sicilia venne
conquistata dai Romani.
In particolare Palermo fu al centro di uno dei principali scontri fra Cartaginesi e
Romani, finché nel 254
a.C. la flotta romana assediò la città, costringendola
alla resa e rendendo schiava la popolazione che venne costretta al
tributo di guerra per riscattare la libertà. Asdrubale tentò
di recuperare la città ma venne sconfitto da Metello,
il console romano.
Un
ennesimo tentativo per recuperarla venne fatto da Amilcare nel 247
a.C. che col suo esercito si insediò alle pendici del Monte
Pellegrino (all'epoca chiamato Erecta) tentando
in più occasioni di riprenderne il comando, ma la città era ormai
fedele a Roma dalla
quale aveva ottenuto il titolo di Pretura, l'Aquila d'oro e il diritto
di battere moneta, restando una delle cinque città libere dell'isola;
per questo motivo i cartaginesi rimasti
dovettero abbandonare definitivamente il territorio palermitano.
Il
periodo romano è stato di tranquillità e la città faceva parte della provincia
di Siracusa; con la successiva divisione dell'Impero la
Sicilia, e con essa Palermo, furono attribuite all'Impero
Romano d'Occidente.
 Testimonianza
dell'agiatezza e dello splendore della romana “Panormus” sono
edifici dell'epoca della zona di Piazza Vittoria fra cui il teatro
esistente fino al tempo dei Normanni e
mosaici scoperti nel 1868 in
Piazza della Vittoria. In epoca imperiale fu colonia romana, come ci
narra Strabone, ed era ancora il granaio di Roma,
ma risentì della decadenza dopo Vespasiano,
subendo le invasioni barbariche dal 445,
con Genserico,
re dei Vandali che
mise a ferro e fuoco la città, fino al dominio di Odoacre, Teodorico capo
degli Ostrogoti. Testimonianza
dell'agiatezza e dello splendore della romana “Panormus” sono
edifici dell'epoca della zona di Piazza Vittoria fra cui il teatro
esistente fino al tempo dei Normanni e
mosaici scoperti nel 1868 in
Piazza della Vittoria. In epoca imperiale fu colonia romana, come ci
narra Strabone, ed era ancora il granaio di Roma,
ma risentì della decadenza dopo Vespasiano,
subendo le invasioni barbariche dal 445,
con Genserico,
re dei Vandali che
mise a ferro e fuoco la città, fino al dominio di Odoacre, Teodorico capo
degli Ostrogoti.
Nel
535 Belisario espugnò
con la sua flotta navale Palermo, sottraendola agli Ostrogoti;
iniziava così il periodo bizantino che si protrasse fino all'830 quando
gli Arabi,
sbarcati a Marsala quattro anni prima, ne fecero la capitale del loro
regno in Sicilia.
Nel IX
secolo i musulmani dal Nordafrica invasero
la Sicilia,
iniziarono la conquista dell'isola nell'827,
conquistarono Palermo nell'831 e
l'intera isola nel 965.
E furono proprio i governatori musulmani a spostare la capitale della
Sicilia a Palermo, città nella quale è rimasta da allora. La città a
quel punto dovette essere dotata di tutte le strutture burocratiche e
quelle destinate ai servizi che spettavano ad una capitale. Nel periodo
musulmano Palermo divenne una città importante nei commerci e nella
cultura, secondo il geografo e viaggiatore Ibn
Hawqal la città era famosa perché al suo interno erano
presenti più di 300 moschee; era
conosciuta in tutto il mondo
arabo. Fu un periodo di prosperità e tolleranza: i cristiani e
gli ebrei vivevano in armonia con i musulmani.
Gli
anni della dominazione araba sancirono la definitiva ascesa della città
e la sua superiorità sugli altri centri della Sicilia.
Sede di un potente emirato che, grazie alla capacità amministrativa dei
Kaglebiti divenne
una terra ricca e florida dai costumi tipicamente musulmani
con influenze nella lingua e nella toponomastica,
nelle culture e nelle costruzioni architettoniche. Le tracce di essa
sopravvivono anche nei monumenti che costituiscono il centro della città
antica.
Il
monaco Teodosio che ci ha fornito queste notizie sosteneva anche che
circa trecento moschee si
ergevano nel territorio palermitano e l'istruzione era affidata a
trecento maestri per una popolazione di oltre trecentomila persone.
Divisa
la Sicilia in
tre valli (Val di Mazara, Val
Demone e Val
di Noto), il territorio veniva controllato con una specie di
signorie affidate ai “Kaid”. Gli Arabi dapprima
perseguitarono i Cristiani,
ma poi lasciarono libertà di culto facendo loro pagare la "gìzia”,
un tributo annuo per mantenere fiorenti i commerci grazie alla
pacificazione.
La
potenza musulmana fu però corrosa dalle lotte intestine all'emirato che
aprirono la via della Sicilia allo
straniero finché nel 1072,
dopo quattro anni d'assedio, il conte Roberto
il Guiscardo ed il conte Ruggero
d'Altavilla, entrambi normanni, espugnavano la città di Palermo.
Di
rilievo i lavori per migliorare la rete idrica cittadina, con la
creazione di svariati Qanat, canali sotterranei che attraversavano tutta
la città ma che sono stati ritrovati anche nella Conca
d'Oro e nella zona di Partanna
Mondello, molto distante rispetto al centro abitato arabo.
Gli
arabi iniziarono anche un'imponente opera di sfruttamento agricolo del
territorio palermitano, attraverso la costruzione di opere
architettoniche migliorarono e riqualificarono ampi terreni rendendoli
coltivabili, in particolare si occuparono della coltura di agrumi, del
papiro, e del cotone.
Forte
sviluppo acquisterà la città anche dal punto di vista commerciale,
divenendo meta fissa dei principali traffici merci del mediterraneo, per
questo motivo verrà anche potenziato il porto cittadino.
I
conquistatori musulmani trasformarono la città nella sede di un emirato
e di conseguenza dotarono la città di molti nuovi edifici pubblici e
difensivi. La paleopoli venne chiamata Halqah e
al suo interno edificarono un nuovo e grandioso castello ed un'enorme
moschea che poteva ospitare fino a 7.000 persone, la moschea risiedeva
al posto dell'attuale cattedrale.
La città venne suddivisa in cinque quartieri: il Kasr nella
punta della Paleopolis; il quartiere della grande Moschea;
la Kalsa (ossia Eletta) sede degli emiri nella riva del
mare; la zona degli Schiavoni, attraversata dal fiume Papireto;
e infine a ponente il Moascher, il quartiere dei soldati
antica sede degli emiri. Il porto venne ingrandito ed ammodernato con la
costruzione di nuovi magazzini e di un arsenale. Sorsero nuovi quartieri
per far fronte ad un forte aumento demografico causato soprattutto da
una forte immigrazione dal resto della sicilia e da tutto il Mediterraneo.
I nuovi quartieri che sorsero furono quello degli Schiavoni a Nord,
a Sud invece
sorsero i quartieri dei Lattarini (zona ricca di
botteghe) e della Moschita (abitato dagli ebrei),
a Sud-Est sorse
il quartiere Nuovo ed infine vicino al mare venne
costruita la cittadella dell'emiro denominata Kalsa.
Nell'XI
secolo nuove mura vennero costruite più esterne per
abbracciare anche i nuovi quartieri periferici come il popoloso Rabad (o
borgo). Sempre contemporaneo il primo nucleo del Castelloamare.

Il
periodo di massimo splendore di Palermo continuò con i Normanni (in
particolare con Ruggero
II e con lo svevo Federico
II), i quali seppero raccogliere e utilizzare l'eredità
culturale araba, greca e romana. Sotto il patrocinio di Federico II di
Svevia Re di Sicilia e Imperatore del Sacro Romano Impero, a Palermo, a
partire dal terzo decennio del XIII secolo, si forma un ambiente di
intensa attività culturale che va sotto il nome di Scuola
siciliana (così definita da Dante nel suo “De vulgari
Eloquentia”). Queste condizioni crearono i presupposti per il primo
tentativo organizzato di una produzione poetica in un volgare romanzo,
il siciliano. Alla morte di Federico II fa seguito un lungo periodo di
instabilità culminata con la rivolta antifrancese del Vespro (1282).
Palermo si separa da Napoli e offre la corona di Sicilia a Federico
III d'Aragona.
I Normanni ripristinarono
il culto cristiano, dichiarando la città capitale dell'isola e nel 1130 Ruggero
II d'Altavilla cingeva la corona di Re
di Sicilia. Cominciava così un regno caratterizzato dalla
convivenza di varie etnie e diverse fedi religiose, una specie di stato
federale con un primo parlamento, creato nel 1129,
e l'organizzazione del catasto secondo una moderna concezione. Gli
edifici più importanti della città ancora oggi ne dimostrano la civiltà,
come la chiesa
della Martorana e la Cappella
Palatina, e il geografo arabo Edrisi, nel libro dedicato a re
Ruggero, ci ha lasciato la testimonianza di questo magnifico periodo di
fasti e ricchezza.
Ai
due Ruggero successero Guglielmo
I (detto il Malo) e Guglielmo
II (detto il Buono), i quali tentarono d'opporsi alle mire
dell'imperatore Federico
Barbarossa, deciso ad annientare il Regno dei Normanni in
Sicilia.
Un
matrimonio di stato fra Enrico
VI, figlio dell'imperatore tedesco, e Costanza
d'Altavilla, figlia di Ruggero II, nel 1185,
tentò un accordo pacifico, ma aprì solo la strada alla conquista Sveva
e nel 1194 Palermo
veniva conquistata dal sovrano tedesco. Aveva così inizio la nuova
dinastia degli Svevi in
Sicilia che con Federico
II, figlio di Costanza I raggiunse il massimo dello splendore.
Palermo, assieme a Castel
del Monte in Puglia,
divenne un centro in cui il sovrano amava passare lunghi periodi.
A
Palermo nacque la "Scuola
poetica siciliana" con la prima poesia italiana; e
politicamente il sovrano chiamato "Stupor mundi"
(meraviglia del mondo) anticipò, come scrive Santi Correnti, "la
figura del principe rinascimentale", anche con le cosiddette Costituzioni
Melfitane (1231).
Il suo regno fu tuttavia caratterizzato dalle lotte contro il Papato e i
Comuni italiani, nelle quali riportò vittorie o cedette a compromessi,
organizzando la quarta
crociata e dotando l'isola e il meridione di castelli e
fortificazioni. Volle essere sepolto nella cattedrale di Palermo, quando
nel 1250 si
concluse improvvisamente la sua vita, conseguentemente scatenando le
lotte di successione in cui Manfredi,
figlio naturale di Federico
II, venne sconfitto a Benevento nel
1266 da Carlo
d'Angiò, fratello del re
di Francia.

Carlo
d'Angiò dava
inizio alla dominazione angioina che sarebbe durata fino al 1282.
Carlo e i suoi funzionari cercarono di sfruttare con tasse e tributi la
Sicilia, mentre frattanto la capitale veniva spostata a Napoli.
Il malcontento dei Siciliani culminò
nella rivolta del Vespro,
il 31 marzo 1282,
quando dinanzi alla chiesa del Santo Spirito – si dice –
esplose la reazione popolare in seguito all'offesa fatta da un certo
Drouet ad una donna palermitana. Tale avvenimento fu l'occasione per
cacciare gli odiati Angioini,
mentre veniva inviato ad assumere la corona del Regno Pietro
III d'Aragona. Cominciò una guerra che sarebbe durata
novant'anni in tre fasi distinte concluse rispettivamente con la pace
di Caltabellotta nel 1302,
la pace
di Catania nel 1347 ed
infine con il Trattato
di Avignone 1372.
Palermo
passò da un sovrano all'altro della dinastia aragonese: Giacomo
II, Federico
III di Aragona e l'isola fu lacerata dalle rivalità fra le
famiglie nobili come i Ventimiglia,
gli Alagona e
i Chiaramonte,
i quali si contendevano il potere nelle terre occidentali della Sicilia.
Tracce artistiche del periodo aragonese troviamo in Palermo in alcuni
palazzi sontuosi come lo Steri e Palazzo
Sclafani di stile
chiaramontano, mentre i commerci con la Repubblica
di Genova e con la Spagna fiorirono
con lo scambio di materie prime e prodotti artigianali.
Nel 1494,
alla morte di re Martino, la Sicilia venne annessa alla Spagna e
Palermo diventava sede dei Viceré, i governatori a cui veniva affidato
il potere nell'isola da condividere con i baroni. Furono espulsi gli ebrei,
istituito il Sant'Uffizio,
e crebbero i privilegi nobiliari. Tuttavia la città vide rilanciare
l'attività artistica e la costruzione di sontuosi edifici pubblici come
la chiesa di San Giuseppe, la chiesa
di Santa Maria dello Spasimo e il nuovo assetto scenografico
di Porta Nuova, pur frutto di pesanti tasse. Dopo Ferdinando d'Aragona
la corona di Sicilia passò a Carlo
V, della dinastia degli Asburgo,
e, alla sua morte, al ramo principale degli Asburgo, quello di Spagna,
con Filippo
II suo figlio, che esercitò il potere da lontano mediante
dei viceré, spalleggiati dalla nobiltà locale, poderosa e, non di
rado, prepotente. La città s'arricchì però, ad uso soprattutto delle
classi nobiliari, dell'apertura di via Maqueda, della scenografia dei Quattro
Canti, con statue innalzate ai sovrani come quella a Carlo V in Piazza
Bologni, di mura robuste e bastioni per la difesa del territorio.
Coinvolta
nelle guerre europee tra Francia, Austria e Spagna,
nel 1713 col trattato
di Utrecht la Sicilia passava a Vittorio
Amedeo II di Savoia per breve tempo, finché dal 1734
ritornavano i Borbone con
Carlo III che scelse Palermo per la sua incoronazione come re di Sicilia
e re di Napoli. Sotto questo monarca la città vide crescere e
sviluppare l'edilizia, l'industria, il commercio in modo fiorente.
A
lui successe il figlio Ferdinando, non molto gradito dai palermitani, ma
nel 1798 gli
eventi della Rivoluzione
francese costrinsero il sovrano a rifugiarsi a Palermo. Nel
1816 cancella il parlamento palermitano ed il Regno
di Sicilia, dando vita all'originale Regno
delle Due Sicilie.
Negli
anni seguenti a causa di questo torto dal 1820 al 1848 la
Sicilia venne coinvolta nei moti rivoluzionari che videro nel 12 gennaio
del 1848 un'insurrezione
popolare capeggiata da Giuseppe
La Masa che proclamava la riapertura del soppresso
parlamento e la monarchia costituzionale con comitati presieduti da Ruggero
Settimo che fu il presidente del nuovo regno che durò
sedici mesi. Ma i Borboni ripresero il potere bombardando le città
siciliane (re Ferdinando IV fu detto perciò “Re Bomba”) che
avrebbero mantenuto fino allo sbarco di Garibaldi.
 Costui
nel 1860,
con la Spedizione
dei Mille preparata dalla rivolta
della Gancia del 4 aprile di Francesco
Riso, entrava trionfante a Palermo da via porta
Termini il 27 maggio, dopo aver assunto la dittatura
dell'isola col proclama di Salemi,
chiamato a liberare la Sicilia dai Borboni da Rosolino
Pilo. Dopo le battaglie vittoriose nell'isola col prebiscito del 1860,
la Sicilia sceglieva l'annessione all'Italia, che si sarebbe costituita
in regno nel 1861. Costui
nel 1860,
con la Spedizione
dei Mille preparata dalla rivolta
della Gancia del 4 aprile di Francesco
Riso, entrava trionfante a Palermo da via porta
Termini il 27 maggio, dopo aver assunto la dittatura
dell'isola col proclama di Salemi,
chiamato a liberare la Sicilia dai Borboni da Rosolino
Pilo. Dopo le battaglie vittoriose nell'isola col prebiscito del 1860,
la Sicilia sceglieva l'annessione all'Italia, che si sarebbe costituita
in regno nel 1861.
Nel 1866 si
ha una rivolta a carattere anti-unitario, la cosiddetta rivolta
del sette e mezzo, contro il nuovo Regno d'Italia da parte di
ex garibaldini delusi, reduci dell'esercito meridionale, partigiani
borbonici e repubblicani, con il conseguente bombardamento da parte
della flotta, che distrusse non poche strutture architettoniche.
Dopo
l'Unità
d'Italia, il comune di Palermo intraprese la costruzione di
alcune importanti opere architettoniche: il taglio di via
Roma e la costruzione dei due teatri più rappresentativi
della città, il Massimo e
il Politeama e
dal 1891 al
1892 ospitò la IV
Esposizione Nazionale.
Nel
primo ventennio del XX
secolo Palermo attraversò un'epoca florida, con un breve ma
intenso periodo liberty e,
grazie ad un gruppo di imprenditori illuminati (Florio, Ingham,
Withaker), Palermo visse una stagione di grande crescita economica e
culturale. Successivamente, lo scoppio della Grande
guerra prima e il fascismo dopo
relegheranno la città ad un ruolo marginale nello scenario italiano.
Palermo
subì notevoli distruzioni a causa dei bombardamenti durante la seconda
guerra mondiale, sin dai primissimi giorni del conflitto, operati
dall'aviazione francese e da quella inglese, prevalentemente su
obiettivi militari. Con l'intervento degli Stati Unit, i bombardamenti
si fecero disastrosi e indiscriminati in prossimità dello sbarco
alleato, distruggendo interi quartieri, causando complessivamente
oltre tremila morti e circa trentamila mutilati e feriti, in gran parte
vecchi, donne e bambini, ed infliggendo gravissimi danni al patrimonio
artistico della città. Per questo motivo fu concessa alla città la Medaglia
d'oro al valor militare nel 1964. Fu poi occupata il 22
luglio 1943 dalle truppe alleate del generale statunitense George
Smith Patton. Ciò provocò l'intensa rappresaglia aerea della Regia
Aeronautica e dalla Luftwaffe,
che avevano per obiettivo anche i movimenti alleati nel porto di
Palermo; l'ultimo bombardamento avvenne il 23 agosto. In quei mesi la
città fu anche sede del governo
militare alleato.
Dopo
la lotta separatista nel biennio 1944/45 del Movimento
Indipendentista Siciliano, dal 1946 Palermo
è stata proclamata capitale della Regione a Statuto
speciale. La sede del Parlamento
siciliano venne posta dal 1947 a Palazzo
dei Normanni.

Ripresasi
dalle distruzioni del secondo
conflitto mondiale, Palermo è oggi - anche in virtù del ruolo
di capitale della Regione autonoma della Sicilia - una città a forte
prevalenza di attività terziaria e caratterizzata da una vivace vita
culturale.
Oggi
il capoluogo siciliano deve la sua rivitalizzazione economica - oltre
alle citate attività del settore terziario - ad una buona ripresa del flusso
turistico, favorito dal clima particolarmente mite di cui la città
gode e dal ricco patrimonio artistico presente sul territorio. Ciò
malgrado, la criminalità organizzata continua ad avere un forte impatto
sulla città, che continua ad essere afflitta da seri problemi economici
e sociali.
Palermo
ha vissuto il peso del dominio mafioso per decenni, caratterizzati dalla
speculazione edilizia, dal cosiddetto “Sacco
di Palermo”. Nella lotta alla mafia nel secondo Novecento sono
stati colpiti uomini dello Stato, come il generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e il presidente della
Regione Piersanti
Mattarella, esponenti della forze dell'ordine come il commissario Boris
Giuliano e il capitano dei Carabineri Mario
D'Aleo, i magistrati Giovanni
Falcone, Paolo
Borsellino, Gaetano
Costa e Rocco
Chinnici, giornalisti come Mauro
De Mauro e Mario
Francese e anche il parroco del quartiere di Brancaccio, don
Pino Puglisi.
Oggi
Palermo, che s'affaccia su uno dei più bei golfi del Mar
Mediterraneo fra Monte
Pellegrino e il Capo Zafferano, circondata da quello che
resta della Conca
d'Oro, conta 700.000 abitanti ed è una città desiderosa di
riscatto e di ritrovare l'antico splendore. Essa è il centro degli
affari e dei commerci più importanti non solo dell'isola, ma con l'Africa e
gli altri Paesi che s'affacciano sul Mar
Mediterraneo, sede di un'Università d'antiche tradizioni, aperta
a molti studenti dei paesi islamici con i quali ha mantenuto antichi
legami, forte delle sue origini. La sua espansione urbana è stata
notevole, favorita nei collegamenti dall'autostrada che la unisce al
resto dell'isola, dall'aeroporto
Falcone-Borsellino e dalle linee marittime recentemente
incrementate, aspirando ad essere il centro di collegamento fra il Nord
Europa e il continente africano.
Palermo
e la setta dei Beati Paoli
 Le
prime testimonianze scritte sull’esistenza della setta appaiono nei
primi del ‘700. Da queste, una delle supposizioni più
accreditata è che le origini storiche dei Beati Paoli stiano
in un’altra associazione segreta, quella dei Vendicosi, attiva
già nel XII secolo e formata da cittadini di ceto
sociale basso che facevano giustizia, con lo scopo di
difendere i palermitani dai soprusi dei nobili. Le
prime testimonianze scritte sull’esistenza della setta appaiono nei
primi del ‘700. Da queste, una delle supposizioni più
accreditata è che le origini storiche dei Beati Paoli stiano
in un’altra associazione segreta, quella dei Vendicosi, attiva
già nel XII secolo e formata da cittadini di ceto
sociale basso che facevano giustizia, con lo scopo di
difendere i palermitani dai soprusi dei nobili.
Quanto
alle origini etimologiche, invece, diverse sono le ipotesi, ma
la più celebre vorrebbe il nome della setta derivi dalla devozione a San
Francesco Di Paola e al fatto che i Beati Paoli si aggirassero per
la città e per le chiese di Palermo,
vestiti di un saio monacale. Nella notte invece, questi uomini giravano
con il volto coperto da un cappuccio nero. Una delle fonti più
attendibili, grazie alla quale oggi sappiamo qualcosa in più sui
Beati Paoli, sta negli scritti del Marchese di Villabianca, che
riportò i racconti della tradizione orale, a lui tramandati sin da
bambino, nei suoi “Opuscoli Palermitani”.
I
tre Beati Paoli - Il Marchese, fu il primo a fare i nomi di
almeno tre supposti Beati Paoli e a collocare storicamente
l’operato della setta tra inizio del ‘600 e fine del ‘700. Villabianca
la descrive come la setta degli scellerati, dispensatrice di giustizia
sommaria ai danni dei potenti, che legittimava contro questi
ultimi, delitti ed atroci torture al fine di proteggere il
bene pubblico.
Del
primo uomo, Giuseppe Amatore, si sa solo che era un fabbricante
di fucili, detto “u Russu” e che fu impiccato a Palermo il
17 dicembre 1704, all’età di 27 anni. Il secondo uomo
misterioso, Girolamo Ammirata, era un contabile di
professione e fu impiccato al piano del Carmine nel 1723 per
avere ucciso un uomo con un colpo di fucile.
Villabianca
racconta che da bambino, ebbe l'occasione di incontrare il terzo uomo
della setta. Era un famoso conducente di carrozze a cavalli di
Palermo, Vito Vituzzu. Quest'uomo scampato alla morte, sciolta
la setta, diventò il sacrestano della chiesa di San Matteo al
Cassaro.
I
luoghi nascosti dei Beati Paoli - Secondo il Marchese di
Villabianca, i Beati Paoli erano soliti riunirsi nei vicoli sotterranei della
città, dopo la mezzanotte, al lume di candele e incappucciati di
nero. Questo luogo di ritrovo era un vero e proprio tribunale dove
i membri della setta decidevano della vita o della morte dei loro
rivali. La rete di vie e grotte sotterranee dove i Beati Paoli si
riunivano, apparteneva ad un'antica necropoli punica che si
pensa fosse localizzata sotto il mercato del Capo di Palermo.
Questa
rete di cunicoli era situata tra la Chiesa di Santa Maria
di Gesù (conosciuta come Chiesa Santa Maruzza dei Canceddi)
e la Grotta di Vicolo degli Orfani. La Santa Maruzza, che si
trova nell'odierna Piazza dei Beati Paoli, ha una cripta
sotterranea che si pensa fosse un ingresso alternativo al
tribunale della setta. All'interno della cripta, un passaggio segreto
portava al tribunale.
L’ingresso
originario, era da palazzo Baldi – Blandano, su quella
che oggi è via Beati Paoli, dove sul muro è visibile una targa
gialla con scritto “Antica sede dei Beati Paoli.” Oggi, al
presunto luogo di aggregazione, si accede da una
porticina che si apre nel Vicolo degli Orfani, una
stradina dietro la chiesa.

Beati
Paoli e Mafia: leggenda o realtà? - Gli scopi e il modo di operare
della setta, hanno fatto sì che, nei primi del ‘900, si diffondesse la
teoria di un legame tra Mafia e Beati
Paoli. In particolare, quando il tenente di polizia di New York Giuseppe
Petrosino, nemico della criminalità italiana trapiantata negli
Stati Uniti, fu assassinato a Palermo in Piazza Marina il
12 marzo 1909, l'inchiesta rivelò che la mafia, facendo
suo il mito dei Beati Paoli, aveva cominciato a tenere incontri
segreti nello stesso sotterraneo della setta.
Settant'anni
dopo Tommaso Buscetta, noto boss di Cosa Nostra, affermò: "La
mafia [...] viene dal passato. Prima c'erano i Beati Paoli […]:
abbiamo lo stesso giuramento, gli stessi doveri". Il pentito Totuccio
Contorno invece, si faceva chiamare “Coriolano della
Floresta”, come il protagonista del noto romanzo di Luigi
Natoli “ i Beati Paoli”. Di fatto, però, secondo gli storici,
il collegamento tra i due fenomeni non è mai stato provato. Infatti lo
studioso palermitano Rosario La Duca afferma: “La mafia
ha un’origine agraria connessa al disintegrarsi della struttura
feudale dell’Isola, avvenuta all’inizio del XIX secolo quando ormai
la setta dei Beati Paoli era da tempo scomparsa”.
Il
mistero irrisolto dei Beati Paoli - Ad oggi non abbiamo una risposta
sicura perchè non ci sono fonti certe che attestino l'esistenza della
setta. Tuttavia, data la notorietà della confraternita e le
documentazioni esistenti al riguardo, non possiamo escludere che ci sia
del vero dietro i racconti sulla sua esistenza.
Oltre
al Marchese di Villabianca anche il famoso scrittore Luigi Natoli nel 1909, ha
raccontato della setta nel suo romanzo a puntate “ I Beati
Paoli”. La storia fu pubblicata sul Giornale di Sicilia in
239 puntate e divenne un patrimonio comune dei siciliani, poveri
e borghesi. In particolare per gli abitanti del Capo, quartiere
dove si pensa si riunisse la setta, il romanzo diventò quasi un
testo sacro, letto in famiglia. Secondo lo storico De Luca, “
In Sicilia, i Beati Paoli è ancora oggi l’unico libro che molta gente
del popolo abbia letto nel corso della sua vita”.
Leggenda
o realtà, i Beati Paoli sono entrati anche nel linguaggio comune. Spesso
a Palermo e dintorni, per dire che una persona è buona solo in
apparenza ma pericolosa nei fatti, si usa il detto: “pari
nu Biatu Paulu“ cioè “ sembri un Beato Paolo”!
Palermo
arabo-normanna

Le
residenze arabo-normanne, la cattedrale e altre chiese, insieme al duomo
di Monreale e a quello di Cefalù, sono state inserite nella lista
dei patrimoni dell'umanità dall'Unesco il 3 luglio del 2015
nel sito seriale "Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù
e Monreale".
I
sette complessi monumentali palermitani che hanno tale riconoscimento
sono:
-
Il Palazzo
dei Normanni con la Cappella Palatina
-
La Chiesa
di San Giovanni degli Eremiti
-
La Chiesa
di Santa Maria dell'Ammiraglio o della Martorana
-
La Chiesa
di San Cataldo
-
La Cattedrale
-
La
Zisa
-
Il Ponte
dell'Ammiraglio
La
Regione ha chiesto che il sito possa ampliarsi ricomprendendo anche il Castello
a Mare, la Cuba, la Cubula, il Castello di Maredolce con
il Parco della Favara, la Chiesa di Santa Maria Maddalena e
la Chiesa della Magione.
A
questi si aggiungono altri complessi architettonici con caratteristiche
e tracce arabo normanne, che tuttavia non rientrano formalmente nel sito
seriale UNESCO, non rispondendo interamente ai suoi criteri: la Cuba
Soprana, inglobata dalla settecentesca Villa di Napoli, la Cappella
di S.Maria l’Incoronata, San Giovanni dei Lebbrosi, la Chiesa
dei Vespri, la Chiesa di Santa Cristina la Vetere, il Palazzo
dell'Uscibene, i Qanat e i Bagni di Cefalà Diana.
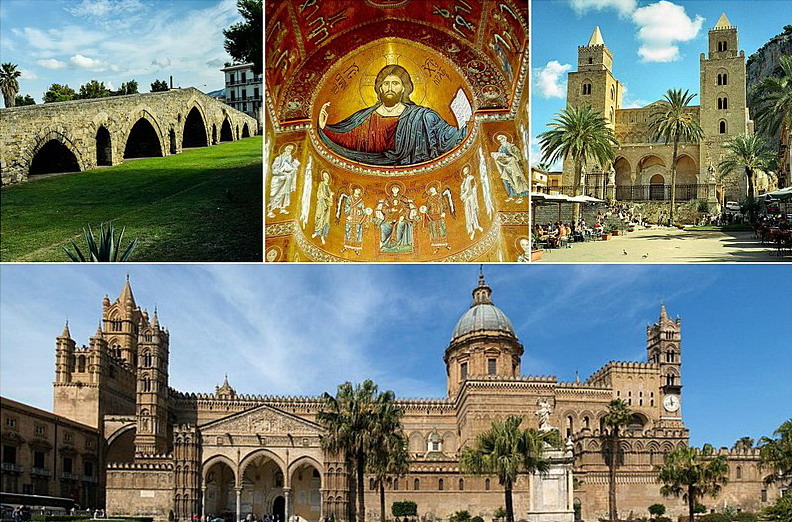
 Pag.
2
Pag.
2
Agosto
2018
|