|
Un
appagamento così intenso che avrebbe portato il primo psicoanalista a
temere di “risvegliare l’invidia degli dèi”. Con un’immagine
decisamente più cruda, Pippo Fava, il giornalista assassinato nel 1984,
la definiva “sontuosa e oscena”, paragonandola a Nuova Delhi, “con
le reggie favolose dei maharaja e i corpi agonizzanti dei paria ai
marini dei viali”.
Ma
cos’è realmente Palermo oggi? La città è dilagata da tempo oltre le
mura e le porte antiche e ha quasi reciso il suo cordone ombelicale con
il mare: il Tirreno sembra a portata di mano ma è quasi invisibile dal
centro storico. Tutta raggomitolata tra i vicoli dei quattro mandamenti
(Kalsa, Castellammare, Albergheria e Monte di Pietà) stupisce per
l’audacia delle sue architetture e la ricchezza del patrimonio
culturale, sconvolge per le macerie della guerra colorate dalla Street
art, confonde con il suo continuo gioco tra realtà e finzione,
stordisce nel barocco platealmente teatrale e negli scintillanti interni
dei palazzi nobiliari, in un saliscendi tra paradiso e inferno. Palermo
è un corpo con molti cuori che battono in luoghi diversi.
A
Ballarò, per esempio, insieme a quello del Capo il mercato più
esuberante, dove la proverbiale stratificazione
culturale si fa materia viva sui banchi traboccanti sarde a beccafico e
tranci di spada, ricotta calda e tuma, pani câ meusa (panino con
la milza) e arancine di riso, mazzi di finocchietto selvatico, frutta
candita e pistacchi, cibi africani e mediorientali. E dove le abbanniàte
(le urla di richiamo dei venditori) evocano un souk, in un legame mai
reciso con il mondo islamico.
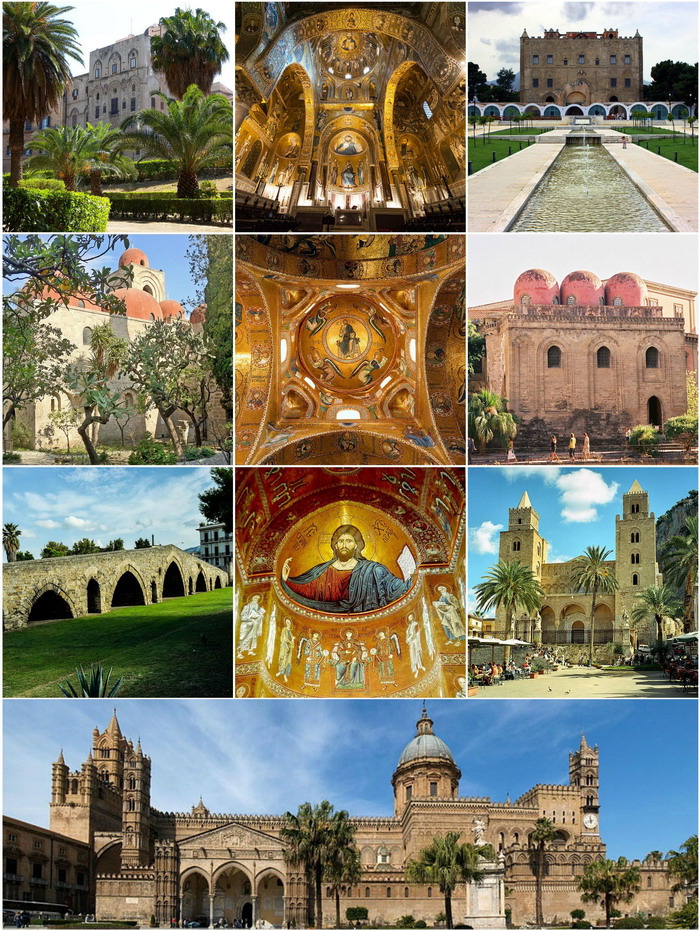 Gli
Arabi occuparono Palermo nell’831, trovandovi una città già vitale.
Vi giunsero per primi i Fenici, nell’VIII secolo a.C., approfittando
di una collocazione geografica eccezionale (a nord il monte Pellegrino,
a est il monte Catalfano, alle spalle la fertile Conca d’Oro) e di un
porto naturalmente conformato (per i Greci fu Panormos, “tutto
porto”). Gli
Arabi occuparono Palermo nell’831, trovandovi una città già vitale.
Vi giunsero per primi i Fenici, nell’VIII secolo a.C., approfittando
di una collocazione geografica eccezionale (a nord il monte Pellegrino,
a est il monte Catalfano, alle spalle la fertile Conca d’Oro) e di un
porto naturalmente conformato (per i Greci fu Panormos, “tutto
porto”).
Più
dei Romani e dei Bizantini, furono gli Arabi a marchiarla a fuoco: in
due secoli e mezzo l’arricchirono di moschee e di giardini profumati
di zagare e gelsomini e la resero la capitale di un emirato autonomo in
grado di rivaleggiare, per abitanti e potenza, con altre metropoli del
tempo come Cordoba e Costantinopoli.
Una
volta preso il sopravvento (1072), non fu affatto semplice per i
Normanni sradicare il substrato islamico. Giocarono perciò la carta del
sincretismo: della cultura araba, di quella bizantina e di quella che
portavano con sé dal Nord Europa. Un altro cuore di Palermo batte perciò
nel complesso di monumenti che costellano il centro storico (Cattedrale,
Palazzo Reale e Cappella Palatina e le tre chiese di San Giovanni degli
Eremiti, San Cataldo e della Martorana) e le immediate vicinanze (la
Zisa e il ponte dell’Ammiraglio), tutti protetti dall’Unesco. Un
cuore multiculturale, si direbbe, in cui l’amalgama delle civiltà ha
generato uno stile unico, quello arabo-normanno (anche se della
magnificenza islamica oggi resta ben poco): metodi costruttivi arabi,
iconografia occidentale, raffinatezze bizantine.
Nella
lucentezza dei palazzi di famiglia (suo nonno era Ruggero II) crebbe
anche un giovane Federico II (1194-1250), alla cui corte cosmopolita
fiorì la Scuola poetica siciliana. E se gli Angioni vennero cacciati in
malo modo nel 1282, furono gli spagnoli (Aragonesi prima, Castigliani
dopo) a dominare la scena politica per quasi 450 anni. L’impronta da
essi lasciata è tuttora palpabile, prima nella robustezza dei palazzi
feudali, quindi nella radicale sistemazione urbanistica culminante nei
Quattro Canti e nel gusto barocco che rivestì le chiese di preziosi
intarsi marmorei e gli oratori di stucchi spumeggianti.
Altri
colpi di scena Palermo li regala ai primi dell’Ottocento: la Palazzina
cinese sembra davvero un sogno d’Oriente, mentre più tardi
l’architetto Ernesto Basile si farà interprete delle esigenze dei
Florio dando vita all’esplosione del Liberty.
LA
SFAVILLANTE PALERMO ARABO-NORMANNA -
Mentre il dominio degli
eredi carolingi sulla penisola presenta, dopo la morte di Carlo Magno,
chiari segnali di crisi, la Sicilia vive l’invasione da parte degli
arabi del Nord Africa che conquistano Palermo nell’831 e l’intera
isola nel 935.
Un secolo dopo sono i
normanni a sostituirsi alla dominazione araba, dichiarando Palermo
(conquistata nel 1072) capitale del loro regno e ripristinandovi il
culto cristiano.
La dominazione
normanna, tuttavia, si rivela inizialmente tollerante con la minoranza
araba, favorendo al contempo la ripopolazione dell’isola da parte di
genti nordeuropee (in particolare provenzali, normanni e bretoni). Si
crea in questo modo un’incredibile convivenza di lingue, culture e
religioni diverse che lascerà dietro di sé una messe di capolavori
dalle variegate influenze.
Proprio questa
caratteristica è stata sottolineata dall’Unesco quando ha
riconosciuto questi siti, nel 2015, Patrimonio dell’Umanità. Nel
dossier si può infatti leggere: “L’insieme degli edifici
costituenti il sito di ‘Palermo arabo-normanna e le cattedrali di
Cefalù e Monreale’ rappresenta un esempio materiale di convivenza,
interazione e interscambio
tra diverse componenti culturali di provenienza storica e geografica
eterogenea”.
L’elenco
delle meraviglie arabo-normanne che impreziosiscono Palermo e i suoi
dintorni è molto lungo e comprende il palazzo della Zisa, le chiese di
San Giovanni degli Eremiti, della Martorana e di San Cataldo, la
Cattedrale della Santa Vergine Maria Assunta, il ponte
dell’Ammiraglio e, soprattutto, i tesori di Palazzo dei Normanni.
Porta
Nuova


La Porta
Nuova, adiacente al Palazzo
dei Normanni, è stata per secoli il più importante accesso a Palermo via
terra. Da essa partono il Corso
Vittorio Emanuele, o Cassaro, la principale arteria
cittadina, e, all'esterno, il Corso
Calatafimi, la strada verso Monreale.
Tommaso
Fazello documenta
l'apertura del primitivo varco nel 1460 denominato Porta
dell'Aquila e la contestuale chiusura di un varco d'accesso
inserito nella cinta muraria a meridione.
Costituita
da un solo ordine di colonne e cornicione, il 13 settembre 1535,
proveniente da Monreale, fece ingresso l'imperatore Carlo
V reduce dalla Conquista
di Tunisi.
Per la
liberazione dal contagio di peste nel fu apposta un'immagine della
Vergine Immacolata e l'iscrizione:
«Virgini Immaculatæ Summo Urbis Præsidio, atque ornamento,
Servati Clientes D. S.»
La
Porta Nuova perfezionata su più livelli fu voluta nel 1583 dal
viceré Marcantonio
Colonna per celebrare la vittoria sulle armate turche e
commemorare i trionfi del sovrano. Nonostante il Senato cittadino
avesse imposto il nome di Porta Austriaca, mentre alcuni
documentatori fanno riferimento a Porta Imperiale, il popolo
palermitano continuò ad appellare il monumentale varco come Porta
Nuova. Nel 1578 il
viceré perpetuò l'esistenza di un corridoio meridionale sopraelevato
comunicante col Palazzo
Reale verosimilmente ricalcante la parte iniziale attraverso
la Galca del
primitivo percorso della Strada
Coperta.
La
costruzione subì la quasi totale distruzione il 20 dicembre 1667, quando
esplosero i depositi di polvere da sparo a causa di un fulmine dovuto ad
un temporale. Nel 1669 l'architetto Gaspare
Guercio la ricostruì integralmente e pensò di porre a
coronamento dell'edificio una copertura piramidale rivestita da
piastrelle policrome maiolicate con le immagini di aquile ad ali
spiegate.
Le
iscrizioni del 1668 recitano
di provvedimenti e risarcimenti operati dal viceré
di Sicilia Francesco
Fernandez de La Cueva, duca
di Alburquerque. Il terremoto del 16 giugno 1686 provocò
dei danni. I lavori di restauro comportarono la realizzazione di scarpe o delfini di
rinforzo sul fianco sinistro, interventi posti in essere dal viceré Giovan
Francesco Pacecho, duca
di Uzeda.
Fino ai
restauri eseguiti nel 1825 è documentato visibile un affresco
raffigurante la Beata Vergine Maria contornata da angeli,
ritratta con Sant'Agata, Sant'Agatone, San
Michele Arcangelo, opera realizzata da Pietro
Novelli sulla parete interna di S - W.
Dal
1870 fa parte del complesso del distretto militare di Palermo.
Nel
settembre 2015 si sono conclusi i lavori di restauro e messa in
sicurezza del monumento.

La
struttura ravvisabile in un vero e proprio arco
trionfale con impianto realizzato in pietre d'intaglio,
ornato di statue, busti, pigne, colonne, pilastri, cornicioni,
balaustre, finestre, fregi, festoni, ghirlande, mascheroni, iscrizioni
marmoree recanti i versi di Antonio
Veneziano e un'aquila marmorea con armi reali, scultura
pericolante, poi rimossa. La costruzione presenta due prospetti
ripartiti su tre ordini, uno rivolto verso la città ricalcante gli
schemi classici degli antichi archi di trionfo, quello esterno presenta
un'architettura originale e bizzarra dominata dalla presenza
spettacolare di paraste binate in bugnato terminanti con quattro telamoni,
raffiguranti i Mori sconfitti da Carlo V, le due figure in posizione
centrale mostrano gli arti mozzati in segno di sottomissione.
Il
primo ordine è costituito dal basamento e dal varco carrozzabile, il
secondo ordine consta di vani recanti finestre - balconi sull'affaccio
verso Monreale e da busti di divinità collocati in oculi ovoidali
sulla facciata del Cassaro (sculture raffiguranti rispettivamente Pace,
Giustizia, Verità, Abbondanza). Un
terzo ordine comprende le logge rivolte ad oriente e occidente
realizzate in marmo bianco con 6 colonne che definiscono 5 archi abbelliti
con altrettanti mascheroni scolpiti nelle chiavi di volta. Ad ogni
campata corrisponde una porta sormontata da timpano ad arco
arricchita da erma intermedia. Chiude la prospettiva la struttura
piramidale coronata da balaustre, comprendente una balconata circondata
dalla copertura maiolicata. Un terrazzino include la lanterna sommitale
sormontata da pinnacolo e banderuola.
Le
dimensioni di 190 palmi in
altezza per 70 in larghezza e 70 di profondità sottintendono un
varco di passaggio largo 19 palmi e alto 38. Due fonti documentate
completavano il prospetto di Monreale nel 1674.
- Palazzo
dei Normanni e Cappella Palatina
Il Palazzo
dei Normanni, noto anche come Palazzo Reale, è attualmente sede
dell'Assemblea regionale siciliana. Il palazzo è la più antica
residenza reale d'Europa, dimora dei sovrani del Regno di Sicilia,
sede imperiale con Federico II e Corrado IV e dello
storico Parlamento siciliano. Al primo piano del palazzo sorge la Cappella
Palatina.
È
uno dei monumenti più visitati nell'isola. I servizi aggiuntivi
turistici sono curati dalla Fondazione Federico II; l'ingresso
principale è su piazza del Parlamento, quello turistico e quello
carraio sono su piazza Indipendenza.
 Dal
3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell'umanità (Unesco)
nell'ambito del sito seriale "Palermo arabo-normanna e le
cattedrali di Cefalù e Monreale". Dal
3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell'umanità (Unesco)
nell'ambito del sito seriale "Palermo arabo-normanna e le
cattedrali di Cefalù e Monreale".
L'attuale
palazzo ingloba nelle fondamenta stratificazioni dei primi insediamenti
fortificati d'origine fenicio - punica databili fra
l'VIII e il V secolo a.C., le cui tracce riemergono nelle
campagne di studi nelle segrete e nei sotterranei. Queste fortificazioni
costituivano il nucleo sociale e politico dei primitivi insediamenti che
formavano la paleopolis, aggregato contrapposto alla zona sacra,
destinata al culto pagano e alle sepolture, ubicata qualche centinaio di
metri più a nord-est a ridosso del fiume Papireto. Quest'ultima
area, futura neapolis, è oggi identificabile col piano
della cattedrale, il campanile ravvisabile nell'alta torre
di avvistamento incastonata nella cinta muraria della cittadella
fortificata, nonché da una fitta rete di ambienti ipogei costituita da
grotte, catacombe, cripte, cuniculi e spelonche, ubicati nelle immediate
adiacenze.
Paleopolis
e neapolis erano comprese su una lunga penisola delimitata a nord dal
fiume Papireto e dal Kemonia a mezzogiorno, striscia di terra
che all'epoca si estendeva lungo la direttrice configurabile con
l'odierno Cassaro. Una vasta e ramificata insenatura permetteva
l'approdo e il riparo delle imbarcazioni in entrambi i corsi d'acqua,
proprio a ridosso del polo monumentale, peculiarità che influì a
determinare il nome della località, in epoca greca Panormos ovvero
Città tutto Porto. Nel 254 a.C. la roccaforte del castrum fu
conquistata dai romani.
Flavio
Belisario conquistò
la città e si impossessò della fortificazione nel 535, il dominio
bizantino perdurò per quasi tre secoli. Sotto il regno di Costantino
IX Monomaco, imperatore costantinopolitano e re di Sicilia, la
fortificazione del kastron assunse il rango di palazzo con il
prefetto Giorgio Maniace il quale lo abbellì facendo
installare opere, manufatti e altro bottino di guerra.
I
due arieti di bronzo, espressioni dell'arte greca e frutto di
saccheggi, in Sicilia adornarono temporaneamente il portale gotico
della Fortezza Maniace di Siracusa per volere di Federico
II di Svevia. Ma di Trastámara per servigi resi nella strenua
difesa di Siracusa, li donò a Giovanni I Ventimiglia, pertanto i
manufatti pervennero dapprima nel castello Ventimiglia di Castelbuono e
in seguito posti a decoro del mausoleo di famiglia nella chiesa di
San Francesco. Per contrasti con la casa regnante e la confisca dei
beni, gli arieti dei Ventimiglia giunsero a Palermo.
Gaspare
Palermo documenta la loro presenza in epoche successive nel Palazzo
Chiaramonte-Steri, nella fortezza di Castello a Mare, trafugati da
un viceré di Sicilia a Napoli, riconsegnati alle sale di
Palazzo Regio. Con la distruzione di un elemento della coppia durante la Rivoluzione
siciliana del 1848, l'esemplare superstite, fu definitivamente
trasferito nelle raccolte del Museo archeologico regionale «Antonio
Salinas».
La
prima costruzione con funzioni di residenza reale denominata 'al
Qasr o Kasr (Alcassar, la dimora degli
emiri), è attribuita al periodo della dominazione islamica,
lasso di tempo di circa due secoli ove si avvicendarono numerosi
governatori o emiri appartenenti, nell'ordine, alle dinastie
degli Aghlabidi, Fatimidi, Kalbiti. Nell'831 dopo la
conquista araba della città il governatore, supremo comandante e
principe di Sicilia denominò la costruzione Castelnuovo che
si contrapponeva all'edificio ubicato in marina denominato Castellammare e
al Castello di Maredolce nel Parco della Favara,
quest'ultima dimora prediletta insieme a tutte le residenze e le
strutture arabe insediate nella vicina Kalsa.
Ibn
Hawqal documenta due medine o città murate contrapposte:
il Qasr e la Kalsa. In mezzo, tre borghi
satelliti tra loro separati e contigui corrispondenti al futuro rabato (Albergheria, Seralcadio, Conceria),
descritto da Muhammad al-Idrisi in epoca normanna.
La
decisione di trasferire la sede del governatore posta nel cuore della
città murata della civitas superior in un luogo più
sicuro e protetto militarmente, è fornita dalla tumultuosa sommossa
popolare contro il governatore fatimita Salīm Ibn Rashid Al Kutāni,
sedata nell'autunno del 937 con l'intervento militare di Khalil ibn
Ishaq. Il nucleo aghlabida è abbandonato dopo aver identificato nei
pressi del porto, nelle adiacenze dell'arsenale, la nuova sede della
cittadella fortificata degli emiri fatimidi, molto più difendibile
nella civitas inferior perché parzialmente protetta dal
mare.

I
sovrani Normanni distinguevano il Castrum superius o Palatium
novum posto sull'altura dal Castrum inferius o Palatium
vetus ubicato a valle, insediandosi al loro arrivo presso
quest'ultimo già dimora della corte araba. Il Parcus Vetus indicava
l'insediamento del centro di potere arabo, l'aggettivo Vetus (vecchio, antico, primitivo, vetusto)
si estendeva tanto all'area, quanto alla dimora del primitivo
accampamento. Accampamento divenuto residenza degli emiri e oggetto di
conquista da parte delle armate normanne, che nell'assedio di Palermo
piantarono nelle immediate adiacenze il loro campo base prima di
sferrare gli attacchi alla Kalsa e al Cassaro fortificato.
Infatti, dalla pianura alluvionale sud - orientale della costa, porta
d'accesso alla città provenendo da est, contraddistinta dal Dattereto prossimo
al fiume Oreto e al Castello di Yahya, partì la
riconquista della città. Negli anni ampliarono e trasformarono
l'edificio dalle caratteristiche mediorientali in un centro complesso e
polifunzionale che esprimeva tutta la potenza della monarchia, così
realizzarono una struttura di edifici. Roberto il Guiscardo lo
ingrandì dotandolo della Cappella di Gerusalemme, il gran
Conte Ruggero edificò la Torre Greca, i quartieri per opifici
e armigeri. Solo dopo la sua morte, la regina reggente Adelasia
del Vasto e l'erede al trono si trasferirono da Messina, città che
era servita da base ai Normanni per estendere il proprio dominio, a
Palermo. Nella capitale gli Altavilla s'insediarono
inizialmente nella residenza di Palazzo della Favara prima
di trasferirsi nelle strutture del Palatium novum.
Nel 1132 Ruggero
II di Sicilia costruì la parte mediana del palazzo, l'ampissimo
appartamento che oggi prende il suo nome, ovvero quella porzione
d'edificio precedentemente destinato a opificio della seta, la Cappella
Palatina e la Torre Joharia. Il luogo di culto dedicato a San
Pietro Apostolo soppiantò la primitiva moschea edificata sulle
carceri e segrete del palazzo. Da Guglielmo I e Guglielmo
II di Sicilia furono aggiunte le ali destinate ai servizi degli eunuchi,
secondo l'usanza araba, gli appartamenti delle dame di corte,
matrone, fanciulle, servitori, l'harem e nella parte settentrionale
fu aggregato il «serraglio degli schiavi», le torri Pisana o
di Santa Ninfa e Chirimbi. Coeva è la realizzazione
della "Via Coperta", un camminamento protetto che dalla Torre
Pisana e la Sala Verde attraverso la contrada della
Guilla conduceva al primitivo Palazzo Arcivescovile con meta
finale la cattedrale metropolitana primaziale della Santa Vergine
Maria Assunta.
In
questo lungo processo di trasformazione, l'antico Palazzo degli
Emiri assunse la denominazione di Palazzo dei Normanni solo
in tempi recenti, polo destinato ben presto a diventare il centro della
cultura e dell'arte europea tra il XII e il XIII secolo.
In
questi sontuosi e raffinati ambienti, infatti, si sviluppò la più
importante cultura europea dell'epoca: qui gli imperatori radunavano i
più grandi scienziati e poeti, musicisti e pittori del tempo.
All'interno del palazzo furono mantenuti gli opifici e i laboratori
tessili per produrre manufatti di rara bellezza mantenendo la
tradizione, le conoscenze, la cultura e il sapere introdotto dai
dominatori orientali, la Zecca, i laboratori di oreficeria ed il Tiraz,
l'opificio per la manifattura di stoffe preziose. Adiacente al regio
palazzo sorgeva la Galca (l'anello), il quartiere regio
che si sviluppava verso est racchiuso fra mura, ospitava edifici di
vario tipo legati alla funzionalità della reggia.
Muhammad
al-Idrisi nel 1150, Ibn Jubayr nel 1184, Ugo
Falcando descrivono nelle loro opere le magnificenze e le vicende
legate al palazzo. Il più rilevante degli episodi avvenuto negli anni 1160 - 1161 vede
il Palazzo Reale teatro della rivolta dei baroni maturata
in seguito alla congiura ordita da Matteo Bonello, durante la quale
le sale della reggia furono saccheggiate e date alle fiamme con la
distruzione di un insostituibile patrimonio librario e artistico.


Al 1194 risale
il saccheggio della reggia voluto da Enrico VI di Svevia, il quale
utilizzò cento muli per trasportare tutto l'oro e gli oggetti preziosi
in essa custodita. Con gli Svevi fu sede delle Scienze e
delle Lettere, elogiata da Dante Alighieri. Con Federico
II di Svevia e il figlio Manfredi furono mantenute nel
palazzo le attività di governo, amministrative e di cancelleria, mentre
quelle letterarie furono distaccate a Palazzo della Favara, luogo
deputato ad ospitare la scuola poetica siciliana.
Nel
1269 per il palazzo cominciò una fase di decadenza. Spoglio delle
macchine da guerra, mostrò tutta la sua vulnerabilità durante i moti
dei Vespri Siciliani culminati nel 1282 con le
sommosse inserite nel contesto della Guerre del Vespro: il popolo
palermitano in rivolta espugnò, depredandolo ancora una volta.
Scacciati gli angioini, Pietro III d'Aragona si trasferì
nel palazzo dimorandovi appena tre anni.
Dopo
l'espulsione degli Angioini nel 1282, la dinastia aragonese propense nel
dimorare allo Steri o Hosterium Magnum confiscato
alla famiglia Chiaramonte. Fra gli aragonesi fu sede di Francesco
II Ventimiglia, nominato signore perpetuo della capitale siciliana nel 1353.
Il 16 febbraio 1361 s'insediò Federico IV d'Aragona, con
i titoli di capitano e giustiziere, castellano del palazzo e di Castellammare.
Risalgono
al 1340 le prime notizie di guasti dovuti ad un rovinoso
crollo che determinarono il progressivo spopolamento della reggia. Il
sito non suscitava più particolare interesse per motivi logistici e di
sicurezza, ad essa si preferiva la residenza di Castellammare. Il
lento abbandono avvenne a partire dagli inizi del XV secolo,
periodo in cui Palazzo Regio e strutture limitrofe furono utilizzati
come cava da cui trarre materiale edilizio utilizzato per la costruzione
di luoghi di culto o cimiteri.

Nonostante
la pressoché totale devastazione, la cimatura e demolizione di alcune
torri, il Palazzo Reale, pur mantenendo solo il suo ruolo difensivo non
rimase disabitato, ma fu sede del Tribunale della Santa
Inquisizione tra il 1513 e il 1553. Nel 1549 Tommaso Fazello offre
un descrizione della situazione disastrosa in cui versava al punto che
era possibile scorgere la Cappella Palatina attraverso le rovine.
Il
palazzo tornò a occupare un ruolo importante nella seconda metà del XVI
secolo quando i viceré spagnoli lo elessero a propria
residenza, abbandonando il Palazzo Chiaramonte-Steri o Hosterium
Magnum. Per contro il Tribunale dell'Inquisizione si
trasferì nelle strutture di Castellammare. Furono poste in essere
iniziative che modificarono radicalmente l'aspetto originario del
complesso:
-
1517 Con
l'avvicendamento al trono del Regno di Sicilia tra Ferdinando
II d'Aragona dei Trastámara e Carlo V d'Asburgo è Ettore
Pignatelli, conte e duca di Monteleone, il primo viceré ad insediarsi
nel sito.
-
1536, Ferrante I Gonzaga, nell'ambito delle opere di potenziamento
dell'intero sistema difensivo della città convocò l'ingegnere
bergamasco Antonio Ferramolino che si era già occupato delle
fortificazioni del Palazzo, ma è nel 1553, dopo il trasferimento allo
Steri del Tribunale della Santa Inquisizione, che si iniziarono le
demolizioni e le nuove costruzioni.
-
1550, Juan de Vega effettuò un primo restauro, fu predisposta
la demolizione della Torre Rossa.
-
1560 Juan de la Cerda, IV duca di Medinaceli avviò i lavori per la
costruzione del Salone del Parlamento, ambiente perfezionato da
Francesco Ferdinando d'Avalos, VII marchese di Pescara.
-
1567, García Álvarez de Toledo y Osorio, predispose la
risistemazione dei vani intorno alla chiesa, l'ampliamento delle
scuderie, la costruzione di nuove stalle.
-
1580, Marcantonio Colonna, duca di Tagliacozzo (insediamento: 24
aprile 1577 - 1584), promosse la realizzazione del camminamento tra la
reggia e Porta Nuova. Nel 1598, gli uffici per
l'amministrazione della giustizia ordinaria Regia Magna Curia,
furono trasferiti in questa sede provenienti da Palazzo
Chiaramonte-Steri.
-
1600, Bernardino de Cardenas y Portugal, duca di Maqueda, realizzò
il cortile porticato che ospitava la Deputazione del Regno istituita
da Alfonso V d'Aragona.
-
1616, Juan Gaspar Fernández Pacheco y Zúñiga, V marchese di Vigliena,
V duca d'Escalona definì la parte centrale dell'ala est dotandola di un
elegante prospetto in stile rinascimentale e un patio interno.
-
1620 23 maggio, Francìsco Ruiz de Castro Andrade y Portugal,
conte di Castro, VIII conte di Lemos e duca di Taurisano decretò la
demolizione del tempio bizantino di Santa Maria dell'Itria detta «la
Pinta» nel quadro di moderni sviluppi urbanistici e del
potenziamento del sistema difensivo della reggia.
-
1637, Il presidente del Regno Luigi Moncada, duca di
Montalto, adeguò l'antico deposito delle munizioni, trasformandolo in
sala delle udienze estive del Parlamento, arricchendolo
d'affreschi, opere dei più celebrati artisti dell'epoca come Vincenzo
La Barbera, Giuseppe Costantino, Pietro Novelli e Gerardo
Astorino. Per tale motivo gli ambienti comunicanti assunsero la
denominazione di Sala Duca di Montalto. Il cortile colonnato noto
col nome di Galleria con la sede principale per i
giudici e i presidenti della Gran Corte Civile e Criminale.
-
1648, Per ordine del cardinale Teodoro Trivulzio viceré di
Sicilia e presidente del Regno, la chiesa della Pinta insieme alla chiesa
di Santa Barbara la Soprana e chiesa di San Giovanni la Calca,
furono abbattute per fare posto a due grossi bastioni posti a difesa del
Palazzo Reale. Bastioni di San Pietro.
-
1649, Il cardinale Teodoro Trivulzio in seguito ai tumulti
causati dalla rivolta antispagnola aggiunse due baluardi muniti
d'artiglieria perfezionati perfezionati da Giovanni d'Austria nel
1650.
-
1696, Pedro Manuel Colón de Portugal dispose la copertura del
camminamento tra reggia e Porta Nuova.

Gli
appartamenti reali subiscono una ulteriore rimodulazione nel 1735 con Carlo
III di Borbone che edificò la Scala Rossa, una scala
monumentale posta presso il cortile colonnato del Duca di Maqueda.
Venute meno le esigenze difensive è compiuta la riduzione o demolizione
dei bastioni orientali per l'adeguamento della piazza al livello del
Cassaro e altrove, la loro trasformazione in Giardini Pensili.
Anche
i Borboni delle Due Sicilie con Ferdinando III fecero
ristrutturare il Palazzo dei Normanni che visse la stagione di maggiore
operosità, dopo la fase cinquecentesca, in virtù della permanenza
della Corte Borbonica: infatti i sovrani, fuggiti con la conquista di
Napoli da parte di Napoleone Bonaparte, si rifugiarono a Palermo.
Il Salone del Parlamento fu adibito all'esposizione della
preziosa Quadreria di Capodimonte e il monarca decise di fare affrescare
nuovamente le pareti e la volta della sala, affinché il salone
presentasse "... uno stile più elegante e più grandioso".
Il ciclo di affreschi raffigurante l'Apoteosi di Ercole di Giuseppe
Velasco sostituì La Maestà Regia, protettrice delle
Scienze e delle Belle Arti commissionato da Francesco
d'Aquino, principe di Caramanico nel 1787.
Altri
interventi decorativi abbellirono le sale di rappresentanza, i corridoi
degli appartamenti del re e della regina al piano nobile durante la loro
permanenza stabile dal 1806 al 1815. In occasione
dei moti rivoluzionari del 1848 furono abbattuti dal popolo in
tumulto i bastioni di Santa Maria e San Michele, la dimora fu
saccheggiata e fu distrutta gran parte del mobilio, arredi velocemente
ripristinati.
Dopo
l'Unità d'Italia fece parte dei beni del comando dei Corpi
dell'Esercito e in occasione dell'esposizione nazionale del 1891 - 1892 furono
rinnovati gli arredi degli appartamenti reali. Nel 1919 si delineò la
possibilità di utilizzare il Palazzo come sede di accademie e nel 1923
fu destinato ad accogliere gli uffici della Soprintendenza ai
monumenti, alcuni Istituti universitari, la Real Accademia di
Scienze Lettere e Arti, la Biblioteca Filosofica, il Museo
etnografico siciliano Giuseppe Pitrè, il Museo Nazionale e l'alloggio
del Prefetto. Furono mantenuti per uso della casa reale alcuni
appartamenti. Nel 1921 è stata acquisita la proprietà da parte del
governo.
Negli
anni '30 del '900 furono portati avanti dei restauri da parte del
sovrintendente ai monumenti Francesco Valenti, poi proseguiti da Mario
Guiotto, che hanno riportato in luce alcune strutture normanne. Nel
1943 fu requisito dalle truppe alleate. Poco dopo la fine
della seconda
guerra mondiale nel 1946, ebbero inizio i primi saggi
archeologici volti a comprendere l'eventuali preesistenze al palazzo,
ovvero le stratificazioni di manufatti e insediamenti anteriori agli
interventi arabi.
Nel
1947 gli enti che lo occupavano furono trasferiti in altri immobili e fu
denominato Palazzo dei Normanni. Nel 1947, divenne sede
dell'Assemblea Regionale Siciliana. Dal 1976 al 1981 furono eseguiti
lavori di trasformazione in alcuni piani del palazzo, curati da Rosario
La Duca. Dopo il terremoto del 2002 che ha
danneggiato alcuni interni, sono stati effettuati dei restauri sugli
affreschi di Sala d'Ercole.
Attualmente
è la sede del Parlamento di Sicilia e dell'Osservatorio astronomico di
Palermo, mentre l'ala di collegamento a porta Nuova è sede
del Comiliter, Comando militare territoriale della Sicilia.

Il Palazzo dei Normanni
è la più antica residenza reale d’Europa e le sue origini affondano
in epoche remote come quella fenicia-punica, le cui tracce sono state
identificate dagli studiosi nelle segrete e nei sotterranei del palazzo.
In epoca greco-romana
l’edificio viene usato come fortificazione, poi conquistata nel 535
dal generale bizantino Flavio Belisario. Ma è solo in epoca islamica
che il palazzo diventa residenza reale e comincia a essere chiamato
alcassar (residenza degli emiri).
Verrebbe da chiedersi
perché, se ogni conquistatore della Sicilia vi ha lasciato le sue
tracce inconfondibili, questo capolavoro è noto universalmente come
Palazzo dei Normanni. Il fatto è che a questo popolo si devono la
struttura attuale dell’edificio e gran parte della sua sfolgorante
bellezza.
In
particolare, è Ruggero II a ristrutturare completamente la parte
centrale del palazzo. Collocandovi poi i suoi appartamenti in una sala
che ancora oggi porta il suo nome (sala Re Ruggero). Il re ricava
l’ampio salone nella parte più antica
dell’edificio, ed erige la Torre Joharia, detta anche Torre del Tesoro
per lo splendore delle sue decorazioni.
Lo stile dei mosaici che
decorano varie sale di questo palazzo presenta delle somiglianze con
quello della cappella Palatina e della cattedrale di Monreale. I
soggetti sono scene di caccia o motivi vegetali orientaleggianti, come
piante di banani e palme. Le scene di caccia rappresentano
un’allegoria della corte normanna raccontata attraverso animali metaforici
come cervi, pavoni e cigni, creature mitologiche come centauri e grifi o
fiere esotiche. Il predominio dell’arte greco-bizantina è evidente
per quanto venato da influenze del vicino Oriente persiano.
L'aggregato
degli edifici assume la forma di una forcella capovolta, i due bracci
meridionali della biforcazione intersecano i manufatti
della Cappella
Palatina che originano due grandi cortili interni. Molteplici stili
si fondono sui svariati ordini e sulle numerose sfaccettature delle
varie prospettive. Gli stili romanico, bizantino, arabo, normanno,
neogotico, chiaramontano, rinascimentale, barocco, miscelano elementi
come strombature, nervature, oculi, rilievi, archi, ogive, bugnato,
monofore e finte bifore, tufo combinato con tarsie di lava, intrecci,
pietra viva, modanature, merlature, marcapiani, archi, timpani dal forte
impatto sensoriale ed emotivo.
Delle
quattro torri normanne originarie: la Greca, la Chirimbi, la Pisana,
la Joaria, oggi rimangono solo le ultime due, di forma
quadrangolare coeve coeve alla
Cappella Palatina. Sono presenti più cortili interni, due di essi
provvisti di logge e portici: il Cortile Maqueda interamente
porticato con due ordini di logge di stile rinascimentale, e il Cortile
della Fontana posto ad un livello superiore rispetto al primo. I
vari livelli sono collegati tra loro da scaloni monumentali. Il Cortile
Maqueda è il crocevia dei principali ambienti, ali e manufatti:
-
Sotto il livello del patio sono ricavate le Sale del duca di
Montalto, oggi sedi di mostre ed esposizioni, da cui si accede a loro
volta agli scavi sotterranei.
-
Dal patio si accede alla chiesa di Santa Maria delle Grazie.
-
Al primo livello è posto l'ingresso alla Cappella Palatina.

-
Prospetto Nord.
L'ala dell'edificio è delimitata da Porta Nuova, nuovo varco d'accesso
costruito da Carlo V per celebrare la Conquista di Tunisi in
sostituzione dell'antica porta denominata Bab ar ryad o Porta
dei giardini. Via Vittorio Emanuele o Cassaro col prolungamento di
Corso Calatafimi separa i due mandamenti, nello specifico distingue
l'Albergaria dal Monte di Pietà o Seralcadi. Con la
trasformazione graduale della Galca (Jalca), e la fusione di
essa al resto della città, la chiesa di Santa Maria Maddalena,
vicinissima a Porta Nuova, venne a trovarsi inglobata nel quartiere di
San Giacomo dei Militari o degli Spagnoli, la cui vasta area estesa dal
Cassaro al Papireto, fin dal 1622 era stata utilizzata dalle truppe
spagnole di stanza in città per il presidio e la difesa della reggia.
-
Prospetto Est.
Il palazzo prospetta su Piazza del Parlamento, che a sua volta si
fonde con Piazza Vittoria e il parco di Villa Bonanno, le
tre aree costituivano il primitivo Piano di Palazzo. Sulla Torre
Pisana si ammira l'originaria facciata del periodo normanno
decorata con arcate strombate e cieche. Più a sud, la facciata in stile
rinascimentale che occupa buona parte dell'intero prospetto. Al centro
è un grande portale che costituisce l'ingresso principale. L'ala
rinascimentale ospita al piano inferiore la Sala degli Armigeri e
al piano superiore il cosiddetto Piano parlamentare ove sono
ubicate la Sala d'Ercole, attuale aula parlamentare dell'Assemblea
regionale siciliana, la Sala Gialla, la Sala Rossa, la Sala
Verde e la Sala dei Viceré.
-
Prospetto Sud.
Su Via del Bastione e sul lato ovest di Piazza Indipendenza parti
dell'edificio poggiano su possenti fondamenta sopra il livello della
strada fronteggiando la ricostruita chiesa di Santa Maria
dell'Itria detta «la Pinta».
-
Prospetto Ovest.
Su Piazza Indipendenza si apre l'accesso carraio e quello
turistico, di fronte Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione
siciliana.
La
torre pisana, altrimenti noto come Torre Santa Ninfa era
un costruzione destinata alla custodia dei tesori, manufatto edificato
da Guglielmo II di Sicilia col contributo di maestranze
pisane. Secondo la tradizione, in epoca sveva con Federico II, la torre
era probabilmente uno dei luoghi di riunione della scuola poetica
siciliana ed ambiente frequentato dallo stesso sovrano. Il vicerè
Francesco d'Aquino di Caramanico fece realizzare nel 1790
l'osservatorio astronomico.
Esternamente
appare priva di decorazioni, ma è lecito supporre dalle tracce visibili
che, nelle zone in cui furono aggiunti dei soppalchi dagli spagnoli,
fosse interamente mosaicata probabilmente con scene di battaglie,
seguendo canoni che imponevano una forte simmetria tra le scene
raffigurate. Comprendeva la Stanza dei Tesori, con doppia porta
d'accesso, circondata da camminamenti di ronda coperti da volte maestose
e le quattro giare murate nel pavimento che potevano contenere
innumerevoli pezzi di monete d'oro.
La
facciata orientale è il risultato di un importante intervento di
restauro di ripristino neogotico dell'architetto Nicolò Puglia nel
1835. Lo stesso Puglia fu l'autore del progetto di decorazione neogotica
dei prospetti occidentali intorno al 1842. Gli interni comprendono nel
piano parlamentare la Sala di Federico, la Sala Cinese e la Sala
Pompeiana, della prima metà dell'Ottocento, decorate con pitture di Giuseppe
Patania e Giovanni Patricolo, ambienti che costituivano gli
appartamenti privati della regina Marina Carolina di Borbone.
Torre
Joharia o Torre
Gioaria, conosciuta come Torre del Tesoro, eretta da Ruggero
II di Sicilia. Presenta la maggior quantità di ornamenti,
risplendente per la magnificenza delle più svariate decorazioni, il re
era solito frequentare per gli abbandoni all'ozio e alla quiete. Il
livello inferiore è occupato dalla Sala degli Armigeri. Al piano
superiore è ubicata la Sala dei Venti, ad est si accede alla Sala
di Ruggero.
Torre
Chirimbi o Torre
Carimbri, edificata da re Guglielmo I di Sicilia. Demolita.
Torre
Greca. Torre
Greca o Torre Rossa, detta anche Torre
Kemonia per la posizione, costruzione fatta edificare in
mattoni di laterizi da maestranze greche, da cui il nome, sul prospetto
meridionale per volere del Gran Conte Ruggero. Nel 1550 il viceré
di Sicilia Juan de Vega la demolì per effettuare un restauro.


Al
secondo livello del Loggiato di Cortile Maqueda è permesso l'accesso al
Piano Parlamentare che, attraverso il Corridoio Mattarella,
consente il percorso fra gli ambienti degli appartamenti reali - secondo
le note documentali, gli appartamenti della regina e del principe
ereditario - ubicati nel plesso rinascimentale, mentre Sala dei
Venti e Sala Ruggero sono dislocati nella Torre
Joaria.
Corridoio
Mattarella
- Ambiente
di collegamento degli ambienti della primitiva Galleria.
All'ingresso è collocato il quadro, olio su tela, opera del pittore
siciliano Giuseppe Sciuti del 1901 raffigurante l’Allegoria
dell'agricoltura, dell'industria e dell'economia, lungo il percorso
è presente una grande statua in bronzo raffigurante Archimede,
opera dell'artista palermitano Benedetto Civiletti, eseguita nel
1893 su commissione di re Umberto I. Un altro acquisto del sovrano
all'Esposizione Nazionale di Palermo del 1891 è un olio su
tela raffigurante la Battaglia di Dogali, opera firmata dal
pittore romano Cesare Biseo del 1887.
Sala
d'Ercole
-
Sala
del Parlamento conosciuta
come Sala d'Ercole perché vi si riunivano negli ultimi
secoli i membri del Parlamento siciliano. Nel 1799 Giuseppe
Velasco, pittore figurista, su committenza di Ferdinando III
di Borbone decorò a tempera le pareti della sala con alcune tra le
dodici Fatiche di Ercole. Sulla volta si ammirano: la Nascita
di Ercole, la scena Ercole si dà la morte facendosi
bruciare su una pira ardente e la monumentale Apoteosi dell'eroe
mitologico greco. Le decorazioni a grottesca e le candelabra in
stile neoclassico pompeiano furono dipinte dal pittore ornatista Benedetto
Codardi. Nell'ambiente si riuniscono dal 1947 i deputati dell'Assemblea
Regionale Siciliana, i quali costituiscono l'organo legislativo della
regione.
Ha
la funzione di anticamera al Salone d'Ercole la Sala di
Archimede. La sala prende il nome dall'omonima statua, ed è
ricavata negli antichi ambienti medievali che collegavano lo scalone
d'onore alla cinquecentesca Sala dei Parlamenti.
 Sala
dei Viceré - Il
nome dell'ambiente deriva dalla presenza di 21 ritratti collocati alle
pareti raffiguranti rispettivamente: viceré di Sicilia, luogotenenti e
presidenti del regno Borbone di Sicilia e delle Due
Sicilie, primo sovrano Carlo III di Borbone.
Altrimenti
noto come Transatlantico. Sala
dei Viceré - Il
nome dell'ambiente deriva dalla presenza di 21 ritratti collocati alle
pareti raffiguranti rispettivamente: viceré di Sicilia, luogotenenti e
presidenti del regno Borbone di Sicilia e delle Due
Sicilie, primo sovrano Carlo III di Borbone.
Altrimenti
noto come Transatlantico.
Alla
stessa stregua delle raccolte di Palazzo Paço da Ribeira di Lisbona,
del Monastero de las Descalzas Reales di Madrid, del Palacio
del Real di Valencia, del Real Alcázar di Madrid, del monastero
dell'Escorial di Madrid, di Palazzo Reale di El Pardo di Madrid,
di Villa Gallia di Paolo Giovio a Borgovico, di Palazzo
di Margherita d'Austria di Malines, della residenza di Binche,
anche i viceré e i governatori della casa d'Asburgo iniziarono
ad arredare, a partire dalla fine del XVI secolo le gallerie
di palazzo reale di Milano, palazzo reale di Napoli e
Palermo.
La
disposizione dei ritratti all'interno della galleria operata dal Manuel
de Benavides y Aragón, conte di Santisteban, risale ai tempi del Bernardino
de Cardenas y Portugal, duca di Maqueda, e annoverava trentasette
ritratti di viceré, da Fernando de Acuña y de Herrera, conte di
Buendía, fino allo stesso Manuel de Benavides y Aragón.
Probabilmente
fu sostituta l'originale decorazione degli inizi del XVII secolo,
come ci suggerisce la descrizione della cerimonia per le nozze di donna Giovanna
d'Austria, figlia di Giovanni d'Austria e nipote di Carlo
V d'Asburgo, con Francesco Branciforte, principe di Pietraperzia. Più
tardi nel 1640 l'ambiente presentava un ciclo di affreschi
raffigurante le Storie della vita di San Francesco d'Assisi e
Sant'Antonio di Padova, opere realizzate da Pietro Novelli, i
cui frammenti superstiti, trasferiti su tela, sono custoditi nella Galleria
regionale di Palazzo Abatellis. Fra le poche raffigurazioni d'epoca
della Galleria, la tavola inserita nel codice illustrato "Teatro
Geografico antiguo y moderno del Reyno de Sicilia", completato
il 1 maggio del 1686 che mostra la sala della galleria ai tempi del
viceré conte di Santisteban.
La
cerimonia d'incoronazione di Carlo III di Borbone a Palermo
del 1735 documentata da Antonio Mongitore, contempla nella Galleria
i ritratti dei sovrani da Ruggero II a Carlo II, mentre
relega i ritratti dei viceré asburgici nelle restanti sale del palazzo.
Il nobile palermitano Francesco Maria Emanuele Gaetani, marchese di
Villabianca, riporta che i ritratti delle anticamere sono gli originali
raccolti da Manuel de Benavides y Aragón. Il presente ciclo della
Galleria fu rinnovato nel 1738 da Carlo di Borbone che ne affidò il
compito della realizzazione al pittore fiammingo Guglielmo
Borremans. Fra i ritratti dei Governatori di Sicilia, facenti le veci
del re che risiedeva a Napoli, si ammirano:
Domenico
Caracciolo, marchese di Villamaina: nel 1782 soppresse l'inquisizione del
Santo Ufficio, destinando le rendite di tale istituzione alla
realizzazione di nuove cattedre universitarie.
Francesco
d'Aquino di Caramanico: nel 1788 fece abolire le angherie, i
lavori che i contadini a titolo gratuito dovevano prestare in favore dei
feudatari. Prima che in Francia, fece abrogare le servitù personali nel
1789 e realizzare nel 1790 l'osservatorio astronomicoubicato sulla Torre
Pisana.
Il
fregio che segna il perimetro della sala in direzione della volta, fu
realizzato nel 1901 da Salvatore Gregorietti ed evidenzia il
simbolo della Sicilia, Trinacria e l'aquila del Senato
Palermitano.
 Sala
di Federico.
Nella Torre Pisana si trova la sala principale degli ex appartamenti
reali. Sala delle udienze di Federico II, si ritiene fosse stata
interamente coperta di mosaici. Non visitabile, dal 1947 è divenuta
studio e ambiente di rappresentanza del Presidente dell’ARS. Sala
di Federico.
Nella Torre Pisana si trova la sala principale degli ex appartamenti
reali. Sala delle udienze di Federico II, si ritiene fosse stata
interamente coperta di mosaici. Non visitabile, dal 1947 è divenuta
studio e ambiente di rappresentanza del Presidente dell’ARS.
Sala
ex Presidenti.
L'ambiente prospetta su piazza Indipendenza, attiguo a Sala d'Ercole,
prende il nome per via dei ritratti collocati alle pareti, raffiguranti
i primi sei presidenti dell'Assemblea regionale siciliana. I saggi
effettuati, posteriori al terremoto di Palermo del 2002, hanno
condotto alla scoperta di complesse realtà archeologiche relative a
stratificazioni di differenti epoche: sono evidenti la costruzione
originaria e gli interventi d'epoca borbonica, quando questa parte è
stata adibita a saloni di residenza regia, seguendo i canoni del tempo.
Sala
Pompeiana.
Altrimenti conosciuta come Sala della Regina, fu voluta da Maria
Carolina d'Asburgo-Lorena, principessa delle due Sicilie, moglie di Ferdinando
IV di Borbone. Il raffinatissimo ambiente, dipinto da Giuseppe
Patania (1807 - 1815), è un altro mirabile esempio di
decorazioni neoclassiche influenzate dagli scavi di Ercolano e Pompei.
Sala
Gregorietti.
Ambiente adibito a sala lettura per i parlamentari, sul soffitto
l'affresco raffigurante l'Allegoria della Primavera decorato
dal palermitano Salvatore Gregorietti.
Sala
Cinese.
Ambiente ispirata alle a mete orientali nel periodo coloniale quali la
Cina, tipica della moda esotica in voga presso molte corti d'Europa,
decorazione caratterizzata dalla presenza di ideogrammi riprodotti
sugli architravi delle porte e finestre. Realizzata da Giuseppe
Patricolo, questo genere di ambienti si prestavano a svariate funzioni,
quali sale di rappresentanza o da semplici ambienti riservati al
convivio.
Salottino
Savoia.
Salottino
del Monetario.
L'ambiente consente la visione d'insieme di tutto il piano. La
denominazione è dovuta alla presenza del pregevole, grande stipo monetiere in
legno ebanizzato a due corpi, decorato con formelle in vetro dipinto con
scene bibliche, tarsie in tartaruga di fiume, colonne tortili laccate in
rosso finta tartaruga e decori in bronzo di fattura siciliana della fine
del XVII secolo. L'olio su tela custodito raffigura il Piano
Palazzo nel 1760, il disegno di Pietro Martorana su
cartoncino ad acquarello e tempera evidenzia la Campagna
palermitana ove fu costruita la casina dei Lombardo, ovvero la
costruzione rilevata da Ferdinando di Borbone al suo arrivo da
Napoli nel dicembre del 1798, edificio divenuto la Palazzina Cinese con
la tenuta di caccia e il Reale Parco della Favorita.
Salottino
del Presidente.
Sala
della Preghiera.
Ambiente attiguo alla Sala Ruggero, altrimenti detto Cappella
della Regina o Carolina, delizioso esempio del
neogotico siciliano con stucchi bianchi e oro. La pala d'altare è un
olio su tela raffigurante la Madonna con Gesù e San Giovanni di
gradevole fattura siciliana della prima metà XIX secolo, opera di Pasquale
Sarullo. Un Cristo in avorio risalta su una croce in tartaruga e la base
impiallacciata in palissandro, d'artista siciliano di fine 1700.
Completano le decorazioni due dipinti, olio su tela della scuola
emiliana del XVIII secolo, raffiguranti rispettivamente Tobiolo
e il padre cieco e Agar e l'angelo.
Sala
dei Paesaggi Siciliani.
L'ambiente in epoca normanna faceva parte dell'appartamento privato del
sovrano. Nella prima metà dell'Ottocento fu anticamera
dell'appartamento utilizzato dai sovrani Borboni. Al tempo dei Savoia fu
utilizzata come salotto e vi furono collocati le due grandi tele
raffiguranti paesaggi siciliani: i Ruderi del Tempio di Giove a
Siracusa di Ettore De Maria Bergler e le Mura
fenicie di Erice di Michele Gordigiani ora in sala
della preghiera. I dipinti furono acquistati da re Umberto I in
occasione dell'esposizione Nazionale di Palermo nel 1891.
Sala
Bianca.
Ambiente altrimenti noto come Sala Stampa caratterizzata
dal riquadro affrescato raffigurante l'Allegoria della prosperità e
delle arti di Giuseppe Velasco che lavorò a palazzo
durante la permanenza dei Borboni in Sicilia.
 Sala
dei Venti - Antica
cappella di Santa Maria Superiore fatta edificare da Roberto il
Guiscardo e Ruggero I di Sicilia nel 1071, convertita ad uso
profano nel 1520. Restauri della Sala delle Quattro Colonna,
così denominata nel XVI secolo quando fu decorata con vetrate
colorate da Simone de Wobreck, autore nel 1560 del dipinto Pittura
dell'isola di Sicilia, opera documentata nella reggia. Sala
dei Venti - Antica
cappella di Santa Maria Superiore fatta edificare da Roberto il
Guiscardo e Ruggero I di Sicilia nel 1071, convertita ad uso
profano nel 1520. Restauri della Sala delle Quattro Colonna,
così denominata nel XVI secolo quando fu decorata con vetrate
colorate da Simone de Wobreck, autore nel 1560 del dipinto Pittura
dell'isola di Sicilia, opera documentata nella reggia.
Dopo
l'insediamento nel 1713, Vittorio Amedeo II di Savoia ne
fa scoperchiare il tetto sistemando al centro della volta lignea a
lucernario la Rosa dei venti. In epoca borbonica vi
sono documentati l'Appartamento delli marmi e quello di S.A.R. il
principe ereditario.
Ambiente
interno tra i più suggestivi ed affascinanti del Palazzo. Inglobato
nella Torre Joharia è coevo, adiacente e comunicante con la Stanza
di Ruggero, sintesi del passaggio di più culture. Proprio la
collocazione ne determinò i lievi interventi successivi. Alle pareti è
collocato un olio su tela raffigurante la Negazione di Pietro,
opera firmata e datata di Filippo Paladini nel 1613.
Sala
Ruggero - Voluta
da Ruggero II d'Altavilla fu ricavata nella Torre Pisana,
l'ala più antica del palazzo con accesso dalla Sala dei Venti. Le
stupende decorazioni parietali furono commissionate dal figlio Guglielmo
I d'Altavilla detto il Malo o il Cattivo,
verosimilmente coeve agli ornamenti delle navate laterali della Cappella
Palatina e improntate allo stesso stile riscontrabile nei cicli musivi
della chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio detta «la Martorana» e
della cattedrale di Santa Maria Nuova di Monreale.
Colonnine
angolari delimitano alti rivestimenti in marmo sovrastati da ampie
superfici a mosaico di grande pregio raffiguranti elementi vegetali
(palme e banani) e scene di carattere aulico e venatorio, simboli del
potere normanno. Sono raccontate con grande dedizione nell'esecuzione
battute di caccia con arcieri e cervi, rappresentati pavoni, cigni,
oltre i mitologici centauri, grifi e altri animali
esotici tra cui leopardi e tigri fra lussureggiante
vegetazione, sottile allusione al Parco del Genoardo, tutto nel
tentativo di mostrare un'allegoria della corte normanna.
Caratteristica
le figure a coppie simmetriche e speculari, arabeschi e girali
dall'effetto caleidoscopico immersi in motivi fitomorfi e zoomorfi. Le
raffinate rappresentazioni dai canoni sontuosi ma con accenti di rigidità,
delineano la chiarissima matrice greco-bizantina dell'opera combinata
con l'influenza pittorica dell'Oriente persiano.
La
decorazione centrale della volta della sala risale invece al periodo
successivo di Federico II, come testimoniato dalla rappresentazione
dell'aquila sveva.
Sala
Rossa - Era
parte dell'originaria Galleria del Palazzo. Sulla
volta, l'opera attribuita a Benedetto Codardi raffigurante: l'Apoteosi
del lavoro, dell'agricoltura, delle arti e delle scienze. La sala
era usata per le udienze dei Viceré e al tempo dei re borboni diventò
la Sala del Trono. Oggi è ambiente istituzionale spesso
utilizzato per le riunioni dei capigruppo.
Sala
Gialla - Altra
sezione dell'antica Galleria adibita a Sala da
ballo dai Borboni e dai Savoia altrimenti nota come Sala
degli Specchi, deve il nome alle pareti rivestite di damasco giallo.
In epoca spagnola era utilizzata come sala delle feste, dei ricevimenti
e dei balli.
Le
opere della volta furono realizzate nella prima metà dell'Ottocento da Giuseppe
Patania con La consegna della Città da parte dei Musulmani,
da Giuseppe Patricolo con La presa di Palermo da parte
dei Normanni, da Vincenzo Riolocon Il ritorno di
Nicodemo al soglio vescovile di Palermo, per rispetto e
riconoscimento dei valori della cultura araba non sono rappresentati
eventi sanguinosi, ma incontri pacifici. Dieci bassorilievi in gesso,
eseguiti probabilmente dal siciliano Nunzio Morello, raffiguranti
la conquista e l'ingresso vittorioso in città del conte Ruggero,
completano le decorazioni. La sala è oggi sede di importanti incontri
culturali.

Sala
Verde - Altra
sala del piano parlamentare, confinante con la sala Gialla. Durante il 1283 si
ha la prima attestazione di Ramon Muntaner della Sala
Verde ubicata dal lato della «Porta di San Michele», ambiente
destinato agli spettacoli pubblici ubicato ove verosimilmente in epoca
romana sorgeva l'anfiteatro. È utilizzata come sede di commissione.
Cappella
Palatina - Con
accesso dalla loggia del primo livello del Cortile Maqueda, si
presenta la Cappella Palatina. Basilica a tre
navate dedicata ai Santi Pietro e Paolo, luogo di culto
edificato per volere di Ruggero II, consacrato il 28 aprile 1140,
con funzioni di cappella privata della famiglia reale.
Non
è facile descrivere il senso di vertigine che si prova entrando nella
cappella Palatina, gioiello incastonato nel palazzo dei Normanni di
Palermo. Si possono prendere a prestito le parole di scrittori famosi
come Oscar Wilde o Guy de Maupassant, che ne furono incantati. Oppure
specchiarsi nei visi di coloro che entrano, un po’ ammirati, un po’
increduli, in questa chiesa piccina ma talmente ricolma di ornamenti che
non si sa dove posare lo sguardo.
Dopo gli interventi di
restauro, la chiesa è tornata al suo fulgore, quasi come dovette
ammirarla, poco meno di 900 anni fa, il sovrano che la fece costruire,
Ruggero II. Già prima dell’incoronazione a re di Sicilia (nel 1130),
Ruggero aveva ordinato l’edificazione di una chiesa nella sua
residenza, l’odierno palazzo dei Normanni. Doveva essere la casa di
Dio, ma anche un luogo celebrativo della potenza del sovrano e delle
molteplici radici dei suoi sudditi. In altre parole, doveva proporre
espressioni artistiche riconducibili a ciascuna delle componenti
culturali della Sicilia normanna: latina, greca e araba.
Originariamente,
l’edificio svettava al di sopra delle costruzioni del palazzo poi, nel
’500, quando vennero sopraelevati i cortili, la cappella fu come
risucchiata nella struttura.
Colori
e luce che comunque sono ancora la principale bellezza della cappella e
piovono sui visitatori dal vasto manto di mosaici che orna tutta la
parte superiore delle pareti e l’abside. Sono capolavori dell’arte
bizantina, realizzati da artisti ignoti. Si caratterizzano per
l’eleganza delle figure e per la brillantezza del fondo, ottenuta
incollando una lamina d’oro su tesserine di vetro. Fra le immagini più
belle ci sono quelle del Cristo Pantocratore nell’abside e
nella cupola sopra il presbiterio, ma nel corso dei secoli i mosaici
sono stati integrati e in parte sostituiti: ecco perché sotto al Pantocratore
sfila una serie di figure di gusto rococò. Tuttavia, gli interventi
successivi non hanno scalfito l’eleganza e la spiritualità
dell’insieme.
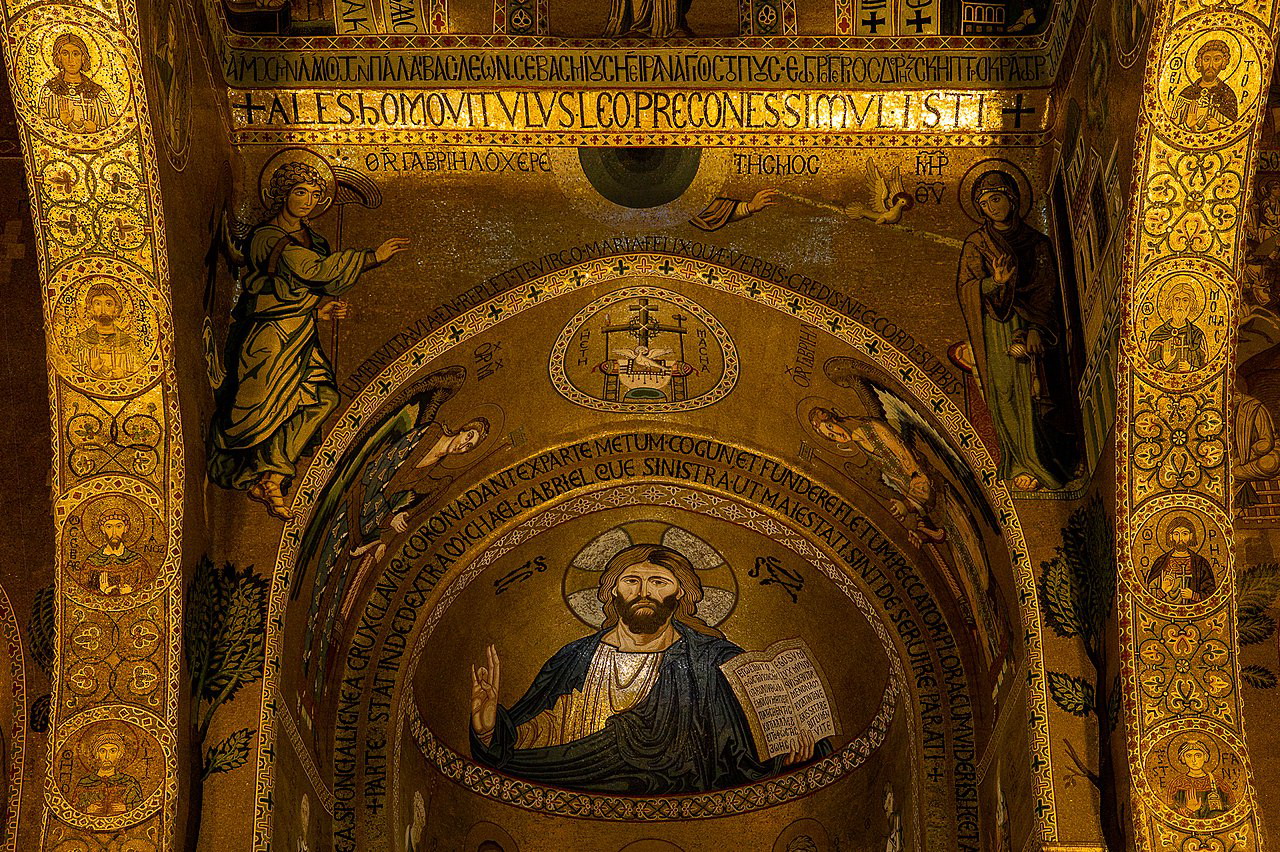
Qui si incontrano tutte
le culture del Mediterraneo. La latinità è espressa dalle colonne
romane e dai dischi di porfido rosso sulle pareti, usati nei secoli
dagli imperatori romani come simbolo del loro potere.
Il pavimento, con i
suoi capolavori geometrici realizzati con tasselli di marmo pregiato, è
invece testimonianza dell’influenza araba che si esprime,
magistralmente, anche nel soffitto. Se alziamo gli occhi alla volta
possiamo infatti ammirare la rivestitura di legno dipinto, realizzata da
artisti maghrebini. I personaggi lì immortalati sono l’unica
testimonianza di figure umane dipinte da artisti islamici all’interno
di un luogo di culto. Secondo alcuni studiosi raffigurerebbero la vita
quotidiana in una corte araba, per altri, invece, sarebbero una
rappresentazione del paradiso islamico.
Le opere marmoree della
cappella si rifanno invece alla tradizione occidentale. Il pavimento a
lastroni di marmo, levigati da secoli di passi, è un capolavoro
d’arte latina, decorato con mosaici di pietre dure a motivi geometrici
che salgono sulle pareti. E lo sono anche il pulpito, egualmente ornato
da intarsi a mosaico di porfido e malachite, con belle sculture a
reggere il leggio, e il candelabro pasquale, un candido, esile fusto
alto quattro metri e mezzo ricoperto di sculture. Opera di autore
ignoto, riporta, fra le altre figure, quella di un uomo dalla testa
coronata, verosimilmente lo stesso Ruggero.
Infine l’arte
islamica: agli artisti invitati dalla Persia venne riservata la
realizzazione del soffitto ligneo, per il quale fu scelto lo stile
islamico a muqamas, cioè ad alveoli. Quel che lo rende
eccezionale è la presenza di figure umane, una circostanza rara se si
considera la riluttanza della tradizione islamica all’uso delle
raffigurazioni antropomorfe. Il soffitto è molto alto, ma con un
binocolo si distinguono uomini a dorso di cammello e portatrici
d’acqua, gente che beve e mangia, odalische, tutti circondati da una
profusione di motivi geometrici, intricati fogliami, figure di animali e
uccelli, eleganti scritte in caratteri cufici inneggianti al re.

All'inizio
della navata è collocato l'imponente trono reale rivestito
di mosaici, vicino al santuario sulla destra il ricco ambone mosaicato
e sostenuto da colonne striate, un superbo candelabro pasquale (alto
m. 4.50), intagliato a foglie d'acanto con figure e animali, tutte
opere del XII secolo combinazioni di elementi romanici, arabi
e bizantini. Il soffitto in legno della navata centrale e
le travature delle navi minori sono decorate con intagli e dipinti di
stile arabo. In ogni spicchio sono presenti stelle lignee con
rappresentazioni di animali, danzatori e scene di vita della corte islamica.
La
cupola, le pareti del transetto e le absidi sono interamente
decorate nella parte superiore da mosaici bizantini, tra i più
importanti della Sicilia, raffiguranti il Cristo Pantocratore, gli
evangelisti e scene bibliche varie. I mosaici di datazione più antica
sono quelli della cupola, risalenti alla costruzione originaria del 1143.
Accanto al Cristo Pantocratore sono raffigurati le
gerarchie di angeli ed arcangeli, profeti, santi e gli evangelisti.
Sulle arcate del presbiterio, le raffigurazioni dell'Annunciazione,
della Presentazione al Tempio, nel catino dell'abside il Cristo
benedicente. Di epoca posteriore (1154-66 circa) sono i mosaici
recanti le iscrizioni latine che ornano la navata centrale,
rappresentazioni di episodi tratti dal Vecchio Testamento, più
tardi quelli delle navatelle, con le Storie di San Pietro e San
Paolo.
Sale
Duca di Montalto
- Formate
da molteplici ambienti, che si trovano nel seminterrato, a fianco e
sotto il Cortile Maqueda. Nel 1553 i viceré spagnoli decisero di
trasferire la propria residenza dal Castello a Mare al Palazzo
Reale dove si realizzarono grandi opere di ristrutturazione. Il piano
seminterrato fu destinato a deposito per le munizioni.
 Nel
1637 il presidente del regno don Luigi Moncada, duca di Montalto, fece
affrescare ai più valenti artisti del tempo Vincenzo La Barbera, Giuseppe
Costantino, Gerardo Astorino e Pietro Novelli, l'antico
deposito delle munizioni, trasformandolo in sala delle udienze estive
del Parlamento siciliano. Il grande ambiente subì un ulteriore modifica
dopo il 1798, quando sotto Ferdinando di Borbone divenne sede delle
scuderie. Nel
1637 il presidente del regno don Luigi Moncada, duca di Montalto, fece
affrescare ai più valenti artisti del tempo Vincenzo La Barbera, Giuseppe
Costantino, Gerardo Astorino e Pietro Novelli, l'antico
deposito delle munizioni, trasformandolo in sala delle udienze estive
del Parlamento siciliano. Il grande ambiente subì un ulteriore modifica
dopo il 1798, quando sotto Ferdinando di Borbone divenne sede delle
scuderie.
Fra
le opere superstiti, meraviglioso, eseguito dal Novelli assieme a figure
allegoriche, l'affresco effigiante Pietro Moncada, avo del duca
di Montalto, i cui frammenti superstiti staccati, trasferiti su tela e
restaurati si possono ammirare nella Galleria regionale di Palazzo
Abatellis.
Nel
1788 le Sale furono trasformate in scuderie, per volere del Re
Ferdinando di Borbone. Oggi ospitano mostre d'arte.
Innumerevoli
sono gli ambienti ricavati nei vari livelli dei numerosi corpi di
fabbrica. Un breve elenco fra i più interessanti:
Ala
Moncada.
Cortile
della Fontana,
realizzato da Camillo Camilliani (1581 - 1584) sull'area dell'ex Torre
Chirimbi, sopraelevato rispetto al Cortile Maqueda e di
qualche decennio anteriore.
Cortile
Maqueda:
struttura con portico intero e due elevazioni di logge:
livello
interrato, depositi trasformati in Sale Duca di Montaldo;
livello
terra con accesso alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, Scalone
d'onore;
1º
livello loggia con accesso alla Cappella Palatina, passaggio al Cortile
della Fontana;
2º
livello loggia con accesso ai Parlamenti generali del Regno.
Mura
Puniche
- Le mura puniche databili intorno al V secolo a.C. sono state
rinvenute nel 1984, esse rappresentano la più antica sezione
stratigrafica di tutta l'area occupata dal Palazzo dei Normanni.
Interessante è la postierla perfettamente conservata ed utilizzata
nell'antichità per gestire gli accessi all'interno della paleapolis.
Porta
di San Michele.
Sala
degli Armigeri.
Segrete
- Le segrete o Prigioni Politiche ubicate allo stesso
livello della chiesa inferiore sottostante la Cappella Palatina e come
essa in origine di fase arabo-normanna, si articolano sotto il Cortile
della Fontana. La sala rettangolare, la più vasta di tali ambienti,
è quella dalla quale deriva il nome di segrete, visto il ritrovamento
negli anni ottanta di taluni graffiti, raffiguranti navi stilisticamente
di gusto medievale.
Stanza
dei Tesori.
Scala
Bianca.
Scala
Rossa.
Scalone
d'onore.
Via
Coperta.
Antica Ruga Magna Coperta d'epoca normanna, il cui
percorso protetto, seguiva lo sviluppo delle primitive fortificazioni
puniche.
Oltre
a dipinti e quadri che nel corso dei secoli hanno adornato la stanze del
palazzo, dal 1947 a oggi l'Ars ha periodicamente acquistato delle opere
d'arte con cui ha arredato i propri uffici. Nel 2010, per la
catalogazione, conservazione e restauro di questo patrimonio, è stata
istituita una "fabbriceria". Tra le opere ottocentesche vi
sono quadri di Francesco Lojacono, Antonino Leto e Ettore
De Maria Bergler, tra quelle del '900 vi sono litografie di Joan
Miró e Henri Matisse e dipinti di Renato Guttuso, Croce
Taravella e Bruno Caruso.
L'ala
ovest del palazzo, insieme alla Porta Nuova, è assegnata
all'Esercito Italiano. Sede dal 1870 del Distretto militare, oggi
ospita il Centro Documentale di Palermo.
Pag.
1 
 Pag.
3 Pag.
3
Agosto
2018
|