|
Città barocca dalle
radici greche, situata nei Monti
Iblei e non distante dal
fiume Anapo e
la Necropoli Rupestre di Pantalica,
nel 2002 è
stata insignita del titolo di Patrimonio
dell'Umanità da parte dell'UNESCO,
insieme con il Val
di Noto.
La
cittadina fa inoltre parte del circuito dei borghi
più belli d'Italia.
Così
come riporta Tucidide,
la città trae origine da Ákrai che derivando dal greco ákrā
altro non significava che "cima, picco, estremità" ma
anche "castello o cittadella che domina una città". Per
quanto riguarda invece "Palazzolo" si tratta di un'aggiunta
successiva, in epoca medievale. Trae chiaramente origine dal latino palatium con
l'aggiunta del suffisso -olum che
diventò quindi "Palatiolum", divenendo infine il "Palazzolo
di Ákrai".
L'esistenza
di Palazzolo Acreide viene testimoniata da Tucidide nella Guerra
del Peloponneso già in
epoca antica. Era
quindi una colonia siracusana fondata
attorno al 664
a.C. (70 anni dopo la
fondazione di Siracusa)
dagli stessi siracusani. Della città antica si conservano numerose
testimonianze, in particolare un importante edificio teatrale e un complesso
di edifici adiacenti all'agorà greco-romana.
Di una strada urbana identifica con il decumano si
conserva integro il manto stradale. Molti degli edifici e dei complessi cimiteriali cristiani furono
esplorati e dal Barone Gabriele Judica di Bauly. Delle ricerche effettuate
dal nobile archeologo si conserva una dettagliata relazione in una pregiata
edizione del 1819, oggi piuttosto rara, ma di facile reperimento nelle
biblioteche specializzate. Le ricerche archeologiche hanno evidenziato una
fase anteriore alla colonizzazione greca, d'interesse è a questo proposito
la necropoli della Pinita un complesso di sepolcri scavati
lungo una ripida parete di calcare, che molto si assomiglia alle maestose
sepolture di Pantalica, della popolazione che vi seppellì i propri defunti
si conosce poco, già svuotati nell'antichità hanno restituito alcuni
manufatti noti all'Orsi, molto interessante è un sepolcro per la
caratteristica volta micenea a testimonianza dei rapporti con il mondo greco
ed egeo. altri luoghi di interesse sono l'antro di Sparno e
alcune grotte-sepolcro nei pressi di Bauly.
Durante
il periodo greco la città coniò una moneta con l'effigie della dea Demetra
e si arricchì di importanti edifici civili, al regno di Gerone
II, probabilmente nato o
cresciuto in questa località, si deve il riordino urbano dell'abitato in
epoca ellenistica. Del periodo romano si conservano parecchie testimonianze
tra queste ad esempio la base di una statua onoraria dedicata a Caio
Verre intercettata da Gabriele
Judica. In epoca tardo antica e cristiana la città accolse una numerosa
comunità di cristiani e di ebrei che
migrarono dopo l'editto del 18 giugno 1492 che espelleva dai domini spagnoli
le comunità israelitiche.
Alla
presenza dei cristiane delle catacombe urbane dell'Intagliata e dell'Intagliatella,
ma anche e soprattutto un cospicuo numero di catacombe rurali note alla
letteratura scientifica. Importanza notevole rivestono in questo contesto le
iscrizione greche e cristiane studiate da Giovanni
Pugliese Carratelli. in epoca
moderna la città è tornata ad essere oggetto di scavi e di studi che hanno
favorito una migliore comprensione della storia dell'abitato antico. Impulso
notevole hanno esercitato le ricerche di Clelia Laviosa, Luigi
Bernabò Brea, Beatrice Basile, Salvatore
Distefano, Giuseppe Voza, Lorenzo
Guzzardi.
La
città antica fu distrutta dalle truppe islamiche nell'827 si
accamparono nei suoi pressi in attesa di occupare Siracusa. Di recente le
ricerche sono state riprese dall'Università
di Varsavia che ha condotto
nell'area della città greco-romana alcune campagne di scavo.
Nella
seduta del 27 giugno 2002 a Budapest,
durante la XXVI Sessione Plenaria dell'UNESCO,
la chiesa di San Sebastiano e quella di San Paolo di Palazzolo Acreide
sono state dichiarate monumento patrimonio
dell'umanità.
Basilica
di San Paolo

La basilica
di San Paolo è la più importante delle chiese cittadine, appartenente
all'arcidiocesi
di Siracusa.
Il
tempio fu edificato sull'area che occupava la primitiva chiesa di Santa
Sofia. Quest'ultima fu concessa ai confrati a patto che mantenessero, nella
nuova costruzione, un ambiente con altare dedicato alla santa. L'edificio
era in parte perfezionato nel 1657, anno in cui fu intronizzato il simulacro
di San Paolo.
Nel
1663 fu elevato a parrocchia sacramentale ad quinquennium e
nel 1669 fu dichiarato sacramentale in perpetuum.
Nel
mese di settembre del 1688 San
Paolo fu eletto, in apposita
assise popolare, patrono
principale e protettore
di Palazzolo
Acreide. L'elezione fu confermata
dalla Sacra
Congregazione dei Riti nel
luglio del 1690.
La
città è suddivisa in contrade cui fanno capo altrettante chiese (dedicate
rispettivamente a San Paolo, San Sebastiano, San Michele, Sant'Antonio). La
chiesa di San Paolo aveva supremazia su tutte.
Con
la concessione del titolo di parrocchia alla chiesa
di San Sebastiano nel 1859
le tensioni e i dissidi tra le due comunità si inasprirono.
Le
reciproche scaramucce e dispetti tra sambastianari e sampaolari,
per sanguigne passioni e viscerale attaccamento alle tradizioni, assumono
dimensioni tali da costituire oggetto d'analisi da parte dell'antropologo Giuseppe
Pitrè.
Il terremoto
di Santa Lucia del 13
dicembre 1990 determinò un lungo periodo di chiusura.
FACCIATA
- Una gradinata a rampa unica di 11 gradini raccorda il piano stradale
con il sagrato su
cui insistono i tre archi del portico o pronao d'accesso
alla basilica. Atri sei gradini attraverso il solo varco centrale permettono
l'accesso al vestibolo,
le arcate minori laterali presentano balaustre in
pietra.
La
suggestiva facciata barocca è opera del netino Vincenzo Sinatra, ripartita
su tre ordini divisi in tre corpi al primo livello, un unico corpo centrale
per i restanti livelli caratterizzati da volumetrie via via decrescenti.
Elaborati cornicioni e marcapiano dalle
ricche modanature separano
i livelli, ringhiere in ferro battuto proteggono i rispettivi camminamenti.
 Il
primo ordine è delimitato da paraste angolari curvilinee che raccordano la
controfacciata determinando nell'atrio due
arcate sfalsate laterali con sviluppo ad ogiva. Il corpo centrale, per due
livelli, è ulteriormente arricchito da coppie di colonne binate aggettanti
che contribuiscono ad esaltare la prospettiva convessa di tutta la
struttura. L'arcata centrale poggia su colonne parimenti sormontate da capitelli
corinzi. Il
primo ordine è delimitato da paraste angolari curvilinee che raccordano la
controfacciata determinando nell'atrio due
arcate sfalsate laterali con sviluppo ad ogiva. Il corpo centrale, per due
livelli, è ulteriormente arricchito da coppie di colonne binate aggettanti
che contribuiscono ad esaltare la prospettiva convessa di tutta la
struttura. L'arcata centrale poggia su colonne parimenti sormontate da capitelli
corinzi.
Il
secondo ordine ricalca lo schema del corpo centrale del primo con lesene ai
lati della grande arcata. All'interno della campata è collocato un gruppo
statuario raffigurante un Gesù Cristo con globo
crucigero ritratto in atto
benedicente, ai lati due angeli osannanti. Due grandi volute raccordano il
corpo centrale al livello inferiore conferendo all'insieme slancio e
simmetria, sulle mensole superiori sono collocati vasi fiammati acroteriali.
Disposte simmetricamente su piedistalli otto statue raffiguranti gli Apostoli.
Il
terzo ordine è costituito da un solo corpo centrale abbellito da coppie di
lesene binate e colonne a sostegno dell'arco. L'ambiente interno ha funzioni
di cella o loggia campanaria. Le restanti quattro statue degli apostoli
delimitano l'apertura frontale.
Chiude
la prospettiva una cuspide a bulbo contornata da vasi acroteriali fiammati
con croci sommitali. La superficie esterna del bulbo reca uno stemma
raffigurante una spada che sostiene tre corone sovrapposte simboleggianti
gli ordini feudali: l'ordine demaniale o civico proprio delle città regie,
l'ordine feudale o baronale, l'ordine ecclesiastico.
INTERNO
- Impianto basilicale a tre navate ripartite da pilastri, due absidi
laterali che racchiudono le due navate minori, lungo le pareti e nei vari
ambienti sono addossati undici altari, di cui due ubicati nelle cappelle
laterali. Il valente pittore Giuseppe
Crestadoro tra la fine del
'700 ed i primi anni dell'800, lavorò molto per la commissione del ciclo
pittorico su tela realizzando ben otto quadri autografi o attribuiti, per la
maggior parte collocati ad ornamento degli altari della navata destra.
NAVATA
DESTRA - Prima
campata: fonte
battesimale, alla parete l'olio
su tela raffigurante il Battesimo di Gesù di Giuseppe
Crestadoro.
Seconda
campata: Cappella di San Biagio. Sull'altare il quadro
raffigurante il Martirio di San Biagio.
Terza
campata: Cappella di San Paolo. Sull'altare il quadro
raffigurante il Battesimo di San Paolo.
Pulpito.
Manufatto ligneo realizzato da Giuseppe e Sebastiano Giuliano nel 1833.
Quarta
campata: Cappella di Santa Sofia. Sull'altare un quadro dedicato
a Santa Sofia.
Quinta
campata: Cappella di San Silvestro. Sull'altare marmoreo il
quadro San Silvestro battezza Costantino, opera di Giuseppe
Crestadoro.
NAVATA
SINISTRA - Prima
campata: Cappella delle Anime Purganti. Sull'altare un grande
quadro di Giuseppe
Crestadoro.
Seconda
campata: ingresso laterale sinistro.
Terza
campata: Cappella del Santissimo Crocifisso. Ambiente con altare
marmoreo, completato da un retroaltare lapideo di fattura settecentesca.
Pregiato Crocifisso collocato su tela raffigurante la Beata
Vergine Maria ritratta con Santa
Maria Maddalena e San
Giovanni Evangelista, opera
d'autore ignoto.
Quarta
campata: Cappella della Madonna Addolorata. Altare realizzato
con marmi pregiati da mastro Carmelo Bonaveura di Catania, nel 1778. Le
colonne ed il timpano sono opera del valente artista scalpellino don Antonio
Gibilisco, artista attivo negli anni venti del XX
secolo. Nella nicchia è posta la
statua in cartapesta raffigurante la Madonna Addolorata.
Quinta
campata: Cappella di San Gaetano di Tiene. L'altare di fattura
ottocentesca, ha una particolare struttura architettonica che lo rende
singolare. Le colonne esterne poggiano sul vuoto, vale a dire il
baricentro delle colonne laterali cade al di fuori del ridotto stilobate.
La particolare realizzazione è resa possibile da mensole con volute
orientate verso l'osservatore. L'artificio rende una prospettiva concava di
colonne tortili binate con sviluppo elicoidale alterno, che determina un
altrettanto articolato timpano ad archi
archi spezzati, sovrapposti e simmetrici disposti su due livelli. Il corpo
centrale delimita una stele intermedia arricchita da stemma coronato
disposto su raggiera.
Del manufatto se ne ignora l'autore. Nell'edicola è custodito il dipinto San
Gaetano di Tiene d'autore ignoto.
ABSIDIOLE
- Absidiola
destra: Cappella del Santissimo Sacramento. Ambiente con altare
ligneo del ‘600 e due quadri ovali di Giuseppe
Crestadoro: la Beata
Vergine degli Agonizzanti e l'Assunzione di Maria. Nella
cappella uno stupendo altare ligneo con un elaborato tabernacolo del XVII - XVIII
secolo, la cui base appartiene
all'organo proveniente da una primitiva collocazione fra il primo e secondo
pilastro della navata di sinistra. Nell'ambiente sono custodite le statue
raffiguranti il Cristo Risorto, proveniente dalla chiesa di San
Domenico, e quella della Madonna Bambina, scolpita da Giuseppe
Giuliano.
Absidiola
sinistra: Cappella della Madonna del Rosario e di San
Domenico, sono presenti le statue dei due santi eponimi, completano
l'apparato pittorico due copie della Conversione di San Paolo del
Caravaggio, realizzate e donate dal Liceo Artistico di Palazzolo.

ALTARE
MAGGIORE - Sull'altare
maggiore è posto un Crocifisso del XVI - XVII
secolo. La monumentale
sopraelevazione versus Deum presenta enormi colonne tortili
policrome con rilievi fitomorfi lungo lo sviluppo elicoidale dei fusti, i
possenti manufatti delimitano l'edicola centrale
contenente il quadro raffigurante la Conversione di San Paolo,
dipinto attribuito a Giuseppe
Crestadoro, dietro la tela è
celata la nicchia ove è custodita abitualmente la statua di San
Paolo. Chiude la prospettiva un massiccio architrave ornato
da vasotti fiammati acroteriali che fanno ala all'iscrizione celebrativa
della stele centrale. L'icona è svelata e rimossa dalla custodia abituale
in occasione delle due principali festività dell'apostolo delle genti.
La
statua fu scolpita dal ragusano Vincenzo Lorefice nel 1567. In tutti questi
secoli ha subito diversi interventi di restauro, che ne hanno alterato lo
stile originario. Quando fu consegnata nel XVI
secolo, la statua era dipinta a
tempera e con colori uniformi, turchino la veste e rosso il manto. Nel 1681,
sembra abbia subito un primo restauro, in seguito al terremoto
del 1693 la statua subì
gravi danni, maggiormente al viso, per cui uno statuario di Messina, nel
1695, ne rifece totalmente la testa.
Alle
pareti laterali sopra gli scranni del coro sono
collocati due dipinti, a sinistra il Naufragio di San Paolo a Malta,
a destra la Predicazione di San Paolo.
In
fondo all'abside, una sovrapposizione d'altari lignei: la base appartiene ad
un antico altare, probabilmente del XVI
secolo caratterizzato da archi
gotici sostenuti da colonnine tortili; coevo è il paliotto di damasco. Il
sopraltare appartiene, invece, ad altro altare ligneo barocco del XVII - XVIII
secolo; sopra, la statua della Madonna
del Carmelo, proveniente dalla chiesa di San Domenico.
Il
seggiolone e le quattro sedie presbiterali scolpite dai fratelli Giuliano
nel 1860.
SAGRESTIA E ORGANO - In
sagrestia oltre ad un prezioso cassarizzo scolpito nel 1778
da Giovanni Torrisi di Catania e Gaetano Rametta di Siracusa, vi sono
quattro grandi armadi, a due a due simili, con sedie boffetti,
inginocchiatoi, cassapanche, e quattro portiere che in alto incorniciano
delle pregevoli tele.
L'organo,
in origine sistemato tra il primo e il secondo pilastro della navata
sinistra, negli anni '30 del XX
secolo fu trasferito nella
cantoria.
Le decorazioni e le pitture di questo palco sono attribuibili a Scalia di
Catania.
Le
due bare, quella della reliquia e quella di San Paolo, sono permanentemente
esposte nella chiesa. Della prima non si conosce l'anno di fabbricazione, la
seconda fu realizzata da Giuseppe e Sebastiano Giuliano nel 1899. Nel
1900 fu indorata da Giovanni Tanasi di Ragusa.
Basilica
di San Sebastiano

Con
l’abbassamento del piano antistante e la conseguente, necessaria,
costruzione dell’ampia scalinata, la facciata della Chiesa di San
Sebastiano ha acquistato una monumentalità scenografica che forse non
possedeva nel XVIII secolo, al momento della riedificazione dopo il
terremoto del 1693.
L’originaria
Chiesa di San Sebastiano fu edificata nell’area dell’attuale sito,
probabilmente nella seconda metà del 1400, vicino ad una piccola chiesa
dedicata a San Rocco. Subì degli ampliamenti già nel XVI secolo ed ancora
nella prima metà del ‘600.
Il
terremoto del 1693 la distrusse quasi del tutto; quella che noi oggi vediamo
è appunto la chiesa ricostruita nel primo ventennio del ‘700 e risorta
dalle macerie del terremoto.
Fu
riedificata a tre navate – la prima era ad una sola navata – più grande
ed “imbellita” di prima. Alla monumentale facciata, disegnata dal
mastro-architetto Mario Diamanti, siracusano, si diede inizio, con
l’intaglio dei pezzi necessari, nel 1721.
La
prima pietra fu posta nel 1723; e lo stesso Diamanti, assieme a mastro
Giovan Battista Milito e mastro Giuseppe Buscema scolpirono tutti i pezzi
del primo ordine, portale, colonne, leoni e cornicioni.
 FACCIATA
- Una monumentale scalinata
costruita nel 1877 (due rampe per un totale di 25 gradini) raccorda il piano
stradale con il ballatoio - balconata su cui insistono i portali d'accesso
alla basilica. La maestosa facciata barocca, realizzata in pietra
giuggiolona, è ripartita su tre ordini divisi in tre corpi delimitati da
lesene binate, un unico
corpo centrale costituisce il terzo livello. Elaborati cornicioni e marcapiano dalle
ricche modanature separano
i livelli, ringhiere in ferro battuto proteggono i rispettivi camminamenti. FACCIATA
- Una monumentale scalinata
costruita nel 1877 (due rampe per un totale di 25 gradini) raccorda il piano
stradale con il ballatoio - balconata su cui insistono i portali d'accesso
alla basilica. La maestosa facciata barocca, realizzata in pietra
giuggiolona, è ripartita su tre ordini divisi in tre corpi delimitati da
lesene binate, un unico
corpo centrale costituisce il terzo livello. Elaborati cornicioni e marcapiano dalle
ricche modanature separano
i livelli, ringhiere in ferro battuto proteggono i rispettivi camminamenti.
I
portali laterali sono delimitati da colonne scanalate sormontate da capitelli
corinzi sormontati da
timpani sovrapposti ad arco spezzato. Architravi con
decorazioni fitomorfi e testa di putto intermedia ornano la cornice dei due
ingressi. Finestre cieche con cornici mistilinee o occhialoni a cartiglio,
sormontano i varchi d'accesso laterali.
Il
portale centrale presenta una coppia di leoni in pietra bianca scolpiti da Mario
Diamanti, ideatore e realizzatore
dell'intero prospetto, decorazioni in rilievo abbelliscono gli alti plinti delle
colonne binate che presentano la parte inferiore del fusto arabescata.
L'arco a tutto sesto dell'ingresso mostra putti nei pennacchi, architrave con
motivi floreali sormontato da timpani sovrapposti spezzati. Costituisce vano
intermedio la nicchia contenente la statua raffigurante San
Sebastiano Martire.
Il
secondo ordine delimitato da pilastri acroteriali (le statue d'abbellimento
non furono mai realizzate), comprende grandi volute a vela di raccordo, alla
base volute a ricciolo e controvolute. Il corpo centrale è occupato da un
timpano che ricalca lo stile e l'architettura del manufatto simile posto al
primo livello. Nell'edicola è
collocato il quadrante di un orologio elettrico andato a rimpiazzare
l'orologio meccanico installato per la prima volta nel 1885.
Il
terzo ordine è costituito da un solo corpo centrale delimitato da pilastri
acroteriali con cuspidi ad obelisco (piramidali), comprende vele con volute
a ricciolo di raccordo e una monofora intermedia con funzioni di cella o
loggia campanaria.
Chiude
la prospettiva un'incastellatura in ferro battuto posta a quota 42 metri sul
livello della piazza, ove svetta u palieddu, una banderuola
segnavento con foggia di bandiera.
INTERNO
- Impianto a croce
latina ripartito in tre
navate separate da quattro pilastri per lato con semicolonne sorreggenti
cinque arcate. La navata centrale e quella destra si concludono con absidi
circolari. La volta della navata presenta un apparato pittorico con scene
raffiguranti Martirio di San Sebastiano con nugolo di frecce, San
Sebastiano processato da Diocleziano, Gloria Celeste di San
Sebastiano Martire Cristiano. Il perimetro della navata e del presbiterio è
contraddistinto da un elaborato cornicione delimitato
da un'artistica inferriata in ferro battuto smaltato.
NAVATA
DESTRA
Prima
campata: Cappella di Sant'Agata. Sull'altare il dipinto
raffigurante il Martirio di Sant'Agata, tela attribuita a Piero
Quintavalle. L'ambiente insieme
alla corrispettiva cappella della navata di sinistra, fu rifinito nel 1867
con pregiato marmo locale rinvenuto in contrada Purbella.
Seconda
campata: Cappella di San Mauro. Sull'altare il dipinto
raffigurante San Mauro, tela di Giuseppe
Tanasi del 1853.
Terza
campata: Cappella di San Sebastiano. Sull'altare il dipinto
raffigurante San Sebastiano, tela di ignoto autore.
Pulpito.
Quarta
campata: Cappella di San Rocco e San Giacomo. Sull'altare il
dipinto raffigurante San Rocco e San Giacomo, tela di Michele
Di Domenico del 1720.
Quinta
campata: Cappella di San Pietro. Sull'altare il dipinto
raffigurante San Pietro in Vincoli, tela di Marcello
Vieri del 1785.
NAVATA
SINISTRA
Prima
campata: Cappella dei Santi Cosma e Damiano. Sull'altare il
dipinto raffigurante i Santi Cosma e Damiano, tela di Piero
Quintavalle del 1855. Fonte
battesimale di Giovanni
Campisi del 1734.
Seconda
campata: Cappella dell'Addolorata. Sull'altare il dipinto
raffigurante Maria Santissima Addolorata, tela di Saverio
Marchese e Giuseppe
Tanasi del 1864.
Terza
campata: Varco d'ingresso. Porta d'entrata laterale. Sull'altare il dipinto
raffigurante San Sebastiano, tela di Giovanni
Belfiore del 1950,
riproduzione di soggetto de Il
Sodoma.
Quarta
campata: Cappella della Madonna Odigitria. Sull'altare il
dipinto raffigurante la Madonna Odigitria, tela di Saverio
Marchese del 1859. Nella
nicchia, dietro la tela, è conservato un gruppo statuario risalente al
cinquecento raffigurante la Madonna Odigitria eletta nel
1644 Patrona Reale di Palazzolo Acreide. Il gruppo statuario è visibile nel
mese di maggio periodo dei festeggiamenti in onore della Madonna Odigitria.
Quinta
campata: Cappella di Santa Margherita. Sull'altare il dipinto
raffigurante Santa Margherita da Cortona, tela di Vito
D'Anna del 1758.

ABSIDI
- Absidiola
destra: Cappella del Santissimo Crocifisso altrimenti nota
come Cappella di Sant'Anna. Ambiente patrocinato dalla Confraternita
del Santissimo Crocifisso del 1721, commissionata all'architetto
palazzoleze Giuseppe
Ferrara. Altare con colonne
binate e timpano triangolare con angeli sulle cimase, raggiera nella
calotta. Nell'edicola è custodito il Crocifisso, manufatto in
cartapesta, opera di Infantino
Farina del XVII
secolo. Ai lati le allegorie
della Fede a sinistra e la Speranza a
destra, statue in gesso realizzate da Gioacchino Gianforma di Catania nel 1783 - 1784.
Altare
di destra. La nicchia custodisce la statua in cartapesta di San
Sebastiano raffigurato sul globo terracqueo del 1926. Sotto
l'altare sono custodite le seguenti reliquie: San
Sebastiano Martire, Velo
della Madonna, San
Placido Martire, San
Pietro Martire, San
Giosuè, San
Vitale Martire, San
Celso Martire, San
Giuseppe da Copertino, Lignum
Crucis, Santa
Concordia Martire, San
Gaudioso Martire, San
Bernardo da Corleone, Santa
Liberata Martire, San
Francesco d'Assisi, Santa
Margherita da Cortona.
Absidiola
sinistra: Cappella del Sacro Cuore. La sopraelevazione
dell'altare è costituita da una coppia di colonne binate poste in
prospettiva convessa (fusto arabescato nella parte inferiore e scanalato
superiormente), sormontate da capitelli corinzi.
Architrave e timpano
spezzato con parti aggettanti sulle quali gravano volute a ricciolo, sulle cimase sono
collocati putti adoranti, costituisce stele intermedia la riproduzione di
raggiera. Nella nicchia centrale è custodita la statua raffigurante il Sacro
Cuore, manufatto in gesso di ignoto autore.
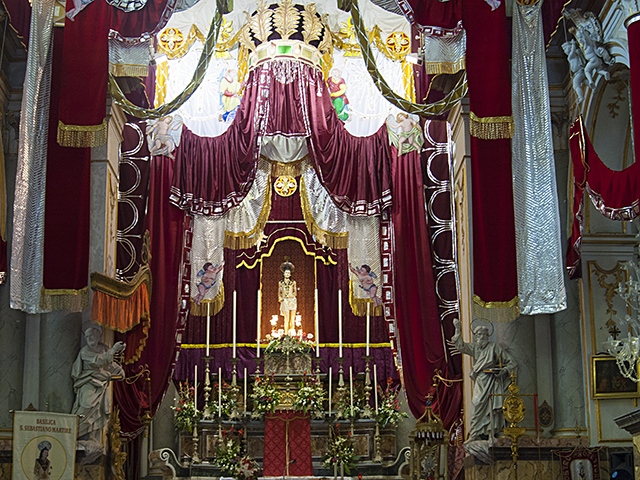 Arco
presbiteriale sorretto da colonne ioniche binate, gruppi scultorei sul
cornicione e stemma centrale in stucco. Arco
presbiteriale sorretto da colonne ioniche binate, gruppi scultorei sul
cornicione e stemma centrale in stucco.
Abside
e altare maggiore: Cappellone di San Sebastiano. Ambiente
delimitato da balustra, alle
estremità sinistra la statua raffigurante l'apostolo San Pietro,
sul lato destro San Paolo, manufatti in gesso, opere di
Gioacchino
Gianforma del 1783 - 1784.
Sui quadroni mistilinei i dipinti raffiguranti Mosè e le Tavole dei
dieci Comandamenti, Giuditta ed Oloferne. Cattedra di ignoto
autore del 1870. Sulla parete di fondo due colonne sorreggono un
camminamento sul cornicione protetto da ringhiera in ferro battuto che si
interrompe ai lati del grande dipinto.
San
Sebastiano, statua lignea di
ignoto autore del 1663. Il simulacro di pregevole fattura è esposto solo
durante i festeggiamenti di gennaio e agosto.
In
tali ricorrenze la fisionomia dell'altare maggiore cambia notevolmente.
Grandi apparati decorativi adornano gli ambienti interni dell'intero
edificio.
Maestosi
baldacchini, frutto di stratificazioni di tessuti, panneggi, paramenti e
arredi liturgici addobbano il presbiterio. Un apparato effimero è
sovrapposto all'area corrispondente al grande dipinto absidale. La pittura
cela la nicchia ove è riposto il simulacro occultandolo alla vista dei
fedeli per lunghi periodi dell'anno, consuetudine molto in voga nelle chiese
delle province sud - orientali dell'Isola.
L'architettura
temporanea riproduce il frontone di un tempio con un'edicola strombata al
centro delimitata da teorie di colonne, all'interno della quale scivola con
opportune guide, l'icona nella funzione denominata Svelata. Con
questa operazione la figura del Santo appare e si mostra ufficialmente ai
fedeli, ai devoti, alla pubblica venerazione dopo
l'operazione di velatura compiuta alla fine dei
festeggiamenti precedenti.
Chiesa
dell'Annunziata

E’
da ritenersi fra le più antiche e più belle chiese di Palazzolo. Edificata
probabilmente nel XIII-XIV sec. fu abbattuta in parte dal terremoto del
1693. La Confraternita dell’Annunziata, in segno della propria vetustà,
occupava il primo posto nelle processioni ufficiali.
Nel
1474 la chiesa si arricchì di un tesoro d’arte. E’ di quest’anno il
contratto stipulato da Juliano Maniuni, rettore della chiesa, con Antonello
da Messina, in cui il più grande pittore siciliano si obbligava a dipingere
su legno il grande quadro dell’Annunciazione. Questo capolavoro è rimasto
nella chiesa fino al 1906, quando, acquistato dalla soprintendenza, con la
motivazione della conservazione e del restauro, fu trasportato a Siracusa.
Oggi il quadro restaurato e riportato su tela si trova esposto nel Museo
Bellomo.
La
chiesa ha una splendida facciata barocca ricostruita dopo il terremoto da un
capomastro architetto locale: Matteo Travisi. Ed il progetto ed il disegno
della facciata è, probabilmente, di Giuseppe Ferrara. Il grande portale è
caratterizzato da quattro colonne tortili, binate, e da una elaborata
trabeazione; il tutto magistralmente intagliato con motivi agresti e festoni
di frutta: uva, melagrane, mele cotogne, pere, fichi ed altro. L’interno
della chiesa, a tre navate, semplice, pulito, luminoso, raffinato, è di
grande suggestione. Le alte arcate della navata centrale sono adornate con
visi e festoni di frutta di bella scultura, mentre prezioso è il cornicione
interno nei suoi diversi elementi decorativi e la volta con leggeri stucchi
settecenteschi.
Nella
navata di destra si trova una statua di Santa Teresa D’Avila scolpita da
Giuseppe Giuliano nella seconda metà dell’800, poi un altare ligneo
settecentesco con il quadro della “Sacra Famiglia”. Dopo la porta
laterale, resti di acquasantiere medioevali, ed un altare ligneo
settecentesco con il bel quadro che rappresenta “Il martirio di Santo
Stefano”.
In
fondo un altare ligneo barocco con un bel quadro della “Madonna del
Carmelo” dipinto da Marcello Vieri nel 1785. Nel transetto una splendida
statua della Madonna del Carmelo, molto venerata in questa chiesa, scolpita
nell’anno 1700; fu indorata verso la metà dell’800 da Cesare
Cappellani, ottimo indoratore e buon artista palazzolese.
L’altare
maggiore è l’altro capolavoro che la chiesa possiede. E’ un altare con
preziosi intarsi marmorei colorati raffiguranti uccelli e delicati motivi
floreali. Le decorazioni, la finezza della esecuzione ed i vari colori dei
marmi sono di una armonia compositiva e cromatica senza pari. Un grande,
quanto raffinato, tabernacolo scolpito nel marmo e caratterizzato da una
miriade di colonnine sormontate da deliziose testine di putti si erge
maestoso sull’altare.
Un
complesso di grande bellezza. In alto, dietro l’altare, una grande tela
rappresentante l’ “Annunciazione” dipinta da Paolo Tanasi nel 1827. Di
ottima fattura la credenza del XVIII sec. così come le belle sedie
presbiteriali del 1865. A chiudere la navata di sinistra si trova un altare
ligneo settecentesco con un bel quadro di “S. Francesco di Paola”
dipinto da Paolo Tanasi nel 1827. Accanto una statua lignea di “S.
Francesco di Paola” scolpita nel 1858 da Cesare Cappellani. Completano la
navata da sinistra tre altari lignei del XVIII sec. con altrettante tele di
autori ignoti: una “Crocifissione con S. Giovanni Battista e S. Paolo”,
“Sant’Apollonia e Santa Caterina, S. Sebastiano”.

Altri
edifici religiosi
La
Chiesa
del Convento è di costruzione recente, annesso alla chiesa è il Convento
dei Padri Cappuccini.
La
Chiesa
di S. Antonio Abate progettata inizialmente a tre navate a croce latina, non
è mai stata completata. Il culto preminente è verso
la Madonna Addolorata.
La
Chiesa
dell'Annunziata è la più antica di Palazzolo A. Ricostruita dopo il
terremoto, ebbe un'impostazione più maestosa, a tre navate. Tre sono i
capolavori d'indiscusso pregio artistico: l'altare di marmo intarsiato con
marmi di diversi colori, rappresentanti l'allegoria della primavera; il
portale della facciata risalente al '700 è di intonazione barocca e
spagnoleggiante; il quadro dell'Annunciazione di Antonello da Messina, oggi
esposto al Museo Bellomo di Siracusa.
La
Chiesa
di S. Michele, semplice nel suo insieme, presenta all'interno colonne in
stile corinzio. La facciata è movimentata da un portale centrale con
colonne anch'esse corinzie.
La
Chiesa
di S. Paolo nasce sulla vecchia Chiesa di S. Sofia. L'imponente facciata in
stile barocco, forse opera di Vincenzo Sinatra (architetto attivo
soprattutto a Noto), è a tre ordini scanditi da archi a tutto sesto e
colonne con capitelli corinzi. L'ultimo livello si eleva in una torre
campanaria correndo via dell'Annunziata, si raggiunge l'omonima chiesa. La
facciata, incompiuta, è arricchita da un notevole portale incorniciato da
colonne tortili.
La
Chiesa
di S. Nicolò è
la Chiesa Madre, è a croce latina con cupola nel transetto, l'interno è a
tre navate e la trabeazione del cornicione presenta una ricca decorazione
barocca. La facciata, rifatta nel 1893, presenta qualche motivo
architettonico classicheggiante.
La
Chiesa
dell'Immacolata ad una navata, è semplice nella sua struttura. All'interno
si può ammirare la pregevole statua della "Madonna col Bambino"
di Francesco Laurana.
Teatro
di Akrai

È
sovente attribuito a Gerone
II, ma la sua datazione oscilla
tra III
secolo a.C. e II
secolo a.C..
Il
teatro subì delle modifiche durante l'epoca romana: venne edificata una
scena più avanzata, venne ridotto lo spazio già angusto dedicato
all'orchestra, si elevò la scena a circa m 1.20 e la si estese fino al muro
di fondo dalla scena greca. In questo periodo venne ingentilito il
chioschetto attiguo e si pavimentò l'orchestra con rivestimenti levigati
anche in situ.
Sotto
la dominazione bizantina, l'edificio venne utilizzato come basamento per
l'edificazione di una struttura per la lavorazione del grano: fu riportato
in superficie dal barone Gabriele
Iudica nel 1824.
Il
teatro, diversamente da quello
di Siracusa, non è stato scavato
nella roccia per asportazione ma è stato invece adagiato su un preesistente
pendio naturale, posto a sud del teatro. La cavea è composta da nove
settori, divisi da otto scalinate: Gabriele Iudica ipotizzò la presenza di
sole dodici file di sedili, ma non si può escludere fossero di più nella
parte centrale. I sedili laterali sono addossati ai muri; ogni gradino è
alto 27 centimetri e largo 74 cm.
Al
centro si sviluppa l'orchestra, contraddistinta dalla caratteristica forma
semi-circolare: quest'ultima consente una maggior vicinanza della scena al
pubblico. Il basamento del proscenio era costituito da grossi blocchi di
pietra, che avevano lo scopo di sostenere gli elementi superiori del
loggiato composto probabilmente da otto colonne o da otto pilastri. La
scena, non molto ampia e realizzata in legno, aveva una profondità di tre
metri ed era chiusa da un muro.
Data
questa descrizione, ci si accorge di come il complesso apparisse asimmetrico
e di piccole dimensioni: questo era dovuto allo svilupparsi dell'edificio in
un tessuto urbano già saturo.
Il
teatro è direttamente collegato tramite una galleria all'agorà della
città e al bouleuterion:
non si conoscono le motivazioni che spinsero a una simile scelta.
Il
teatro è dal 1991 sede delle rappresentazioni Festival Internazionale del
Teatro Classico dei Giovani organizzato dall'Istituto
nazionale del dramma antico.
I
Santoni

Si
tratta di un complesso di figurazioni relative ad uno dei culti più
misteriosi dell'antichità: il culto della Magna
Mater. Il sito, nonostante il
deplorevole stato di conservazione, è unico al mondo per la grandezza e per
la completezza delle rappresentazioni ed è considerato il principale centro
del culto della Dea Cibele in
Sicilia.
Il
colle su cui fu fondata la colonia siracusana di Akrai fu sede di abitazione
umana fin da epoca molto antica. Sul suo pendio settentrionale si apre,
infatti, un riparo sotto la roccia che ha fornito al Museo di Siracusa
un'abbondante industria litica che mostra, nel suo complesso, tutti i
caratteri di quel paleolitico superiore che è, ad oggi, la più antica
civiltà sicuramente identificata nell'isola.
Tucidide riporta
che Akrai fu fondata nel 664 a.C.- 665 a.C. dai siracusani su un altipiano
delimitato da margini scoscesi e da quattro corsi d'acqua, dal quale si
dominavano tutte le vie di accesso. La città fu la fortezza che garantì a
Siracusa le libere comunicazioni con le città greche della costa
meridionale della Sicilia e con le città sicule dell'interno.
Nel
corso del IV e V
secolo Akrai si affermò
come il più importante centro cristiano della Sicilia orientale dopo
Siracusa, come attestano le molte e vaste catacombe.
Non
è noto quando la città abbia cessato di esistere, lo storico Michele
Amari ipotizzò la sua
distruzione nel corso della conquista
islamica della Sicilia dell'827.
La
medievale Palazzolo Acreide, sorta in prossimità dell'antica Akrai, è
citata per la prima volta nella geografia di Edrisi.
Il
grande complesso di sculture rupestri ubicato lungo il lato meridionale del
colle Orbo si svolge su un costone roccioso affacciato su un sentiero alle
cui estremità si aprono due spianate semi-circolari. Nelle due spianate e
lungo il sentiero sono visibili delle pietre circolari, verosimilmente
basamenti di altari.
Le
sculture sono racchiuse in dodici ampie nicchie scavate nella roccia, undici
poste sullo stesso livello e una posta su un livello più basso. Ulteriori
nicchie più piccole, prive di immagini, completano la struttura che
presenta un impianto architettonico regolare il cui carattere unitario ha
consentito di identificare il luogo come un santuario e non come un
aggregato di rilievi aventi carattere votivo. Il ritrovamento di lucerne,
olle e piccole patere ha consentito, inoltre, di identificare il sito come
sede di culto.
In
dieci delle nicchie è riprodotta l'immagine della dea assisa in trono di
prospetto circondata da altre figure. In uno solo dei rilievi la dea è
raffigurata in piedi, a grandezza naturale.
 L'identificazione
della dea raffigurata nelle nicchie con Cibele è derivata dal raffronto con
l'iconografia con cui essa era rappresentata nel mondo greco e, in
particolare, ad Atene.
La dea è raffigurata con il chitone pieghettato e l'himaton ricadente dalla
spalla sinistra e raccolto sulle ginocchia. I capelli sono acconciati nella
forma cosiddetta “a melone” con due lunghi riccioli che scendono sulle
spalle e, sul capo, è posto il modio.
Ai suoi lati, in basso, sono presenti due leoni in posizione araldica. L'identificazione
della dea raffigurata nelle nicchie con Cibele è derivata dal raffronto con
l'iconografia con cui essa era rappresentata nel mondo greco e, in
particolare, ad Atene.
La dea è raffigurata con il chitone pieghettato e l'himaton ricadente dalla
spalla sinistra e raccolto sulle ginocchia. I capelli sono acconciati nella
forma cosiddetta “a melone” con due lunghi riccioli che scendono sulle
spalle e, sul capo, è posto il modio.
Ai suoi lati, in basso, sono presenti due leoni in posizione araldica.
In
alcune figurazioni sono chiaramente visibili la patera nella mano destra
posata sul sedile e il timpano nella sinistra, nelle altre, ragioni di
verosimiglianza e tenui tracce sui rilievi sfigurati possono farcene
ragionevolmente presumere la presenza.
La
posizione della dea raffigurata nelle nicchie ripropone due modelli
iconografici: quello della dea seduta in trono, spesso all'interno di un
naiskos, caratteristica del contesto nord-ionico ed eolico meridionale e
quello della dea con la figura in piedi caratteristica del contesto sud
ionico.
Tra
le figure minori raffigurate accanto alla dea Cibele in almeno cinque
nicchie (nelle altre non è possibile, per le scarse condizioni di
conservazione, escludere l'originaria presenza di figure minori) sono stati
identificati Hermes, Attis, Hecate,
i Dioscuri,
i Galli e
i Coribanti.
In
merito alla figura principale rappresentata all'interno della dodicesima
nicchia, quella posta nel livello più basso, sono state formulate, finora,
solo delle ipotesi che tendono, comunque, ad escludere che si tratti di
Cibele per via della foggia dell'abito, una corta tunica che lascia scoperte
le ginocchia che non trova alcun riscontro nell'iconografia della dea.
Come
si è detto, oltre a Cibele, nei rilievi sono raffigurati alcuni personaggi
nel cui rapporto con la dea sono riconoscibili tre schemi iconografici
riconducibili a precisi motivi religiosi che si ritrovano in monumenti di età
ellenistica e romana.
Il
primo schema è costituito dal riferimento, insieme mitico e rituale, ai
Galli, sacerdoti della Dea e ai Coribanti, suoi mitici accompagnatori,
raffigurati come due piccole figure che in cinque rilievi appaiono alla
destra e alla sinistra del capo di Cibele. Essi indossano una tunica, spesso
un mantello, un berretto frigio e portano, come attributi, un timpano nella
sinistra e un'asta nella destra.
L'associazione
di tre personaggi divini: Cibele, Ermes e Attis riconoscibile nel II rilievo
acerense, costituisce il secondo schema iconografico riscontrato in altre
raffigurazioni greche. In questo rilievo, il maggiore di tutto il complesso,
Cibele è raffigurata in una posizione insolita, in piedi con le braccia
allargate e le mani appoggiate, in gesto protettivo, sul capo di Hermes a
destra e di Attis a sinistra. Il primo è riconoscibile per il caduceo,
il secondo per il pedum
pastorale e per la tipica
posizione incrociata delle gambe.
Sempre
nel secondo rilievo, alla destra di Attis è raffigurato un personaggio
femminile di cui sono riconoscibili con sicurezza solo i contorni e parti di
una tunica panneggiata. Il movimento in avanti del piede destro e la
presenza, nella mano sinistra di un oggetto che somiglia ad una lunga torcia
hanno portato ad identificare il personaggio con Hecate dadofora. Si delinea
così un terzo schema iconografico riconducibile al motivo religioso di
un'ulteriore triade divina Cibele, Hermes ed Hecate di cui si ha riscontro
in una serie di monumenti di età ellenistica e romana.
Nel
secondo rilievo è, inoltre, presente un ulteriore elemento degno di nota:
due personaggi che incedono su due grandi cavalli nei quali sono stati
riconosciuti i Dioscuri. Anche di quest'ultimo schema iconografico che
associa i Dioscuri alla grande dea dei misteri esistono riscontri in fonti
epigrafiche e monumentali.
Il
santuario rupestre di Akrai offre, quindi, nella ricchezza e nella
complessità delle sue raffigurazioni, una sorta di sintesi delle
iconografie e delle dottrine teologiche connesse al culto metroaco.
La
singolarità del monumento acerense risiede proprio in questa contemporanea
presenza, attorno alla dea, di personaggi che molteplici fonti letterarie,
epigrafiche e monumentali indicano essere ad essa connessi, ma secondo
formule distinte e, in nessun altro caso noto, in un'unica composizione.
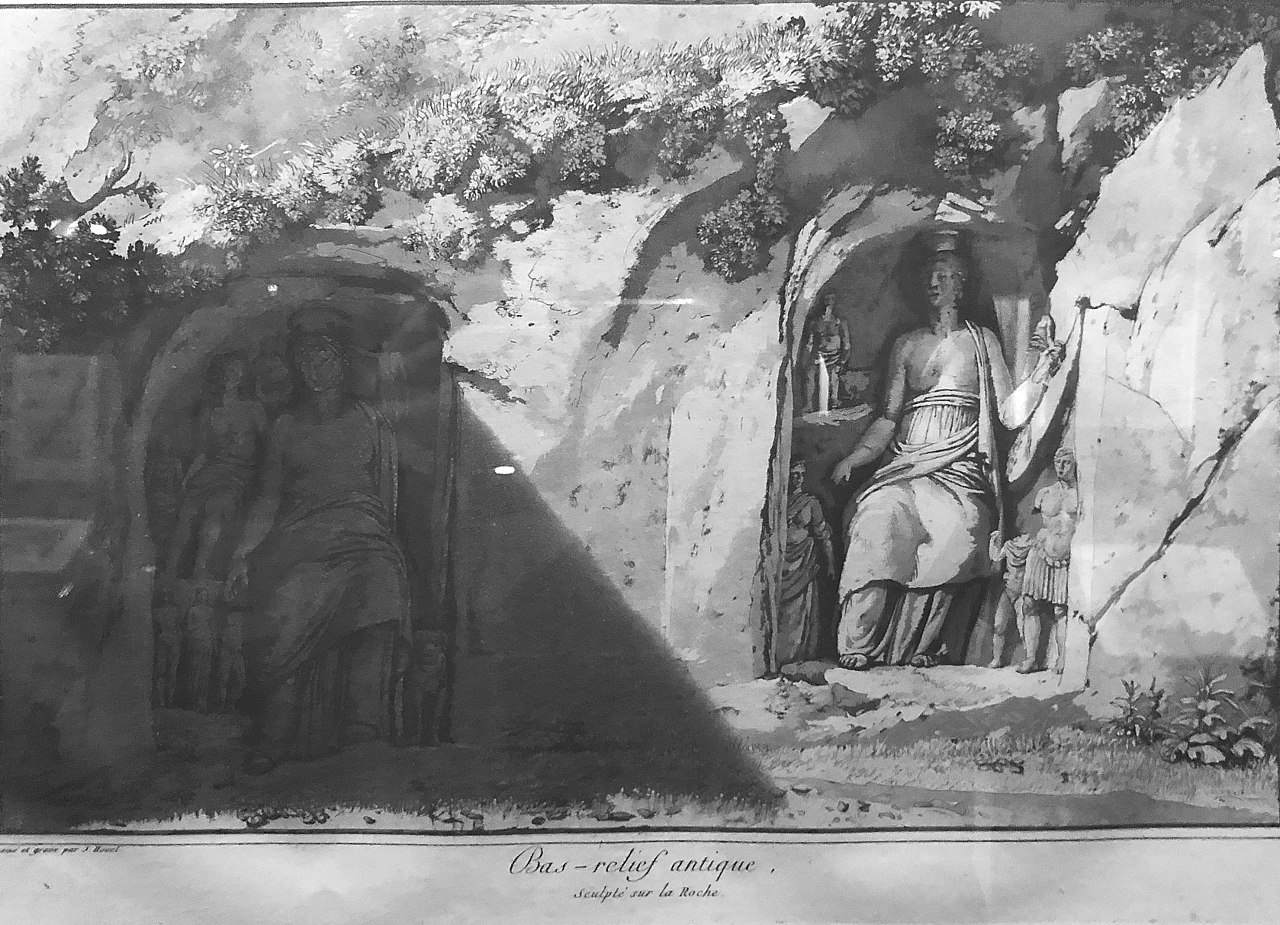
Sulla
base di un giudizio sullo stile delle sculture e dei reperti archeologici
emersi nell'area, il santuario è stato datato dagli studiosi intorno al
IV-III secolo a.C., in piena età
ellenistica.
I
Santoni furono per la prima volta nominati nel XVIII secolo da Ignazio
Paternò principe di Biscari nel
libro Viaggio per tutte le antichità della Sicilia e dal pittore
francese Jean
Houel che ne diede una
descrizione artistica corredata da tavole pittoriche di gusto
classicheggiante.
I
disegni di Houel, seppur ricchi di fascino, non sono fedeli alle
raffigurazioni originali e, insieme all'interpretazione di sculture
funerarie data dall'autore, hanno contribuito a determinare le errate
conclusioni di alcuni studiosi successivi. Ad esempio nella figura 2 è
possibile osservare come, nel disegno di Houel, i leoni al fianco della Dea
sono raffigurati come cani.
L'indagine
scientifica di scavo iniziò nel XIX sec ad opera del barone Gabriele
Iudica, custode reale delle
antichità della Valle di Noto che,
ricercando le tombe ipotizzate da Houel, portò alla luce altri gruppi
scultorei, un lastricato e oggetti quali lucere, olle e piccole patere. Lo
Iudica condivise l'interpretazione di Houel che considerava le sculture
espressione di pratiche funerarie.
Nel
1840 Domenico
Lo Faso, Duca di Serradifalco pubblicò
la descrizione del sito corredata da alcuni disegni di Francesco
Saverio Cavallari e,
basandosi sul riferimento funerario delle sculture ventilato da Houel e
dallo Iudica, ipotizzò l'identificazione del personaggio principale con
Iside Persefone. La sua tesi fu condivisa nel secolo successivo dall'Orsi e
dal Pace che
ravvisarono nel complesso scultoreo le immagini Demetra e Core Persefone,
due divinità siciliote per eccellenza.
L'autorevolezza
dei due studiosi ha, per lungo tempo, fatto passare in secondo piano le
argomentazioni di Alexander
Conze che, nel 1880,
basandosi sui disegni del Cavallari, colse per primo le analogie tra le
raffigurazioni acerensi e quelle anatoliche e greche della Dea Cibele.

Nel
1953, con gli Scavi della Soprintendenza alle Antichità furono eseguiti
precisi disegni delle sculture da Rosario
Carta e, delle fotografie
che furono pubblicati dal Prof. Luigi
Bernabò Brea in un volume
che ha operato una prezioso lavoro di raccolta di elementi di valutazione e
di ricostruzione scientifica che ha consentito di inserire il santuario
metroaco di Akrai nel più ampio contesto della diffusione del culto di
Cibele nel mondo greco romano.
Il
riconoscimento della struttura unitaria che caratterizza il sito si deve,
infine, all'approfondita indagine svolta dalla prof. Giulia Sfameni Gasparro
Gasparro che, attraverso il confronto con un'ampia serie di documenti
riconducibili al contesto religioso e storico nel quale il santuario si
inserisce, ha consentito di ricostruire, per quanto possibile stante lo
stato di degrado del complesso, il significato delle raffigurazioni del
santuario rupestre di Akrai. nella monografia I culti orientali in
Sicilia.
Contigue al
teatro, due latomie (cave) di epoca greca, sono state trasformate dai
cristiani in catacombe ed in abitazioni. In quella denominata Intagliatella,
più stretta, si può distinguere all'inizio, sulla destra, un bassorilievo
raffigurante un eroe che partecipa ad un banchetto (sulla destra) e che
effettua un sacrificio (a sinistra). Vicino alla recinzione, gli scavi hanno
riportato alla luce dei quartieri abitati ed una costruzione circolare,
probabilmente un tempio di epoca romana.
Ai
piedi del colle una serie di bassorilievi scolpiti nel calcare documenta il
culto degli acrensi nei confronti della dea Cibele o Magna Mater,
riconoscibile per il timpano, il Modio e i leoni. I rilievi risalenti alla
metà del III sec. a.C. scoperti anch'essi dal barone Judica (nel 1809)),
sono 12 e nel gergo locale vengono denominati "Santoni".
Scolpiti
su una parete che si estende per circa 30 metri, sono di fattura rozza ma
testimoni di valore storico e religioso. La necropoli della pineta occupa la
sommità pianeggiante di detta contrada, ed è visibile dalla strada
panoramica.
E'
possibile percorrere la strada che costeggia la zona archeologica che offre
belle viste sulla vallata circostante e permette di rendersi conto della
posizione di dominio e controllo della città antica, nata come avamposto
difensivo di Siracusa.

|