|
DAL
2016
SITO
PATRIMONIO
IN
PERICOLO
-
Seconda
guerra
civile
in
Libia,
presenza
di
gruppi
armati,
danni
esistenti
e
probabili
futuri
danneggiamenti.
Al
confine
con
Tassili
N'Ajjer
in
Algeria,
si
erge
il
Tadrart
Acacus,
massiccio
roccioso
che
racchiude
migliaia
di
pitture
rupestri
in
stili
molto
diversi,
datate
tra
il
12.000
a.C.
e
il
100
d.C.
Tali
pitture
testimoniano
i
netti
cambiamenti
della
fauna
e
della
flora
e
i
diversi
stili
di
vita
delle
popolazioni
che
si
succedettero
in
questa
regione
del
Sahara.
Sulla
parete
di
roccia
basaltica
levigata
dal
vento,
generazioni
di
tuareg
e
nomadi
del
deserto,
hanno
lasciato
messaggi
alle
carovane
che
sarebbero
passate
di
lì
dopo
di
loro.
Alcuni
di
essi
sono
disegnati
con
il
gesso,
altri
incisi
con
un
punteruolo.
Alcuni,
forse,
hanno
pochi
giorni,
altri
sono
vecchi
di
secoli.
Ma
tutti
sembrano
segni
remoti,
tracciati
in
lingua
tuareg.
Il
Tadrart
Acacus
è
solo
il
prologo
di
una
storia
che
ha
più
di
10.000
anni,
narrata
dagli
innumerevoli
siti
ricchi
di
pitture
e
incisioni
rupestri,
che
si
estende
per
250
chilometri
nella
regione
sud-occidentale
della
Libia,
fino
al
confine
con
l'Algeria.
Paradossalmente,
le
tracce
più
recenti
appaiono
anche
le
più
rozze,
come
se
nel
tempo
il
senso
artistico
si
fosse
involuto
di
pari
passo
con
i
mutamenti
climatici
nella
regione.
Oltre
ai
geroglifici
tifinagh,
le
pitture
e
le
incisioni
più
recenti
risalgono
a
2000-3000
anni
fa,
ovvero
a
un
periodo
che
gli
studiosi
hanno
denominato
"camelino"
a
causa
della
preponderanza
dei
dromedari
tra
i
soggetti
ritratti.
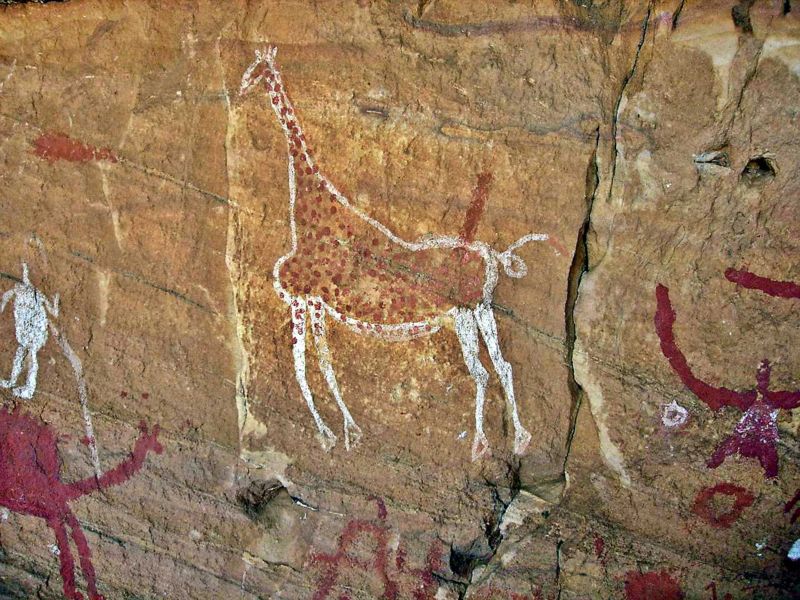
All'epoca
quell'area del
Sahara
doveva
essere
grossomodo
come
oggi:
un
labirinto
di
rocce
nere,
solcato
da
profonde
valli
di
sabbia
dove,
nonostante
la
bellezza
del
paesaggio,
era
arduo
vivere.
Nel periodo precedente, tra i
3000
e
i
4000
anni
fa,
la
desertificazione
era
già
in
fase
avanzata,
ma
nell'Acacus
sopravvivevano
ancora
vaste
oasi
e
le
distanze
tra
l'una
e
l'altra
potevano
essere
coperte
dai
cavalli.
In
quell'epoca,
chiamata
"cavallino",
gli
uomini
disegnavano
e
incidevano
con
maestria
quadrupedi
e
figure
umane,
spesso
impettite
su
strani
carri.
Ancora
prima,
tra
gli
8000
e
i
4000
anni
fa,
la
civiltà
sahariana
era
pastorale
e
parzialmente
sedentaria.
I disegni realizzati in questo
lasso
di
tempo
-
incisi
con
la
tecnica
della
martellatura
o
dipinti
con
ocra
rossa,
ossido
di
ferro
e
altre
sostanze
minerali
fissate
con
albume
e
urina
-
ritraggono
mandrie
di
bovini
e
scene
umane
corali
che
testimoniano
una
società
organizzata
e
un
relativo
benessere,
seppur
primitivo,
che
aveva
favorito
l'espressione
artistica.
Uno
dei
siti
rupestri
più
stupefacenti
della
prima
età
pastorale
è
il
Wan
Amil,
nel
sud
dell'Acacus.
Vi
è
descritta,
con
un'accurata
scelta
cromatica,
la
battaglia
tra
due
fazioni
contrassegnate
da
copricapi
rossi
e
gialli.
Accanto,
come
in
un
racconto
a
fumetti,
vi
è
una
scena
che
è
stata
interpretata
come
un
matrimonio,
celebrato
per
sancire
la
pace.
Ma
è
nella
fase
ancora
più
primitiva,
quella
detta
"delle
teste
rotonde"
(9000-8000
anni
fa)
che
la
civiltà
sahariana
ha
lasciato
le
più
interessanti
e
"magiche"
tracce
di
sé.
Era,
questo,
il
tempo
in
cui
l'uomo
prese
coscienza
della
sua
forza
rispetto
agli
altri
esseri
viventi
e
concepì
l'idea
del
divino:
hanno
infatti
una
valenza
sacra
le
grandi
figure
antropomorfe
che
si
trovano,
per
esempio,
negli
anfratti
di
Wan
Tabu
e
Wan
Amillal.
Diecimila
anni
fa,
infine,
il
Sahara
era
verde
e
popolato
da
mammiferi
come
giraffe,
elefanti,
grandi
predatori
e,
soprattutto,
bufali
della
specie
estinta
Bubalus
antiquus,
soggetto
dominante
delle
pitture
più
antiche.
Sebbene
già
descritta
da
Erodoto
nel
V
secolo
a.C,
l'arte
rupestre
sahariana
è
rimasta
praticamente
sconosciuta
fino
a
metà
dell'Ottocento,
quando,
grazie
all'esploratore
tedesco
Heinrich
Barth,
prese
il
via
un'opera
di
studio
e
catalogazione
che
continua
ancora
oggi.
E
che
è
stata
portata
avanti
in
modo
ampio
e
sistematico
dallo
studioso
italiano
Fabrizio
Mori.

Ad
oltre
un
secolo
dalle
prime
segnalazioni
di
incisioni
preistoriche
ad
opera
del
viaggiatore
tedesco
Heinrich
Bart
(1856),
le
manifestazioni
artistiche
del
Fezzan
sono
universalmente
riconosciute
come
uno
dei
patrimoni
culturali
dell’umanità.
È
dal
1985
che
le
montagne
del
Tadrart
Acacus
sono
infatti
inserite
nella
“World
Heritage
List”
dell’Unesco,
fatto
che
le
conferisce
status
particolare,
sia
per
le
possibili
modalità
di
utilizzo
e
gestione,
che
per
quelle
di
tutela
e
salvaguardia.
Fu
Paolo
Graziosi,
alla
fine
degli
anni
’30,
a
studiare
per
la
prima
volta
ed
in
maniera
sistematica
i
graffiti
del
Fezzan,
fornendone
le
prime
indicazioni
interpretative.
Vennero
costruite
allora
le
prime
griglie
cronologiche,
ed
abbozzati
i
confronti
tra
il
Sahara
e
le
regioni
limitrofe,
dalla
Valle
del
Nilo
alla
costa
del
Mediterraneo.
Alcuni
anni
dopo,
nel
1955,
fu
Fabrizio
Mori
ad
attrezzare
una
piccola
spedizione
per
visitare
l’interno
dell’Acacus,
fino
ad
allora
pressoché
ignorato
dalle
ricerche
precedenti,
e
documenta
le
stupefacenti
pitture
dello
Wadi
Teshuinat.
Il
Tadrart
Acacus
e
il
Messak
Settafet
sono
punteggiati
da
migliaia
di
graffiti,
eseguiti
con
tecniche
e
caratteristiche
tematiche
differenti,
la
cui
antichità
è
vivacemente
dibattuta.
Da
un
lato
è
ampiamente
sostenuta
l’ipotesi
di
associare
tali
rappresentazioni
alle
prime
comunità
di
cacciatori-raccoglitori
dell’antico
Olocene,
databili
a
circa
10.000
anni
fa,
a
definire
quindi
una
sorta
di
cronologia
‘lunga’.
Altri
ricercatori,
perlopiù
di
scuola
francese,
ritengono
che
tutta
l’arte
rupestre
sahariana
sia
il
prodotto
di
pastori
neolitici,
a
cominciare
da
circa
7000
anni
fa,
quindi
sostanzialmente
più
‘corta’.
I
graffiti
più
antichi
sono
il
prodotto
di
quei
cacciatori
specializzati
che
popolavano
le
montagne
e
le
aree
pianeggianti
della
Libia
meridionale.

All’inizio
dell’Olocene,
circa
10.000
anni
fa,
queste
regioni
erano
più
ricche
di
vegetazione
e
frequentate
da
una
fauna
oggi
scomparsa.
L’arte
di
questi
antichi
cacciatori
sceglie
soggetti
imponenti,
e
quindi
probabilmente
più
prestigiosi,
come
il
Bubalus
antiquus,
un
enorme
bovino
selvatico,
estinto
in
epoca
arcaica:
è
proprio
questo
animale,
le
cui
spettacolari
rappresentazioni
del
Messak
Settafet
raggiungono
stupefacente
vigore
e
bellezza,
che
segna
la
‘corrente
stilistica’,
definita
della
‘Grande
Fauna
Selvaggia’
o
‘Bubalina’.
Questi
graffiti
sono
eseguiti
con
stile
naturalistico,
vigoroso.
Il
segno
è
profondo,
spesso
eseguito
con
tecniche
diverse
–
martellatura
o
levigatura
–
e
i
soggetti
rappresentati
sono
esclusivamente
animali
selvatici.
È
questa
la
ragione
principale
che
ha
fatto
ipotizzare
una
loro
maggiore
antichità
rispetto
alle
imponenti
mandrie
di
buoi
che
caratterizzeranno
il
periodo
neolitico
pastorale.
Le
aree
con
maggiore
concentrazione
sono
gli
uidian
del
Messak
Settafet,
in
particolare
Wadi
In
Elobu,
Wadi
Tilizagen,
Wadi
Alamasse,
solo
per
citarne
alcuni.
Ma
anche
l’Acacus,
specie
nelle
sue
porzioni
più
interne,
vede
rappresentate
alcune
eccezionali
opere.
Probabilmente
già
intorno
a
8500
anni
da
oggi,
il
Sahara
centrale
assiste
alla
fioritura
di
un’arte
pittorica,
spettacolare
per
temi
ed
esecuzione,
caratterizzata
dalla
presenza
di
figurazione
antropomorfe,
con
teste
tondeggianti
o
discoidi
prive
di
ogni
carattere
somatico
del
volto:
fu
proprio
questa
caratteristica,
ubiqua
nel
Sahara,
a
suggerire
a
Henri
Lhote
il
termine
‘Teste
Rotonde’.
La
distribuzione
di
questa
corrente
artistica
sembra
limitata
a
parte
dei
massicci
sahariani
–
Tassili-n-Ajjer,
Acacus,
Ennedi
–
ma
distribuita
su
un
arco
cronologico
assai
ampio,
probabilmente
più
di
due
millenni.
Le
pitture
delle
‘Teste
Rotonde’
sono
assai
diversificate,
e
possono
variare
da
figurazioni
antropomorfe
semplificate,
monocromatiche,
a
composizioni
policrome
anche
di
dimensioni
notevolissime.
Il
quadro
è
arricchito
dalla
rappresentazione
di
animali
selvatici,
perlopiù
antilopi
e
mufloni,
dalla
presenza
di
scene
di
carattere
rituale,
da
elementi
enigmatici
e
di
difficile
lettura.



La
grandezza
artistica
della
fase
delle
‘Teste
Rotonde’
sta
certamente
nello
straordinario
fascino
evocativo
che
esse
emanano:
alcune
rappresentazioni
antropomorfe,
come
gli
individui
di
Grub,
o
Afozzigiar,
nella
loro
apparente
immobilità
e
nella
scomposizione
formale
di
alcuni
elementi
manifestano
davvero
una
‘modernità’
spettacolare.
Il
mondo
delle
‘Teste
Rotonde’,
rappresentato
cosi
come
possiamo
oggi
vedere
nei
ripari
di
Grub,
Anshalt,
Uan
Afuda,
Afozzigiar,
testimonia
una
notevole
ricchezza
culturale,
un
universo
permeato
di
aspetti
simbolici,
riti
di
iniziazione,
scene
di
danza,
in
cui
donne
e
uomini,
talora
con
maschere
o
con
oggetti
tra
le
mani,
scelgono
e
disegnano
il
loro
modo
di
concepire
il
mondo.
Intorno
ai
7000
anni
fa,
tutto
il
Sahara
è
come
accarezzato
da
un
incredibile
movimento
culturale,
di
stupefacente
ricchezza
e
potenza
artistica.
È
la
fase
‘Pastorale’,
detta
anche
‘Bovidiana’.
Migliaia
di
pitture
e
graffiti
decorano
ed
incidono
blocchi
di
pietra,
pareti
rocciose,
lastre
isolate.
Il
paesaggio
umano
ed
archeologico
muta
incessantemente,
e
il
Sahara
centrale
diviene,
proprio
in
questo
periodo,
il
luogo
al
mondo
forse
con
la
massima
concentrazione
di
arte
preistorica.
Camminare
lungo
gli
uidian
dell’Acacus
e
del
Messak
Settafet
è
davvero
come
passeggiare
in
una
galleria
d’arte
all’aperto,
con
straordinarie
scene
di
vita
quotidiana,
come
la
costruzione
di
accampamenti,
le
operazioni
di
mungitura,
gli
scambi
di
oggetti.
È
un’arte
narrativa,
naturalistica,
vivida.
Il
centro
dell’universo
è
divenuto
il
bestiame:
mandrie
di
grandi
bovini
pezzati
si
muovono
lungo
le
pareti
di
Uan
Tabu,
Tagg-n-Tort,
Teshuinat.
Sono
animali
dipinti
con
grandissima
accuratezza
:
qui
le
corna
assumono
grande
rilievo
figurativo,
e
simbolico,
e
vengono
raffigurate
scene
di
attività
sia
lavorativa
che
sociale.

L’arte
pastorale,
nelle
sue
differenti
articolazioni
stilistiche
e
formali,
abbraccia
un
lungo
intervallo
cronologico,
più
di
tremila
anni,
e
quest’impressionante
documentazione
sembra
sottolinearne
i
cambiamenti,
le
modifiche,
le
popolazioni,
quasi
i
‘volti’
degli
attori
protagonisti.
È
con
questa
fase
stilistica,
infatti,
che
i
caratteri
somatici,
le
‘razze’,
cominciano
ad
avere
una
vera
rappresentazione
formale:
la
rappresentazione
del
corpo,
i
tratti
del
viso,
le
acconciature
dei
capelli,
i
vestiti,
sono
solo
alcuni
degli
elementi
che
lasciano
ipotizzare
contatti
regionali,
movimenti
popolazionistici,
integrazioni
culturali:
i
pastori
mediterranidi
di
Uan
Amil,
o
le
figure
nilo-camitiche
di
Ti-n-Lalan
rappresentano
forse
davvero
aree
diverse
di
provenienza
e
differenti
caratterizzazioni
culturali
Il
periodo
pastorale,
lungo
e
punteggiato
da
importanti
discontinuità,
appare
come
il
frutto
di
processi
complessi,
in
cui
confluiscono
tradizioni
differenti.
L’arte
pastorale
dell’Acacus
e
del
Messak
ha
al
proprio
centro
il
bovino,
vero
centro
ideologico
dei
pastori
preistorici.
 L’importanza
che
il
bestiame
ha
in
queste
società
è
osservabile
in
altre
forme
del
mondo
simbolico
e
rituale,
rappresentato
dal
sacrificio
di
animali
attraverso
riti
specifici,
che
culminano
nel
seppellimento
votivo
di
parti
dell’animale,
talora
corredate
da
vasi
di
ceramica. L’importanza
che
il
bestiame
ha
in
queste
società
è
osservabile
in
altre
forme
del
mondo
simbolico
e
rituale,
rappresentato
dal
sacrificio
di
animali
attraverso
riti
specifici,
che
culminano
nel
seppellimento
votivo
di
parti
dell’animale,
talora
corredate
da
vasi
di
ceramica.
Il
Messak
Settafet
ha
restituito
elementi
spettacolari:
lungo
le
pareti
degli
uidian
sono
graffite
scene
di
uccisione
dell’animale,
raffigurato
con
le
zampe
drammaticamente
rivolte
all’insù.
Poco
distanti,
le
strutture
in
pietra
proteggono
i
resti
dell’animale,
sepolto
oltre
5000
anni
fa,
straordinari
oggetti
di
culto
di
quei
pastori
oramai
scomparsi.
Trascurate
per
molto
tempo,
le
pitture
della
fase
del
‘Cavallo’,
così
definite
per
l’introduzione
da
oriente
di
questo
animale,
e
quindi
preciso
testimone
cronologico,
sono
state
recentemente
rivalutate
nell’ambito
dello
studio
della
nascita
dello
stato
arcaico
nel
Fezzan,
quello
dei
Garamanti.
Sebbene
meno
accurate
di
quelle
antiche
per
aspetti
tecnici
–
il
colore
meno
saturo,
il
tratto
più
incerto,
le
composizioni
scarsamente
articolate
–
le
pitture
di
questa
fase
mantengono
un
elevato
grado
di
formalizzazione
e
conseguente
interesse
artistico,
espresso
in
particolare
dal
ricorrente
tema
dei
corpi
umani
rappresentati
in
stile
‘bitriangolare’,
e
dalla
ubiqua
presenza
dei
cosiddetti
‘carri
volanti’.
Elemento
altamente
spettacolare,
la
rappresentazione
di
questi
carri,
sia
incisi
che
dipinti,
e
ancor
più
la
loro
distribuzione
nel
Sahara
centrale,
attrassero
l’attenzione
dello
studioso
francese
Henri
Lhote,
che
per
primo
ipotizzò
che
potessero
essere
collegati
alle
vie
di
commercio
che
attraversavano
in
età
protostorica
il
Sahara:
le
prime
vie
carovaniere.
  Le
recenti
ricerche
di
Mario
Liverani
stanno
dimostrando
come
la
civiltà
dei
Garamanti
rappresenti
una
complessa
struttura
sociale,
fondata
sul
controllo
politico,
e
forse
militare,
delle
vie
di
commercio
tra
coste
del
Mediterraneo
e
Africa
sub-sahariana:
beni,
persone
ed
animali
viaggiarono
lungo
le
rotte
carovaniere,
e
l’arte
ci
fornisce
ancora
una
volta
elementi
per
sostanziare
ed
arricchire
il
panorama
storico-archeologico.
È
in
questo
momento
storico
che
vengono
introdotti
sistemi
organizzati
di
irrigazione
e
la
coltura
della
palma
da
dattero,
elemento
quest’ultimo
spesso
rappresentato
nelle
pitture
dell’Acacus. Le
recenti
ricerche
di
Mario
Liverani
stanno
dimostrando
come
la
civiltà
dei
Garamanti
rappresenti
una
complessa
struttura
sociale,
fondata
sul
controllo
politico,
e
forse
militare,
delle
vie
di
commercio
tra
coste
del
Mediterraneo
e
Africa
sub-sahariana:
beni,
persone
ed
animali
viaggiarono
lungo
le
rotte
carovaniere,
e
l’arte
ci
fornisce
ancora
una
volta
elementi
per
sostanziare
ed
arricchire
il
panorama
storico-archeologico.
È
in
questo
momento
storico
che
vengono
introdotti
sistemi
organizzati
di
irrigazione
e
la
coltura
della
palma
da
dattero,
elemento
quest’ultimo
spesso
rappresentato
nelle
pitture
dell’Acacus.
Aldilà
degli
studi
‘stilistici’
e
sulle
tradizioni
storico-artistiche
di
questa
regione,
recentemente
è
stata
avviata
una
nuova
stagione
di
lavoro
che
mira
alla
valutazione
dello
stato
di
conservazione
delle
incisioni
e
delle
pitture
preistoriche
e
storiche
dei
siti
più
importanti
inclusi
nel
progetto
del
"Parco
Archeologico”.
In
questo
senso
l’affascinante
patrimonio
artistico
custodito
nelle
grotte
e
nei
ripari
viene
esplorato
con
criteri
finora
poco
praticati,
al
fine
di
comprendere
anche
le
relazioni
spaziali
tra
i
soggetti
rappresentati
e
le
aree
decorate
delle
pareti.
È
stato
inoltre
introdotto
il
campionamento
sistematico
di
pigmenti
da
sottoporre
ad
analisi
radiometriche
e
chimico-fisiche,
mentre
una
copertura
fotografica
criteriata
costituisce
un
efficace
supporto,
utile
alla
contestualizzazione
delle
decorazioni
stesse
e
dei
siti,
nonché
per
la
conservazione
delle
stesse
manifestazioni
artistiche.







|