|
Le incisioni
rupestri della Val Camonica si trovano in provincia
di Brescia e costituiscono una delle più ampie collezioni
di petroglifi preistorici del
mondo. L'arte rupestre è segnalata su circa 2 000 rocce in oltre
180 località comprese in 24 comuni, con una particolare concentrazione
nelle municipalità di Capo
di Ponte, Ceto (Nadro), Cimbergo e Paspardo, Sonico, Sellero, Darfo
Boario Terme, Ossimo dove
esistono 8 parchi attrezzati per la visita.
Si
tratta del primo Patrimonio
dell'umanità riconosciuto dell'UNESCO in Italia (1979),
che ha riconosciuto oltre 140 000 figure, anche se nuove
ininterrotte scoperte ne hanno progressivamente aumentato il numero
complessivo portandole fino a duecentomila se non trecentomila.
Le
incisioni furono realizzate lungo un arco di tempo di ottomila anni,
fino all'Età
del ferro (I
millennio a.C.); quelle dell'ultimo periodo sono attribuite al
popolo dei Camuni ricordato
dalle fonti latine. La tradizione petroglifica non si esaurì
repentinamente: sono state identificate incisioni - anche se in numero
assai ridotto, non comparabile con la grandiosa attività preistorica -
di epoca romana, medievale e perfino contemporanea, fino al XIX
secolo. La maggior parte delle incisioni è stata realizzata con
la tecnica della martellina;
in numero minore quelle ottenute attraverso il graffito.
Le
figure si presentano a volte semplicemente sovrapposte senza ordine
apparente, ma spesso invece appaiono in relazione logica tra loro, a
illustrazione di un rito religioso o di una scena di caccia o di lotta;
tale impostazione spiega lo schematismo delle immagini, ognuna delle
quali è un ideogramma che
rappresenta non tanto l'oggetto reale, ma la sua "idea". La
loro funzione è riconducibile a riti celebrativi, commemorativi,
iniziatici o propiziatori - dapprima in ambito religioso, in seguito
anche laico -, che si tenevano in occasioni particolari, singole o
ricorrenti. Tra i segni più noti rinvenuti in Val Camonica spicca la
cosiddetta Rosa
camuna, che è stata adottata come simbolo ufficiale della
regione Lombardia.
Nel dialetto locale della Valle Camonica le incisioni rupestri vengono
indicate col termine riduttivo di pitoti, ovvero pupazzi.
Lo studio su base scientifica
delle rocce arenarie incise risale al 1908, anno in cui apparve sulla
rivista mensile del Touring Club Italiano un saggio riguardante i massi
di Cemmo. Da allora l'esplorazione, la catalogazione e lo studio dei
graffiti andò progressivamente estendendosi.

Il sito preistorico della
Valcamonica, ancora non completamente esplorato, si estende su un’area
lunga 70 chilometri. Le figure, incise su circa 2440 rocce, sono più di
40.000. Queste incisioni rupestri, di cui esistono esempi in Spagna,
nell'Assia, in Svezia ed in Gran Bretagna hanno carattere simbolico ed
evocano scene di navigazione, di danza, di guerra, di aratura, di magia,
ecc. e si dispiegano su un arco di tempo di 8 millenni che ha preceduto
la nostra presente era.
La
grande quantità di figure, come al Monte Bego, è dovuta al particolare
supporto roccioso, un'arenaria permiana (o Verrucano lombardo) a grana
molto fine e cemento siliceo fortemente levigata dai ghiacciai.
Le
incisioni sulla roccia arenaria sono ottenute con diversi stili:
-
tracciando i contorni con uno strumento appuntito, creando quindi dei
graffiti;
- con
la tecnica a martellina, ovvero colpendo ripetutamente la superficie con
un sasso;
- con
la tecnica della martellina indiretta, usando un punteruolo metallico
colpito da un percussore litico.
Le incisioni rupestri della
Valcamonica costituiscono una straordinaria documentazione per immagini
dei costumi e della mentalità preistorica. La decifrazione sistematica,
la classificazione tipologica e lo studio cronologico di questi
petroglifi ha portato un considerevole contributo nei campi della
preistoria, della sociologia e dell’etnologia.
 Le
più antiche figure (sebbene molto limitate di numero) risalgono alla
fine del paleolitico (animali di grandi di grandi dimensioni, cervi,
alci). Le
più antiche figure (sebbene molto limitate di numero) risalgono alla
fine del paleolitico (animali di grandi di grandi dimensioni, cervi,
alci).
Il
primo sostanzioso ciclo dell'arte rupestre camuna ha inizio con la fase
finale del neolitico (metà del IV millennio a.C.), con la
raffigurazione schematica di campi coltivati (cosiddette
"mappe" o incisioni topografiche), in corrispondenza con
l'introduzione di pratiche agricole più evolute e con l'invenzione
dell'aratro.
Nella
successiva età del Rame (III millennio a.C.) segue la realizzazione di
statue stele e di composizioni monumentali (figure umane, pugnali, asce,
scene di aratura a traino bovino, cervi e bovini allineati), di
probabile significato e funzione rituale, collegate alla raffigurazione
iconografica di divinità solari o alla venerazione memorialistica di
antenati importanti.
Con
l'età del Bronzo Antico e Medio (figure di armi, asce, pugnali) ha
termine il primo grande ciclo dell'arte rupestre camuna.
Il
secondo grande ciclo ha inizio con l'età del Bronzo Medio-Recente (metà
II millennio a.C.), con la raffigurazione di figure umane schematiche
(cosiddetti oranti).
L'età
del Ferro (80% di tutte le figure, I millennio a.C.) vede una notevole
"esplosione" figurativa, si raffigurano situazioni in
movimento e le scene assumono carattere narrativo. Suggestivi esempi di
arte rupestre derivano dalle scene di caccia o di combattimento,
esaltazione di coraggio e virilità, e dalle raffigurazione di probabili
cerimonie rituali.
L'arrivo
dei romani segna la fine del ciclo istoriativo camuno, proseguito in
epoche successive (particolarmente nel medioevo) solo in maniera
sporadica.
Le
raffigurazioni sono diffusissime nella media Valle Camonica e
rappresentano soprattutto:
Animali
-
Cervo: diffuso soprattutto sulla sponda orientale dell'Oglio, presso il
Parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane. Sulla sponda
occidentale sono eccezionali le scene di caccia ai cervi dalle corna a
forma di lira del Parco archeologico comunale di Seradina-Bedolina. Per
la simbologia si rimanda alla figura del Cervo nella mitologia.
-
Uccelli: se ne possono distinguere chiaramente due tipologie: quelli con
becco arcuato verso il basso, chiamati rapaci, e quelli con il becco
verso l'alto, definiti uccelli acquatici. Si suppone che abbiano un
valore psicopompico.
-
Canidi: anche qua ti tipologie differenti: quelli con la coda arricciata
verso l'alto si suppone siano animali domestici, quelli con la coda
allungata sarebbero invece canidi selvatici come lupi o volpi.
Antropomorfi
- Diffusi
su entrambe le sponde dell'Oglio sono rappresentati sia da soli che in
gruppo. le categorie più definibili sono:
-
Oranti: personaggi con gambe larghe e braccia rivolte verso l'alto, in
una supposta posizione di preghiera
-
Duellanti: combattimenti tra due personaggi armati di spade e scudi.
Forse combattimenti gladiatori.
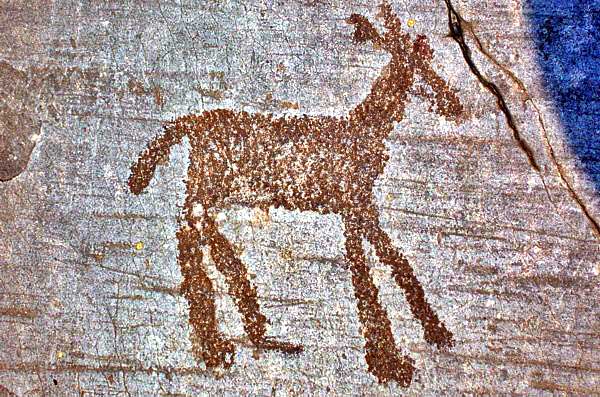 Figure
di capanna -
Ampiamente
diffuse sulla sponda orientale, soprattutto nella riserva naturale
Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, sono delle
raffigurazioni che rappresentano una struttura simile ad una abitazione
coperta da tetto spesso spiovente. Figure
di capanna -
Ampiamente
diffuse sulla sponda orientale, soprattutto nella riserva naturale
Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, sono delle
raffigurazioni che rappresentano una struttura simile ad una abitazione
coperta da tetto spesso spiovente.
Fino ad
oggi sono state catalogate oltre 1500 tipologie differenti di figura di
capanna. Gli studiosi ritengono che non si tratti di rappresentazioni
reali quanto di strutture astratte legate al culto dei morti.
Figure
di paletta -
Una delle
raffigurazioni più misteriose della Valle Camonica. Diffusissima in
certi settori, soprattutto nella parte nord-est della riserva naturale
Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, sembra completamente
assente da certi luoghi. Sicuramente doveva avere un forte valore
simbolico.
Scene
di aratura -
Diffuse prevalentemente sulla sponda occidentale sono sicuramente
legate al culto della fertilità, data la presenza di rappresentazioni
di ierogamie nelle vicinanze.
Negli anni
sessanta l'archeologo Emmanuel
Anati, tra i primi a studiare sistematicamente il corpus nel
suo complesso, stilò una prima cronologia delle incisioni rupestri,
comparando lo stile e le tipologie di simboli scoperti e individuando
possibili correlazioni con la periodizzazione storica tradizionale,
dalla Preistoria al Medioevo.
Epipaleolitico
- Le incisioni più antiche risalgono all'Epipaleolitico (o Mesolitico, VIII-VI
millennio a.C. circa), qualche millennio dopo il ritiro del
ghiacciaio che ricopriva la Val Camonica (Glaciazione
Würm), e furono opera di cacciatori nomadi di passaggio, che
seguivano gli spostamenti degli animali. Le figure rappresentate infatti
raffigurano animali di grandi dimensioni (cervi e alci), che
costituiscono le tipiche prede di quel periodo. Sono presenti nel comune
di Darfo
Boario Terme, nel Parco comunale delle incisioni rupestri di
Luine.
Neolitico
- Con il Neolitico (V-IV
millennio a.C. circa) si diffusero anche in Val Camonica le
pratiche agricole, con la formazione dei primi insediamenti a carattere
stanziale. Nel campo dell'arte rupestre, a costituire gli elementi
principali delle composizioni sono figure umane e insiemi di elementi
geometrici (rettangoli, cerchi, puntini, probabilmente interpretabili
come rappresentazioni "topografiche" del territorio agricolo),
attributi simbolici che completano il significato delle figure
antropomorfe. Ve ne sono nella Riserva
naturale Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo[9].
Secondo alcuni studiosi peraltro tali figure antropomorfe schematiche (i
cosiddetti "oranti") sarebbero da attribuire ad epoche più
tarde, e in particolare all'età del Bronzo (II millennio a.C.). In
questo modo solo le figure geometriche (le probabili "mappe")
rappresenterebbero l'inizio dell'arte rupestre camuna post-paleolitica.
Analoga sequenza è presente al Monte Bego (Francia), l'altro grande
polo dell'arte rupestre alpina.

Età
del rame - Durante l'Età
del rame (o Calcolitico, III
millennio a.C. circa), comparvero la ruota, il carro e le
prime forme di metallurgia.
Si assiste nell'arte rupestre alla realizzazione di massi
istoriati con simboli celesti, animali, armi, arature, file
di esseri umani e altri segni. A questi monumenti, conservati
principalmente nel Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo e
in quello di Asinino-Anvòia (Ossimo),
si attribuisce una funzione rituale, collegata alla venerazione degli
antenati.
Età
del bronzo - Con l'Età
del bronzo (II
millennio a.C. circa) tra le incisioni su rocce affioranti
prende il sopravvento il tema delle armi, a testimonianza del maggior
rilievo assunto dai guerrieri nella società camuna del tempo, accanto a
quello delle figure geometriche (cerchi e varianti) in continuità con
le epoche precedenti.
Età
del ferro - Le incisioni dell'Età
del ferro (I
millennio a.C.) sono quelle attribuite al popolo dei Camuni e
costituiscono circa il 70-80% di tutte le figure censite. Le opere
manifestano l'ideale di virilità e di eroica superiorità cui ambivano;
dominano le rappresentazioni di duelli e di figure umane, anche di
grandi dimensioni, che ostentano le proprie armi, la muscolatura e i
genitali. Sono inoltre presenti capanne, labirinti, impronte di piede,
scene di caccia, reticoli e simboli vari. Anche nell'età del Ferro sono
presenti composizioni topografiche, risalenti ai secoli centrali del I
millennio a.C. (VI-IV sec. a.C.), come nella famosa mappa di Bedolina,
dapprima studiata alla fine degli anni sessanta del secolo scorso da
Miguel Beltrán Llorís e più recentemente da Cristina Turconi per
l'Università di Milano, una delle più conosciute rocce incise di tutta
la Val Camonica.
 Età
romana - Durante la dominazione romana della Val Camonica (I-V
secolo d.C.) l'attività petroglifica subì una forte
contrazione, fino a entrare in una fase di latenza. Età
romana - Durante la dominazione romana della Val Camonica (I-V
secolo d.C.) l'attività petroglifica subì una forte
contrazione, fino a entrare in una fase di latenza.
Età
Moderna - Alla fine del Medioevo in Val Camonica si verifica una
ripresa dell'attività istoriativa. Si tratta di varie tipologie di
segni, sia di concezione cristiana (croci e scritte) sia di ambito
civile. Non è dimostrata la tesi che le incisioni di epoca storica
andarono a risacralizzare i precedenti segni precristiani. Al contrario
le ultime ricerche hanno dimostrato che in epoca moderna le incisioni
sono perlopiù di concezione laica. Tra gli esempi si ricordano: le
spirali, le torri, i sistemi di fortificazione e difesa del territorio,
antropomorfi armati e a cavallo, date, impiccati, chiavi. Tra i segni di
concezione religiosa si trovano le croci, gli ostensori spesso associati
alle bare.
Scoperta
e valorizzazione - La prima segnalazione di rocce incise risale al 1909,
anno in cui Walther
Laeng (italianizzato Gualtiero) segnalò al Comitato
Nazionale per la Protezione dei Monumenti due massi istoriati nei pressi
di Cemmo. Lo stesso Laeng nel 1914 scrisse una breve nota sui due
monumenti per la prima edizione della Guida d'Italia edita dal Touring
Club Italiano. Soltanto negli anni
venti, però, i massi incontrarono l'interesse di alcuni
studiosi, come l'antichista Giovanni Bonafini, il geologo Senofonte
Squinabol e, a partire dal 1929,
l'antropologo torinese Giovanni
Marro e l'archeologo fiorentino Paolo
Graziosi. Ben presto vengono scoperte numerose incisioni anche
sulle rocce circostanti e le ricerche, oltre che da Marro, vengono
condotte anche da Raffaello Battaglia per conto della Soprintendenza
alle Antichità di Padova.
Negli anni
trenta la notorietà delle incisioni si diffuse in Italia e
all'estero, tanto che nel 1935-1937 una
vasta campagna di studi fu condotta dai tedeschi Franz
Altheim ed Erika Trautmann. Altheim avviò una lettura
ideologica in senso nazista delle incisioni, presto imitata in
versione fascista anche
da Marro, volta a identificarle come una testimonianza della supposta razza
ariana ancestrale.
La
mappatura e la catalogazione ripresero dopo la Seconda
guerra mondiale, condotte sia da studiosi del neonato Museo di
Scienze naturali di Brescia guidati
da Laeng, sia da esperti nazionali e internazionali. Nel 1955,
con l'istituzione, per iniziativa della sovraintendenza archeologica
della Lombardia,
del Parco
nazionale delle incisioni rupestri di Naquane, iniziò l'opera di
tutela del patrimonio rupestre.
Nel 1956 iniziarono
le esplorazioni di Emmanuel
Anati che scoprì nuovi petroglifi e condusse
un'osservazione sistematica dell'intero patrimonio; tali studi gli
permisero di dare alle stampe, nel 1960,
il primo volume di sintesi generale sull'argomento: La civilisation
du Val Camonica. Lo stesso Anati fondò, nel 1964,
il Centro
Camuno di Studi Preistorici, che si sarebbe fatto carico, oltre
che delle ricerche sistematiche, della stampa e della divulgazione di
vari volumi e di una propria pubblicazione periodica, il Bollettino
del Centro Camuno di Studi Preistorici (BCSP). Nel 1968 si
svolse il primo Valcamonica Symposium, primo di una lunga serie di
convegni, che riunì in Val Camonica numerosi studiosi d'arte e vita
preistorica.
Dopo
l'inclusione tra i Patrimoni dell'Umanità UNESCO promossa del Consiglio
internazionale per i monumenti e i siti il 29 marzo 1979, si
tenne a Milano la
mostra I Camuni, alle radici della civiltà europea (1982).
Le ricerche degli anni successivi hanno poi ulteriormente ampliato il
patrimonio rupestre censito.
Parchi
delle incisioni rupestri
Le
incisioni rupestri sono raccolte in otto parchi tematici:
|
N°
|
Nome
|
Località
|
Note
|
|
1.
|
Parco
di Interesse Sovracomunale del Lago Moro, Luine e Monticolo
|
Darfo
Boario Terme
|
  Vasta
area protetta che contiene due aree principali: il sito del
Parco di Luine e quello dei Corni freschi. Le incisioni si
presentano particolarmente ostiche da osservare poiché il
supporto roccioso è rappresentato da pietra
Simona. Vasta
area protetta che contiene due aree principali: il sito del
Parco di Luine e quello dei Corni freschi. Le incisioni si
presentano particolarmente ostiche da osservare poiché il
supporto roccioso è rappresentato da pietra
Simona.
|
|
2.
|
Parco
archeologico di Asinino-Anvòia
|
Ossimo
|
  Sorge
su un'area di culto dell'Età
del Rame con
ricostruzioni di statue stele ivi ritrovate. Sorge
su un'area di culto dell'Età
del Rame con
ricostruzioni di statue stele ivi ritrovate.
|
|
3.
|
Riserva
naturale Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo
|
Ceto Cimbergo Paspardo
|
 La
Riserva è una vasta area
naturale protetta,
in gran parte boschiva, con castagneti e betulle, che si estende
per 290 ha.
Al suo interno si conservano oltre La
Riserva è una vasta area
naturale protetta,
in gran parte boschiva, con castagneti e betulle, che si estende
per 290 ha.
Al suo interno si conservano oltre  400 rocce incise con
particolari concentrazioni nelle aree di Foppe (Nadro di Ceto),
Campanine (Cimbergo),
Plas, In Vall e Sottolaiolo (Paspardo). 400 rocce incise con
particolari concentrazioni nelle aree di Foppe (Nadro di Ceto),
Campanine (Cimbergo),
Plas, In Vall e Sottolaiolo (Paspardo).
|
|
4.
|
Parco
nazionale delle incisioni rupestri di Naquane
|
Capo
di Ponte
|
 Il
primo parco fondato in Valle Camonica nel 1955.
Si estende per 14 ettari con 104 rocce incise. Il
primo parco fondato in Valle Camonica nel 1955.
Si estende per 14 ettari con 104 rocce incise.
|
|
5.
|
Parco
archeologico nazionale dei Massi di Cemmo
|
Capo
di Ponte
|
 Conserva
i Massi di Cemmo, due massi erratici con incisioni rupestri
dell'età del rame che furono le prime incisioni segnalate della
Valle Camonica nel 1909. Presenza di statue
stele. Conserva
i Massi di Cemmo, due massi erratici con incisioni rupestri
dell'età del rame che furono le prime incisioni segnalate della
Valle Camonica nel 1909. Presenza di statue
stele.
|
|
6.
|
Parco
archeologico comunale di Seradina-Bedolina
|
Capo
di Ponte
|
 Ultimo
parco aperto in Valle Camonica nel 2005. Vi è la presenza di
incisioni databili alla tarda età del Bronzo e del Ferro. Ultimo
parco aperto in Valle Camonica nel 2005. Vi è la presenza di
incisioni databili alla tarda età del Bronzo e del Ferro.
|
|
7.
|
Parco
comunale archeologico-minerario di Sellero
|
Sellero
|
 I
primi ritrovamenti avvennero durante gli anni
sessanta con
la scoperta di venticinque figurazioni, tra cui la roccia dell'Idolo
femminile. I
primi ritrovamenti avvennero durante gli anni
sessanta con
la scoperta di venticinque figurazioni, tra cui la roccia dell'Idolo
femminile.
|
|
8.
|
Percorso
pluritematico del "Coren delle Fate"
|
Sonico
|
  Presenza
dell'incisione raffigurante l'Idolo di Sonico, accompagnata con
due dischi solari, che ricorda un bambino in fasce. Presenza
dell'incisione raffigurante l'Idolo di Sonico, accompagnata con
due dischi solari, che ricorda un bambino in fasce.
|
PARCO
COMUNALE DELLE INCISIONE RUPESTRI DI LUINE A DARFO BOARIO TERME
(BRESCIA) - Il Parco abbraccia una vasta area verde nei territori di
Darfo Boario Terme e Angolo Terme, in cui ricadono due ambiti
archeologici: Luine e i Corni Freschi.
L’area
archeologica di Luine, in posizione dominante rispetto all’abitato di
Darfo B.T. ha restituito, oltre alle numerose incisioni rupestri, resti
di probabili luoghi di culto, fondi di capanna e strutture murarie a
secco, che potrebbero testimoniare la presenza di un “santuario”
usato da una o più comunità preistoriche per svolgere cerimonie
collettive. Sugli affioramenti di pietra Simona, dal caratteristico
colore viola, si contano più di 100 pannelli istoriati.
A
Luine si possono vedere le più antiche incisioni rupestri del ciclo
camuno, risalenti al periodo mesolitico, forse eseguite da cacciatori
seminomadi che hanno utilizzato la valle come territorio di caccia sul
finire delle grandi glaciazioni. Successivamente la zona fu abbandonata
per diventare nuovamente luogo di culto e incisione verso la fine del
Neolitico e soprattutto nell’età del Bronzo e del Ferro.
 Le
rocce principali sono dotate di cartellonistica esplicativa e tutti i
percorsi sono ben segnalati e mantenuti. Segnaliamo la grande roccia 34,
imperdibile per la sua importanza storica e per la sua bellezza
artistica. Si tratta di un’enorme superficie inclinata che le
incisioni ricoprono quasi completamente, abbracciando l’intero ciclo
artistico camuno: dalla grande sagoma di animale databile a circa 10.000
anni fa, ai guerrieri di età del Ferro del I millennio a.C. Le
rocce principali sono dotate di cartellonistica esplicativa e tutti i
percorsi sono ben segnalati e mantenuti. Segnaliamo la grande roccia 34,
imperdibile per la sua importanza storica e per la sua bellezza
artistica. Si tratta di un’enorme superficie inclinata che le
incisioni ricoprono quasi completamente, abbracciando l’intero ciclo
artistico camuno: dalla grande sagoma di animale databile a circa 10.000
anni fa, ai guerrieri di età del Ferro del I millennio a.C.
Quasi
tutto il repertorio camuno si concentra su questa roccia, considerata
fra le più belle della Valle Camonica. Nella parte alta si leggono le
grandi sagome di guerrieri a corpo quadrato (alte quasi un metro)
risalenti alla fine dell’età del Ferro; sotto, si trovano grandi
reticoli affiancati da figure di duellanti più piccole. Si leggono
chiaramente figure più enigmatiche: un meandro, un labirinto e una rosa
camuna, mentre un mammellone sporgente ospita una composizione di armi
di età del Bronzo. Nelle limpide giornate invernali, la vista dal basso
di questa roccia emoziona e toglie il respiro!
Sempre
a Luine è documentata un’importante fase neolitica, ma soprattutto
una quantità eccezionale di raffigurazioni di armi e composizioni
geometriche di età del Rame e del Bronzo. Fra queste ultime spiccano
senza dubbio le non comuni rappresentazioni di alabarde, oggetti di
prestigio rimasti in uso non oltre l’antica età del Bronzo (inizi del
II millennio a.C.).
L’area
del masso dei Corni Freschi, sulla riva destra dell’Oglio alla
base della collina del Monticolo, fa parte del complesso di siti di
culto che nel corso dell’età del Rame (III millennio a.C.)
caratterizzano diverse località della Valle Camonica.
Il
masso, segnalato nel 1961 da Emmanuel Anati, è un grande blocco di
arenaria precipitato dal versante roccioso alle sue spalle: al centro
della parete verticale è stata incisa una composizione di nove
alabarde, dalla quale deriva l’altro nome con il quale viene indicato:
“Roccia delle alabarde”. Le armi sono state incise a grandezza
pressoché naturale, con lame che vanno da 25 a 30 cm di lunghezza
circa.
Simili
contesti, nei quali grandi massi staccatisi da pareti sono stati incisi
e sono divenuti parte integrante di aree sacre, sono noti anche in altre
località della Valle Camonica: a Cemmo di Capo di Ponte e presso la
roccia 30 di Foppe di Nadro, nel comune di Ceto. I confronti tipologici
ed iconografici, sia con analoghe armi rinvenute in contesti di scavo
(Villafranca – VR) sia con raffigurazioni simili incise su altri massi
della Valle Camonica (la stele Cemmo 3), hanno permesso di datare le
istoriazioni dei Corni Freschi alla fine dell’età del Rame (seconda
metà del III millennio a.C.).

PARCO
ARCHEOLOGICO DI ANVOIA, OSSIMO - Il
parco archeologico di Asinino-Anvòia sull’altopiano di Ossimo-Borno
permette di approfondire il tema dei santuari megalitici dell’età del
Rame (III millennio a.C.). Qui, infatti, sono note diverse aree di culto
con allineamenti di stele e massi, attorno ai quali si svolgevano
cerimonie e riti (Anvòia, Pat, Passagròp e Ceresolo di Malegno).
Percorrendo
per circa 2 km la strada carreggiata che parte dalla Chiesa di S. Rocco
di Ossimo Inferiore, si arriva in automobile all’ingresso del parco in
località Asinino.
Una
serie di pannelli informativi illustra le campagne di scavo condotte
nell’area di di Anvòia da Francesco Fedele (Università Federico II
di Napoli, scavi 1988-2003), nel corso delle quali sono stati ritrovati
quattro massi, allineati secondo un orientamento nord-sud. Di questi,
tre erano rivolti a est con le facce principali istoriate.
Particolarmente importante il ritrovamento “in situ” di
offerte votive, buche di palo e ammassi di ciottoli con presenza di
resti di stele, forse rotte intenzionalmente.
Le
raffigurazioni incise sulle superfici dei tre massi maggiori richiamano,
in maniera molto stilizzata, volti umani; è possibile riconoscere linee
parallele a forma di “U” o di “T”, triangoli sovrapposti,
pendagli ad occhiale e collari. Solo sul monolite denominato “M3”
sono presenti alcune raffigurazioni di pugnali a lama triangolare e pomo
semilunato, di tipo "Remedello" (2800-2400 a.C.).
L’antico
sito calcolitico è illustrato da un plastico che mostra come si
presentava 4.500 anni fa e da riproduzioni in resina degli originali,
rimossi per motivi conservativi.

RISERVA
NATURALE INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO A NADRO - La
riserva nata nel 1983 per valorizzare l'immenso patrimonio artistico
della Valle Camonica, si sviluppa attraverso i tre comuni di Ceto,
Cimbergo e Paspardo. E' una vasta area protetta, in gran parte boschiva,
contenente al suo interno numerosissimi reperti di incisioni rupestri.
La
Riserva Naturale delle Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo
è l’area archeologica protetta più grande della Valle Camonica, con
oltre 400 rocce incise. Si estende per circa 300 ettari abbracciando i
tre paesi di Nadro di Ceto, Cimbergo e Paspardo.
L'ingresso
a questa vasta area boschiva può essere effettuato in differenti punti,
attraverso strade agro-silvo-pastorali, ma il percorso che si diparte
dal paese di Nadro è sicuramente il più accessibile. In questo luogo
è possibile ammirare la ricostruzione di due abitazioni preistoriche,
dalle quali si prosegue lungo il percorso che si sviluppa attraverso un
gran numero di rocce ricche di incisioni rupestri. I petroglifi
rappresentano differenti periodi storici che vanno dall'età del rame
fino all'età medievale; ogni roccia è riportata su pannelli
esplicativi che ne facilitano la lettura.
 La
visita inizia dal Museo didattico della Riserva con sede a Nadro
(infopoint, biglietteria, audio guide, bookshoop, wi-fi, servizi) e
prosegue in uno dei numerosi percorsi di visita con accesso da Nadro di
Ceto (per Foppe), da Cimbergo (per Campanine – Figna) e da Paspardo
(per Plas – Capitello, In Vall e Sottolaiolo). Gli itinerari di visita
consentono, in poche ore o più giorni, di ammirare molteplici aspetti
della riserva: siti archeologici, aspetti etnografici ed ambientali. La
visita inizia dal Museo didattico della Riserva con sede a Nadro
(infopoint, biglietteria, audio guide, bookshoop, wi-fi, servizi) e
prosegue in uno dei numerosi percorsi di visita con accesso da Nadro di
Ceto (per Foppe), da Cimbergo (per Campanine – Figna) e da Paspardo
(per Plas – Capitello, In Vall e Sottolaiolo). Gli itinerari di visita
consentono, in poche ore o più giorni, di ammirare molteplici aspetti
della riserva: siti archeologici, aspetti etnografici ed ambientali.
L’area di
Foppe di Nadro è un susseguirsi di superfici fittamente
istoriate organizzate in un piacevole percorso ad anello. Le incisioni
ritrovate vanno dal V millennio a.C. fino all’alto medioevo;
particolarmente importanti le figurazioni dell’età del Bronzo (II
millennio a.C. con una ricca tipologia di armi) e i leggiadri guerrieri
riferibili alla fase di influenza etrusca (età del Ferro medio).
All’ingresso dell’area istoriata, su un leggero pianoro, è
allestita un’area di sosta dedicata all’attività didattica con una
simulazione di scavo archeologico, la ricostruzione di una capanna
neolitica e di una casa retica dell’età del Ferro.
La
rocca di Cimbergo (XII-XIII sec.) incombe sul sentiero che
conduce a Campanine, dove le ricerche archeologiche, da poco concluse,
hanno individuato più di 100 rocce istoriate, di cui solo una dozzina
organizzata nel percorso di visita turistico. L’area iniziò ad essere
istoriata durante l’età tardo-neolitica (fine IV mill. a.C.), fu
momentaneamente abbandonata durante i secoli successivi (poche le
incisioni del II mill. a.C.) e il suo utilizzo riprese nell’ultimo
millennio a.C. Vi è stata inoltre individuata una ricchissima e finora
unica concentrazione di istoriazioni eseguite dalla fine dell’epoca
romana fino alla piena età moderna.
A
causa della sua considerevole estensione, l’area archeologica di
Paspardo è suddivisa in sottoaree immerse in un suggestivo ambiente
montano, in buona parte integro, ciascuna caratterizzata da stili
esecutivi e da soggetti unici non riscontrabili in altre zone della
Valle. Segnaliamo le zone aperte al pubblico e dotate di infrastrutture
turistiche, tutte comodamente raggiungibili a piedi dal paese: Plas –
Capitello, In Vall e Sottolaiolo.

PARCO
NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI DI NAQUANE A CAPO DI PONTE (BRESCIA)
- Il Parco
Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, a Capo di Ponte, è stato
il primo parco istituito in Valle Camonica nel 1955. L’area si estende
per oltre 14 ettari e costituisce uno dei più importanti complessi di
rocce incise nell’ambito del sito del Patrimonio Mondiale UNESCO n. 94
“Arte Rupestre della Valle Camonica”. Al suo interno, in uno
splendido ambiente boschivo, è possibile ammirare ben 104 rocce incise,
corredate da pannelli informativi e suddivise in 5 percorsi di visita
facilmente percorribili per circa 3 Km. La visita completa di tutti i
percorsi richiede almeno 4 ore.
Su queste
ampie superfici di arenaria di colore grigio-violaceo, levigate
dall’azione dei ghiacciai, gli antichi abitanti della valle
realizzarono immagini picchiettando con un percussore litico o, più
raramente, incidendo con uno strumento a punta. La cronologia delle
istoriazioni del Parco si colloca tra il Neolitico (V-IV millennio a.C.)
e l’età del Ferro (I millennio a.C.), anche se non mancano incisioni
di età storica. L’epoca meglio rappresentata è sicuramente l’età
del Ferro, quando la Valle era abitata dai Camunni delle
fonti romane.
Alcune
rocce sono di notevoli dimensioni, come la Roccia 1, che colpisce il
visitatore per la straordinaria ricchezza e varietà delle figure
incise, circa un migliaio. Sono presenti molte figure di animali, uomini
armati, telai verticali a pesi, palette, edifici, coppelle e un
labirinto.
Molte
rocce sono dominate da figure umane realizzate in modo schematico, nella
posizione detta dell’orante: hanno braccia rivolte verso l’alto,
gambe contrapposte e corpo lineare, con alcune varianti. Gli studi
mostrano la lunga durata di questo tipo di figura che ha inizio nel
Neolitico e perdura fino agli inizi età del Ferro. Sulle rocce del
Parco possono essere presenti guerrieri, cavalieri, animali, edifici,
figure simboliche ed iscrizioni camune, a volte interpretati come
elementi di scene di significato complesso, ma è necessaria molta
prudenza.
Molto
spesso le superfici rocciose erano ripetutamente incise, sovrapponendo
tra loro figure di età diverse. È così che ad esempio è nata la
cosiddetta “scena del villaggio” della roccia 35, dove alcuni
edifici che si sovrappongono a precedenti scene di caccia al cervo
sembrano mostrare un villaggio con le sue attività. Alcune figure
presentano una particolare valenza artistica, come la famosa
raffigurazione del sacerdote che corre della roccia 35. In alcuni casi
abbiamo vere e proprie raffigurazioni divine, come nel caso della Roccia
70, dove una figura di grandi dimensioni, dalle evidenti corna di cervo,
è interpretata come il dio Cernunnos, che trova confronti con il
celebre calderone di Gundestrup (Danimarca).

PARCO
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DEI MASSI DI CEMMO - Nella
piccola valle di Pian delle Greppe, a poca distanza dalla frazione
omonima di Capo di Ponte, sorge il Parco Archeologico Nazionale dei
Massi di Cemmo. Un’area archeologica non solo di grande suggestione
per il contesto naturale, ma anche di grande importanza nella storia
degli studi dell’arte camuna. La segnalazione dei massi, infatti,
avvenuta nel 1909 ad opera del giovane geografo Gualtiero Laeng,
costituisce la prima menzione di incisioni rupestri nella Valle
Camonica. Da allora sono stati numerosi gli studiosi che hanno condotto
indagini nell’area o hanno proposto un’analisi delle istoriazioni.
A
partire dalle ricerche di Emmanuel Anati per il Centro Camuno di Studi
Preistorici (1962) fino agli interventi che la Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia ha avviato a partire dai primi anni ’80,
in occasione di lavori pubblici nell’area. Proprio le ultime indagini,
promosse in previsione della creazione del parco (inaugurato
nell’ottobre del 2005), hanno finalmente permesso la ricostruzione
della complessa e lunga storia del sito.
 L’area
dei due massi, precipitati dalla parete retrostante all’inizio
dell’Olocene, risulta già frequentata nel Mesolitico Antico (circa
IX millennio a.C.) e nel Neolitico Recente (IV millennio
a.C.), ma è trasformata in un vero e proprio santuario megalitico
nell’età del Rame, quando i due massi furono incisi e la zona
antistante venne circoscritta da tre solchi di aratura e arricchita da
molte altre stele. L’area
dei due massi, precipitati dalla parete retrostante all’inizio
dell’Olocene, risulta già frequentata nel Mesolitico Antico (circa
IX millennio a.C.) e nel Neolitico Recente (IV millennio
a.C.), ma è trasformata in un vero e proprio santuario megalitico
nell’età del Rame, quando i due massi furono incisi e la zona
antistante venne circoscritta da tre solchi di aratura e arricchita da
molte altre stele.
Nell’età
del Bronzo fu costruito un grande muro, largo alla base 2,50 metri,
che circoscrive lo spazio sacro, che viene ristrutturato anche nell’età
del Ferro (V/IV-II/I sec. a.C). Il santuario perdura in età
romana e viene definitivamente disattivato con l’avvento del
Cristianesimo: le stele sono abbattute e in parte buttate in grandi
fosse.
Sul
Masso 2, oltre alle raffigurazioni di animali (stambecchi, cerbiatte e
canidi in cui si riconoscono branchi di lupi ed un cane raffigurato con
la coda all’insù), si riconoscono armi (un’ascia, un’alabarda e
numerosi pugnali) e figure umane stilizzate. Si possono ammirare due
celebri raffigurazioni legate alle innovazioni tecnologiche del III
millennio a.C.: un carro a quattro ruote piene e un aratro.
Sul
Masso 1 sono incise oltre centocinquanta raffigurazioni comprendenti
animali (cervi dalle grandi corna ramificate, cerbiatte, camosci con
corte corna ad uncino, stambecchi, cinghiali o maiali, canidi e bovidi),
pugnali e una scena di aratura.
Le
oltre 20 stele e gli altri materiali, rinvenuti nel corso delle recenti
indagini, hanno trovato collocazione nel MuPre – Museo Nazionale della
Preistoria della Valle Camonica a Villa Agostani a Capo di Ponte.

PARCO
ARCHEOLOGICO COMUNALE DI SERADINA-BEDOLINA A CAPO DI PONTE (BRESCIA) - La
riserva, raggiungibile dal paese di Capo di Ponte, copre un territorio
posto tra i 400 e i 600 m s.l.m. Soggetta ad una particolare esposizione
del sole, l’area è caratterizzata da una flora specifica di climi più
caldi. Vicino agli alberi tipici della media valle, è possibile
ammirare alcune specie particolari come l’Opuntia Compressa, piccolo
fico d’India che con i suoi frutti viola richiama le sfumature della
roccia affiorante.
Figure
e segni di quest’area sono segnalati dai vari studiosi fin dagli anni
trenta del Novecento, ma vere e proprie ricerche sistematiche iniziano
solo nel 1963, quando Emmanuel Anati, direttore e fondatore del Centro
Camuno di Studi Preistorici, pone la sua attenzione sul sito. Nei
successivi tre anni, Anati individua le sottoaree in cui la zona è
divisa ancora oggi: Seradina I-Corno, Seradina I-Ronco Felappi, Seradina
II, Seradina III e Bedolina, quest’ultima resa famosa dall’insieme
di incisioni definite Mappa di Bedolina.
Negli
anni seguenti il Centro Camuno concentra i suoi studi sulla grande
roccia 12 di Seradina I, mentre nel frattempo la Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Lombardia decide di salvaguardare la Mappa di
Bedolina grazie ad un restauro conservativo.
All’interno
del Parco è possibile apprezzare, grazie a cinque percorsi di visita,
varie tipologie di incisioni. L’occhio del visitatore può ammirare i
maestosi guerrieri-cacciatori, le numerose scene di aratura, la capanne
e le iscrizioni in Nord Etrusco. Percorrendo il sentiero che collega
l’area di Seradina a Bedolina, si può restare affascinati dalle
incisioni di corni, probabili strumenti musicali ed arrivare a scoprire
la Mappa di Bedolina, posizionata su una terrazza naturale che permette
di abbracciare con lo sguardo tutto il paesaggio sottostante.
Di
notevole importanza è la roccia 12 di Seradina I, sulla quale è
possibile ammirare un centinaio di figure incise. Estremamente curate e
dinamiche rappresentano scene di caccia al cervo e scene di aratura: si
riconoscono duellanti, cavalieri, cervi dalle grandi corna, cani dalla
bocca spalancata, eroi che fermano a mani nude serpenti e oranti con le
braccia alzate.
Oltre
a queste figure, realizzate con un tratto fine e sicuro, tipiche di
quest’area sono anche le rappresentazioni di armati dai corpi
squadrati, che sono stati incisi all’interno.
All’ingresso
del primo percorso di visita sono ubicate due cascine di servizio con
saletta di proiezione che presenta il Parco, una mostra permanente
dei calchi in gesso della collezione “Battista Maffessoli” (fedeli
riproduzioni delle più importanti rocce incise della Valle Camonica),
la mostra fotografica "Nel bosco dei Graffiti" e un'area
relax.

PARCO
COMUNALE DI SELLERO (BRESCIA) - Il Parco Comunale Archeologico e
Minerario di Sellero racchiude ben quattro diversi siti d’arte
rupestre e l’area mineraria di Carona.
Testimoniata
fin dall’età del Ferro, primo millennio a.C., l’attività mineraria
segna l’economia della Valle Camonica durante tutta l’età storica,
divenendo preponderante nel XVI e XVII secolo.
Le
miniere di Carona, poste a nord-ovest del paese di Sellero, a circa 800
m. s.l.m., sono caratterizzare da cunicoli, gallerie e resti di
alloggiamenti per gli operai e per gli attrezzi e sono state sfruttate a
partire dalla fine dell’800 fino al 1951. Ricche di carbonato di
calcio, calcopirite e quarzo presentano anche rame e ferro.
 Dei
quattro siti d’arte rupestre solo uno, quello di Carpène, è stata
attrezzato con un percorso di visita. Dei
quattro siti d’arte rupestre solo uno, quello di Carpène, è stata
attrezzato con un percorso di visita.
Lasciata
l’auto nel paese di Sellero, vicino al torrente Re, è possibile
raggiungere le rocce di Carpène, percorrendo un sentiero che sale di
quota, alternando salite a tratti pianeggianti. Dopo una breve camminata
(25-30 minuti) si arriva all’area attrezzata dov’è possibile
ammirare alcune delle circa venti superfici che compongono questo sito.
Le
prime indagini sistematiche nell’area, già segnalata negli anni ’30
del ‘900, sono degli anni ’80 quando l’amministrazione comunale
richiede l’intervento del Centro Camuno di Studi Preistorici.
Nel
2008, su impulso del Dipartimento Valcamonica Lombardia del Centro
Camuno, nasce il parco comunale Archeologico e Minerario di Sellero,
dove il valore dell’arte rupestre si unisce alla tutela della natura
circostante.
Le
superfici affioranti sono caratterizzate da una roccia dura con
striature metalliche che denunciano la presenza di quarzo al loro
interno, difficili da incidere sono state scelte dall’uomo della
preistoria fin dal Neolitico (fine IV-inizi III millenio a.C.). Le
figure presenti testimoniano una pausa dell’azione incisoria nell’età
del Rame e del Bronzo (III-II millennio a.C.) e un significativa ripresa
della produzione nell’età del Ferro (I millennio a.C.).
Tra le
rocce indicate dal percorso, la grande roccia 2-3 offre la possibilità
di osservare alcune delle figure più importanti del parco, su questa
superficie si riconosce il maestoso insieme di elementi geometrici
definito da alcuni studiosi “idolo femminile” da altri “mappa
topografica”; il “viandante”, forse rappresentazione del dio
celtico Esus, e la più grande incisione di “Rosa Camuna” ad oggi
conosciuta.
Le
restanti superfici offrono la possibilità di ammirare uno dei temi
peculiari dell’età del Ferro: i guerrieri, rappresentati singoli o in
scene corali. Caratterizzati da scudi, spade o lance ed elmi gli armati
segnano la roccia 1 e la vicina roccia 4. Alternati a palette, canalette
e coppelle sono quasi sempre appiedati, tranne per alcune affascinanti
scene di cavalieri, fra le quali uno sembrerebbe intento in una prova di
abilità in piedi sul cavallo.

PERCORSO
PLURITEMATICO DEL "COREN DELLE FATE" - Il
Percorso Pluritematico del “Coren delle Fate” di Sonico, posto
all’interno dell’esteso Parco dell’Adamello, è stato oggetto nel
2007 di un intervento di valorizzazione.
L’area,
segnalata per la prima volta nel 1950, è studiata in un primo momento
da Emmanuel Anati, fondatore e direttore del Centro Camuno di Studi
Preistorici, che scopre e pubblica l”idolo di Sonico”, figura
geometrica sulla roccia 1. Successivamente, il lavoro di Ausilio Priuli
(anni ’90) permette una più larga indagine dell’area con
l’individuazione di nuove superfici incise e la creazione del parco.
Situata
in Alta Valle Camonica, l’area è caratterizzata dalla presenza di
rocce micascistiche (Scisti di Edolo), rocce dure e rugose, difficili da
incidere. Tipiche anche del vicino parco comunale archeologico e
minerario di Sellero, queste pietre differiscono dalle superfici dei
parchi della media valle: arenarie permiane di colore violaceo più
facili da scalfire.
Lasciata
l’auto nei pressi del centro storico del paese di Sonico, si
intraprende il percorso segnalato dai pannelli del Parco
dell’Adamello. Il sentiero si inoltra lungo un affascinante bosco di
castagni in leggera salita per alcuni minuti fino a giungere a un bivio
dove, seguendo le indicazioni dei pannelli, si imbocca il ripido
percorso che conduce alle rocce incise.
Giunti
alla roccia 1, la prima superficie che si incontra lungo il sentiero,
non si può non rimanere incantati dalla visuale circostante: queste
incisioni sono tra le più settentrionali della valle e si trovano in un
luogo strategico, posto in posizione dominante rispetto all’abitato
moderno. Da questa terrazza naturale è possibile ammirare l’inizio
della Valle di Corteno, collegamento con la Val Tellina, e il paese di
Edolo, superato il quale si può raggiungere il Passo del Tonale e
quindi il Trentino.
Le
incisioni che si possono ammirare sulle superfici affioranti sono quasi
esclusivamente di due tipologie: figure geometriche e palette. Cerchi,
linee e coppelle (piccole incisioni circolari) si alternano e abbinano
in svariati modi creando giochi e composizioni spesso uniti tra loro da
linee e canalette. Secondo un primo studio, avanzato dal prof. Anati
negli anni ’60 del ‘900, alcune figure circolari della roccia 1
avrebbero rappresentato un “idolo”, databile al Neolitico (V-IV
millennio a.C.). Successive ricerche hanno avanzato l’ipotesi che si
tratti di rappresentazioni topografiche, riscontrabili in molte zone
della valle.
Tra
le varie figure presenti, molto interessanti sono le ruote raggiate,
probabilmente legate alla ciclicità del sole e alla sacralità del
fuoco. A fianco delle numerose raffigurazioni geometriche, sono invece
rare le incisioni figurative. Tra
queste, molto diffuse sono le figure di “palette”.

Fonte:
|