Hierapolis,
la città posta a dominare la
valle del fiume Lykos lungo il
percorso che collega l'Anatolia
interna al Mediterraneo, era il più
rinomato centro termale del mondo
romano. Le nobildonne della corte
imperiale erano disposte a
intraprendere viaggi lunghi e
faticosi pur di potersi bagnare
nell'acqua benefica, color della
ruggine, delle piscine. Vi
giacevano immerse per ore,
detergendosi con saponi profumati
all'alloro, per poi presentarsi al
cospetto dei loro uomini con il
capo cinto da grappoli d'uva. Il
luogo delle cure di bellezza era -
e ancora è - tanto poetico quanto
straordinario, con le sue piscine
naturali racchiuse in terrazze di
travertino che l'azione incessante
dell'acqua ha ricoperto di un
manto calcareo candido come
bambagia. Tanto che i turchi hanno
dato a quel luogo il nome di
Pamukkale, "castello di
cotone".
Sotto la
tutela dell'Unesco sia per le sue
caratteristiche naturali sia per
l'importanza storica,
Hierapolis-Pamukkale fu fondata
intorno al 190 a.C. da Eumene II,
re della dinastia degli Attalidi,
in corrispondenza di una sorgente
sotterranea dove già da lungo
tempo le popolazioni lidie e
frigie veneravano la dea madre
Cibele. Il sovrano la chiamò
Hierapolis in omaggio a Hiera,
moglie di Telefo, leggendario re
di Pergamo. Poco meno di un secolo
dopo fu Attalo III, un altro re di
Pergamo, a cedere la città - che
già contava notevoli costruzioni
dall'elegante architettura
ellenistica - ai romani, i quali
la posero sotto la giurisdizione
del governatore di Efeso.
Al
centro di una zona altamente
sismica, Hierapolis fu funestata
da due terremoti, rispettivamente
nel 17 e nel 60 d.C. E l'opera di
ricostruzione, che pure ha seguito
l'impianto urbanistico greco, ha
fornito alla città un aspetto
tipicamente romano. A fare da
perno era il Plutonium, l'antica
sorgente sotterranea che i romani
avevano dedicato al dio
dell'oltretomba. Da qui, come
racconta Strabone, si
sprigionavano vapori tossici,
letali per chiunque tranne che per
i sacerdoti, che dimostravano i
loro poteri facendovi volare
attraverso delle colombe, le quali
morivano istantaneamente.

Hierapolis
fu un centro propulsore del
cristianesimo. Nell'anno 80 vi fu
martirizzato l'apostolo Filippo
insieme ai suoi sette figli. E nel
V secolo i bizantini eressero in
suo onore il Martyrion, una
maestosa basilica a pianta
ottagonale, oggi semidiroccata. Ma
la testimonianza più affascinante
delle civiltà che si alternarono
a Hierapolis senza soluzione di
continuità è la necropoli che
sorge a poca distanza dalle
vestigia dell'antica città. Dalle
più antiche tombe a tumulo di età
ellenistica, a quelle romane con
elaborati sarcofagi, alle tombe a
volta dell'era cristiana, le oltre
1200 sepolture fanno della
necropoli di Hierapolis la più
ampia e meglio conservata
dell'Anatolia.
Le recenti
attività di scavo hanno permesso
di riconoscere l'impianto urbano
di Hierapolis, riferibile
probabilmente ad età ellenistica,
con un asse principale nord-sud,
la grande plateia, lungo la quale
si sviluppa un reticolo stradale
ortogonale che divide la città in
isolati regolari, piuttosto
allungati. All'interno di questo
impianto si disponevano gli
edifici pubblici e le case. Nella
parte nord della città, lungo la
strada che portava verso Tripolis,
cominciarono a formarsi, tra il II
e il I sec. a.C., i primi nuclei
della necropoli, che si svilupperà
in età imperiale, con tombe a
fossa ed edifici funerari.
L'assetto monumentale della città
meglio riconoscibile è quello che
si creò in età flavia, dopo il
rovinoso terremoto del 60 d.C.,
tra la fine del I ed il III sec.
d.C. É a questo periodo, infatti,
che si può far risalire la
costruzione dei principali
monumenti quali il teatro, il
recinto del tempio di Apollo,
l'agora commerciale, due grandi
ninfei pubblici, ecc.
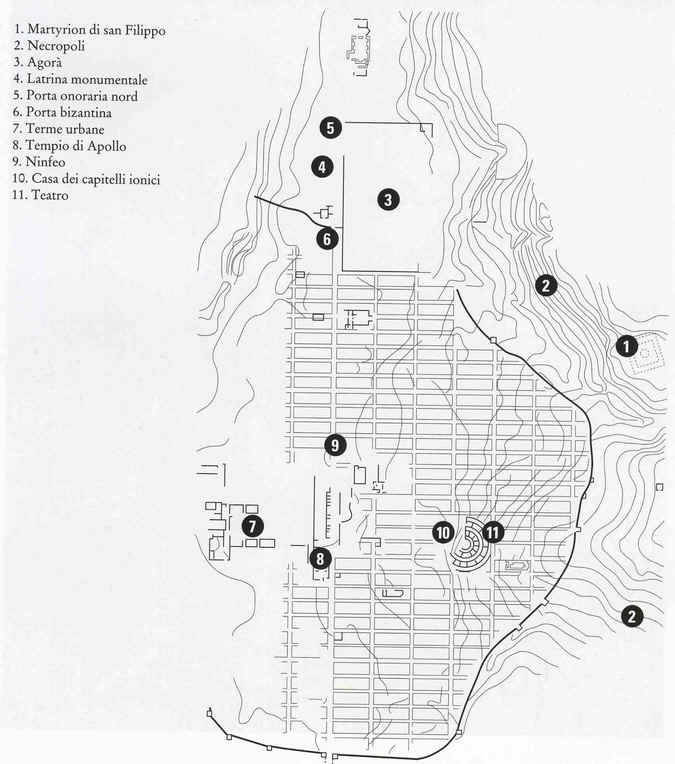 La crescita
della città subì un brusco
arresto nel corso del IV sec. d.C.
a causa di un violento terremoto
che distrusse estese aree come
quella dell'Agora commerciale.
La crescita
della città subì un brusco
arresto nel corso del IV sec. d.C.
a causa di un violento terremoto
che distrusse estese aree come
quella dell'Agora commerciale.
Con la
costruzione delle mura di
fortificazione bizantine, alla
fine del IV sec. d.C., la parte
nord della città, compresa
l'Agora commerciale, fu esclusa
dal perimetro urbano ed utilizzata
come cava per recuperare il
materiale da costruzione.
Hierapolis
diviene in questa fase un
importante centro della Cristianità
e lungo l'asse viario principale
furono costruite la chiesa
extraurbana (Terme-chiesa), la
Cattedrale con il Battistero, la
Basilica a pilastri e, sulla
collina orientale, il Martyrion di
S. Filippo.
Alla fine
del VI sec. d.C. un altro
terremoto provocò il crollo della
maggior parte degli edifici
ierapolitani comprese le mura
bizantine.
Nelle più
recenti campagne di scavo sono
state indagate in modo sistematico
anche le fasi medievali le quali
attestano profonde trasformazioni
dell'abitato in nuclei agricoli
che fanno riferimento al castello
costruito, con materiali di
spoglio, su uno sperone del
pianoro.






AGORA
- La vasta piana tra la Via di
Frontino e le pendici delle
montagne ad est fu trasformata,
nel corso del II sec. d.C., in una
grande piazza in cui si può
riconoscere l'Agorà commerciale
di Hierapolis. Larga circa 170
metri e lunga 280, l'Agorà è
circondata sui lati nord, ovest e
sud da portici di marmo con
facciata ionica e fila interna di
colonne corinzie. Sul lato est si
conservano, invece, i resti della
monumentale stoà-basilica che,
impostata su una scalinata in
marmo di 4 metri, dominava la
piazza.
La stoà-basilica
aveva una facciata a due piani ed
un porticato con pilastri a
sezione quadrata a cui si
addossano semicolonne, scanalate
superiormente, con basi di tipo
ionico e capitelli, pure ionici,
con maschere barbate sulle facce
laterali. Il piano superiore aveva
una fila di pilastri a semicolonne
in breccia rossastra con capitelli
corinzi in marmo bianco.
L'ingresso alla stoà-basilica era
segnato da un corpo avanzato con
pilastri su cui poggiano capitelli
figurati con leoni che azzannano
tori e sfingi.
CASA DEI
CAPITELLI IONICI - Lungo una
strada secondaria (stenopos) che
portava verso il teatro è stato
messo in luce un complesso
abitativo la “casa dei capitelli
ionici”. La casa è organizzata
in diversi ambienti che si aprono
su un peristilio centrale quadrato
con tre colonne per lato. Le
sottili colonne, alte metri 2,95,
sono in marmo brecciato rossastro,
con capitelli ionici in marmo
bianco che danno il nome alla
casa.
Il
rinvenimento, nel crollo, di altre
colonne più piccole in onice,
ancora con capitelli ionici, fa
ipotizzare la presenza, almeno
nella parte centrale, di un piano
superiore. L'esistenza di un piano
sopraelevato è anche attestata da
tavelle di terracotta, di
dimensioni più piccole rispetto a
quelle che costituiscono i
pavimenti su cui sono crollate le
strutture. Lo scavo ha permesso di
ricostruire una sequenza di fasi
di frequentazione e rifacimenti
dal II al X sec. d.C.
La
struttura originaria
dell'edificio, sulla base dello
stile degli elementi
architettonici e dei pavimenti in
opus spicatum in cotto, si può
riferire al II sec. d.C. La casa
doveva appartenere ad una delle
famiglie aristocratiche della città
come provano i numerosi oggetti
dell'arredo di marmo, tra cui
un'erma con testa di Dioniso ed
una testa di divinità barbata,
pure in marmo. La casa subì gravi
distruzioni nel corso del
terremoto del IV sec. d.C.; nella
fase di ristrutturazione (inizi V
sec. d.C.) fu modificata
l'organizzazione dei vani intorno
al peristilio e fu ricavato un
nuovo ambiente con pavimento in
opus sectile e zoccolature in
marmo.

LATRINA
- All'ingresso della città,
subito dopo la Porta di Frontino,
si trova una grande latrina
pubblica (fine I sec. d.C.).
L'edificio è stato rinvenuto in
una situazione di crollo,
provocato dal terremoto del VII
sec. d.C., ed è stato poi
ricostruito ricomponendo e
ricollocando i vari elementi nella
posizione originaria.
All'edificio, largo oltre 6 metri
e lungo 20 metri, si accedeva dai
due lati brevi.
Dai due
ingressi laterali, attraverso una
scala di tre gradini, si scendeva
al livello originario, più basso
di almeno un metro rispetto al
piano stradale. Il vano unico, è
diviso longitudinalmente in due
navate da una fila di colonne
doriche monolitiche che
sostenevano il tetto a grandi
lastre di travertino. Un canale
correva lungo i quattro lati
convogliando i liquami nella
cloaca della via di Frontino;
lungo i muri perimetrali rimangono
gli incassi in cui erano inseriti
i sedili.
MARTYRION
- L'edificio fu costruito,
alla fine del IV o gli inizi del V
sec. d.C., su un alto pianoro dal
quale si domina la città ed il
paesaggio circostante, all´interno
di un´area di necropoli. La
struttura è costituita da un vano
centrale, ottagono, su cui si
aprono otto ambienti rettangolari
circondati da una serie di camere
perimetrali. I vani rettangolari
si affacciano sull'ottagono
mediante tre archi sostenuti da
colonne sormontate da capitelli
marmorei compositi.
Il vano
centrale è pavimentato con lastre
di marmo ed era sormontato da una
copertura a cupola lignea coperta
da lamine di piombo, distrutta da
un incendio. I vani radiali hanno
una pavimentazione a mosaico di
grosse tessere con motivi
geometrici a quadrifogli, larga
treccia e bordi a tralci vegetali.
Questo edificio a pianta centrale
tipica dei martyria, sorto in area
cimiteriale, è stato collegato
alla tradizione del diacono
Filippo che in età apostolica si
trasferì a Hierapolis

MURA
BIZANTINE - Le mura bizantine
furono costruite tra la fine del
IV e gli inizi del V sec. d. C.
Non molto imponenti, misurano solo
metri 2,50 di larghezza e furono
realizzate con blocchi di
reimpiego provenienti dalla
demolizione degli edifici
pubblici, in particolare dall'Agorà.
La cinta muraria ingloba quasi
tutto l'abitato di età romana ed
è munita di 24 torri a pianta
quadrata disposte evidentemente in
base ad esigenze strategiche di
controllo del territorio.
In
corrispondenza della via
principale si aprono due porte,
una a nord ed una a sud; lungo il
lato orientale due postierle
conducono verso il Martyrion di S.
Filippo e le tombe della necropoli
orientale. La porta Nord, ad un
solo passaggio, con un grande arco
di scarico, è fiancheggiata da
due torri a pianta quadrata. Al di
sopra del fornice, molto
probabilmente, erano collocate
quattro mensole con teste di
leoni, di pantera e di Gorgoni,
appartenenti ad edifici più
antichi e rinvenute in posizione
di caduta davanti all'ingresso.
 NECROPOLI - Vaste necropoli
si estendono fuori del perimetro
dell'abitato; la più importante
per il numero e l'imponenza dei
monumenti è la necropoli
nord.
NECROPOLI - Vaste necropoli
si estendono fuori del perimetro
dell'abitato; la più importante
per il numero e l'imponenza dei
monumenti è la necropoli
nord.
L'architettura
funeraria presenta un'eccezionale
varietà di tipi e di soluzioni.
I più
antichi sepolcri sono quelli a
tumulo, riferibili all'età
ellenistica (II-I sec. a.C.), in
cui la camera funeraria a volta è
coperta da un cono artificiale di
terra circondato da un muro
circolare in cui si apre la porta
d'ingresso.






NINFEO
DEI TRITONI - Il Ninfeo dei
Tritoni è, insieme al Ninfeo
vicino al Tempio di Apollo, una
delle due grandi fontane
monumentali della città.
L'edificio è costituito da una
vasca lunga 70 metri, aperta sulla
strada, e da una facciata con due
risvolti sui quali sono ricavate
nicchie per l'alloggio di statue.
Gli scavi
sistematici del monumento,
iniziati nel 1993, hanno permesso
di recuperare gli elementi della
decorazione architettonica e
figurata in marmo, crollati nella
grande vasca e coperti da strati
di calcare concrezionati. Di
particolare interesse sono le
lastre con scene di Amazzonomachia
e rilievi con personificazioni di
fiumi e sorgenti. I caratteri
stilistici degli elementi
architettonici e la dedica all´Imperatore
Alessandro Severo, incisa su
un'architrave, fanno datare il
complesso alla prima metà del III
sec. d. C
TEATRO
- L'edificio, che occupa circa
quattro isolati del centro urbano,
si addossa in parte al pendio
roccioso. La cavea, molto ripida,
è divisa in due parti dal diazoma
mediano e, verticalmente, da 8
scalette in 9 cunei (kerkides);
superiormente vi era la galleria
di summa cavea. Al centro della
ima cavea è collocata un'ampia
esedra marmorea di proedria, con
sedili terminanti a zampe leonine
e alto schienale, per ospitare
personaggi di alto rango.
La cavea si
salda all'edificio scenico creando
una struttura unitaria e chiusa
secondo i modelli
dell'architettura romana.
L'edificio scenico si articola in
un logeion (palcoscenico) ed in
una scena. Della scena si conserva
solo il primo piano; la parte
superiore è stata rinvenuta in
crollo sul palcoscenico e
nell'orchestra. Il muro della
frontescena poggia su un podio che
si incurva in esedre in
corrispondenza delle porte
principali. Il podio, che poggia
su basamenti sagomati ed ha
cornice decorata a foglie d'acanto
e di quercia, regge lastre
marmoree scolpite con un ciclo
figurativo dedicato ad Apollo ed
Artemide. Questo maestoso edificio
fu costruito nel III sec. d.C.,
sotto l'imperatore Settimio
Severo, inglobando e cancellando
le fasi precedenti.

Lo
straordinario stato di
conservazione del fregio, che
ornava il basamento del colonnato
appoggiato al frontescena del
teatro, pone quest'opera tra i più
importanti complessi di
decorazione teatrale attualmente
noti in Asia Minore. In questi
edifici prevalgono decorazioni con
figure generiche di eroi e del
seguito di Dioniso, divinità dei
travestimenti e dei camuffamenti e
di conseguenza ispiratore della
recitazione.
Il
teatro di Hierapolis, pur
conservando un fregio dionisiaco,
presenta nel punto più importante
della struttura, ovvero lungo il
palco dove gli attori agivano, un
fregio costituito da 49 lastre
rappresentanti i miti di Artemide
e Apollo. L'originalità dei temi
figurativi non attinge a consueti
motivi di repertorio, ma risulta
legato alla realtà culturale
della città, all'ambiente
microasiatico dove spesso è
ambientato il ciclo mitologico
riguardante i due gemelli nati da
Latona, divinità anch'essa
originaria dell'Asia Minore,
venerati nei più grandi santuari
microasiatici, Artemide a Efeso,
Apollo nei templi oracolari di
Didime e di Claro oltre che a
Hierapolis stessa.

Attraverso
un programma iconografico
organico, si passa dalla gloria
della città fiorita nel periodo
ellenistico alla grandezza attuale
(inizio III secolo a.C.) dovuta
all'imperatore Settimio Severo.
Fulcro di tutta la narrazione,
infatti, è l'altorilievo fissato
all'architrave in corrispondenza
della porta principale: esso
rappresenta l'apoteosi
dell'imperatore Settimio Severo in
vesti di Zeus incoronato dalla
Vittoria, circondato dalla moglie,
Giulia Domna, e dai figli,
Caracalla e Geta, e da una serie
di personificazioni, tra cui la
città di Hierapolis, il coraggio,
la giustizia, la fortuna, sotto i
cui buoni auspici venivano svolte
le gare di teatro.
La
sottile corrispondenza tra
l'iconografia e le descrizioni dei
miti nei testi letterari permette
di ipotizzare che l'autore, grande
sostenitore dell'impero come unica
forma di governo possibile, sia da
ricercarsi in Antipatro, filosofo
sofista alla corte imperiale,
istruttore dei figli
dell'imperatore, nativo di
Hierapolis.
VIA
DI FRONTINO - La Via di
Frontino è la strada principale
(plateia) che attraversa l'intero
abitato. Larga 14 metri, è
lastricata e fornita di
marciapiedi; al centro corre la
grande cloaca coperta da lastroni
monolitici. Lungo i due lati si
aprono ambienti allineati con
funzione di case, depositi e
botteghe, unificati da una
facciata in travertino di ordine
dorico.
La
strada appare, per le sue
caratteristiche architettoniche,
organicamente concepita in un
progetto unitario con la porta di
Frontino che costituisce
l'ingresso monumentale alla città
romana. La porta a tre fornici, è
costruita con blocchi squadrati di
travertino e fiancheggiata da due
torri a pianta circolare.
Un'iscrizione monumentale in marmo
sulla facciata con dedica del
proconsole d'Asia, Sesto Giulio
Frontino, all'imperatore Domiziano
permette di far risalire la
costruzione della porta e della
strada alla fine del I sec. d.C.

TEMPIO DI
APOLLO - Le ricerche degli
anni sessanta hanno permesso di
identificare un grande edificio di
marmo collegato, grazie ai dati
restituiti dai documenti
epigrafici rinvenuti durante lo
scavo, al culto della principale
divinità di Hierapolis, Apollo.
L'edificio si imposta su di una
monumentale scalinata e ingloba
l'ingresso ad una cavità ipogeica
in cui va riconosciuto il
Plutonio, l'accesso al mondo
sotterraneo di cui parlano le
fonti letterarie antiche.
Il tempio
era ubicato all'interno di un´area
sacra, di circa 70 metri di
larghezza, circondata da un muro
di recinzione (temenos) al quale
si addossava un porticato in
marmo. Il lato nord è poco
visibile perché parzialmente
coperto dal passaggio della strada
moderna che porta al teatro. Le
strutture del tempio sono più
tarde ma la presenza di due
capitelli ionici e di un capitello
corinzio del I sec. d.C. fanno
ipotizzare l'esistenza nell'area
di un più antico edificio
templare
Ai piedi dei Monti Còkelez si
staglia un dirupo di 200 metri di
altezza. È un luogo che possiede
un fascino speciale e che un
"piccolo" dettaglio
geologico rende unico al mondo:
nella parte alta del dirupo si
trova una sorgente di acque
termali calcaree che scendono
verso la pianura lasciando dietro
di sé una "cascata" di
sedimenti dalle forme fantastiche
e una serie di piscine tiepide
che, per il colore della roccia,
sembrano scavate nel ghiaccio.
Quando, nell'XI secolo, i Turchi
conquistarono l'Anatolia
costruirono qui una fortezza e
diedero alla località il suo nome
definitivo: Pamukkale, ossia
"castello di cotone".
Fin dall'antichità si conoscevano le virtù delle acque di
Pamukkale che, oltre a essere
indicate per la cura delle
malattie degli occhi e della
pelle, venivano utilizzate per
sgrassare la lana e fissare le
tinture. Quando Eumene II, re di
Pergamo tra il 197 e il 159 a.C,
decise di fondare una città in
prossimità delle sorgenti, fu
assicurata anche la prosperità
del luogo. Fin dalle origini,
Hierapolis è stata un'importante
stazione termale, un luogo di
culto per i suoi numerosi templi e
anche un attivo centro di attività
tessile. La qualità delle acque
permetteva di ottenere, mediante
una tintura vegetale, un colorante
rosso intenso dai costi molto più
accessibili rispetto a quelli
della porpora di origine animale
utilizzata dai Fenici.
I movimenti
tettonici non solo hanno causato
frequenti terremoti, ma hanno
anche permesso la nascita di
numerose fonti termali, ed è
proprio l'acqua che sgorgata da
queste fonti con il suo contenuto
minerale, in particolare di gesso,
che creò Pamukkale. A parte una
piccola quantità di materiale
radioattivo, l'acqua contiene
grandi quantità di carbonato di
idrogeno e calcio, che rende le
piogge ricche di bicarbonato di
calcio. Questi fenomeni
atmosferici lasciano spessi strati
bianchi di calcare e travertino
lungo il pendio della montagna,
rendendo l'area simile ad una
fortezza di cotone o di cascate di
ghiaccio.

Pamukkale
è un importante centro turco per
i turisti che viaggiano dalle
coste dell'Adalia e del Mar Egeo
per vedere questo luogo che, in
coppia con Hierapolis, è uno dei
Patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO. Esistono pochi luoghi
al mondo simili a questo, ad
esempio le Mammoth Hot Springs
negli USA, e Huanglong nella
provincia cinese di Sichuan (altro
sito dell'UNESCO).
Sfortunatamente
Pamukkale venne abusata nel tardo
ventesimo secolo, alcuni hotel
sono stati costruiti sopra al
sito, distruggendo parte delle
rovine di Hierapolis. L'acqua
calda è stata incanalata per
riempire le piscine degli
alberghi, e quella mancante rubata
ai monumenti che in questo modo
hanno preso il tipico colore
bruno. Inoltre è stata costruita
una strada asfaltata in mezzo al
sito. Le persone ci camminano
sopra con le scarpe, lavandosi con
sapone e shampoo nelle piscine, ed
anche guidando bici e moto lungo
la discesa.
 Dopo che
l'UNESCO ha messo gli occhi su
Pamukkale, e dato che il sito
stava perdendo attrattiva, venne
attualizzato un piano di recupero.
Gli hotel furono demoliti, e la
strada coperta da piscine
artificiali che sono tuttora
accessibili, a differenza del
resto, dai turisti scalzi. Vi si
possono trovare anche dei girini.
Una piccola trincea è stata
scavata lungo il bordo, al fine di
recuperare l'acqua ed evitarne la
dispersione. Le parti brune
vengono lasciate al sole, senza
essere coperte dall'acqua,
sbiancandole e peggiorando quindi
il problema. Molte piscine sono
vuote. Alcune aree sono coperte
d'acqua per un paio di ore al
giorno, secondo la programmazione
mostrata in cima alla collina.
Dopo che
l'UNESCO ha messo gli occhi su
Pamukkale, e dato che il sito
stava perdendo attrattiva, venne
attualizzato un piano di recupero.
Gli hotel furono demoliti, e la
strada coperta da piscine
artificiali che sono tuttora
accessibili, a differenza del
resto, dai turisti scalzi. Vi si
possono trovare anche dei girini.
Una piccola trincea è stata
scavata lungo il bordo, al fine di
recuperare l'acqua ed evitarne la
dispersione. Le parti brune
vengono lasciate al sole, senza
essere coperte dall'acqua,
sbiancandole e peggiorando quindi
il problema. Molte piscine sono
vuote. Alcune aree sono coperte
d'acqua per un paio di ore al
giorno, secondo la programmazione
mostrata in cima alla collina.
L'attività
vulcanica sotterranea che ha
generato le fonti termali,
permette anche all'anidride
carbonica di fuoriuscire generando
quella che viene chiamata
"Plutonium", formata
interamente da plutone, e che
significa "luogo del dio
della morte".
ACQUE MIRACOLOSE
- Con una temperatura che si
aggira sui
35 gradi centigradi
e una portata media di circa
40 metri cubi
al secondo, le acque curative di
Hierapolis Pamukkale sono state
considerate preziose fin
dall'antichità. L'architetto
Vitruvio e il geografo Strabone (I
secolo a.C. - I secolo d.C),
mentre studiavano la rapidità con
cui il deposito lasciato dalla
corrente si solidifica, ci
descrivono un paesaggio ben
diverso da quello odierno.






L'oasi
termale era attraversata da canali
di irrigazione, che regolavano il
flusso delle acque in modo che
l'agricoltura e le manifatture ne
potessero sfruttare al meglio le
proprietà. Dall'esistenza di
monete coniate con l'immagine di
Dioniso si deduce che la
produzione locale avesse un buon
commercio. I giardini dovevano
essere numerosi, tanto da
giustificare l'esistenza di una
corporazione di kepourgòi,
giardinieri, menzionata in
un'iscrizione. L'utilità maggiore
di quelle acque non potabili
consisteva nella loro capacità di
fissare la tintura delle lane.
Lavoratori della lana, tintori,
tessitori erano raggruppati in
potenti corporazioni.
I
porphyrabàphoi acquisirono una
posizione preminente poiché
avevano scoperto che utilizzando
una pianta originaria della zona,
e che gli studiosi hanno
identificato con la rhus cothinus
della famiglia delle Coccigee,
potevano tingere di porpora i
tessuti senza dover acquistare il
costoso murice.
Le
caratteristiche stesse del famoso
marmo locale, materia prima dei
sarcofagi funerari dei maggiori
esponenti dell'aristocrazia locale
greca e poi romana, sarebbero
derivate, secondo Filostrato
(prima metà del III secolo d.C),
dallo scorrere delle correnti
calde.
Il
loro ristagnare ne avrebbe
prodotto una varietà giallognola,
le correnti più limpide creavano
una pietra trasparente come il
cristallo, le qualità variegate
nascevano dalle diverse condizioni
di sedimentazione. Purtroppo le
nostre testimonianze si riducono
alle decorazioni e agli elementi
architettonici degli edifici della
città, tuttavia le ricerche hanno
permesso di identificare la
"pietra di Hierapolis"
con un onice o un alabastro più o
meno trasparente, ma non colorato.