La
più celebre struttura architettonica dell'India e probabilmente una
delle più belle al mondo. Nessuna riproduzione rende la magia e le
perfette proporzioni di questo luogo, che Tagore definì "Una
lacrima sul volto del Tempo".
Fu voluto da Shah Jahàn, imperatore
dal 1628 al 1658, che apparteneva alla stirpe islamica dei Moghul;
questa dinastia discendeva dalle tribù mongole che nei secoli
precedenti, capeggiate da Attila e Gengis Khan, avevano seminato il
terrore in Asia e in Europa. Nel 1526 il loro condottiero Baber calò
in India dalle pianure dell'Asia centrale dopo avere fallito
nell'intento di conquistare Samarcanda, scalzò la dinastia musulmana
che da più di trecento anni vi dominava e fondò il suo impero.
Stabilì la sua capitale ad Agra, situata a 206 chilometri a sud di
Delhi, non distante dal deserto del Rajasthan. In quella città, che
era appena stata strappata da suo figlio Humayun al clan guerriero
indiano dei Rajputi, Baber iniziò subito i lavori per realizzare un
parco che chiamò Rambagh (il giardino della bellezza), facendo
scavare un pozzo e deviare le acque del fiume Jumna per alimentare
canali, terme e fontane. Con i suoi giochi d'acqua, i sentieri
simmetrici e le distese di fiori, il Rambagh divenne allora il modello
di tutti i giardini moghul, compreso quello del Taj Mahal. Tutti gli
imperatori che succedettero a Baber proseguirono la sua opera, dedicando
sforzi e mezzi economici ingenti alla costruzione della città
imperiale. Non fu però soltanto il rispetto della tradizione a far nascere il Taj
Mahal,
un'opera alla cui origine sta il grande amore di un uomo per la sua
donna.

Il
Taj Mahal, La Corona del Palazzo, è una tomba, un mausoleo
costruito da Shah Jahan, quinto imperatore Moghul (dal 1628 al 1658) per
la moglie Mumtaz Mahal, la Preferita del Palazzo, seconda e favorita
sposa del sovrano. Mumtaz Mahal, il cui vero nome era Arjuman Banu
Begum, era una principessa persiana, che influenzò grandemente la
vita e la visione politica di Shah Jahan. Morì a trentanove anni
dando alla luce il 13 figlio nel 1631, lasciando il sovrano in un
profondissimo lutto che gli incanutì i capelli tutti in una
volta, e che estese per decreto al regno. Alla moglie agonizzante
- che soleva accompagnarlo in ogni circostanza, comprese le
campagne militari, rivelando una relazione strettissima di amicizia,
fiducia e complicità tra i due sposi - il sovrano promette di
non sposarsi mai più e di edificarle un mausoleo funebre che sarà la
testimonianza perenne del loro profondo e unico amore. 
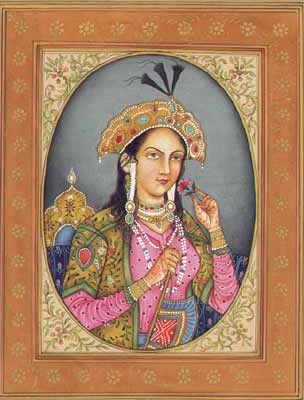 Sei mesi dopo la morte della regina, avvenuta a Burhanpur, il
suo corpo venne trasportato ad Agra e nel 1631 fu riposto
provvisoriamente in una cripta vicino al luogo destinato alla tomba
definitiva che, nelle intenzioni di Shah Jahan, doveva essere il più
straordinario monumento mai costruito per una donna.
Sei mesi dopo la morte della regina, avvenuta a Burhanpur, il
suo corpo venne trasportato ad Agra e nel 1631 fu riposto
provvisoriamente in una cripta vicino al luogo destinato alla tomba
definitiva che, nelle intenzioni di Shah Jahan, doveva essere il più
straordinario monumento mai costruito per una donna.
Il
risultato sarà un'opera eccezionale: dodicimila tonnellate di pietre
e marmi trasportati da grandi distanze; un edificio la cui
circonferenza supera la Basilica di San Pietro e la Piazza del Bernini
messe assieme; la perfezione delle forme raggiunta grazie a complessi
calcoli matematici; la profusione di pietre rare incastonate nei muri;
le pregevoli decorazioni affidate al più grande calligrafo persiano
dell'epoca, Amanat Khan.
La notizia che l'imperatore stava cercando qualcuno cui
affidare il grandioso progetto fece accorrere ad Agra schiere di
architetti e artigiani provenienti dall'India meridionale, dalla
Birmania, da Ceylon, dalla Transcaucasia e dalla Persia. Nessun
documento dell'epoca indica il nome del progettista del Taj Mahal, ma
la tradizione vuole che a realizzarlo sia stato l'architetto Ustad
'Isa. Si racconta che, alla conclusione dei lavori, Shah Jahan abbia
fatto tagliare le mani ai capomastri, accecare i calligrafi e
decapitare l'architetto, affinché nessuno di loro potesse più
realizzare un altro edificio simile.
Ricordato di volta in volta con
nomi diversi (Ustad Khan Effendi, 'Isa Mohammed Effendi, Ustad
Mohammed, 'Isa Affendi, 'Isa Khan), indicato come proveniente dai
luoghi più disparati (da Costantinopoli, da Shiraz o Isfahan in
Persia, da Samarcanda, da Kandahar in Afghanistan, o anche da Delhi o
Agra) e appartenente a svariate etnie (arabo, cristiano, russo,
indiano o ebreo), Ustad 'Isa è forse un personaggio nato per
soddisfare la curiosità dei turisti inglesi che nell'Ottocento
andavano in visita ad Agra.
Altrettanto prive di fondamento sono le ipotesi secondo cui
quel monumento, in perfetto stile indo-persiano, sarebbe stato
disegnato da un europeo (sono stati fatti i nomi dell'orafo veneziano
Gerolamo Veroneo e dell'argentiere francese Austin de Bordeaux). Oltre
alle considerazioni stilistiche e all'inattendibilità delle fonti su
cui queste ipotesi poggiano, è inaccettabile l'idea che un architetto
cristiano possa aver ricevuto l'incarico di costruire un edificio il
cui ingresso, fino all'occupazione inglese, era proibito ai non
musulmani, i quali, se contravvenivano al divieto, venivano condannati
a morte. Del resto l'ispiratrice del mausoleo Mumtaz Mahal, come
testimonia l'iscrizione che orna il suo sarcofago - "Proteggici,
o Signore, dalla genìa dei miscredenti" - era stata un'acerrima
nemica del cristianesimo e aveva spinto Shah Jahàn a sterminare i
portoghesi che si erano stanziati a Hooghly (sul luogo dell'odierna
Calcutta).
Secondo
alcuni studiosi, l'ideatore più probabile del Tàj Mahal è il
persiano Ustad Ahmad Lahori, che già in precedenza, nel suo duplice
ruolo di ingegnere e di astrologo, aveva ricevuto da Shah Jahan
l'incarico di disegnare alcune delle sue opere più ambiziose. Secondo
altri, il mausoleo non fu progettato da un solo uomo, ma da un gruppo
di esperti coordinati personalmente dall'imperatore. L'impianto
dell'edificio, peraltro, non è una novità assoluta, ma richiama con
le sue cupole e i suoi minareti molte costruzioni indiane, quali il
Forte Rosso di Agra, ampliato e rimaneggiato per volontà dello stesso
Shah Jahan, e ancor più il sepolcro del secondo imperatore moghul
Humayun, costruito a Delhi più di un secolo prima. Come quella dei
suoi illustri precedenti, l'architettura del Taj Mahal costituisce una
sintesi armoniosa tra la ricca tradizione costruttiva islamica
persiana e quella della decorazione indiana.
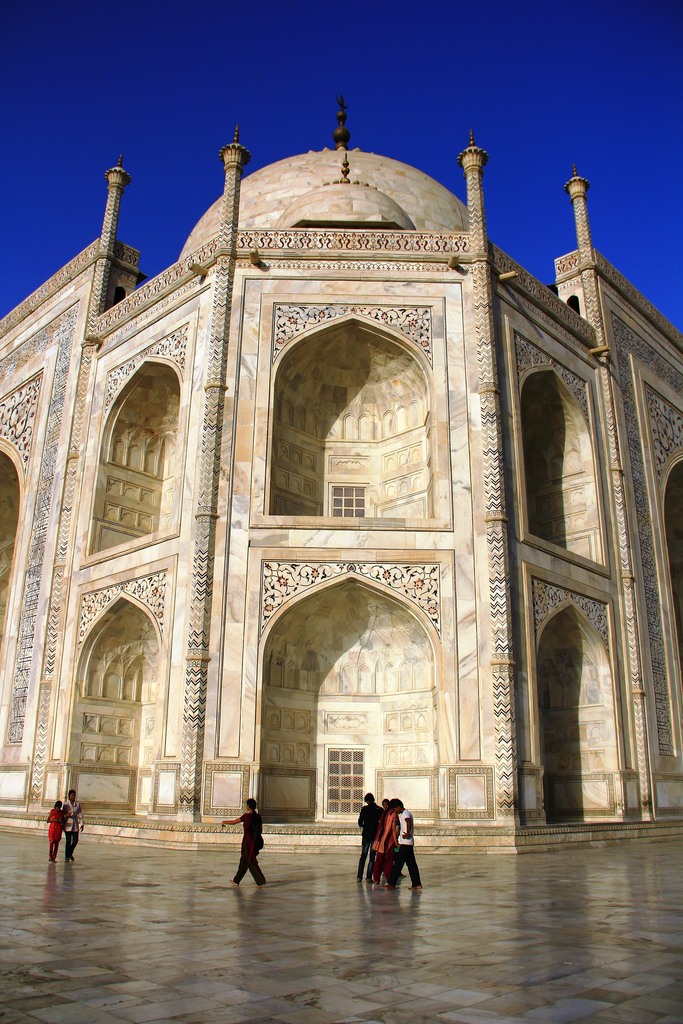

Molto prima dell'avvento di Shah Jahan, infatti, gli
scalpellini indiani erano famosi in tutto l'Oriente per la loro non
comune abilità nel lavorare la pietra; quando nel XIV secolo
Tamerlano aveva voluto abbellire la sua capitale, Samarcanda, vi aveva
chiamato dall'India i migliori artigiani del marmo, che divennero
l'orgoglio delle sue botteghe e, alla sua morte, innalzarono per lui
il mausoleo del Gure AmTr, indicato anch'esso come uno dei modelli ai
quali il Tàj Mahal potrebbe essersi ispirato.
 Nonostante la
comprovata perizia delle maestranze locali, per il suo progetto
ambizioso l'imperatore fece giungere ad Agra artigiani provenienti da
tutta l'Asia: dalla Turchia, Ismail Afandi, che realizzò l'enorme
cupola del mausoleo; da Lahore, nell'attuale Pakistan, l'esperto
gioielliere Qazim Khan, che ebbe l'incarico di fondere e modellare
l'oro del pinnacolo della cupola; da Delhi, infine, abilissimi
mosaicisti guidati da Chiranji Lai.
Nonostante la
comprovata perizia delle maestranze locali, per il suo progetto
ambizioso l'imperatore fece giungere ad Agra artigiani provenienti da
tutta l'Asia: dalla Turchia, Ismail Afandi, che realizzò l'enorme
cupola del mausoleo; da Lahore, nell'attuale Pakistan, l'esperto
gioielliere Qazim Khan, che ebbe l'incarico di fondere e modellare
l'oro del pinnacolo della cupola; da Delhi, infine, abilissimi
mosaicisti guidati da Chiranji Lai.
Ma gli artisti giunti dalla Persia, e in particolare da Bagdad e da
Shiraz, i più numerosi e
considerati superiori per cultura e conoscenze tecniche, furono
determinanti nel dare al Tàj Mahal il suo singolare carattere misto,
indiano e persiano. In particolare, da Shiraz fu chiamato Amanat Khan,
il celebre maestro di calligrafia che decorò la facciata e la cripta
del mausoleo con iscrizioni in caratteri arabi.
Le iscrizioni che costellavano nicchie, archi, cupole,
portali e minareti rappresentavano da un millennio un motivo tipico
dell'arte musulmana (nella quale era proscritta la rappresentazione
della figura umana), che impiegava i segni eleganti della scrittura
per definire lo spazio architettonico e, soprattutto, per offrire agli
occhi dei fedeli brani dei testi sacri islamici. L'importanza
attribuita all'attività dei calligrafi è testimoniata al Taj Mahal
dagli ingenti compensi pagati a Amanat Khan, la cui firma fu l'unica
considerata degna di comparire sulle mura del mausoleo ed è tuttora
visibile all'interno, alla base della cupola, circondata da versetti
del Corano.

I lavori, iniziati nel 1631, proseguirono ininterrottamente
per diciassette anni e richiesero il lavoro di 20.000 operai. Per
accoglierli sorse nello spazio di fronte al cantiere una piccola città,
che assunse il nome di Mumtàzabad in onore della regina morta. Questa
città crebbe con una prosperità tale da divenire più importante
della stessa Agra, e sembra persino che Shah Jahan abbia pensato di
trasferirvi la sua residenza ufficiale. A Mumtàzabad giungevano le
carovane che portavano i materiali da costruzione: il tufo rosso
estratto nelle vicine cave della regione; il marmo bianco, trasportato
su carri trainati da buoi, bufali, elefanti e cammelli dal Makran, a
più di trecento chilometri di distanza; e le pietre rare provenienti
da regioni ancora più lontane, come giada e cristallo dalla Cina,
turchese dal Tibet, lapislazzuli dall'Afghanistan, crisolito
dall'Egitto, conchiglie, corallo e madreperla dall'oceano Indiano.
Nel
XVIII secolo, con l'avvento degli europei e il crollo dell' impero
Moghul, il complesso cadde nell'abbandono e fu oggetto di scempio,
fino allo scellerato progetto di Lord William Bentink, Governatore
generale del Bengala, che ne cominciò lo smantellamento e la
vendita del marmo in Europa. Fortunatamente, a causa dello scarso
riscontro economico ottenuto, la distruzione si interruppe. Ma in
4 secoli di esistenza il Taj ha attraversato tutte le tensioni e le
contraddizioni della storia indiana, fino al 1965, quando durante la
guerra Indo-pakistana fu tenuto lungamente incappucciato con
un'immensa rete nera per nasconderlo ai raid aerei e sottrarlo ai
bombardamenti. Le ultime aggressioni sono quelle dell'inquinamento e
del turismo: per salvare i suoi marmi candidi dalla corrosione
dell'anidride solforosa il governo ha dovuto chiudere 250 piccole
fabbriche locali, costringendo 100mila operai alla disoccupazione.
Persino il fiato dei turisti è una minaccia: 3 milioni di visitatori
all'anno provocano un'umidità pericolosa per la conservazione dei
dipinti all'interno del mausoleo.

Il
complesso architettonico del Taj Mahal copre approssimativamente
un'area di 580 x 300 metri quadrati
e si compone di cinque elementi principali: il darwaza
(portone), il bageecha (giardino) che è la tipica forma di charbagh
(giardino diviso in quattro parti) mughal, il masjid (moschea),
il mihman khana (casa degli ospiti) ed infine il mausoleum
ovvero la tomba di Taj Mahal.
Il complesso tombale venne realizzato
in modo tale da essere accessibile sia dal nord che dal sud,
rispettivamente dal fiume Yamuna oppure dalla terraferma. All'interno del giardino,
si trovano aiuole di fiori, canali
d'acqua che riflettono l'immagine del Taj e viali alberati.
Il
Taj Mahal fu costruito all'interno di un grande giardino che misura 300 x
300 metri quadrati, interamente
circondato da un muro di pianta quadrata. Sui lati della strada che conduce al cancello
esterno, collocato al centro della cinta orientale, vi sono due
edifici ottagonali: a sinistra quello definito "tomba delle dame
di compagnia" perché ospita al suo interno due sarcofaghi, a
destra una piccola moschea di tufo rosso, diventata un'officina di
marmisti durante il periodo dell'occupazione inglese e perciò detta
"dei tagliatori di pietra".
All'entrata un lungo corridoio pieno di botteghe conduce a
un cortile su cui sorge il portale interno, ingresso vero e proprio
del Taj Mahal. Il portale è un edificio a tre piani rivestito di
arenaria rossa, con un'arcata colossale al centro; l'ingresso si apre
sulla sua facciata sud, decorata con versetti del Corano abilmente
realizzati con lettere di marmo nero di dimensioni crescenti verso
l'alto per sembrare, a chi guarda dal basso, tutte della stessa
misura. La presenza di una serie di barriere che compongono un
edificio separato dalla costruzione principale è caratteristica
dell'architettura musulmana, e svolgeva la doppia funzione di
proteggere le ricchezze custodite all'interno e di separare lo spazio
sacro da quello profano. Purtroppo non è più possibile ammirare i
portali d'argento che qui si trovavano in origine, smontati e fusi durante la ribellione della fazione indù degli
Jati,
avvenuta nel 1764.

Si accede così ai giardini, concepiti con un
sorvegliatissimo criterio geometrico. Il loro tappeto verde, che si
estende dal portale fino alla base dell'edificio principale, è
infatti diviso in quattro riquadri regolari da canali di marmo che
confluiscono nella grande fontana centrale, nelle cui acque si
riflette la cupola del mausoleo. Il parco fu chiaramente ideato sul
modello del giardino persiano, che prevedeva l'inserimento degli
elementi naturali in una struttura artificiale creata dall'uomo. Il
giardino del Taj - assai lontano da quello giapponese, volto a imitare
e ad accentuare la natura - somiglia meno al giardino orientale che al
parco di Versailles, dal quale peraltro si differenzia nettamente per
la funzione cui adempie, quella di introdurre spiritualmente
all'edificio sacro. Dopo l'abbandono dell'intero complesso seguito
alla morte dei diretti discendenti di Shàh Jahan, e il decadimento e
la predazione di cui fu oggetto per due secoli, il parco fu
restaurato. Degli animali, dei boschetti, delle aiuole, dei frutteti
che lo allietarono un tempo nulla è rimasto, a eccezione, forse, di
un vecchio albero di simal vicino al mausoleo.

Grazie alla studiatissima inquadratura del giardino e alla
collocazione su una grande terrazza all'estremità settentrionale del
recinto, il mausoleo sembra lontanissimo e piccolissimo se visto dal
portale, mentre, per l'illusione ottica contraria, si ingrandisce a
dismisura se ci si avvicina. L'edificio poggia su una piattaforma
rettangolare di arenaria rossa, alta sette metri, delimitata ai
quattro angoli da minareti di quarantadue metri d'altezza, privi di
funzioni pratiche ma costruiti per conferire slancio verticale
all'insieme.










È fiancheggiato da due moschee gemelle di marmo e
arenaria rossa: quella a occidente, con tre cupole e i pennacchi
contornati di arabeschi di pietra dura, ha il soffitto interno coperto
da affreschi; quella a oriente, nota con il nome di jawab, "la
risposta", poiché perfettamente simmetrica all'altra, non fu mai
usata per il culto e svolgeva probabilmente una pura funzione
estetica.
Il mausoleo vero e proprio è il grande edificio centrale,
con pianta a base quadrata smussata agli angoli. È dominato dalla
maestosa cupola centrale, dal diametro di venti metri e la
caratteristica forma orientale a bulbo, che ritorna nelle quattro
cupolette minori. La sua struttura in mattoni è interamente rivestita
all'esterno da lastre di marmo bianco che producono un effetto di
straordinaria luminosità.
Quarantatré tipi di pietre dure e preziose
compongono raffinati motivi vegetali a intarsio, i cui giochi di
colore sono valorizzati dai riflessi delle fontane del giardino e
dalle variazioni di luce nelle diverse ore del giorno e condizioni meteorologiche. Su ognuno dei quattro lati dell'edificio si apre un
alto arco acuto che conduce a una stanza ottagonale, da cui si accede
alla camera funeraria collocata al centro.

L'INFLUENZA PERSIANA - La tomba della regina Mumtaz Mahal è situata su un
terrazzo sopraelevato ed è circondata da quattro minareti, uno per
ogni angolo del terrazzo stesso. Si crede che i minareti siano
leggermente inclinati verso l'esterno in modo da non crollare sulla
tomba, in caso di terremoto.
Come la maggior parte delle tombe
moghul, anche il Taj mostra segni evidenti dell'influenza persiana.
Visto dall'alto è un quadrato con gli angoli smussati composto,
all'interno, da numerose stanze. La stanza principale è circondata da
otto stanze minori ciascuna delle quali presenta delle aperture a
forma di arco.
L'edificio è coperto da cinque
cupole: la più grande, che ha una forma a bulbo, si trova sopra la
stanza principale, le altre coprono quattro delle stanze minori. Il
cenotafio si trova al livello dell'ingresso della stanza principale;
la tomba vera e propria invece è esattamente nel livello sottostante.
La pavimentazione della stanza
tombale è una scacchiera di marmo bianco e nero e molti lavori
artistici in pietra dura, tra cui figure geometriche, fiori e piante,
adornano la stanza.

AD OGNI ORA, UN ASPETTO DIVERSO - Diversi studiosi hanno cercato di capire cosa renda questo
monumento così unico e magnifico. Una ragione è attribuita alle sue
perfette proporzioni e alla geometria.
Una seconda è dovuta ai diversi modi
in cui il Taj si mostra ai suoi visitatori.
Rivestito di delicato marmo, infatti,
il Taj varia il proprio aspetto durante la giornata, a seconda del
cambiamento della luce del sole e dei diversi effetti ottici provocati
dalle ombre sul marmo. Il monumento è considerato particolarmente
bello visto di notte, alla luce della luna piena.
In origine il progetto comprendeva
anche la costruzione, dalla parte opposta del fiume, di un complesso
identico ma in marmo nero invece che bianco, che sarebbe dovuto essere
il mausoleo dell'imperatore. Aurangzeb, il figlio di Shah Jahan,
preoccupato per le ingenti somme di denaro che il padre aveva già
investito per il Taj Mahal, costrinse l'imperatore agli arresti e ne
prese il posto sul trono nel 1658.
Shah Jahan trascorse il resto della
sua vita nella fortezza di Agra, fissando dalla finestra la lontana
sagoma del Taj dove, alla sua morte, venne seppellito insieme alla
moglie.
Per questo motivo, nonostante ci
siano prove archeologiche che le costruzioni del secondo monumento
erano iniziate, il progetto originario non fu mai portato a termine.
MODERNA MERAVIGLIA - Alla fine del XIX secolo, complice il tempo e i ladri di
tombe, il Taj Mahal versava in un forte stato di abbandono. Quando,
nello stesso periodo l'inglese Lord Curzon venne nominato vicerè dell'India, fu avviato un progetto di restauro del monumento.
In questa occasione i tradizionali
giardini del Taj Mahal vennero sostituiti dai classici prati in stile
britannico che sono ancora oggi visibili.

IL SEPOLCRO DI MUMTAZ MAHAL
Alla fine del 1631, mentre iniziavano i lavori per la
costruzione del Tàj Mahal, il corpo di Mumtàz Mahal fu trasportato
da Burhanpur, dove la regina era morta, ad Agra, e posto in un
mausoleo provvisorio vicino al luogo destinato alla sepoltura
definitiva.
La tomba della regina fu, insieme alle due moschee che le
fanno da guardia, il primo edificio del complesso a essere costruito.
Probabilmente la tomba sorse in dieci anni, mentre ne dovettero
passare altri dodici prima che l'intero complesso fosse terminato.
Quando la tomba venne completata, l'imperatore depose sul feretro
della moglie i diamanti più preziosi del suo tesoro e fece stendere
sul sarcofago un manto di perle.
Il sepolcro fu circondato da una
balaustra d'oro e i pavimenti dell'intera stanza, oggi nudi e
consumati dal passaggio dei visitatori, vennero ricoperti da
pregiatissimi tappeti persiani e moghul, sostituiti quasi ogni giorno.
Centinaia di candelieri d'argento e di lampade d'oro vennero appesi
alle pareti e la porta d'ingresso fu dotata di un cancello d'argento
massiccio.
Di tutti questi tesori, trafugati durante i saccheggi che
accompagnarono il tramonto dell'era moghul, rimane ora assai poco.
Nell'enorme vano ottagonale della camera funeraria, in cui la luce
filtra da finestre munite di transenne di marmo traforate, campeggia
il sarcofago della regina e accanto, in posizione asimmetrica, quello
di Shah Jahàn, qui collocato alla sua morte nel 1666.
Entrambe le
tombe, oggi vuote poiché i corpi dei sovrani sono stati spostati
nella cripta sottostante, sono circondate da una transenna ottagonale
di marmo scolpita in una delicatissima filigrana. I mosaici di pietre
rare che ricoprono i due sepolcri sono considerati tra i più belli
del mondo: al centro di quello sul sarcofago di Mumtaz è
rappresentata una penna, mentre sulla tomba dell'imperatore compare un
calamaio, simboli della complementarietà delle loro anime.
La vivacità
dei colori dei sepolcri contrasta con la sobrietà dei disegni
calligrafici delle pareti superiori. Il motivo floreale della
transenna si ritrova invece in bassorilievo sulle pareti inferiori
della sala centrale e delle quattro stanze ottagonali che la
circondano, destinate ad accogliere i parenti di Shah Jahan, ma mai
utilizzate. Per la loro acustica, rivelatasi perfetta, questi ambienti
ospitano talvolta concerti di musica sacra. Sotto la cupola, in
particolare, il rumore più debole si amplifica e si riproduce in modo
sorprendente.
