|
Il parco
nazionale del Pollino,
situato tra Basilicata e Calabria tra
le province di Cosenza, Potenza e Matera,
con i suoi 192.562 ettari,
di cui 88.650 nel versante lucano e 103.915 in quello
calabro, è il parco
nazionale più grande
d'Italia;
prende il nome dall'omonimo massiccio
montuoso.
Si
estende tra il sud della Basilicata e il nord della Calabria e in esso è
inserito il gruppo montuoso del Pollino, il più elevato dell’Appennino
Meridionale. Il versante lucano del Parco è suddiviso in quattro vallate
principali: la Valle del Mercure, la Valle del Frido, la Valle del Sarmento e la
Valle del Sinni. Appartengono al territorio calabrese la Valle del Raganello e
la Valle del Coscile. Il Parco offre una moltitudine di paesaggi incantevoli,
con grandi aree incontaminate e differenti a seconda dell’altitudine.
Il
Parco è consigliato a chi ama il trekking e l’escursionismo, a chi ama il
contatto diretto con la natura più incontaminata e selvaggia, a chi ama
l’alpinismo e il rafting, agli amanti del torrentismo più estremo e a tutti
coloro che hanno voglia di scoprire un territorio solitario e silenzioso rotto
solo dal vento che si infrange tra le foglie degli alberi, o gustare sapori e
sensazioni ormai dimenticate.
Dal
novembre 2015, con l'inserimento nella lista
globale dei geoparchi da
parte dell'UNESCO,
il parco del Pollino è considerato sito
patrimonio mondiale.
Il
parco nazionale del Pollino è stato istituito nel 1988,
mentre la perimetrazione provvisoria è del 1990,
così come le misure di salvaguardia.
Tra
gli anni 1993 e 1994 s'insediano gli organismi amministrativi e tecnici:
presidenza, consiglio di amministrazione e direzione; la sede dell'ente di
gestione è ubicata in Rotonda (PZ).
Il
parco si estende su 56 comuni (di cui 24 in Basilicata e 32 in Calabria), 9 comunità
montane e 4 riserve
orientate: Rubbio in Basilicata, Raganello,
Lao e Argentino in Calabria.
Le
sue vette, tra le più alte del sud d'Italia, sono coperte di neve per molti
mesi dell'anno. Dalle cime, ad occhio nudo, si osservano le coste tirreniche e
il litorale ionico.
L'emblema
del parco è il pino
loricato; tale specie è
presente anche in numerose altre stazioni fitoclimatiche delle
montagne balcaniiche e greche.

Il
territorio del Parco comprende in tutto 56 comuni, 24 in Basilicata (22 nella provincia
di Potenza e 2 nella provincia
di Matera), e 32 in Calabria
(provincia di Cosenza).
I
comuni in territorio lucano sono: Calvera, Castelluccio
Inferiore, Castelluccio
Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo
di Sant'Andrea, Carbone, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla
in Sinni, Latronico, Lauria, Noepoli, Rotonda, San
Costantino Albanese, San Giorgio
Lucano (Mt), San
Paolo Albanese, San
Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova
di Pollino, Valsinni (Mt), Viggianello.
I
comuni in territorio calabro sono: Acquaformosa, Aieta, Alessandria
del Carretto, Belvedere
Marittimo, Buonvicino, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla
Marittima, Frascineto, Grisolia, Laino
Borgo, Laino
Castello, Lungro, Maierà, Morano
Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Papasidero, Plataci, Praia
a Mare, San
Basile, San
Donato di Ninea, Sangineto, San
Lorenzo Bellizzi, San
Sosti, Sant'Agata
di Esaro, Santa
Domenica Talao, Saracena, Tortora, Verbicaro.
Fra
questi alcuni sono di interesse storico-archeologico: Castelluccio
Inferiore, Viggianello e Rotonda nel
versante lucano, e Castrovillari, Civita, Morano
Calabro, Laino
Borgo, Mormanno,
e Papasidero nel
versante calabrese.
Altri
comuni, importanti dal punto di vista socio-culturale, sono le comunità
albanesi che si
insediarono nel territorio tra il 1470 e
il 1540.
Nel versante lucano si trovano San
Paolo Albanese e San
Costantino Albanese, mentre nel versante calabrese si trovano San
Basile, Lungro, Plataci, Frascineto e Civita.
Il
paese più alto del parco è Alessandria
del Carretto con i suoi 999 metri s.l.m.,
paese che ancora oggi conserva antiche tradizioni culturali e musicali.
Tra
gli edifici religiosi degni di nota si annoverano, in territorio calabro, il
complesso monastico della Madonna delle Armi a Cerchiara e
ruderi di conventi, come quello del Colloreto a Morano
Calabro, mentre in Basilicata,
nel comune di San
Severino Lucano, a 1537
metri di quota è situato il santuario della Madonna
del Pollino, meta di un
culto religioso profondamente radicato nella gente del luogo.
All'interno
della valle del
Mercure, in territorio di
Rotonda, sono stati ritrovati interessanti reperti paleontologici: Elephas
antiquus, Hippopotamus
major.

Geologia
Il
confine calabro-lucano riveste un particolare interesse nella geologia
dell'Italia meridionale,
rappresentando la complessa fascia di raccordo tra i domini strutturali
dell'Appennino Calcareo auct. e le coltri cristallino-metamorfico-sedimentarie
dell'Arco
Calabro-Peloritano.
"Pollino
Geopark" - Il
17 novembre 2015, i 195 Stati membri dell'UNESCO,
nell’ambito della 38ª sessione plenaria della conferenza generale
dell'UNESCO, hanno riconosciuto la Rete
dei Geoparchi Mondiale quale
Progetto prioritario dell’UNESCO. Tutti i 120 membri della Rete Globale dei
Geoparchi hanno quindi ottenuto il riconoscimento di "Unesco Global
Geopark". Tra questi è presente il Pollino Geopark e da
ciò ne consegue che tutto il territorio del parco nazionale del Pollino è
entrato a far parte del Patrimonio dell’UNESCO.
Il
"Pollino Geopark" racchiude 69 geositi ricadenti
all’interno del proprio territorio, comprendendo circhi
glaciali, depositi
morenici (risalenti
all'ultima glaciazione
wurmiana),nevai, fossili di
Rudiste, particolari formazioni rocciose (come la successione
ofiolitica di Timpa
delle Murge e Timpa di Pietrasasso, ma anche le lave
a cuscino del Monte
Cerviero) grotte preistoriche (Grotta
del Romito), gole scavate
nella roccia calcarea (Raganello,
Lao, Rosa e Garavina), pianori carsici, doline,
profondi inghiottitoi (Abisso
del Bifurto), timpe e vette
che superano i 2000 metri di quota.
Oltre
ai siti di interesse geologico il Pollino Geopark comprende
anche numerosi siti di interesse non geologico, che mirano, insieme ai geositi,
a valorizzare l'intero territorio del parco nazionale del Pollino, dal punto di
vista geoturistico, naturalistico, culturale, storico e archeologico, in modo da
far conoscere e apprezzare tanta bellezza.
Glacialismo
- L'attuale
profilo delle vette più elevate risulta fortemente modellato dall'azione di
antichi ghiacciai,
le cui tracce più evidenti si rinvengono sul versante nord-occidentale di Serra
Dolcedorme con la conca denominata Fossa del Lupo, antica zona di
accumulo delle masse ghiacciate che alimentavano l'imponente ghiacciaio
del Frido; sul versante nord-orientale del Monte Pollino con i due circhi
glaciali separati dal
contrafforte nord-est della stessa montagna; e sul versante settentrionale di
Serra del Prete con il bello e vasto circo glaciale alla cui base sporge
l'accumulo frontale di detrito morenico ricoperto
da una fitta e vasta faggeta.
I
ghiacciai in ritiro, oltre ai depositi morenici, hanno abbandonato massi di
notevoli dimensioni, i cosiddetti massi
erratici. Caratteristici
perché isolati e lontani da probabili punti di caduta, sono facilmente
osservabili sui piani di Pollino e Acquafredda, a
un'altitudine compresa tra i 1.800 e i 2.000 metri di quota.
 Il
nevaio del Pollino - Nevai stagionali,
alcuni dei quali di notevoli dimensioni, sono presenti su tutte le vette più
alte del massiccio. Sul Monte Pollino, in particolare, nell'avvallamento
immediatamente a sud rispetto alla cima (nei pressi di un'antica dolina),
a quota 2.225 m slm, ne sorge uno che
è facile scorgere anche a fine agosto. Il 9 ottobre 2010 presso il suddetto
nevaio è stato installato un rilevatore di temperatura per un monitoraggio
diretto del microclima locale. Il
nevaio del Pollino - Nevai stagionali,
alcuni dei quali di notevoli dimensioni, sono presenti su tutte le vette più
alte del massiccio. Sul Monte Pollino, in particolare, nell'avvallamento
immediatamente a sud rispetto alla cima (nei pressi di un'antica dolina),
a quota 2.225 m slm, ne sorge uno che
è facile scorgere anche a fine agosto. Il 9 ottobre 2010 presso il suddetto
nevaio è stato installato un rilevatore di temperatura per un monitoraggio
diretto del microclima locale.
Riserve
naturali orientate
Valle
del Fiume Lao (5.200 ha)
- Comune di Papasidero (CS)
Gole
del Raganello (1.600 ha)
- Comune di San
Lorenzo Bellizzi (CS)
Valle
del Fiume Argentino (3.980 ha)
- Comune di Orsomanno (CS)
Rubbio
(211 ha)
- Comune di Francavilla
in Sinni (PZ)
Flora
- Tra
tante altre specie arboree presenti nel parco vi sono l'abete
bianco, il faggio,
tutti e sette i tipi di aceri di cui l'acero
di Lobelius, il pino
nero, il tasso diverse
specie di querce, castagni, ed alle quote più elevate e sui pendii più ripidi
è presente il pino
loricato, specie rarissima,
che si adatta agli habitat più
ostili, dove altre specie molto rustiche (il faggio in primis) non sono
in grado di sopravvivere.
Fioriture
di Orchidee si
osservano soprattutto in primavera, insieme a quelle di viole, genziane,
campanule e, in estate, il raro giglio
rosso, oltre a molte specie
di piante officinali
ed aromatiche, tra le quali
la fanno da padrona le Labiatae,
con molteplici specie di menta ed
inoltre tutte le varietà di timo, santoreggia, lavanda, issopo,
le cui fioriture avvengono al culmine dell'estate.
Non
da meno sono da considerare le varie famiglie di frutti di bosco e di specie
arboree selvatiche che producono frutti e bacche come
le mele selvatiche,
i vari Prunus,
le fragoline di bosco e
i lamponi di
cui sono disseminati i sentieri e le frequenti radure, laddove le condizioni
climatiche e di soleggiamento ne consentono la fruttificazione.
Riconoscimento UNESCO della
faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, la faggeta vetusta più a Sud d'Europa.
Vi vive un antico albero, un pino
loricato, la cui età è
stata stimata al radiocarbonio in 1.230 anni da ricercatori dell’università
della Tuscia, i quali l'hanno chiamato Italus,
dal mitico eroe eponimo dell'Italia.
Fauna
- Anche
la fauna è varia, e comprende specie ormai estinte in altre zone montuose. Fra
i mammiferi presenti nel parco si segnalano il lupo
appenninico, il gatto
selvatico, la volpe,
il cinghiale,
il capriolo autoctono
di Orsomarso, la lontra,
il tasso (Meles meles),
lo scoiattolo nero
meridionale, il driomio.
L'avifauna
comprende l'aquila reale,
l'avvoltoio capovaccaio, il falco
pellegrino, il biancone,
il falco lanario,
il nibbio reale,
il gufo reale,
il gufo comune, il gracchio
corallino, il corvo
imperiale, il picchio
nero e la rara coturnice.
Tra
i rettili presenti vi sono la biscia
dal collare e la vipera.
E ancora sono presenti l'ululone,
la salamandra pezzata,
la rosalia alpina,
ecc...
Di
recente reintroduzione il cervo (nel
2002-03) e l'avvoltoio
grifone (nel 2002).

Questi
tipici paesi sono abitati da contadini, pastori, artigiani e da minoranze
etniche quali gli albanesi che hanno custodito gelosamente le loro tradizioni,
la loro lingua e i loro costumi. Più in alto spettacolari vallate di alta
quota, immense foresti verdeggianti di faggio, di castagno, di cerro coperti di
muschio, di funghi, di erbe aromatiche e popolate dal lupo appenninico, dal
capriolo, dall’aquila reale, dal gufo nero, dal corvo imperiale.
Ancora
più in alto nelle solitarie vette maestose trovano rifugio, oltre che nei
Balcani, magnifici esemplari di Pino Loricato. Albero imponente ed elegante, di
straordinaria bellezza, propaggine dell’ultima glaciazione deve il suo nome
alla struttura della corteccia che ricorda vagamente le loriche, piastre
metalliche delle antiche corazze romane.
Dai
profili contorti, a causa del peso della neve e dei forti venti a cui è
sottoposto, il Pino Loricato simbolo del Parco, può essere considerato per la
sua rarità quasi un “monumento”, anche dopo la morte il suo tronco perdendo
la corteccia resta lì in piedi per anni a guardia del territorio circostante.
Visitare
il Parco del Pollino
Il Parco
del Pollino è un luogo dove arte, tradizioni e natura si sposano alla
perfezione andando a esaltare le bellezze di un territorio davvero unico. Il
parco del Pollino si trova a cavallo tra Basilicata e Calabria e
spazia dal mar Tirreno allo Jonio in un susseguirsi di bellissimi
paesaggi tra montagne che superano i duemila metri, boschi incontaminati, gole
profonde e alti pascoli. Il Pollino è però anche un luogo ricco di storia
e di autentici gioielli architettonici con i suoi tanti borghi e paesi che
conservano ancora vive le tracce di un passato in cui il rapporto con
l’ambiente circostante è sempre stato al centro della vita
quotidiana.
Il
parco del Pollino è oggi una meta ancora fuori dal circuito del grande
turismo di massa, ma comunque molto ricercata da chiunque voglia godersi una
vacanza diversa: all’insegna della vita all’aria aperta, senza dubbio, ma
anche in grado di regalare forti emozioni alla scoperta di luoghi ancora integri
dove il tempo sembra essersi fermato. Ecco dieci tappe da non perdere nel vostro
viaggio nel parco del Pollino.
Quasi
200mila ettari di natura incontaminata a cavallo di due regioni e compresi tra
due mari. Questo e molto altro ancora è il Parco
Nazionale del Pollino, oggi considerato l’area protetta più estesa
d’Italia. L’intera zona del Pollino è formata dai Massicci del Pollino e
dell’Orsomarso, la catena montuosa che fa parte dell’Appennino meridionale a
confine con la Basilicata e la Calabria e vanta le vette più alte del Sud
Italia continentale.
Il
parco nazionale del Pollino è però anche una terra d’acqua visto che sono
numerosi i fiumi che lo attraversano e che con la loro azione incessante ne
hanno profondamente segnato il paesaggio andando a disegnare gole profonde e
ampie vallate che non solo offrono ai visitatori un panorama mozzafiato, ma sono
diventate degli importanti centri per attività sportive come il rafting.
Un’eccellenza del parco nazionale del Pollina è poi quella delle sue erbe
officinali che, in mezzo alla natura rigogliosa di queste zone e grazie a un
sistema ecologico ancora invariato, qui possono crescere in modo prospero.

GROTTA DELLE
NINFEE - A Cerchiara,
paese in provincia di Cosenza affacciato sulla piana di Sibari si trova uno
spettacolo della natura conosciuto e apprezzato fin dall’antichità: la grotta
delle Ninfe.
Secondo la
leggenda in questo luogo mistico si trovava addirittura il talamo di Calipso, la
nereide figlia di Atlante che si innamorò di Ulisse.
Vedendo lo
spettacolo della grotta delle Ninfe, d’altro canto, non è difficile capire il
perché si tratti di un luogo da sempre al centro di miti e leggende, si tratta
di una sorta di canyon strettissimo che taglia in due un grande sperone roccioso
all’interno del quale i raggi del sole fanno fatica a filtrare.
Qui scorre un
ruscello che va a creare al centro della grotta una piscina di acqua calda dove
si formano fanghi dalle importanti proprietà terapeutiche. Immergersi nelle
acque della grotta delle Ninfe, circondati dalle alte pareti calcaree, è
un’esperienza davvero unica, oltre che estremamente rilassante, ma non sempre
possibile per motivi di sicurezza. Nel paese di Cerchiara si trova comunque una
grande piscina, questa a pagamento a differenza della grotta a cui vi si può
accedere gratuitamente.

SAN SEVERINO
LUCANO - San Severino
Lucano, in provincia di Potenza, rappresenta la porta d’accesso settentrionale
al massiccio del Pollino, ma è soprattutto un pittoresco borgo che si trova a
metà tra il Tirreno e lo Jonio.
San Severino
Lucano è un paese di acqua, di montagne che superano i duemila metri e di una
natura ancora incontaminata che lo abbraccia rigogliosa.
Una visita a
San Severino sarà dunque dedicata principalmente alle escursioni e alla
scoperta di un territorio dall’incredibile bellezza e che è possibile
ammirare da una posizione privilegiata dallo splendido santuario della Madonna
del Pollino, una struttura religiosa settecentesca appollaiata come un nido
d’aquila a 1527 metri d’altezza e da cui si gode di una vista straordinaria
sulla Serra del Prete, la Serra di Viggianello, il colle dell’Impiso e quello
del Grattacielo.
Le escursioni
da fare, a piedi, in bici o a cavallo, poi certo non mancano attorno a San
Severino Lucano, da non perdere in questo caso sono i tanti sentieri che
conducono verso nord nel bellissimo Bosco Magnano, ma anche alla scoperta della
selvaggia gola del Frido.

VIGGIANELLO
- A poco più di 500
metri sul livello del mare, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino si trova
Viggianello, un antico avamposto romano nelle terre dei lucani che, secolo dopo
secolo, si è trasformato di pari passo con la terra che lo circonda.
Ancora oggi
Viggianello è un borgo dalla forte impronta bizantina e normanna. Bizantini
erano i monaci che disseminarono il territorio di celle monastiche con chiesa in
comune che sono ancora ben visibili ai piedi del centro storico, mentre normanna
è l’origine dell’insediamento attuale in collina.
Questa lunga e
ricca storia ha lasciato un’architettura molto ricca con chiese e palazzi
gentilizi che conservano al loro interno importanti opere d’arte.
Da non perdere
è senza dubbio la quattrocentesca cappella di San Sebastiano, di origine
bizantina come diverse altre cappelle sparse nella campagna, oppure la chiesa
madre dedicata a Santa Caterina d’Alessandria. Per quanto riguarda le opere
d’arte, da segnalare è Madonna con Bambino in marmo bianco di Pietro Bernini,
il padre di Gian Lorenzo, custodita nel convento di Sant’Antonio a
’Pantana’.
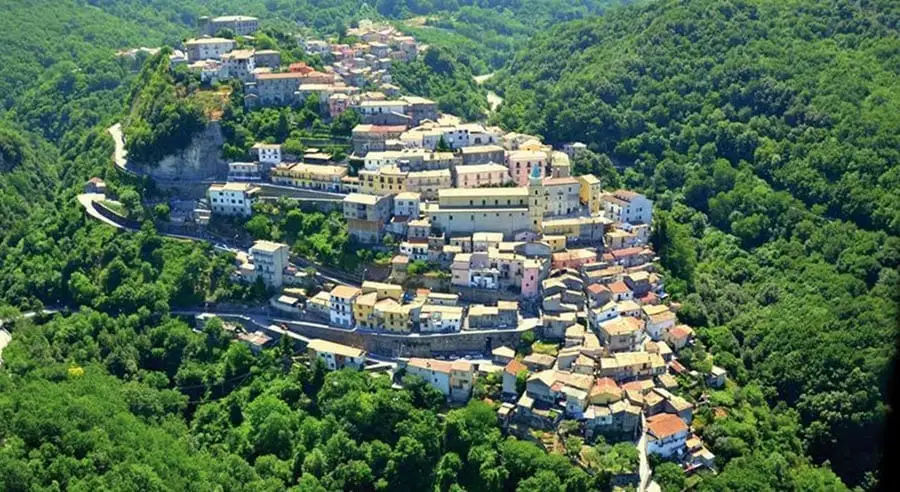
PAPASIDERO -
Questo antico borgo
medievale arroccato alle falde del mote Ciagola, nell’Alto tirreno cosentino,
è ormai da tempo una tappa obbligata per tutti gli amanti della vita all’aria
aperta e, in particolare, del rafting.
Ogni anno
tantissimi appassionati giungono a Papasidero per
lanciarsi tra le correnti del fiume Lao sia a bordo dei gommoni, ma anche per
cimentarsi nel kayak, nel canyoning o nell’acqua trekking. Se Papasidero,
d’altronde, è la forza della natura a farle da padrona, qui sono conservate
anche importanti tracce di insediamenti che risalgono addirittura al
Paleolitico.
Tutto ruota in
questo caso attorno al sito archeologico delle grotte del Romito e ai suoi
straordinari ritrovamenti. Di grande fascino a Papasidero sono però anche i
tanti edifici religiosi a partire dallo splendido santuario della Madonna di
Costantinopoli, costruito a partire dal 1600 al di sotto di una grande rupe
posta sul fiume Lao.
Una posizione
davvero unica a cui si accede grazie a un sentiero a gradoni lastricati e
attraversando un suggestivo ponte ad arco sul Lao.

GROTTE DI
ROMITO - Una finestra
sulla preistoria nel cuore del parco del Pollino. A Papasidero si trova la
meravigliosa Grotta
del Romito che, assieme al Riparo del Romito, costituiscono uno dei
più importanti giacimenti dell’Italia meridionale risalenti al tardo
Pleistocene.
All’interno
di uno stretto canyon a poco distanza dal fiume Lao sono conservate importanti
tracce della presenza di homo sapiens a partire dalla fine del Paleolitico, ma
anche nel Mesolitico e nel Neolitico.
Oggi la grotta
e il riparo sono separati da un muro realizzato quando la caverna fu utilizzata
come dormitorio, ma in epoca preistorica i due ambienti erano un’unica, grande
abitazione e i segni di questa lunga frequentazione sono ancora ben visibili tra
strumenti litici e ossei, graffiti e scheletri.
Il capolavoro
della grotta del Romito è senza dubbio la grande figura di toro, lunga circa
1,20 metri, incisa su un masso di circa 2,30 metri di lunghezza e inclinato di
45 gradi. Un disegno, di proporzioni perfette ed eseguito con tratto sicuro.
Nella grotta è inoltre possibile osservare, nel luogo del loro rinvenimento,
delle riproduzioni di sepoltura datate all’incirca 9.200 anni prima della
nascita di Cristo.

MORANO
CALABRO - Più ci si
avvicina a Morano
Calabro, più si ha
l’impressione di avvicinarsi a un presepe meravigliosamente cesellato dalle
sapienti mani di un maestro artigiano.
Morano Calabro
si trova arroccato sulla cima di un colle con il castello e la chiesa che
sovrastano le fila di case che dolcemente degradano verso valle. Sullo sfondo,
infine, a incorniciare questo panorama da sogno ci sono le vette dei monti
Pollino, Serra Dolcedorme e Serra del Prete che superano tutte i duemila
metri.
Morano Calabro
è un borgo dalla storia millenaria che, secolo dopo secolo, è sempre riuscito
a conservare intatte le proprie tradizioni e il proprio stile di vita.
Oggi Morano
Calabro è una tappa sicuramente suggestiva nel vostro viaggio alla scoperta del
parco del Pollino. A Morano Calabro non solo è bello perdersi tra vicoli e
stradini che salgono e scendono ripidi lungo i pendii del colle, ma lo è anche
scoprire le tante opere d’arte che qui sono conservate. Se d’altro canto gli
scorci di Morano Calabro rapirono la fantasia persino di un genio del Novecento
come Maurits Escher, che ha lasciato un eredità una splendida rappresentazione
speculare del paese, il borgo conserva anche autentici capolavori firmati, per
esempio, da Bartolomeo Vivarini e da Pietro Bernini, padre di Gian Lorenzo.

SANTUARIO
DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI - Addossato,
quasi incastrato, tra la costa del monte e la sponde del fiume Lao, il santuario
della Madonna di Costantinopoli è un luogo dotato di un fascino mistico a cui
non si piò restare indifferenti.
Qui secolo dopo
secolo è passata la storia di questi luoghi e le sue tracce sono ancora ben
visibili non solo nell’architettura degli edifici che formano il santuario o
nelle opere d’arte che vi sono conservate, ma anche dalla devozione che gli
abitanti portano verso il Santuario della Madonna di Costantinopoli.
Per raggiungere
la chiesa, che si trova a poche centinaia di metri dal centro di Papasidero, si
deve attraversare un ponte risalente all’inizio del XX secolo, ma sotto la cui
campata è ancora ben visibile quello medievale detto della Rognosa.
Proprio questo
antico nome ha portato gli storici a ipotizzare la presenza nell’area dove ora
sorge il santuario, di una piccola chiesa tardo medioevale di cui è riprodotto
l’impianto nell’affresco della Vergine omonima custodito nella cappella di
Santa Sofia, dove compare un edificio a navata unica e campaniletto a vela, che
durante l’epidemia del 1656 venne utilizzata come lazzaretto. Dopo quella
calamità la Vergine di Costantinopoli fu eletta patrona cittadina e si
procedette così all’ampliamento del santuario.

MUSEO ETNICO
ARBERESH DI CIVITA -
Nell’ex municipio di Civita si trova un museo davvero particolare che permette
ai suoi visitatori di conoscere a fondo la storia e le tradizioni degli albanesi
d’Italia, gli arbeshe.
Si tratta di
popolazioni che si stabilirono in tutto il Sud Italia, ma in particolare in
Calabria, tra il XV e il XVII secolo e da allora hanno sempre conservato la
propria cultura, la propria lingua e le proprie tradizioni.
A questa
comunità e alla sua lunga e ricca storia da più di 30 a Civita è dedicato il Museo
etnico Arbëresh al cui interno sono raccolte diverse testimonianze
sulla civiltà contadina locale e in particolare della comunità di tradizione
albanese. Il museo si sviluppa su due piani e si compone di quattro sale: sala
dell’accoglienza, sala del telaio, sala dei totem, sala del costume.
Passeggiando
per il museo si possono osservare da vicino i tradizionali costumi albanesi, ma
anche una rassegna fotografica e testimonianze sui paesi dell’etnia arbëresh
in Italia, una raccolta iconografica sui riti bizantini e una biblioteca di
testi albanesi. Molto belli, infine, un’icona della Madonna di Odigitria e gli
appunti di un cantastorie sulla Storia di Skanderbeg.

CASTELLO DI
VALSINNI - Arte e
letteratura, storia e leggenda: tutto questo e molto altro ancora contribuiscono
a creare il fascino del Castello
di Valsinni.
Attorno a
questo imponente edificio si sviluppa tutta la parte storica del borgo di
Valsinni, un vero gioiello dove tra antichi edifici addossati uno all’altro
spicca la bella chiesa Madre dedicata a Santa Maria Assunta. La particolare
conformazione di questo luogo, inoltre, ha prodotto una particolarità
architettonica: i gafi, aperture coperte che passano sotto le case per aggirare
i dislivelli.
A rendere
celebre Valsinni è però soprattutto il suo castello a cui addirittura
Benedetto Croce dedicò un cantico poetico a Isabella Morra, poetessa
cinquecentesca che, reclusa nelle stanze del castello portò avanti un amore
platonico con il cavaliere spagnolo Diego Sandoval fino a che i suoi fratelli,
venuti a conoscenza di questi mormorii, non avevano accolto il legame che univa
i due poeti e per motivi di ”onore” oltre che politici attuarono una
sanguinosa vendetta.
Una storia
funesta che nel 1928, come detto, ispirò Benedetto Croce, ma a cui anche Dacia
Maraini dedicò uno spettacolo teatrale e che il borgo di Valsinni ricorda ogni
anno con tanti eventi dedicati.

Fonte:
|