Cosenza, il
capoluogo di provincia più a nord della Calabria, sorge sul colle Pancrazio,
detto U Castiaddru, nella valle
del fiume Crati, alla confluenza di quest'ultimo con il Busento.
Tale confluenza consente di distinguere l'area dell'insediamento primigenio,
posta in alto fino al colle Pancrazio, e la città moderna sviluppatasi lungo la
riva sinistra del Crati.
Il nucleo
storico, meglio conosciuto come Cosenza vecchia, rispecchia la comune
facies degli antichi insediamenti collinari, dominata da vicoli erti, stretti e
tortuosi lungo i quali si erge un'edificazione fatta da fabbricati minuti e
palazzi signorili, arroccati sul colle Pancrazio, successivamente sui colli
Guarassano e Torrevetere, a sinistra del Crati, mentre sono assai rare le
abitazioni su i restanti colli circostanti, Gramazio, Triglio, Mussano e
Venneri. La zona a sud è bagnata anche dai fiumi Cardone e Iassa mentre la zona
nord - ovest del perimetro comunale è attraversata dal torrente Campagnano che
rappresenta il punto di contatto con i comuni dell'area urbana di Castrolibero e
Rende.
L'intera area
di insediamento è protetta a ovest dalla Catena
Costiera meridionale (lungo la quale svetta Monte
Cocuzzo di formazione dolomitico-calcarea e che molti ritengono
invece erroneamente un vulcano spento) che separa la città dal Mar
Tirreno, e a est dalla Sila,
l'altipiano boscoso in cui vive ancora il lupo,
animale totemico della città stessa e simbolo della locale squadra di calcio.

Le origini
della città, abbastanza nebulose, risalgono probabilmente all'VIII
secolo a.C., epoca in cui sul suo territorio sorgeva il villaggio italico
di Kos, di cui sono arrivate a noi alcune monete, conservate al British
Museum di Londra,
risalenti almeno al 420 a.C.; in seguito la città si affaccerà definitivamente
alla storia intorno IV
secolo a.C., momento in cui il luogo era divenuto di importanza
strategica per i Bruzi,
che la conquistarono e ne fecero la loro capitale; è improbabile che i Bruzi,
che parlavano osco, abbiano dato alla città nel 356
a.C. il nome di "Consentia", che è latino (molto
probabilmente mantennero l'originale nome di Cosa o Cossa) e che quindi le venne
dato dai Romani, con riferimento al "consenso" dei Bruzi a
confederarsi e/o al "consensum" dei due fiumi, ovvero alla loro
confluenza; in ogni caso, alla Confoederatio Brutia aderirono tutte le altre
città e villaggi bruzi, oltre ad essere riconosciuta anche dai Lucani,
costretti a firmare un trattato di pace detto "di donna Brettia", che
in futuro divenne una vera alleanza fra i due popoli.
Consentia,
dunque si presentava, durante la massima espansione dei Bretti, come una città
fortificata e temuta, sviluppata e prospera al punto di essere definita
"metropoli" e capitale di un vasto territorio che si espandeva a nord
fino all'entroterra della Basilicata e della Puglia e a sud, fino all'Aspromonte.
controllando sia la costa ionica che tirrenica e quasi tutte le città della Magna
Grecia calabra, che una dopo l'altra caddero sotto i continui
attacchi dei Bruzi. Infatti a nulla valsero gli aiuti di Dionisio prima
e successivamente di Alessandro I
d'Epiro detto il Molosso zio di Alessandro
Magno; quest'ultimo in effetti riuscì a conquistare Consentia, ma morì
poi in battaglia nel 331
a.C. nelle vicinanze, a Pandosia.
Consentia cade ancora nel 275
a.C., quando la confederazione Bruzia si alleò con Pirro re
d'Epiro nella
guerra contro Roma, ma fu risparmiata e addirittura nominata città della Repubblica
romana lasciando intatto il suo ruolo di capitale bruzia.
La voglia di
libertà, di autonomia, la fierezza e l'attitudine alla guerra dei bretti porto,
però, a numerose rivolte contro Roma, tra cui sino di rilevante importanza
quelle del 218
a.C., quando si allearono con Annibale durante
la seconda guerra
punica, e quella dal 73
a.C. al 71
a.C., allorquando i bretti si unirono alla rivolta degli schiavi guidata
da Spartaco,
che nella zona di Cosenza, raccolse in breve tempo ingenti truppe.
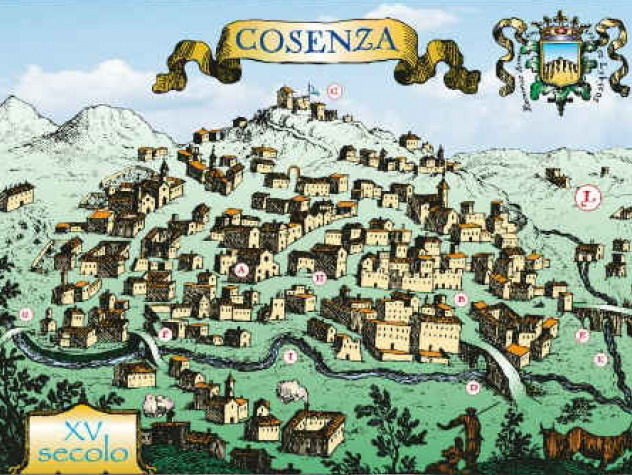 A
seguito di questi accadimenti Roma tolse a Consentia lo stato di città della
repubblica romana, sciolse la lega dei Bruzi, levandole dunque lo stato di
capitale, e ne espropriò le terre, facendola diventare semplicemente colonia
romana. Della città di epoca ellenistica restano pochi resti a causa della
continuità di vita del suo centro storico: blocchi parallelepipedi di arenaria
locale pertinenti alla Rocca Brettia sono visibili in vari punti della città,
resti di un vasto edificio monumentale con soglia d'ingresso a piazzetta Antonio
Toscano, resti di case al di sotto dell'ex Seminario Arcivescovile e del Palazzo
Sersale. Al di sopra della capitale dei Brettii fu edificata la colonia romana.
A
seguito di questi accadimenti Roma tolse a Consentia lo stato di città della
repubblica romana, sciolse la lega dei Bruzi, levandole dunque lo stato di
capitale, e ne espropriò le terre, facendola diventare semplicemente colonia
romana. Della città di epoca ellenistica restano pochi resti a causa della
continuità di vita del suo centro storico: blocchi parallelepipedi di arenaria
locale pertinenti alla Rocca Brettia sono visibili in vari punti della città,
resti di un vasto edificio monumentale con soglia d'ingresso a piazzetta Antonio
Toscano, resti di case al di sotto dell'ex Seminario Arcivescovile e del Palazzo
Sersale. Al di sopra della capitale dei Brettii fu edificata la colonia romana.
Sotto la
dominazione romana, Cosenza divenne una stazione della Via
Capua-Rhegium, meglio nota come via Popilia (o via Annia) la via che
congiungeva Roma alla Sicilia.
Durante la
guerra civile tra Pompeo e Cesare, Cosenza si schierò con la fazione di Cesare,
e quindi fu assediata per ordine di Pompeo dai soldati arrivati dalla Sicilia.
Nel 29
a.C. Consentia diventa colonia sotto Augusto,
il quale le concesse nuovamente la cittadinanza romana dopo essersi assicurato
della totale resa dei Bretti e ne delimitò i confini con l'assegnazione del suo
agro in duecento iugeri.
Da quel momento
Consentia cambia connotazione, e da bellica e fortificata si trasforma in una
fiorente città a connotazione commerciale e culturale.
Nel 304, Massimiano,
imperatore romano, si stabilisce a Consentia per far fronte ad una rivolta di
ordine religioso. Con l'eliminazione di Bulla, iniziò il martirio dei cristiani nel
capoluogo bruzio, che vide numerosi suoi figli martiri tra cui san Dionigi e san
Callisto. Nel 313 con
l'editto di Milano il Cristianesimo esce
dalla clandestinità. Per un secolo Consentia vive nel benessere, nella pace e
nello splendore, finché Alarico re
dei Visigoti non
la invade subito dopo aver perpetrato il Sacco
di Roma del 24 agosto 410.
Durante l'invasione, nei pressi della città nel 410, Alarico muore di malaria e,
secondo la leggenda, fu seppellito in armatura dal suo esercito, con una parte
del bottino di Roma ed il suo cavallo nel letto del fiume Busento,
il quale venne momentaneamente deviato per poi essere reindirizzato nel letto
naturale facendo perdere per sempre il punto preciso della sepoltura.
Sono visibili
testimonianze della città romana nel centro storico: scavo di una domus in
piazzetta A. Toscano, scavo di edifici termali in via S. Tommaso e Palazzo
Sersale, resti delle mura di cinta in opus
reticulatum.
Nel 554 l'esercito
di Giustiniano sconfisse
gli Ostrogoti; Narsete entrò
a Consentia e con l'era bizantina la
città riacquistò nuovamente il titolo capitale delle terre meridionali
liberate dai bizantini. Nell'anno 568, Giustino
il Giovane, nipote di Giustiniano, divenne Imperatore e Consentia venne
trasformata in ducato. In questo periodo il capoluogo bruzio divenne culla di
letterati, si formarono le nuove classi dirigenti e vi nacque la prima scuola
musicale. Nei secoli VIII e IX fu dominio prima longobardo,
durante il quale divenne sede di Gastaldato del Principato
di Salerno, e poi bizantino,
conosciuta col nome di Constantia. Violentemente contesa da saraceni e
longobardi, la città fu quasi distrutta e riedificata nel 988.

Nel 1057 Roberto
il Guiscardo diede inizio all'occupazione normanna della
Calabria. Constantia fu ostile a questa nuova dominazione, tanto che in città
si scatenò una ribellione che però fu presto sedata. In questo periodo divenne
capitale e sede del giustizierato Val
di Crati e Terra Giordana e residenza di Ruggero
II, Duca di Calabria che iniziò la costruzione del Castello sui
ruderi di una fortezza saracena. Con il matrimonio tra Costanza
d'Altavilla, ultima erede tra i sovrani normanni, ed Enrico
VI di Hohenstaufen inizia
la dominazione sveva.
Sotto Federico
II di Svevia, lo "stupor mundi" che considerava Cosenza la sua
sede preferita dopo Palermo e Napoli,
iniziò un periodo prosperoso sia culturalmente che economicamente grazie anche
all'istituzione di un'importante fiera annuale (La
fiera della Maddalena), una fase che gratificò la città di numerosi
privilegi. Venne completato e consacrato il Duomo
di Cosenza, nel quale fu fatto seppellire il figlio primogenito Enrico
VII, nato dal matrimonio con Costanza
d'Aragona, morto suicida e in contrasto con il padre che lo aveva
condannato prima a morte, poi al carcere a vita, e inoltre venne ristrutturato
il Castello con
le due torri ottagonali.
Dopo la morte
di Federico II il passaggio dall'età Normanno - Sveva al periodo angioino non
fu facile. La città venne attanagliata dal brigantaggio e
dalla miseria in virtù di un fiscalismo accentuato e da una serie di lotte
intestine, pur non essendo mai stata infeudata e pur avendo conservato sempre un
soddisfacente margine di autonomia grazie ai numerosi privilegi elargiti dai
dominatori. Passò un secolo prima di ritrovare la tranquillità, quando,
accolse Luigi III
d'Angiò che, dal 1432 insieme
alla moglie, Margherita
di Savoia, risiedette nel castello eleggendo
la città a sede dell'erede al trono di Napoli, dandole il titolo di centro del ducato
di Calabria. Luigi III d'Angiò venne colpito dalla malaria,
morì il 12 novembre 1434 e
fu seppellito nel Duomo.
In seguito a
lunghe e cruente guerre di successione gli Angioini furono sostituiti dagli Aragonesi che
decretarono Cosenza la capitale della Calabria
Citra Naethum, poi capoluogo della Calabria
Citeriore che comprendeva grosso modo la provincia cosentina. Il
periodo aragonese consacrò
Cosenza la più importante città del reame nel campo del diritto (1494-1557).
Dopo Napoli diventa
la seconda città ad avere una cartografia e
nel 1511 nasce
l'Accademia Cosentina fondata
da Aulo Giano
Parrasio e portata al suo massimo splendore da Bernardino
Telesio, il più grande dei cosentini illustri, definito da Francesco
Bacone il primo degli uomini nuovi. In seguito viene conquistata
dagli spagnoli e
nonostante le ribellioni e contrasti di vario genere diviene uno dei centri più
vivi della cultura meridionale. In questo periodo fiorirono ingegni di alto
livello come Antonio
Serra, il primo che si occupò di economia politica, Tommaso
Cornelio, medico e scienziato, Pirro
Schettini, poeta, Gian
Vincenzo Gravina, il teorico che fondò a Roma l'Accademia
dell'Arcadia.
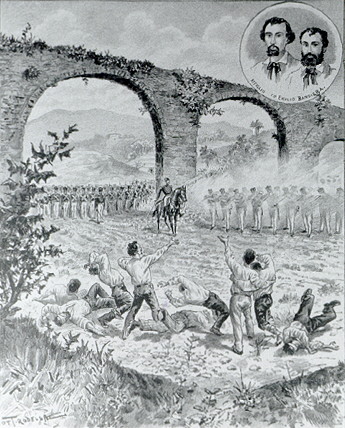 Il
XVI secolo vide un impressionante fioritura umanistica e segnò per Cosenza una
rinascita intellettuale, tanto che venne definita "Atene della
Calabria". Dopo duecento anni di dominio spagnolo seguì nel 1707 quello
degli austriaci e
dopo la guerra di successione polacca (1738) il regno di Napoli venne assegnato
a Carlo III di
Borbone che governò fino all'unità d'Italia. Questo periodo venne
caratterizzato da contrasti e dalla formazione di sette massoniche e giacobine.
Nel 1799 molti cosentini parteciparono agli eventi turbinosi della Repubblica
Partenopea, dando il loro contributo di azione e di idee sia nelle file
dei sanfedisti che in quelle dei patrioti giacobini e filo-francesi.
Il
XVI secolo vide un impressionante fioritura umanistica e segnò per Cosenza una
rinascita intellettuale, tanto che venne definita "Atene della
Calabria". Dopo duecento anni di dominio spagnolo seguì nel 1707 quello
degli austriaci e
dopo la guerra di successione polacca (1738) il regno di Napoli venne assegnato
a Carlo III di
Borbone che governò fino all'unità d'Italia. Questo periodo venne
caratterizzato da contrasti e dalla formazione di sette massoniche e giacobine.
Nel 1799 molti cosentini parteciparono agli eventi turbinosi della Repubblica
Partenopea, dando il loro contributo di azione e di idee sia nelle file
dei sanfedisti che in quelle dei patrioti giacobini e filo-francesi.
Durante
l'occupazione napoleonica la
città fu contrassegnata dalla costruzione di opere pubbliche e da un
orientamento anticlericale e libertario. Si svilupparono tendenze filo-francesi
da parte delle classi colte nelle quali iniziava a diffondersi la Carboneria,
mentre i contadini si davano al brigantaggio e si nascondevano sulle montagne
silane per sfuggire alla pressione fiscale. La famiglia Zupi si
schierò dalla parte dell'imperatore tradendo i Borboni regnanti,
seguì uno scontro di un anno nel quale il generale dell'esercito francese Daniele
Zupi Marino si nascose nelle cantine della sua villa per non essere
trovato. Celebre fu il massacro dei Brazzalotto perpetrato dai francesi verso
l'omonima famiglia accusata di tradimento essendo rimasti fedeli ai Borbone. Nel 1815,
con il ritorno dei Borboni, Daniele Zupi Marino fu infine scovato e messo al
rogo.
In questo
periodo anche a Cosenza si manifestarono movimenti liberali e patriottici: nel
1837 un gruppo di congiurati cosentini, fra cui Domenico Abate, Luigi Pullano,
Raffaele Laurelli, Carlo Calvello, Nicola Lepiane, Pasquale
Abate, Luigi Belmonte, e Antonio Stumpo pianificarono una insurrezione
che avrebbe dovuto svolgersi con tumulti nelle carceri e con il contemporaneo
arrivo dei rivoltosi. Inizialmente pianificata per il 22 di luglio,
l'azione venne rimandata al 31 luglio perché si sospettava che le autorità ne
fossero a conoscenza. Tuttavia, sia i carcerati che alcuni dei partecipanti non
vennero a conoscenza della decisione, e i tumulti cominciarono ugualmente il 22
luglio, venendo facilmente sedati dalle autorità borboniche. Diversi
dei congiurati vennero arrestati e condannati a morte, e poiché i rivoluzionari
per fare insorgere la popolazione avevano accusato il governo borbonico di
essere responsabile della diffusione del colera che
aveva in quel momento colpito la regione, molti di loro vennero a loro volta
accusati di avere causato l'epidemia per
poterne incolparne le autorità.
I moti
rivoluzionari più noti sono comunque quelli del 15 marzo 1844 che
si conclusero con uno scontro a fuoco nel Largo dell'Intendenza tra i soldati
borbonici e 21 patrioti poi condannati a morte, e dei quali ne furono
giustiziati soltanto sei. Da questa rivolta presero spunto i Fratelli
Bandiera, veneziani che vennero in soccorso ai fratelli calabresi e
vennero fucilati presso il Vallone
di Rovito insieme ad altri 7 ufficiali il 25 luglio 1844.
In seguito i cosentini parteciparono a molte vicende del Risorgimento,
dalle guerre d'indipendenza fino all'impresa
dei Mille. Garibaldi fu
a Cosenza il 31 agosto del 1860; due mesi dopo, un plebiscito sanzionò
l'annessione al Regno
d'Italia.
Il
propagandismo fascista a
Cosenza si intensificò solo sul finire degli anni trenta, fino ad allora il
capoluogo bruzio si era mostrato ad esso ostile. Essenzialmente i fascisti
fecero sì che i più giovani fossero educati alla cultura del regime e
allontanati dalla Chiesa oppositrice. Tutto ciò portò ad una nuova mentalità
cittadina che la vide appoggiare il Duce nella
sua idea di partecipare alla seconda
Guerra mondiale, lasciatisi abbagliare dalle mire del colonialismo
fascista. Mussolini arrivò in città nel 1939.
La visita venne pubblicizzata e presentata in pompa magna, attirando migliaia di
persone dalla provincia e dalla Calabria intera, ma che non lasciò nulla di
concreto per Cosenza che non ne trasse alcun vantaggio. La visita in effetti fu,
per certi versi, controproducente. Infatti nell'immediato allargò la popolarità
degli oppositori che si fecero sentire su argomenti quali l'alleanza con la
Germania o l'entrata in guerra dell'Italia al
loro fianco. Durante la guerra Cosenza fu bombardata massicciamente solo nel 1943 dagli
anglo-americano. Quell'anno Cosenza subì nuove incursioni che causarono 136
vittime, mentre la situazione socio-economica portò la città verso una
catastrofica paralisi. La fine della guerra lasciò la città priva di un ordine
amministrativo e politico che colmarono gli inglesi designando Prefetto Pietro
Mancini, il quale diede la carica di Primo Cittadino al compagno di
partito Francesco Vaccaro. Nelle elezioni del 1946,
la città elesse a sindaco il democristiano Maurizio
Quintieri. La città, però, continuava a vivere una situazione economica
disastrata, tanto che nel 1950 le
famiglie senza tetto erano 1307 e 436 quelle che vivevano in baracche.

Dal 1951 al 1961,
grazie al boom economico che investì l'intera penisola,
Cosenza iniziò una veloce risalita economico-finanziaria. Il decennio si
caratterizzò per la notevole espansione edilizia benché la città fosse priva
un piano regolatore funzionale. In questo clima la speculazione edilizia richiamò
in città grossi e piccoli proprietari terrieri che, intuendo il grosso
guadagno, utilizzarono i propri terreni per la costruzione della città nuova,
facendo così quasi scomparire l'attività agricola cittadina. Politicamente la
città era governata, quasi senza una opposizione dalla Dc. l'opposizione, di
sinistra, era guidata da Giacomo
Mancini, figlio di Pietro, Prefetto designato nell'immediato dopo guerra
dagli inglesi. Giacomo Mancini, sotto lo pseudonimo di Gino Verità iniziò
a scrivere una serie di articoli contro l'allora potere politico di palazzo dei
Bruzi, suscitarono velenose polemiche nella Dc cosentina. Nel 1958 le
elezioni politiche videro vincitore, Riccardo
Misasi, forte anche dell'appoggio clericale cittadino.
Nel 1971 la
popolazione superò i 100.000 abitanti. Come per il resto d'Italia, nacque una
giunta comunale Dc-Psi.
Cosenza, che già
aveva subito una cementificazione selvaggia, quasi del tutto non regolata, vide
crescere enormi quartieri staccati dal centro urbano, quasi tutti di carattere
popolare e senza preoccuparsi troppo di integrarli con strade e infrastrutture.
La nuova urbanizzazione cosentina portò ad una divisione classista, la quale si
avverte anche nella città vecchia, in cui la storica cittadinanza si riversò
nella città nuova, vendendo o affittando le vecchie dimore alle famiglie di
immigrati. Si può affermare che, pur avendo risolto il problema per la quasi
totalità delle famiglie senza tetto, si creo altresì, una situazione di
emarginazione sociale che venne risolto, anche se non del tutto, solo 25 anni
dopo, durante l'ultima amministrazione Mancini.
Come duemila
anni prima, sotto i romani, Cosenza torna ad essere un'importante stazione di
una grande infrastruttura viaria del sud Italia: la Salerno-Reggio
Calabria, fatta passare nei pressi della città grazie anche al
contributo dell'allora Ministro
dei lavori pubblici Giacomo
Mancini (1964).
Importante fu anche la scelta di dotare la città di importanti assi viarie,
urbane ed extraurbane. Il collegamento tra lo svincolo autostradale e la
superstrada Crotone-Paola;
il ponte Mancini, che collegava la città nuova alla vecchia; la nuova ferrovia Cosenza-Paola e
il progetto della nuova stazione ferroviaria (Stazione Vaglio
Lise). Durante questo periodo di sconvolgimento urbano, nasceva l'idea di
far sorgere un'università a Cosenza. L'idea era quella di impostarla sulla
residenzialità di docenti e allievi e che agevolasse l'ingresso agli studenti
più meritevoli ed ai meno abbienti, su una aggregazione dipartimentale della
ricerca e della didattica, la prima del tipo in Italia, con corsi di laurea
innovativi e legati alla realtà territoriale.
Le principali
idee di luogo di edificazione erano due e provenivano entrambe dallo stesso
partito, quello socialista. La prima corrente era quella di Francesco
Principe e dell'allora Ministro
alla Pubblica Istruzione Misasi, che volevano edificarla a nord del
capoluogo, indirizzando così anche lo sviluppo urbano verso la cittadina di Rende nella
quale venne materialmente costruita l'Università.
Rende dunque iniziò ad espandersi verso Sud, trasformando le due distinte città,
in un'unica area urbana senza alcuna zona di discontinuità e che sta aprendo a
una lenta ma inesorabile corsa verso il comune unico. La seconda corrente,
quella di Mancini, proponeva una collocazione a sud della città nella valle del fiume
Savuto. Ciò avrebbe probabilmente consentito l'accentramento della città
vecchia e la sua rinascita.
Visitare
il centro storico

Cosenza è una
città d'arte e cultura. E' piena di chiese che custodiscono pregevoli dipinti.
E' la patria dell'umanista Aulo Giano Parrasio (1470-1521), che nel 1511 vi
fondò una delle primissime accademie d'Europa, dove per almeno un secolo si
raccolsero le migliori menti della Calabria. E' la città del filosofo
Bernardino Telesio (1509-1599), il cui pensiero antiaristotelico ispirò
Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Cartesio. E oggi è anche lo straordinario
museo all'aperto in cui chiunque, senza neppure pagare un biglietto ma
semplicemnte passegiando in centro, può ammirare le opere di alcuni tra i più
grandi scultori del Novecento, installate nel 2006 per iniziativa della famiglia
del mecenate Carlo Bilotti.
Cosenza è
anche una città antica. Secondo il geografo e storico greco Strabone, era stata
fondata nel IV secolo a.C. dai Brettiii, poi chiamati Bruzi dai Romani, un
popolo italico originario della Sila che ne fece la capitale di una
confederazione. Occupa sette colli, proprio come Roma, e si affaccia sulla valle
del Crati nel punto in cui il fiume principale della Calabria riceve il suo
affluente Busento.
Secondo la
leggenda, proprio in quel punto sarebbe stato sepolto il re dei Visigoti
Alarico, morto qui nel 410 a.C., forse di malaria, durante la sua discesa in
Italia dopo il sacco di Roma. Le cronache antiche raccontavano che il re fu
tumulato insieme al suo cavallo e con tutto il bottino saccheggiato. Dicono
anche che per nascondere il punto della sepoltura fu addirittura deviato il
Busento e che gli schiavi che avevano partecipato a quegli immani lavori furono
uccisi perchè non svelassero il segreto. Sia come sia, nulla è mai stato
ritrovato.
Il centro
storico di Cosenza assomiglia a un piccolo borgo, un paesino fatto di viuzze
tortuose con archi e sottopassaggi, chiese medevali, palazzi nobiliari, casette
antiche e vecchie botteghe artigiane.
L'arteria
principale è intitolata al grande Telesio; il punto più alto è la cima del
colle Pancrazio, su cui sorgono le rovine del Castello Svevo. Questa millenaria,
severa fortezza fu costruita nell'XI secolo dai normanni su una fortificazione
saracena, a sua volta costruita sui ruderi di una rocca dei Bruzi, e fu poi
rinnovata nel XIII secolo dall'imperatore Federico II di Svevia, a cui di deve,
tra l'altro, la torre ottagonale.
Oltre piazza
dei Bruzi si stende il centro nuovo attraversato dall'isola pedonale di corso
Mazzini, su cui si affacciano boutique e ristoranti, banche e locali alla moda
perfetti per prendere un aperitivo mentre si osserva il passeggio. Ed è qui che
si possono ammirare le straordinarie sculture del MaB, il Museo all'aperto
Bilotti, intitolato all'imprenditore e collezionista cosentino (1934-2006) che
si trasferì a New York per completare gli studi e poi rimase a vivere negli
Stati Uniti, ma avendo la propria città natale sempre nel cuore: e infatti ha
voluto lasciarle in eedità la grande arte del Novecento. Ci sono opere, tra gli
altri, di Amedeo Modigliani, Mimmo Rotella, Pietro Consagra, Salvador Dalì,
Emilio Greco, Giacomo Manzù, Giorgio De Chirico.
E oltre a
questa straordinaria collezione, la città può anche vantare, dal 2018, una
grande opera di architettura contemporanea. il ponte sul Crati intitolato a San
Francesco di Paola e firmato dall'archistar di Valenncia Santiago Calatrava.
Castello
Normanno-Svevo

Il Castello
normanno-svevo si trova sul colle Pancrazio a 383 metri sul livello del
mare.
Il
castello di Cosenza, posto sulla sommità del colle Pancrazio, uno dei sette
colli della città, è edificato su una motta artificiale
di forma rettangolare, il cui orientamento rimanda alle edificazioni dei Bretii (VI
sec a.C.), popolazione che era solita posizionare le proprie fabbriche rispetto
alle direzioni astronomiche fondamentali.
Per
mancanza di fonti documentarie, non è certo che il luogo dove sorge il castello
sia esattamente quello occupato un tempo dalla Rocca Bretia, ma è indubbio che
i cosentini costruirono, nel 937 d.C., il proprio forte in cima allo stesso
colle.
Il
forte viene spesso definito Normanno, e infatti, a partire dal XII secolo, Ruggiero
II ingrandì il castello dandogli i caratteri delle coeve
costruzioni. In questo periodo il castello ospitò anche la Curia.
 Un
funesto terremoto (1184), il primo di una lunga serie, distrusse la rocca
rendendola inagibile. Solo con l’arrivo di Federico
II di Svevia (XIII secolo) il castello ritornò al suo splendore,
assumendo importante funzione difensiva. Furono gli stessi Svevi ad ampliare la
rocca facendole assumere l’impostazione tipica dei castelli federiciani:
impianto rettangolare, torri angolari, camminamenti di ronda merlati, sale
voltate.
Un
funesto terremoto (1184), il primo di una lunga serie, distrusse la rocca
rendendola inagibile. Solo con l’arrivo di Federico
II di Svevia (XIII secolo) il castello ritornò al suo splendore,
assumendo importante funzione difensiva. Furono gli stessi Svevi ad ampliare la
rocca facendole assumere l’impostazione tipica dei castelli federiciani:
impianto rettangolare, torri angolari, camminamenti di ronda merlati, sale
voltate.
Con
gli Angioini (XIII-XV secolo) e in particolare con Luigi
III duca di Calabria e la sua sposa Margherita
di Savoia, il forte assunse per la prima volta la funzione di residenza
principesca. Durante le lunghe lotte tra Angioini e Aragonesi il
castello ospitò la zecca (seconda metà del 1400) e una prigione per
politici.
Nel
XVI secolo, periodo di dominazione spagnola, ritorna ad avere la sua originaria
funzione militare, mentre a partire dal 1638, anno di un altro disastroso
terremoto, iniziò la decadenza del fortilizio che venne adibito solo a deposito
di materiale. In questo anno cade una delle torri e viene distrutta quasi tutta
la merlatura. I lavori per il recupero diventano a questo punto particolarmente
ingenti, e si preferisce quindi lasciare allo stato di abbandono la fabbrica.
Con l’impegno di restaurarlo, nella seconda metà del 1700, il castello fu
concesso prima al Vescovo Capece Galeota, che lo rimaneggiò fortemente per
adattarlo a Seminario Diocesano, e successivamente all'Arcivescovo Gennaro
Clemente Francone.
Con
la presenza dei Borboni (XIX
secolo) furono ordinati numerosi restauri e si portarono a compimento tutte le
parti, ma nello stesso tempo si modificò ancora l’aspetto della rocca. In
questo periodo la fabbrica assunse infatti la funzione di carcere.
Nell'ultimo
secolo la struttura, ridotta a rudere da numerosi terremoti, ha cessato
qualsiasi funzione. Dopo il sisma del 1870 che ebbe epicentro proprio a Cosenza,
il castello fu acquistato dal Comune (atto del 23 dicembre 1885) ma rimase per
lungo tempo in stato di degrado e abbandono.
Solo
gli ultimi lunghissimi lavori, iniziati nel 2008, hanno permesso di riportare in
funzione il castello per usi quasi prettamente privati con un aerea destinata
alla ristorazione e alle feste.


 Pag.
2
Pag.
2