Il territorio
comunale fu abitato fin dall'Età del bronzo, come testimoniato dai
rinvenimenti ottenuti negli scavi condotti nella Grotta della Pietrosa o
dai resti di capanne scoperti a Taureana di Palmi.
Dal IV
secolo a.C., e fino al X secolo, nel territorio comunale si sviluppò la
città di Tauriana. Sulla sua fondazione, alcune leggende narrano di una
possibile colonizzazione achea dell'area. Altre ipotesi storiche
ricollegano la nascita della città alla seconda metà del IV secolo
a.C., quando dei gruppi brettii, nello specifico i «Tauriani», si
resero autonomi dai lucani, raggiungendo e conquistando una parte della
Calabria meridionale. Nell'alto medioevo la città crebbe d'importanza
diventando sede vescovile.
Nel 951 Tauriana
venne distrutta dalle milizie dell'emiro di Palermo Hasan Ibn Alì e,
fuggendo, la parte dei taurianensi dedita ai traffici ed alle arti
marinaresche si stabilì nella parte alta della costiera, tra il monte
Aulinas ed il fiume Metaurus, nella contrada De Palmis dove
vi erano alcune case coloniche.
Dei primi
secoli di vita del piccolo villaggio di Palmi (Palmae in latino),
casale di Seminara, sono giunte ai giorni nostri poche informazioni. Si narra
che da Palmi il conte Ruggero I di Sicilia radunò l'armata normanna
per muovere alla conquista della Sicilia. Dagli inizi della dominazione normanna,
fino al principio del XIII secolo, le uniche notizie riguardano le
vicende che accompagnarono i conventi di Sant'Elia lo Juniore e
di San Fantino. Le dimensioni dell'abitato nel Trecento dovevano
essere contenute, dato che la chiesa di San Nicola era l'unica
esistente.
Si rifugiò a
Palmi, nel 1495, il re Ferdinando II d'Aragona dopo aver subito
una sconfitta a Seminara contro le truppe del generale Robert Stuart
d'Aubigny.
Il centro
abitato fu colpito nel 1549 dai pirati saraceni e distrutto
interamente. Pertanto il feudatario duca Carlo Spinelli, decise di riedificare
la città fortificandola. In seguito alla sua ricostruzione la città crebbe
ulteriormente d'importanza attirando tutti i traffici marittimi delle coste
meridionali della Calabria.
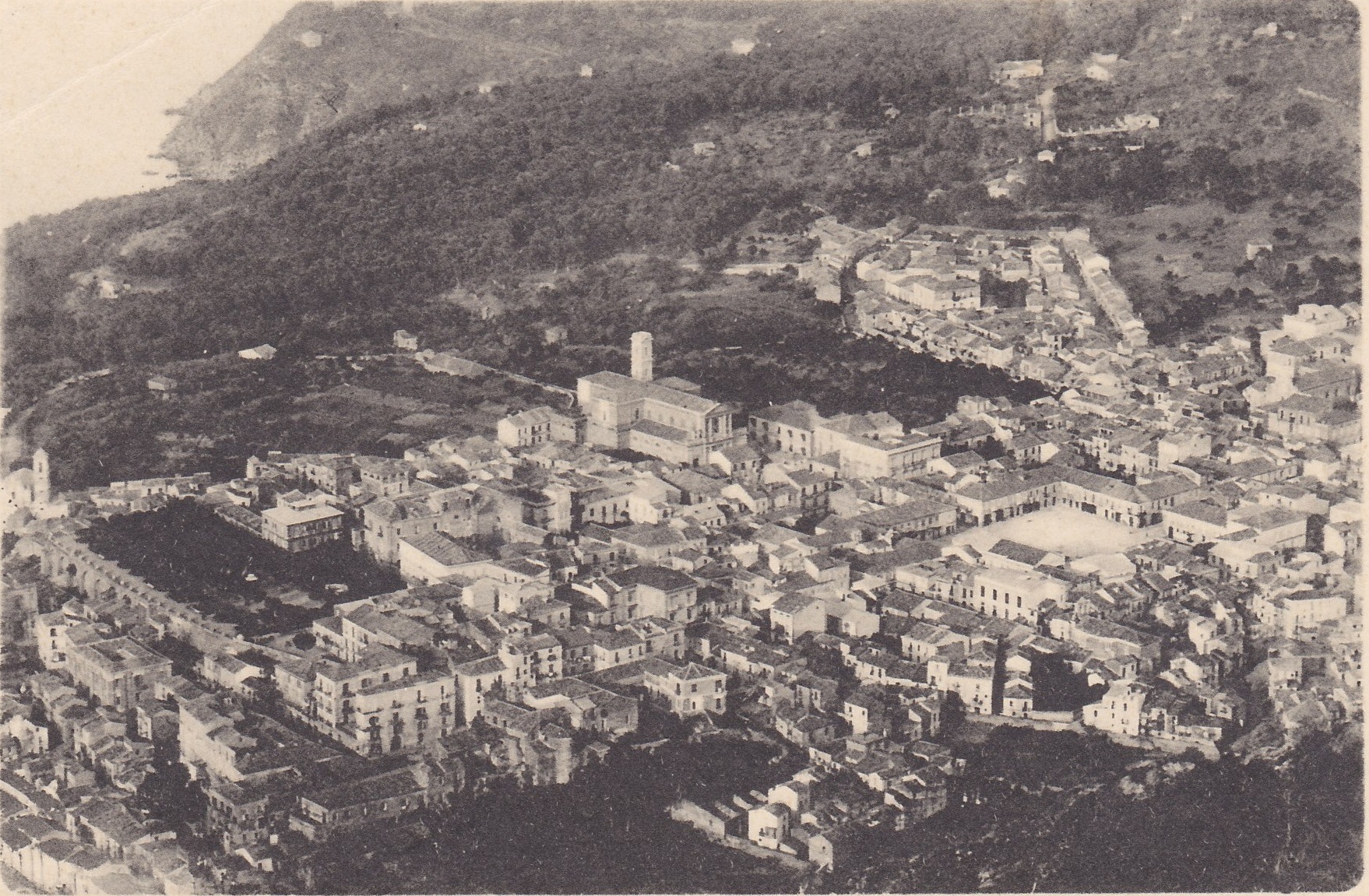
Indipendente
da Seminara nel 1632, nel XVII secolo la città si sviluppò
urbanisticamente ed economicamente grazie all'attività commerciale dei suoi
abitanti ed al marchese Andrea Concublet che le istituì una
"fiera". Le mura ad est vennero abbattute per permettere l'unione
con i nuovi agglomerati che venivano a formarsi, in conseguenza dell'aumento
di popolazione. Sempre nel XVII secolo il tessuto urbano, fino a quael momento
costituito da rioni distanti tra di loro, si concentrò intorno ad un nodo
principale formato dalla nuova "piazza del Mercato".
Nel XVIII
secolo Palmi attraversò il periodo più florido della sua storia, fino a
quando fu colpita dal Terremoto della Calabria meridionale del 1783 che
la distrusse completamente provocando circa 1.400 morti. La ricostruzione
della città avvenne seguendo parzialmente il Piano Regolatore redatto
dall'ing. De Cosiron.
La città
venne posta a capoluogo di distretto nel 1806. Nel 1860 avvenne
lo sbarco di Giuseppe Garibaldi e della spedizione dei mille alla Marina
di Palmi, e l'evento fece mettere in fuga il numeroso presidio borbonico
presente in città. Con l'Unità d'Italia, il distretto venne abrogato e Palmi
fu posta a capo dell'omonimo circondario (abolito nel 1927). Nel 1894 la
città fu epicentro di un terremoto che produsse numerose rovine e 9
morti.
Nel 1908 Palmi
venne nuovamente distrutta, quasi nella sua totalità, dal violento terremoto
del 28 dicembre, che provocò nella sola città calabrese circa 600 morti. Il
centro abitato venne ricostruito su progetto dell'ing. Pucci, stravolgendo
completamente l'assetto urbano dei secoli passati. La ricostruzione, che
interessò tutta la prima metà del XX secolo, rese gradevole l'aspetto
della città, con l'uniformità delle volumetrie, con il gusto neoclassico dei
nuovi edifici e con la realizzazione di monumenti ed opere d'arte.
Il secondo
dopoguerra vide lo sviluppo cittadino nel settore terziario, ponendo
Palmi come principale polo amministrativo, direzionale e scolastico del
versante tirrenico della provincia grazie all'istituzione di scuole di secondo
grado, strutture di forze armate, strutture sanitarie e giudiziarie e sedi di
altri enti pubblici e privati. Nel 1998 fu istituito dalla Provincia
di Reggio Calabria il Circondario della Piana, rinominato nel 2008 Circondario
di Palmi.
Concattedrale
di San Nicola vescovo
La concattedrale di San
Nicola vescovo è il principale
luogo di culto cattolico di Palmi.
È ubicata nel centro storico e prospetta sulla piazza Duomo, di
fronte al Palazzo
comunale e a fianco
degli uffici vescovili della diocesi
di Oppido Mamertina-Palmi.
Chiamata anche chiesa madre o matrice, è
sede dell'omonima parrocchia eretta nel XIV
secolo. Al suo interno è
custodita la reliquia del Sacro
Capello oltre
alla venerata icona della Madonna
della Sacra Lettera.
Tra
il 1310 ed
il 1311,
è attestata in Palmi una
chiesa dedicata a san
Nicola, che
risultava essere l'unica del villaggio. La
chiesa di san Nicola è nuovamente citata, per la prima volta come parrocchia,
in atti del 1532 e,
negli anni successivi, risulta in
commendam a vari
commendatari. Inoltre è descritta anche nella visita ex limina a Palmi di
mons. Marco Antonio
Del Tufo, vescovo della diocesi
di Mileto, nel 1586. L'edificio
sorgeva discosto dalle mura cittadine di Carlopoli e
vi avevano sede la confraternita
di san Nicola e la confraternita
del Santissimo Sacramento. Al
suo interno vi era l'altare maggiore, una
cappella dedicata al Santissimo
Sacramento e gli
altari laterali dedicati rispettivamente a san
Pietro, san
Nicola, san
Giorgio, san
Girolamo e alla Natività
del Signore.
 Nel 1664 vi
venne fondata una congrega
del "Purgatorio" o del "Sacro Monte delle cinquanta messe". In quel
secolo, nella chiesa erano
custoditi un quadro di san Giovanni che predica, di autore ignoto,
ed un quadro dell'Assunta,
opera di Giacomo
Farelli, oltre ad
essere usata anche per la sepoltura dei fedeli, cosa che si protrarrà
pure nel secolo
successivo.
Nel 1664 vi
venne fondata una congrega
del "Purgatorio" o del "Sacro Monte delle cinquanta messe". In quel
secolo, nella chiesa erano
custoditi un quadro di san Giovanni che predica, di autore ignoto,
ed un quadro dell'Assunta,
opera di Giacomo
Farelli, oltre ad
essere usata anche per la sepoltura dei fedeli, cosa che si protrarrà
pure nel secolo
successivo.
Nei
documenti della visita del 1707 di
mons. Domenicantonio
Bernardini vescovo
della diocesi di
Mileto, la chiesa
presentava l'altare
maggiore dedicato ai santi
Pietro e Paolo e gli altari laterali del Santissimo
Crocifisso, di san
Nicola, di san
Giovanni Battista, di san
Girolamo, delle anime
del Purgatorio,
di san Giuseppe,
di sant'Antonio
Abate e di san
Francesco da Paola.
Il
luogo di culto venne riedificato nel periodo tra il 1740 e
il 1743 e,
nel mentre, il 25 agosto 1741 il
vescovo della diocesi
di Mileto mons. Marcello
Filomarini, eresse la
chiesa a «insigne collegiata»
avendo ottenuto la bolla
pontificia da papa
Benedetto XIII. Nella
seconda metà del XVIII
secolo, il feudatario di Palmi Giovan
Battista Spinelli II, ne collocò il suo seggio ducale, che era stato spostato
da Seminara a
Palmi.
La
chiesa venne nuovamente distrutta dal violento terremoto
del 5 febbraio 1783. Nel marzo del 1786 il
vicario generale per il dipartimento della Piana,
riferì che si era quasi interamente riedificata, con la città di Palmi, la
sua «chiesa cattedrale» con direzione dei lavori da parte dell'ing. Pietro
Galdo. Questo nuovo
edificio di culto fu però ricostruito con materiale difettoso ed i muri, dopo
pochi anni, incominciarono a far crepe anche a seguito del terremoto del 1791.
Nel 1803 i
muri che avevano evidenziato delle lesioni negli anni precedenti, crollarono
in più parti tanto che l'edificio fu reso inagibile e le funzioni
parrocchiali vennero spostate nella chiesa
di san Rocco,
dove furono collocati temporaneamente il quadro della Madonna
della Lettera e
la statua di san
Nicola.
La
chiesa, tornata agibile, aveva dimensioni che la rendevano imponente, tant'è
che nel panorama della città il tempio si stagliava sulle altre costruzioni
dell'abitato. La collegiata però venne ulteriormente danneggiata dal terremoto
del 1894 e si
provvide ancora una volta alla sua parziale ricostruzione.
Sopraggiunse
ulteriormente il terremoto
del 1908 che arrecò nuovi
e gravi danni alla struttura pregiudicandone l'utilizzo. Pertanto, nel 1909 si
procedette alla demolizione del fabbricato e successivamente una chiesa
provvisoria venne realizzata vicino al luogo dove sorgeva la vecchia chiesa
demolita.
Nel 1915,
il Comune di Palmi affidò
l’incarico di realizzare la nuova chiesa all’ing. padre Carmelo
Umberto Angiolini e
il progetto venne approvato nel 1926. L'anno seguente venne approvato però
un nuovo progetto, redatto stavolta dall'ing. Mario
Pandelli. I lavori
iniziarono nel 1929,
realizzati dalla ditta S.I.L.A. di Roma con
fondi stanziati per la ricostruzione delle chiese dei centri terremotati del
1908. La nuova e attuale chiesa collegiata fu aperta al culto nel 1932.
Nel 1954 venne
invece realizzato ed inaugurato, su progetto dell'ing. Francesco De Luca il
nuovo campanile con funzione anche di torre civica della città. Negli anni
sessanta vi fu
l'adeguamento della chiesa alla riforma
liturgica post Concilio
Vaticano II, con
l'aggiunta di una mensa e
di un ambone marmorei.
Nel 1979 il
luogo di culto e tutta la città di Palmi passarono
dalla giurisdizione della diocesi
di Mileto a quella
nuova di Oppido
Mamertina-Palmi e il
20 giugno 1988 la
chiesa assunse il titolo di concattedrale della diocesi.
A
metà degli anni
novanta del XX
secolo, accanto alla
concattedrale furono realizzate ed inaugurate alcune importanti strutture
sociali al servizio della comunità.
Nel
periodo tra il 2001 e
il 2003,
su progetto dell'ing. Nicola Gentile, la concattedrale è stata completamente
ristrutturata con i fondi dell'otto
per mille e, in
occasione del Giubileo
straordinario della misericordia del 2016,
il luogo di culto è stato scelto quale chiesa giubilare.

Esterno
- La facciata della
concattedrale è a
salienti, ripartita
verticalmente da quattro lesene,
che si innalzano da una zoccolatura in pietra che si sviluppa per tutta la
larghezza della facciata, e da modanatura con cornice ad archetti
pensili. Nella
ripartizione centrale, di altezza maggiore rispetto a quelle laterali, è
collocato centralmente un protiro con timpano triangolare
ed un piccolo portico,
con arco a tutto
sesto sorretto da
quattro colonne, nel quale è collocato l'ingresso principale dell'edificio,
rialzato di tre gradini rispetto alla piazza. Nelle colonne sono inseriti
dei capitelli con
i simboli dei quattro
evangelisti. Sopra il
protiro è collocato invece un artistico rosone. Le
due ripartizioni laterali presentano entrambe un ingresso, rialzato sempre di
tre gradini rispetto al sagrato,
con arco a tutto sesto sormontato da una monofora. La
facciata è conclusa, nel punto più alto, da una croce in ferro.
Le
pareti laterali presentano delle lesene che
le ripartiscono in corrispondenza delle campate,
raccordate da una cornice con arco a tutto sesto nella parte bassa e da una
cornice con architetti pensili nella parte alta. Ogni campata è inoltre di
provvista una monofora nella parte bassa, che illumina la navata laterale, ed
una nella parte alta, che illumina la navata centrale. Il transetto presenta
alle estremità due facciate
a capanna con un'abside poligonale
sormontata da una trifora.
Anche la facciata tergale è a capanna e ripropone un'abside sormontata da una
trifora. All'incrocio tra il transetto e la navata centrale si innalza una
cupola ottagonale
sprovvista di aperture. Sia la facciata che la cupola sono concluse alla
sommità da una croce in ferro.
La copertura,
con manto in tegole marsigliesi
presenta numerosi spioventi, ad altezze differente ed in corrispondenza delle
divisioni interne dell'edificio.
 Torre
civica - La
Torre civica, di proprietà comunale, è collocata a lato sinistro della
chiesa. È detta anche Torre dell'orologio per la presenza di quattro orologi,
disposti su ognuna delle facce della torre, che suonano ad ogni ora con dei
rintocchi. Il monumento svolge anche la funzione di campanile della
concattedrale, poiché dotato di quattro campane (che
appartengono alla parrocchia poiché erano collocate nel campanile della
vecchia chiesa madre del XIX
secolo).
Torre
civica - La
Torre civica, di proprietà comunale, è collocata a lato sinistro della
chiesa. È detta anche Torre dell'orologio per la presenza di quattro orologi,
disposti su ognuna delle facce della torre, che suonano ad ogni ora con dei
rintocchi. Il monumento svolge anche la funzione di campanile della
concattedrale, poiché dotato di quattro campane (che
appartengono alla parrocchia poiché erano collocate nel campanile della
vecchia chiesa madre del XIX
secolo).
La torre venne
realizzata nel 1954 ed
ebbe notevoli difficoltà di costruzione, data l'altezza del manufatto di 40
metri e poiché il sottosuolo era composto da terreni superficialmente
sciolti. Pertanto il direttore dei lavori, l'ingegnere Francesco De Luca,
progettò una palificazione di 81 pali in cemento compresso, affondati nel
terreno per una quota che andava da 5 a 23 metri.
La suddetta palificazione
venne sormontata da un massiccio telaio in calcestruzzo che formò la
piattaforma sopra la quale venne innalzata la torre. Il costruttore dell'opera
fu il cavaliere Annunziato Seminara.
La
torre avente tutte e quattro facce uguali, inizia con una zoccolatura bugnata,
sopra la quale sono collocate delle trifore con archi
a tutto sesto. Nella parte
centrale disposti come detto i quattro orologi e, nella parte superiore, vi
sono delle aperture in archi
a sesto acuto nella
zona di alloggio delle campane. Infine, nella sommità della torre vi è un
tamburo poligonale sopra il quale è collocata la copertura cuspidata conclusa
alla sommità da una croce in ferro.
La
Torre civica è attualmente la costruzione più alta della città di Palmi,
ed una delle più alte della Calabria.
Interno
- Al
suo interno la concattedrale è
suddivisa in tre navate rettangolari
scandite da arcate a
tutto sesto definite
da due file di otto colonne doriche quadrangolari.
Dalle navate laterali si aprono, all'incrocio con il transetto,
due absidi laterali
corrispondenti alle
cappelle consacrate, rispettivamente, a san
Nicola ed al Sacro
Cuore di Gesù. L'abside
ottagonale che conclude la navata centrale, alle spalle dell'altare
maggiore, funge da
deambulatorio. All'incrocio
tra la navata centrale ed il transetto è
collocata la cupola ottagonale
priva di finestrature. Dalla navata destra è raggiungibile la cappella della
Madonna della Lettera.
Le
tre navate, fino al transetto compreso, corrispondono all'aula,
mentre il presbiterio, rialzato di tre gradini rispetto al resto dell'edificio, è collocato nel coro,
avente anch'esso larghezza pari a tutte e tre le navate.
Navata
destra - La parete
laterale della navata
risulta scandita verticalmente da pilastri che sorreggono arcate
a tutto sesto e che
la suddividono in sei campate prima
del transetto, più altre
due successive allo stesso. In ogni campata è collocata una stretta monofora.
La navata risulta divisa da quella centrale sempre da pilastri sormontati da
archi a tutto sesto.
Partendo
dall'ingresso, nella prima campata è collocata una base
processionale (2000)
in legno e
argento, con la quale viene portato in processione il quadro di Maria
Santissima della Sacra Lettera.
La parte lignea del fercolo venne
realizzato dall'artigiano ebanista Giuseppe Arcuri (con pigmentazione
cromatica ad opera di Rosaria Raco) mentre i bassorilievi argentei furono
realizzati dai fratelli Vincenzo e Giuseppe Simonetta.
Nella
terza campata è posizionato un dipinto,
in olio su tela,
raffigurante Sant'Anna e Maria
bambina (1937),
opera del sacerdote Vincenzo
Pugliese.
Nella
quarta campata è collocato un dipinto,
in olio su tela,
raffigurante San
Francesco d’Assisi che abbraccia Gesù
crocifisso e angeli (1935),
realizzato anch'esso da Vincenzo Pugliese.
Nella
quinta campata si trova un gruppo
scultoreo rappresentante San
Giuseppe e Gesù bambino (XVIII
secolo), in legno scolpito
e dipinto, opera di scuola
calabrese.
Nella
sesta e ultima campata prima del transetto è
posizionato l'ingresso laterale della concattedrale, che conduce all'esterno.
Nella
prima campata dopo il transetto è
posizionato un dipinto,
in olio su tela,
raffigurante la Madonna
del Rosario, mentre nella seconda è invece posto l'accesso alla cappella
della Madonna della Lettera.
Addossata
alla parete di fondo della navata è collocata una fonte
battesimale in marmo con
coprifonte in legno intagliato,
alle cui spalle è posto un dipinto raffigurante il Battesimo
di Gesù operato da San
Giovanni Battista (XX secolo).
 Completano
le opere d'arte della navata alcune Stazioni
della Via Crucis (XX
secolo), in legno
intagliato
e oleografia su
tela, opera di artisti locali.
Completano
le opere d'arte della navata alcune Stazioni
della Via Crucis (XX
secolo), in legno
intagliato
e oleografia su
tela, opera di artisti locali.
Il soffitto della
navata è formato da volte
a crociera, ognuna in
corrispondenza di una campata, mentre la pavimentazione è
in seminato veneziano.
Navata
sinistra - La parete
laterale della navata
risulta scandita verticalmente da pilastri che
sorreggono arcate a
tutto sesto e che la
suddividono in sei campate prima del transetto,
più altre due successive allo stesso. In ogni campata è collocata una
stretta monofora.
La navata risulta divisa da quella centrale sempre da pilastri sormontati da
archi a tutto sesto.
Partendo
dall'ingresso, nella seconda campata è posizionato un Crocifisso (XX
secolo), realizzato in legno e bronzo fuso,
opera di bottega calabrese.
Nella
terza campata è collocato un confessionale in legno.
Nella
quarta campata è posizionato un dipinto,
in olio su tela,
raffigurante San
Giuseppe e Gesù
bambino (1899), realizzato
dal pittore palmese di scuola napoletana Domenico
Augimeri. La tela è
considerata una delle principali opere dell'artista.
Nella
quinta campata si trova un gruppo
scultoreo rappresentante Maria
Santissima Assunta e angeli (XVIII
secolo), in legno di
tiglio scolpito e
dipinto, opera di scuola dell'Italia
meridionale, probabilmente
attribuibile allo scultore Domenico
De Lorenzo.
Nella
sesta e ultima campata prima del transetto è
posto un secondo confessionale in legno.
Sulla
seconda campata dopo il transetto è posta la porta d'accesso alla sacrestia mentre
sulla parete di fondo della navata è collocato un quadro contenente un antico stendardo appartenente
alla soppressa confraternita
del Santissimo Sacramento.
Completano
le opere d'arte della navata alcune Stazioni
della Via Crucis (XX
secolo), in legno intagliato
e oleografia su
tela, opera di artisti locali.
Il soffitto della
navata è formato da volte
a crociera, ognuna in
corrispondenza di una campata, mentre la pavimentazione è
in seminato veneziano.

Navata
centrale - Nella controfacciata è
posta, in corrispondenza dell'ingresso principale, una bussola.
La
navata risulta divisa da quelle laterali, come detto, da pilastri sormontati
da archi a tutto
sesto. All'incrocio con il transetto si
apre invece un arco
trionfale. Al livello
superiore la navata presenta pareti
laterali che
ripropongo una stretta monofora per
ogni campata.
Salendo
sopra il presbiterio,
nella navata centrale è collocato l'altare
maggiore, realizzato dal
maestro Alfarone. L'opera,
in marmo bianco policromo intarsiato,
presenta tre pinnacoli alla
cui cima sono posti ornamenti vegetali, ed un'edicola.
Nel pinnacolo centrale è raffigurato, in bronzo,
il simbolo dell'Agnus Dei. All'interno
dell'edicola è
esposta un'icona antica
di Maria
Santissima della Lettera con il Bambino (1774), realizzata
in metallo laminato
e legno scolpito
e dipinto a olio. Il quadro è opera di autore sconosciuto, probabilmente di
scuola messinese. Ai
due lati l'altare presenta due aperture ad arco
acuto, che conducono
all'interno dell'edicola, chiuse da sportelli in ferro battuto e dipinto. Di
fronte l'altare sono collocati una mensa e
un ambone in
marmo (1965).
La parete
di fondo, nella parte
alta, presenta una trifora mentre
nella parte bassa, dietro l'altare
maggiore si apre al
deambulatorio.
Il soffitto della
navata è formato da volte
a crociera, ognuna in
corrispondenza di una campata mentre la pavimentazione è
in seminato veneziano nell'aula
e in marmo bianco
sul presbiterio.
Transetto
- Il transetto si
sviluppa trasversalmente a tutte e tre le navate e
risulta scandito da pilastri cruciformi. Alle
estremità presenta delle pareti con,
nella parte alta, una trifora centrale
e, nella parte bassa, le aperture delle cappelle dedicate al Sacro Cuore di
Gesù e a San Nicola. Le uniche opere d'arte collocate nel transetto
corrispondono alle restanti Stazioni
della Via Crucis (XX
secolo), in legno intagliato
e oleografia su
tela, opera di artisti locali.
Il pavimento del
transetto risulta in seminato
veneziano, mentre il
soffitto è formato da volte
a crociera ad
eccezione dell'incrocio con la navata centrale, nel quale si innalza una cupola ottagonale
priva di finestre. Al centro della cupola risulta posizionato un
lampadario a corona (XX
secolo) in ferro
battuto e dipinto.

Cappella
del Sacro Cuore di Gesù
- All'estremità
destra del transetto è collocata un'abside a
pianta poligonale, nella quale si trova la cappella consacrata
al Sacro Cuore di Gesù.
Le pareti dell'abside
sono, nella parte bassa, rivestite in mattoni faccia
a vista e dispongono di quattro monofore,
una per lato. Centralmente è posto l'altare
laterale del Sacro
Cuore di Gesù (XX secolo),
realizzato in marmo bianco
e grigio scolpito da maestranze locali,
con sportello di tabernacolo in metallo raffigurante
la Risurrezione di
Gesù. Sopra l'altare
sono posizionate, alle due estremità, due statue di angeli reggi-candelabro mentre
centralmente è collocata un'edicola in muratura intonacata,
staccata dal resto dell'altare, contenente una statua del Sacro
Cuore di Gesù (XX secolo),
realizzata in gesso modellato
e dipinto.
L'abside
presenta una pavimentazione in marmo e
risulta separata rispetto all'aula da
un cancello di balaustra in ferro
battuto e dipinto (XX
secolo), opera di bottega calabrese.
La copertura è formata invece da una semi-cupola che
presenta policromi affreschi con
figure angeliche,
ad opera di Vincenzo
Pugliese.
Cappella
di San Nicola di Bari - All'estremità
sinistra del transetto è collocata un'abside a
pianta poligonale, nella quale si trova la cappella consacrata
a San Nicola di Bari, patrono di Palmi
e compatrono della diocesi
di Oppido Mamertina-Palmi.
 Le pareti dell'abside
sono, nella parte bassa, rivestite in mattoni faccia
a vista e dispongono di quattro monofore,
una per lato. Centralmente è posto l'altare
laterale di San
Nicola di Bari (1937), realizzato
in marmo bianco
e grigio scolpito da maestranze locali,
con sportello di tabernacolo in
metallo raffigurante l'Agnus
Dei. Sopra l'altare
sono posizionate, alle due estremità, due statue di angeli reggi-candelabro mentre
centralmente è collocata un'edicola in muratura intonacata,
staccata dal resto dell'altare, contenente una statua di San
Nicola di Bari (XIX secolo),
realizzata in legno scolpito
e dipinto e opera di scuola dell'Italia
meridionale. La
statua è stata restaurata nel 2018 dall'architetto
Amedeo Lico della Bretia Restauri di Rogliano, a seguito di raccolta di fondi
effettuata dal "Comitato Festeggiamenti Patronali di San Nicola".
Le pareti dell'abside
sono, nella parte bassa, rivestite in mattoni faccia
a vista e dispongono di quattro monofore,
una per lato. Centralmente è posto l'altare
laterale di San
Nicola di Bari (1937), realizzato
in marmo bianco
e grigio scolpito da maestranze locali,
con sportello di tabernacolo in
metallo raffigurante l'Agnus
Dei. Sopra l'altare
sono posizionate, alle due estremità, due statue di angeli reggi-candelabro mentre
centralmente è collocata un'edicola in muratura intonacata,
staccata dal resto dell'altare, contenente una statua di San
Nicola di Bari (XIX secolo),
realizzata in legno scolpito
e dipinto e opera di scuola dell'Italia
meridionale. La
statua è stata restaurata nel 2018 dall'architetto
Amedeo Lico della Bretia Restauri di Rogliano, a seguito di raccolta di fondi
effettuata dal "Comitato Festeggiamenti Patronali di San Nicola".
L'abside
presenta una pavimentazione in marmo e
risulta separata rispetto all'aula da
un cancello di balaustra in ferro
battuto e dipinto (XX
secolo), opera di bottega calabrese.
La copertura è formata invece da una semi-cupola che
presenta policromi affreschi raffiguranti angeli musicanti,
ad opera di Vincenzo
Pugliese.
Deambulatorio
- L'ultima abside,
che si apre a conclusione della navata centrale dietro il presbiterio e
l'altare maggiore, anch'essa a pianta poligonale, svolge la funzione di deambulatorio.
In
questa parte della chiesa è conservata una statua in legno scolpito
e dipinto di Sant'Elia
profeta (seconda
metà del XVIII
secolo), opera
della scuola di Giuseppe
Sammartino e un
ritratto, dipinto in olio
su tela, di monsignor Valentino
Marino (XX secolo),
opera di scuola dell'Italia
meridionale.
La pavimentazione è
in marmo,
le pareti verticali presentano una monofora per
ogni lato e la copertura è
formata da una volta
a botte.
Cappella
della Madonna della Lettera -
La cappella,
restaurata e ristrutturata nel XXI
secolo, è
a pianta rettangolare e risulta accessibile da una porta posizionata
nell'ultima campata della navata destra. La cappella è consacrata a Maria
Santissima della Sacra lettera e conserva la reliquia mariana del Sacro
Capello. Questa reliquia
è posta all'interno di un reliquiario (XVIII
secolo), realizzato da
bottega dell'Italia
meridionale, a sua volta
collocato dentro una teca, inaugurata il 29 agosto 2009 e
addossata alla parete
laterale destra della
cappella. L'opera è stata progettata dell'architetto Carmelo
Bagalà ed è
adornata da un bassorilievo dell'artista Maurizio
Carnevali. Sopra la
teca è posizionato un dipinto,
in olio su tela,
raffigurante Maria
Santissima della Sacra Lettera (XVIII
secolo).
La pavimentazione della
cappella è in ceramica mentre
il soffitto presenta
una copertura piana
costituita da un solaio in cemento
armato.
 Pag. 2
Pag. 2