|
Nella
zona orientale del territorio agrigentino, a 25 km dal capoluogo sorge Naro,
città che ha avuto grande impulso architettonico con il Barocco e le cui
testimonianze artistiche presenti oggi in città la collocano tra le più
interessanti città barocche dell'isola.
Una
delle città più antiche e pittoresche della Sicilia, dove la cultura
araba-normanna si è incontrata dando vita, nell'arte e nell'architettura,
ad opere di altissimo pregio. Dall'alto del suo monte, a quasi 600 m.s.m.
circondato per tre lati dal fiume omonimo, e con la lussureggiante Valle ai
suoi piedi, Naro doveva certamente aver affascinato i viaggiatori del
passato (Al Idriss, Ibn Gybayr, Jean Houel). Si può immaginare di
affacciarsi da un grande balcone naturale aperto sulla "Valle del
Paradiso" e sul "Mare Nostrum".
La
sua posizione elevata, naturalmente protetta, la hanno resa un luogo
particolarmente ambito. Le sue origini millenarie hanno dato vita, nel corso
dei secoli, alla leggenda ed al mito. Secondo alcuni studiosi e fra essi
Filippo Cluverio, Paolo Orsi, Fra Saverio Cappuccino, Paolo Castelli e
Salvatore Pitruzzella, rifacendosi alle testimonianze archeologiche
rinvenute in alcune parti del territorio di Naro (serra di Furore,
Dainomeli, San Gaetano, Ragamè e Castellaccio), ci viene attestata
l'esistenza di insediamenti umani in epoche remotissime (prima età del
bronzo). Notizie meno incerte, è quella che vuole Naro fondata dai Sicani
con il nome di Indara.
Altra
ipotesi leggendaria, ma suffragata da alcune fonti, è quella che ritiene
essere stata in Naro l'antico "AGRAGAS JONICUM" (680 a.C.),
colonia della greca Gela, otto anni dopo la sua fondazione (688 a.C.) e
cento anni innanzi Agrigento (AGRAGAS DORICUM 580 a.C.). E' certo comunque
che le origini della Città precedono l'onda della penetrazione fenicia e
greca e, naturalmente, l'occupazione romana.
L'ipotesi
più probabile ed accettata da molti senza contrasti, è quella che vuole
essere stato in Naro il Castello di Mothyum o Mòtyov, di cui parla Diodoro
, assalito e preso a tradimento da Ducezio di Nicea (odierna Noto), re dei
Siculi, nel 452 a.C. e riconquistato dagli Agrigentini l'anno dopo (451
a.C.). Una fortezza posta in cima al colle e custodita da un presidio
agrigentino, tra quelle volute da Falaride, tiranno di Agrigento (570-555
a.C.) a presidio del suo vasto territorio, situata lungo il tragitto
Agrigento-Gela, mentre la città continuò a chiamarsi Akragas Jonicum fino
al tempo del tiranno Fintia (276 a.C.), che volle che tutto il sito fosse
chiamato Mothyum, come il Castello. Ciò è avvalorato anche dalle
innumerevoli monete trovate del periodo greco e da vario materiale
archeologico dell'epoca.
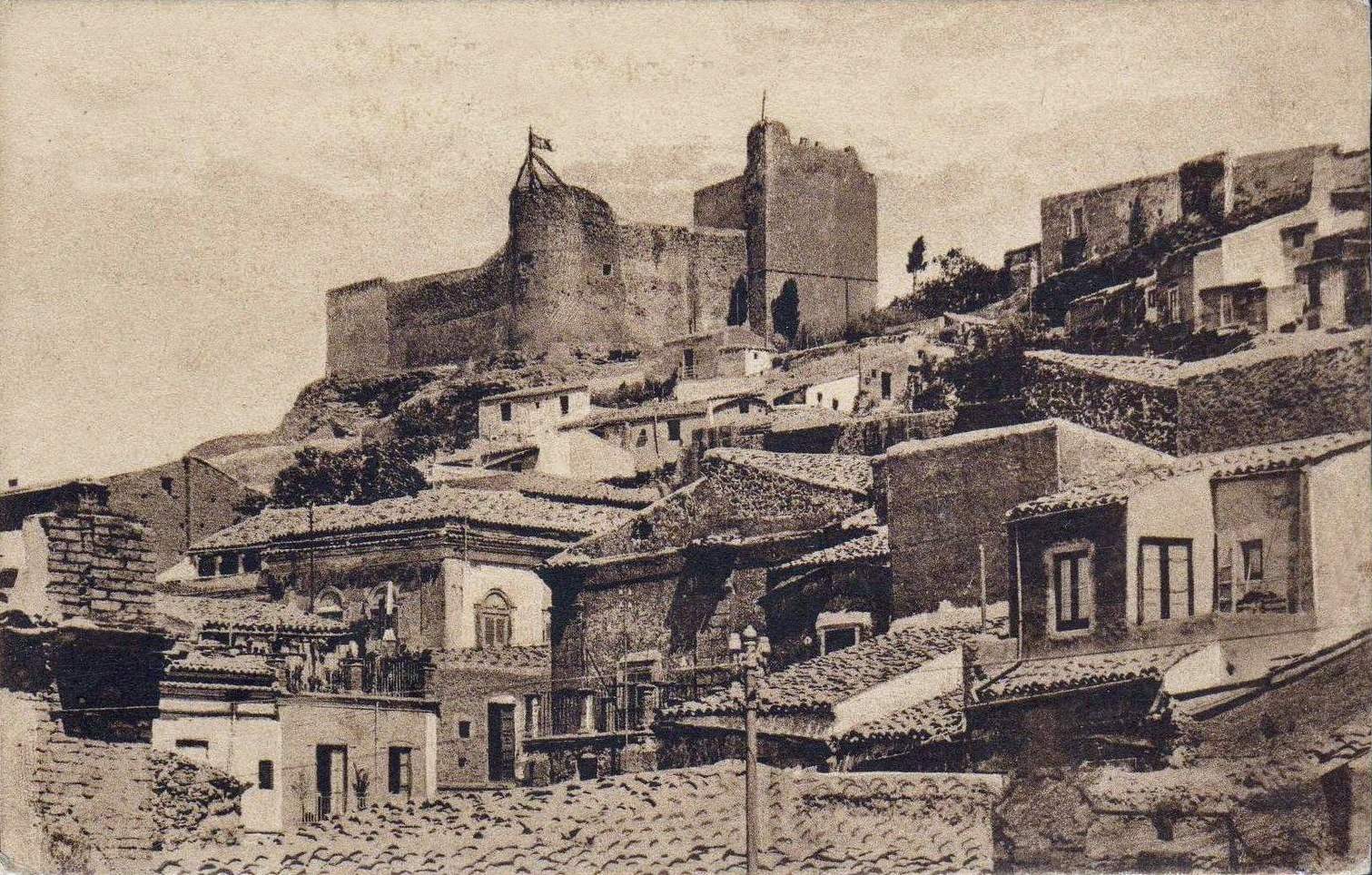
Altri
farebbero derivare la sua origine dai Fenici ed il suo toponimo dal fenicio
"NAHAR", che vuol dire "fiamma", poiché dicono essere
stata in quel colle una vedetta, donde per mezzo di fiamme
"ammonivasi" le genti d'intorno a guardarsi dalle insidie dei
nemici. Naro, infatti, nel 406 a.C. entra a far parte del dominio punico e
sotto Caratagine, faceva parte di una rete di collegamento di vedette, che
andava da Licata a Selinunte.
Ma
l'ipotesi più suggestiva resta quella che identifica Naro con Camico, dal
fiume che le scorreva vicino, la mitica Città costruita da Dedalo, il
divino architetto del labirinto di Creta, per Cocalo, leggendario re dei
Sicani, e dove Cocalo trasportò la sua reggia ed i suoi tesori. A questo
punto Camico sorgeva vicino Acragante, separate l'una dall'altra dal fiume.
Presa a tradimento, distrutta e rasa al suolo nel 256, dai Romani durante la
prima guerra punica, gli abitanti che scampano si rifugiano nella vicina
Inico, alla quale alternarono il nome Inico o Indara in Naro o che così
chiamarono a ricordo del maestro di Dedalo, che si chiamava NARO, come dice
Pausania (Periegesi) e Diodoro Siculo. Ma l'opinione più diffusa è che
Naro, fabbricata sull'altezza di un monte, prenda la sua origine dai
Saraceni, che le diedero nome Nar - che secondo il loro idioma vuol dire
fiamma (Nar-Urbs ignisFulgentissima), volendo con ciò alludere a quei segni
che in tempo di guerra si facevano con fiaccole sulla vetta dei di lei
monti. E ciò è errato perché Naro all'epoca della conquista araba
(Berberi) era già un fiorente casale, con un castello importantissimo, che
formava uno dei centri di strategia con Sutera, Cammarata, Castronovo e
Castrogiovanni e Butera.
La
dominazione araba durò fino a quando nel 1086 l'ultimo emiro di Naro, Al
Qasim ibn-Hammùd, si arrese al Conte Ruggero, che dopo aver conquistato il
25 luglio Agrigento, con una manovra lampo espugnava tutte le fortezze
intorno Agrigento, comprese Naro, Ravanusa, Muculufa, Bifara e Licata. La
leggenda narra che il Conte fece uccidere tutti gli uomini validi...ed ecco
perché nel territorio di Naro esistono molte belle donne con gli occhi
verdi o azzurri. Naro, pertanto, ha avuto parecchi nomi nel corso dei
millenni Agragante, Agragas Jonicum, Inico, Indara, Camico, Nahar, Mothyum,
Corconia, Nar.
Durante il
periodo romano la città, che probabilmente portava il nome di Carconiana,
acquisisce una vocazione agricola che ne caratterizzerà la storia dei
secoli successivi.
Nel suo
territorio esistono resti di insediamenti paleocristiani, in particolare
delle catacombe, e di ville
romane. In territorio di Naro nacque San
Gregorio vescovo d'Agrigento.

Della
storia della città durante il periodo bizantino non si hanno molte notizie,
sicuramente il centro urbano conosce un periodo di sviluppo e prosperità
dopo la conquista araba avvenuta nell'839 ad opera dell'emiro Ibn
Hamud, saranno proprio gli arabi ad intuire l'importanza strategica
del centro urbano, in ottima posizione per controllare il territorio
circostante da sfruttare con l'agricoltura ed al centro dei commerci poiché
lungo la strada di collegamento fra Agrigento e Catania.
La città durante il periodo arabo venne dunque ampliata e fortificata e
permise all'emiro Ibn Hamud di resistere alla conquista normanna fino al 1086,
quando Naro, dopo quattro mesi di assedio, cadde ad opera del Conte
Ruggero, ben quattordici anni dopo la conquista di Palermo.
Lo stesso Conte Ruggero, poco dopo la conquista della città trasformò la
moschea in chiesa Madre stabilendovi il decanato della diocesi
di Girgenti.
Con gli svevi, venne nominata città parlamentare e
chiamata "Fulgentissima" da Federico
II di Svevia, che le diede tale titolo nel parlamento di Messina del 1233 annoverandola
fra le 23 Regie o Parlamentarie del Regno
di Sicilia. Ogni città demaniale del regno venne posta a capo di una comarca,
suddivisione che si mantenne fino al 1793,
quando le comarche vennero sostituite dai distretti e il territorio di Naro
fu smembrato e inserito nel distretto di Girgenti.
La comarca di Naro comprendeva gli attuali territori di Canicattì,
Sommatino, Delia, Camastra, Grotte, Racalmuto, Castrofilippo e Campobello di
Licata.
Nel 1263,
secondo quanto riportato da Fra
Saverio Cappuccino, la città viene dotata di una cinta di mura
fortificate, che però sono probabilmente il rifacimento e ampliamento di
precedenti strutture arabe. Sulle mura vennero originariamente aperte sei
porte: la porta della Fenice, la porta S. Giorgio e la porta
d'Oro (o porta Vecchia) sul versante settentrionale, la porta di
Girgenti e la porta dell'Annunziata sul versante meridionale, la porta di S.
Agostino ad ovest.
Una settima porta venne aperta a sud-est nel 1377: la
porta di Licata. Prendendo parte ai Vespri
siciliani la città si libera dai francesi con una sanguinosa
rivolta che si conclude il 3 aprile 1282 con
l'uccisione del governatore Francesco
Turpiano e di tutti i francesi a guardia del castello. Naro
deciderà allora di reggersi da sola sotto la guida del governatore francese Ognibene
Montaperto.

Gli inizi
del secolo
XIV sono un periodo d'oro per la città, sotto la castellania di Pietro
Lancia la rilevanza politica della città cresce a tal punto che
il re Federico
III d'Aragona promulga dal castello
di Naro i 21 capitoli per il buon governo delle città nel 1309
(nel 1324 secondo alcuni studiosi). Seguirà a questo periodo una
decadenza economica causata da mezzo secolo di lotte interne, decadenza che
verrà superata a partire dal 1366 quando
la città passa a Matteo
Chiaramonte ed inizierà così un intenso periodo culturale ed
artistico durante il quale viene costruita la chiesa di Santa Caterina,
viene definito l'Oratorio di S. Barbara, si amplia il castello e
probabilmente viene anche restaurata ed ingrandita la matrice che
sul finire del secolo ottiene il titolo di Duomo da re Martino
il Giovane.
Fino al
1492, anno in cui fu emessa l'ordinanza di bando degli Ebrei dalla Sicilia
emanata da Ferdinando
II d'Aragona, Naro ospitò una comunità
ebraica.
Ottenne il
titolo di città nel 1525 quando,
per petizione presentata al Real Parlamento di cui Naro occupava il 18º
posto del braccio demaniale dal magnifico naritano Don
Girolamo D'Andrea, si vide concedere tale titolo (fino ad allora si
chiamava "terra del demanio di Naro") da Carlo
V, che per mezzo del suo viceré, il Duca di Monteleone concesse alla
città anche il privilegio del Mero e Misto Impero, autorizzandola
quindi ad esercitare giustizia civile e penale da sé (di tale privilegio
godevano all'epoca solo Palermo e Messina in
tutta la Sicilia).
Nel 1615 venne
nominata capo comarca dal Parlamento Generale svoltosi a Palermo.
Nel 1645 ottenne
anche il privilegio del Bussolo Senatorio (da qui la sigla S.P.Q.N.
nello stemma della città), tramite il quale i giurati e i patrizi venivano
eletti ogni anno direttamente dal consiglio cittadino e i primi prendevano
il titolo di senatori. Il XVII e
il XVIII
secolo rappresentano un periodo di particolare splendore per la
città durante il quale i diversi ordini monastici presenti costruiscono o
rinnovano diverse chiese e monasteri che caratterizzano il tessuto urbano
della città attuale.
Il 4
febbraio del 2005 il comune è stato colpito da una frana che ha messo in
pericolo gran parte del centro storico. Circa 70 abitazioni sono state
dichiarate inagibili, diverse sono state abbattute. Centocinquanta persone
sono state sfollate in abitazioni di fortuna.
Castello
chiaramontano

È
forse il monumento più famoso di Naro, la cui storia s'identifica con le
sue vicissitudini. Si può affermare che il castello è la stessa ragione
d'essere della Città, perché senza di esso, forse, Naro non sarebbe stata
una realtà od il suo divenire avrebbe avuto altre manifestazioni.
Il
sito fu certamente scelto non solo per le sue caratteristiche di
difendibilità, ma per quelle connesse con il controllo dell'ampia e ferace
vallata. Per cui, sotto gli Arabi prima e sotto i Normanni ed i Chiaramonte
dopo, il Castello assunse non solo la difesa militare limitata alle esigenze
locali, ma anche quello d'elemento fondamentale per la struttura e
l'organizzazione territoriale di un vasto comprensorio inserito, in altre
parole, nel sistema di controllo dell'isola, quale presidio territoriale
strategico.
Tale
posizione, mantenuta ed accresciuta nei secoli, fece sì che Naro, crogiolo
di civiltà, di storia e d'arte, ed il suo Castello diventasse teatro
d'importanti avvenimenti, alcuni dei quali hanno perfino inciso sulla storia
dell'Isola. Imponente nel suo profilo di pietra gialla, il Castello sembra
vigilare ancora oggi sia sulle vecchie case dell'antico "borgo",
quasi accucciate sotto le possenti ali del vecchio Maniero, sia sugli
edifici della parte nuova della Città evocando, immoto testimone, immagini
che conservano intatto il sigillo del tempo.
Percorrendo
il lastricato della via Archeologica che inizia dirimpetto al convento delle
Suore di Carità od ascendendo la spettacolare scalinata completa di n. 156
scalini, realizzata nel 700, antistante il Duomo Normanno, si giunge ai
piedi del "Mastio-Dedalico", com'era anche chiamato in epoca
lontana, poi detto comunemente dei Chiaramonte, dal nome dell'antica e
nobile famiglia che governò Naro per più di un secolo, discendente da
Federico Chiaramonte dei Clermont di Piccardia d'Auvergen, che aveva sposato
Marchisia Profolio dei Signori di Ragusa e Conti di Caccamo.
 Secondo
alcuni storici e fra essi Pancrazio, Polieno, Frontino e Placido Palmeri, la
suo origine è leggendaria. È collocato nell'età di Cocalo, il mitico re
dei Sicani, di cui era la primitiva fortezza. Secondo
alcuni storici e fra essi Pancrazio, Polieno, Frontino e Placido Palmeri, la
suo origine è leggendaria. È collocato nell'età di Cocalo, il mitico re
dei Sicani, di cui era la primitiva fortezza.
Quel
che è certo che preesisteva alla conquista degli arabi, che lo ingrandirono
e lo fortificarono. Ospitò varie volte Federico II d'Aragona, che nel 1330
vi fece aggiungere la massiccia torre quadrata, alta m. 21 e larga per ogni
facciata m. 13, come testimonierebbe lo stemma araldico della Casa Aragonese
sul lato occidentale della facciata.
Fu
rimaneggiato in epoca chiaramontana, quando Matteo Chiaramonte ottenne la
Signoria di Naro. Sembra che nel periodo arabo le dimensioni del castello
siano state più estese, fino ad arrivare al Vecchio Duomo, allora moschea,
con un ampio circuito di mura che arrivava alla casa del conte Arrigo Rosso
di San Secondo, vicino la porta Vecchia e, si dice, che poteva ospitare una
guarnigione d'otto mila uomini.
Pare
che nell'anno 828 sia stata sede dell'emiro Salem, il fondatore di Salemi,
messo a governare con mille uomini dall'emiro Abu Dekak, che aveva già
conquistato Naro nel marzo dell'828 e nell'anno 829 dall'emiro Abd Allàh el
Chalid ben Jshak. Ed, in seguito dall'emiro Ibn Al Abbas, che talvolta
ricusò il denaro e volle piuttosto uomini, del Kaid Alì-Ibn-Hawwas. Dal
1081 al maggio 1089 rimane sotto la signoria di Ibn-el-Werd, Signore di
Girgenti, Siracusa, Noto e Catania.
Le
cronache dicono di lui che scannò i prigionieri e fin le suore di un
convento trasse nello harem di Siracusa. Lo spavaldo arabo muore, annegato,
combattendo contro il Gran Conte.
A
questi succede l'emiro Al Qasim ibn-el-Hamud, l'ultimo Signore arabo di
Naro. Anticamente isolato in un pianoro, domina tutta la città e la ferace
vallata.
Munito
d'alte mura, si articola intorno ad un ampio cortile non accentrato e tutto
intorno una serie di vani, un tempo adibiti a scuderie ed abitazioni degli
armigeri.
È
costruito con elementi decorativi in pietra da taglio a faccia vista. La
torre quadrata rivestita con accurato paramento murario in conci squadrati,
presenta sul lato nord-est due belle bifore archiacute, le cui due colonnine
di marmo sono state sottratte, con grave danno, perché, uniche finestre di
epoca chiaramontana della prima metà del trecento, poggiate su una grossa
cornice, che delimita i due ordini.
A
mezzo di una scala rampante ed attraverso un bellissimo portale ogivale,
artisticamente decorato con motivi chiaramontani, si accede al Salone della
Torre, in altre parole alla cosiddetta Sala del Principe o dei Baroni,
illuminata dalle bifore succitate, con copertura a botte a sesto acuto,
formata da blocchetti di pietra arenaria, proveniente da una cava, da
qualche tempo abbandonata, esistente in contrada Donato, rinforzata da un
arco mediano traverso, sistemato su pilastri semicircolari a base
semiottagonale e capitelli floreali.
Sopra
di questa, salendo per una scala di pietra, vi è un porterra, ornato di
muraglia merlata, ove nell'angolo di levante e mezzogiorno, vi era una
garitta di guardia, la cui veduta si estendeva dall'Etna al mare Africano di
Sciacca e tutt'intorno quasi all'infinito. Dichiarato Monumento Nazionale
nel 1912 per opera del Comm. Dr. Domenico Riolo, per parecchi anni è stato
adibito a carcere mandamentale.
Il
castello è attualmente visitabile e presenta al suo interno la Mostra
permanente dell'abito d'epoca "Vento di donne", raccolta di
abiti (per lo più femminili) e accessori di fine Ottocento e inizio
Novecento.
Al
suo interno è stata recentemente ospitata la mostra itinerante Il
genio di Leonardo, raccolta di riproduzioni di opere del maestro
toscano Leonardo
da Vinci. La mostra,
curata dall'associazione Anthropos, è stata inaugurata il 28 marzo 2009.

Il
fantasma del Castello - Come
ogni castello che si rispetti anche questo di Naro ha i suoi ricordi di
sangue e di delitti. Un'antica leggenda narra di Madonna Giselda, la
castellana dalle chiome nere e dagli occhi azzurri, che innamoratasi del
proprio paggio Beltrando ebbe un tragico destino. In una notte di luna
piena, mentre Beltrando le cantava sulla terrazza il suo amore,
accompagnandosi con le dolci note del liuto, furono sorpresi dal geloso
marito, Pietro Giovanni Calvello allora Signore di Naro:
- Silenti
nubi che nel ciel vagante,
- bianche
come barchette in alto mare,
- a
quel meta ne tende il vostro andare,
- lontano,
lontano, e dal zefero portate?
- Squallido
tutt'intorno è l'immenso,
- romito
il colle e triste la paura,
- che
mette all'alma un senso di paura.
- Il
picciol fiume scorre terso terso,
- e
i rai riflette de la fredda luna
- che
in alto e fra le stelle guarda e tace
- Il
mondo senza speme e senza pace,
- cadono
scialbe le foglie ad un ad una,
- lente
ed avvizzite giù nella foresta.
- Così
… l'uman vita passa mesta…
Il
giovane paggio fu ucciso e gettato dall'alto della torre. Giselda, richiusa
in una fredda e buia cella, si lasciò morire di fame e di dolore.
Dice
la leggenda che, ancora oggi, nelle notti chiare d'autunno un bianco
fantasma di donna vaga sulla terrazza del castello: è madonna Giselda alla
ricerca dell'amato Beltrando. E quando si siede nel vano di una merlatura a
contemplare il creato, un usignolo sale dai sottostanti giardini e, fattele
appresso, con melodiosi gorgheggi canta una struggente e dolorosa canzone.
E
la gente, ricordando questa tragica storia d'amore con commossa fantasia,
narra ancora oggi di un bianco fantasma di donna, che nelle notti chiare di
luna, vaga perdutamente sugli spalti del castello alla ricerca dell'amato
Bertraldo.
 Reggia
di Cocalo, "Castellaccio" Reggia
di Cocalo, "Castellaccio"
A
circa due chilometri di distanza da Naro, vi è il Castellaccio. Questo
luogo testimonia l’esistenza di un’antica fortezza edificata dai Sicani
nel 1240 a.C. circa; alcuni storici reputano che si tratta di Camico la
capitale del leggendario regno di Cocalo, re dei Sicani. Essa sorge su un
altopiano quadrilungo che regala un panorama strabiliante.
Sono
sopravissute all’intemperie del tempo: degli avanzi di mura ciclopiche,
un’antica scala che forse conduceva alla porta della città e numerose
grotte. Emblematico è la torre, che secondo alcune testimonianze, insieme
alla torre sulla cima di Naro con quella che era situata sul colle
Caravello, costituivano le cosiddette ‘tre torri’ rappresentate sullo
stemma della città di Naro, anche se altri fonti credano che lo stemma
rappresenta le torri presenti nella mira urbiche della città di Naro.
Mura
e porte urbane
Naro,
come tutti i comuni del periodo medievale, era chiuso da una cinta di solide
mura merlate, la cui costruzione si fa risalire al 1263. Furono rafforzate
nel 1482 e delimitavano un'area pressoché romboidale.
Nel
suo perimetro erano valide opere di difesa militare, la torre della
collegiata (Duomo), la torre di San Secondo, la torre della Fenice (in
corrispondenza dell'odierna Via Madonna della Rocca) e la Torretta.
L'unico
reperto ben visibile delle mura è la porta Vecchia, che testimonia il
sistema costruttivo realizzato in pietra con arco ogivale ed eleganti
merlature.
La
cinta muraria, di cui il tracciato originale c'è dato da un dipinto del XIV
secolo, conservato nel Santuario di san Calogero, era controllato da sette
Porte, simili alla Porta Vecchia.
Le
porte d'accesso alla Città nella parte alta erano: Porta della Fenice,
Porta San Giorgio (nei pressi del castello), Porta Vecchia (nell'odierna via
omonima) o Porta d'Oro, per il colore delle monete circolanti nel vicino
ghetto degli Ebrei e per il frumento che ne entrava e che proveniva dalle
ricche terre sottostanti, attraverso la reggia trazzera dei Molini, che
metteva in comunicazione Naro e la parte nord-orientale della Comarca.
Molto
importanti sono le porte della zona bassa, perché ognuna immetteva da una
parte verso la campagna circostante, tramite trazzere e dall'altra
immettevano in veri e propri assi stradali.
La
porta Sant'Agostino, ex Porta Palermo, ad Ovest, che mutò nome dopo
l'erezione del Convento agostiniano, che segna l'imbocco della Via
Laudicina, con in fondo il convento dei frati agostiniani, a sud la Porta
Girgenti all'inizio della via Lucchesi in asse con il castello ed il duomo;
Porta Trinità, che nel 1480 muta il nome in porta Annunziata per l'erezione
del nuovo convento e della Chiesa del Carmelo, all'inizio della via Specchi
e la Porta Licata, aperta nel 1377 per volere di Matteo Chiaramonte, segna
l'inizio di quello che dal seicento in poi diventerà l'asse stradale più
importante di Naro, cioè la via Maestra e dei Monasteri, l'odierna via
Dante Alighieri.
Fino
al 1810, nel giorno dell'Ascensione, una singolare processione, che aveva
inizio dalla Chiesa della Madonna della Rocca, percorreva la cinta muraria
per la benedizione delle mura.
Porta
d'Oro

La Porta
d'Oro (o Porta Vecchia) è l'unica rimasta delle sei porte che
permettevano l'accesso alla città di Naro nel
periodo medievale.
La
porta fu edificata insieme alle mura di cinta della città, che delimitavano
un'area romboidale, nel 1263.
Nel 1482 le
mura furono restaurate ma nel XVIII
secolo, venute meno le
funzionalità difensive, furono man mano distrutte. La porta d'oro
rappresenta uno dei pochi tratti della cinta muraria conservatisi pressoché
intatti fino ai giorni nostri. Il suo nome deriva dalla presenza della
dogana e dalla conseguente ricchezza proveniente dai commerci degli ebrei
della locale comunità
ebraica che
proprio vicino a tale porta avevano il loro ghetto e dalla gran quantità di
frumento che, proveniente dalle campagne sottostanti, entrava in città
attraverso tale porta.
La
porta è costituita da un arco a
tutto sesto ed è sovrastata da merli, nei tratti di mura ad essa
circostanti sono state oggi ricavate delle abitazioni.
Duomo
Normanno

Il Duomo
Normanno è un ex luogo
di culto cattolico.
Esso è monumento
nazionale ed è chiuso al culto dal 1867.
Esso
venne edificato nel 1089 ad
opera di Ruggero
D'Altavilla al di sopra di una preesistente moschea araba poco
dopo la conquista normanna di Naro avvenuta nel 1086 e
venne dedicato a Maria
Santissima Assunta dagli Angeli. Venne elevato a Chiesa Madre,
ad opera di Gualtiero
Offmill Arcivescovo
di Palermo, nel 1174,
anno in cui venne abbandonato il rito ortodosso nella Chiesa
di San Nicolò di Bari.
Nel 1266 (la
seconda domenica di maggio) venne consacrato alla Vergine
Annunziata, alla presenza del cardinale Rodolfo, Vescovo
d'Albano e legato apostolico di Papa
Clemente IV, insieme agli arcivescovi di Palermo e
di Bari ed
ai vescovi di Agrigento,
di Mazara e di Patti.
Sul
finire del secolo
XIV ottiene il titolo di Duomo dal re Martino
il Giovane.
Il
portale d'ingresso è di epoca chiaramontana e presenta un caratteristico
arco a sesto acuto poggiato sopra un gruppo di quattordici colonnine,
riccamente modulato ed ornato da zig-zag e palmette.
L'interno
fu totalmente rinnovato in età barocca e mantiene pochi resti della
originaria ornamentazione in stile corinzio, che però può essere rinvenuta
nel cornicione, nelle colonne e nei capitelli.
Si
presenta ad impianto a croce latina con cupola ad intersezione dell'unica
navata con il transetto. L'interno è modulato secondo un ordine di colonne
addossate ai muri della navata, sormontate da cornici da cui si dipartono
dei costoloni trasversali in conci di tufo d'irrigidimento della copertura a
botte, oggi restaurata.
 La
chiesa costruita quasi interamente in pietra tufacea, lunga m. 50,60 e larga
m. 9,50, è dotata di corpi laterali aggiunti in successione tale da non
rispettare alcuna simmetria. La
chiesa costruita quasi interamente in pietra tufacea, lunga m. 50,60 e larga
m. 9,50, è dotata di corpi laterali aggiunti in successione tale da non
rispettare alcuna simmetria.
In
particolare nel 1565 vi fu aggiunta, da Bernardo Lucchesi Palli di
Campofranco, la cappella maggiore, dedicata alla Madonna della Catena, un
tempo Patrona della Città di Naro, in cui si trovava una statua, opera di
Gagini, che ora si conserva nella Chiesa Madre, inglobando un'antica torre
araba.
Nel
1771 per volere del vescovo d'Agrigento, Antonio Lanza, fu restaurata dagli
architetti Gaetano e Giuseppe Bennica d'Agrigento e completata dopo 17 anni.
Nel
1788 fu affrescata da due stucchisti palermitani, Emanuele Ruisi ed il
figlio Domenico, mentre mastro Ignazio Citillo ed Amedeo Vella, artisti
naritani, la ornarono d'arabeschi.
La
volta nella parte centrale, prima del crollo, mostrava magnifici affreschi
eseguiti da D. Provenzani, il famoso pittore di Palma di Montechiaro: Maria
Assunta, Aronne con l'incenso, Davide con l'arpa, Mosè con le tavole della
legge, Giosuè in atto di fermare il sole e Giuditta che libera il popolo di
Betulia.
Della
Signoria dei Chiaramonte ci resta il bel portale d'ingresso, restaurato nel
1818, sebbene corroso dal tempo, con il suo caratteristico arco a sesto
acuto, poggiato sopra un gruppo di quattordici colonnine, riccamente
modulato ed ornato a zig-zag e palmette, rappresenta uno degli esempi più
perfetti di raffinatezza e di preziosità formale raggiunta dall'arte
chiaramontana.
Nel
vestibolo della chiesa, sulla destra della porta d'ingresso, una rustica
nicchia trecentesca con arco e linee spezzate. L'interno, totalmente
rinnovato in tarda età barocca mantiene pochi resti della ricca
ornamentazione di stile corinzio originaria, rivelabile ampiamente nelle
colonne, nei capitelli e nel cornicione.
Nell'interno
si poteva ammirare un magnifico affresco del sec.XV (ora presso i locali
della Biblioteca Comunale) che raffigura Maria SS. Assunta in cielo, con
dodici figure denotanti gli apostoli (foto 28).
Manca
la testa della Madonna (b), toltavi con arte da persona del mestiere e che
farà bella mostra di sé in qualche museo di Londra o di Parigi, come
frammemto d'affresco d'Antonello da Messina, come lamenta il Pitruzzella. Fu
chiusa al culto nel 1867 e destinata in seguito a cimitero dei morti di
colera nel 1889 e la maggior parte delle opere d'arte ivi custodite fu
portata in altre chiese. Era sede della Confraternita dello SS.Sacramento,
formata da nobili e sacerdoti, fondata nel 1700, che si mantenne fino alla
metà del 1800, al tempo del Rev.do Priore Francesco Costa. Il Viatico è
ora celebrato dalla Chiesa Madre con una solenne processione.
Santuario
e Chiesa di San Calogero

Il
santurario venne edificato nel 1599 al
di sopra della "grotta" di san
Calogero, dove la tradizione vuole che il santo nero abbia dimorato
per una parte della sua vita. La facciata, più volte ripresa, ha aspetto
barocco. L'ultimo rinnovo risale al 1954.
L'interno è ad unica navata e conserva diversi dipinti fra i quali alcuni
raffigurano san Francesco, la Pietà e san Lorenzo Giustiniani.
Non
si hanno notizie storiche del periodo in cui fu costruita la chiesa di San
Calogero. Si dice, però, che la fondazione della chiesa è stata anteriore
al convento. Pare, infatti, che una chiesa dedicata a San Calogero sia stata
edificata verso il 1436, al tempo di Papa Eugenio IV, mentre il convento fu
fondato dai RR. PP. di San Giorgio in Alga nel 1543, sotto il pontefice
Paolo III.
Il
29 giugno dello stesso anno, la chiesa fu concessa dal vescovo d'Agrigento
P. Pietro D'Aragona e Tagliavia ai PP. RR. di San Giorgio in Alga, essendo
giurati della Città Placido Camastra, Giovan Battista Gueli, Antonio Di
Sazio e Giulio Mazza.
I
RR. PP. di San Giorgio in Alga, chiamati così perché avevano la loro casa
principale nell'isola di San Giorgio in Alga a Venezia, furono fondati
all'inizio del 400' da alcuni nobili fiorentini, abbellirono ed ingrandirono
la chiesa e tennero la medesima ed il convento fino all'abolizione del loro
ordine. Il complesso religioso, quindi, fu acquistato dai RR. PP. Minori
Conventuali di san Francesco (con atto del 4 aprile 1672, rogato dal notaio
Lorenzo Favara), per la somma di cinque mila scudi, con la condizione di
mantenere lo studio di Filosofia e vegliare sul culto del Protettore San
Calogero.
La
chiesa, restaurata varie volte nel 1666, nel 1748 (anno inciso
nell'architrave della porta principale), nel 1819 (fu riportata alla luce la
cripta del Santo), nel 1950 e nel 1957, ad unica navata con profonda abside,
dipinta da D. Bennardino Buongiovanni e da P. Domenico Di Miceli, rispecchia
l'impianto seicentesco.
Dal
santuario, scendendo delle scale, è possibile accedere alla cosiddetta
grotta di San
Calogero, una cappella all'interno della quale è conservata, sopra
l'altare principale, la statua del Santo nero realizzata da F. Frazzatta nel 1556,
e completata dopo la sua morte dalla figlia.
All'interno
della cappella è sepolto il corpo della venerabile suor
Serafina Pulcella Lucchesi, nobile narese alla quale, secondo la
leggenda, il santo apparve in sogno durante la pestilenza che nel '600 colpì
la città per annunciarle che per sua grazia la peste sarebbe presso
cessata.


Nella
parte sinistra della cappella si trova la vera e propria grotta dove il
santo abitò durante la sua vita, al suo interno si trova un affresco
raffigurante il santo inginocchiato in preghiera oltre ad una copiosa
quantità di ex voto lasciati dai fedeli nel corso degli anni.
La
cripta è stata restaurata da Umberto Colonna da Bari, lo stesso artista che
ha dipinto anche la figura di San Calogero in preghiera all'interno della
grotta, mentre è stata indorata da Cocò Schembri, quando fu pure rinnovato
il settecentesco altare da Tito Vaccaro, maestro ebanista, entrambi nostri
concittadini.
Varie
opere, degne di nota, della prima metà del secolo XVIII, si conservano
nella chiesa insieme a numerosi dipinti d'autori anche contemporanei.
Notevole
è la cappella (700) dedicata a Santa Lucia, affrescata con scene della vita
della Santa di Siracusa, l'altare marmoreo del 1444, scolpito a bassorilievo
con l'adorazione del SS. Sacramento.
Ed,
altresì, un Cristo alla colonna, molto curioso, in marmo le cui particolari
venature imitano il sangue sparso sul corpo flagellato, opera di maestranze
trapanasi.
Il
prospetto esterno, forse dovuto a Giovanni Biagio Amico od a Rosario
Gagliardi, mostra i suoi partiti architettonici più rilevanti nella
facciata principale convessa, divisa in duplice ordine, di gusto barocco, in
cui risalta il portale principale d'ingresso in pietra da taglio.
Notevole
è anche il coevo portale laterale secondario, legato a formule rococò,
diviso in due sezioni, l'inferiore fiancheggiato da due colonne per lato,
poggianti su alti piedistalli ed a corpo avanzato rispetto al parametro
murario e terminanti, con raffinati capitelli corinzi, su cui poggia una
cornice, dove si eleva una cappelletta al centro della quale v'è l'affresco
di San Calogero con la cerva ed il cacciatore Arcadio.
Attualmente
la chiesa ed il convento è sede dei P. Guanelliani, che con il loro
costante impegno in campo spirituale e sociale, mantengono l'attività del
Santuario in crescente dinamismo, ultimamente con la lodevole iniziativa
dell'istituzione di una Casa-Albergo in favore degli anziani.
La
festa di san Calogero - Il santuario è meta di molti fedeli che vengono
a ringraziare il Santo per le molteplici grazie ricevute, uno dei modi più
caratteristici di ringraziare il santo consiste nel portare al Santuario
delle forme di pane modellate come le parti del corpo guarite per
intercessione del patrono di Naro, san Calogero è infatti venerato come
santo taumaturgo (che guarisce dalle malattie). Queste forme di pane vengono
benedette dai padri guanelliani e poi distribuite ai fedeli. Il flusso di
persone devote al santo nero si fa più copioso a partire dal 18 maggio,
inizio del mese di san Calogero, e culmina con la festa del 18 giugno,
quando i fedeli trascinano il Santo, posto su una grande slitta detta
straula, per le vie della città tirandolo con delle funi lunghe 200 metri.
Il periodo dei festeggiamenti ha inizio il 15 giugno con
"l'acchianata" del simulacro dalla grotta al santuario e termina
il 25 giugno con la cosiddetta ottava di san Calogero. Durante questi dieci
giorni in città si svolgono diverse manifestazioni artistiche e culturali e
le vie principali sono allestite a fiera e mercato.
 Pag.
2 Pag.
2
|