|
Chiesa
di San Francesco
La
chiesa e l'annesso convento di San Francesco, furono fondati di piccole
dimensioni e di povere strutture nel 1229 da Rodorico Palmeri di Naro, dei
Padri Conventuali dell'ordine dei Mendicanti, con Breve Apostolica dal Papa
Gregorio IX, che diede come reliquia un pezzo del cordone, con cui San
Francesco si cingeva la vita, due anni dopo la canonizzazione del
"Poverello d'Assisi", lungo la strada degli allori (oggi Largo
Milazzo) nel sito ove esisteva il "Fondaco delle olive" di grande
importanza strategica poiché al centro del nucleo cittadino, in asse a nord
con il castello ed a sud con la porta di Girgenti.
La
posizione è ideale per un controllo generale di tutta la città e l'Ordine
gradualmente aumenta la sua rilevanza economica e sociale, tanto che alla
fine del secolo XVI i Francescani possederanno ben tre conventi: quello dei
Minori Conventuali, quello dei Minori Osservanti a Santa Maria di Gesù ed
un secondo convento di Minori Conventuali a San Calogero ed, inoltre, nel
secolo XVII promuoveranno l'edificazione di un sobborgo fuori le mura.
Dopo
quasi un secolo, per la povertà delle strutture, il convento fu ricostruito
dalle fondamenta nel 1330 da Giovanni Chiaramonte, allora Signore di Naro.
Subì
varie modifiche nel secolo XVII e XVIII.
 Oggi
è Sede del Palazzo di Città, cui si accede dal severo chiostro
settecentesco, con giardino con, al centro, un'artistica fontana e con atrio
interno, costituito da pilastri portanti, con semicolonne addossate su cui
poggiano elegante arcate, ad una sola navata longitudinale, modulata
lateralmente secondo un ordine di paraste addossate alle pareti, su cui,
come una cornice, diparte la volta a botte. Ora si presenta come uno fra i
tipici esempi del primo barocco siciliano, per volontà del P. Francesco
Miccichè, provinciale e guardiano del convento francescano. Oggi
è Sede del Palazzo di Città, cui si accede dal severo chiostro
settecentesco, con giardino con, al centro, un'artistica fontana e con atrio
interno, costituito da pilastri portanti, con semicolonne addossate su cui
poggiano elegante arcate, ad una sola navata longitudinale, modulata
lateralmente secondo un ordine di paraste addossate alle pareti, su cui,
come una cornice, diparte la volta a botte. Ora si presenta come uno fra i
tipici esempi del primo barocco siciliano, per volontà del P. Francesco
Miccichè, provinciale e guardiano del convento francescano.
Ha
nobile facciata in tufo giallino con manieristici intagli di esuberante
gusto spagnolesco, entro un telaio di lesine di tipo cinquecentesco e coppie
di cariatidi, che mostrano un eccentrico effetto plastico - chiaroscurale.
Grande
interesse riveste la parte inferiore con il grande portale, fiancheggiato da
coppie di cariatidi e sormontato dalla nicchia dell'Immacolata.
La
parte superiore adorna da una grande finta finestra e da nicchie, ormai
vuote, entro paraste cinquecentesche, era sormontata da un artistico
orologio a corda fatto collocare nel 1896 per volontà del nobile Benedetto
Contrino, allora Sindaco di Naro, con alcuni pilastri che bene si
armonizzano con tutto il prospetto (recentemente l'artistico orologio è
stato sostituito con uno più moderno: elettrico!).
L'interno,
ad unica navata con volta, presenta una ricca decorazione a stucco, eseguita
da Francesco Santalucia e dal figlio Salvatore ed indorata da P. Clemente da
Bivona, religioso del medesimo ordine (1780), che si articola su due ordini
divisi dal cornicione.
La
stessa volta ha una pregevole decorazione a fresco dovuta al pennello di
Domenico Provenzani, l'enfant prodige, figlio del falegname del Principe Don
Ferdinando Tomasi di Lampedusa, allievo di Vito D'Anna e del Serenario, che
nel 1780 dipinse lo scenografico affresco con il trionfo dell'Immacolata, di
ispirazione dantesca, oltre ad altri quattro minori che coprono tutta la
volta e che si ispirano al Vecchio Testamento.
Nella
chiesa si conservano alcune pregevoli tele, tra le quali lo Sposalizio della
Vergine (transetto) ideato da Raffaello e realizzato a Roma nel 1780 dal
trapanese Giuseppe Mazzarese, che chiude la cappella dove è custodita la
splendida statua rococò dell'Immacolata, rivestita da una lamina
d'argento, dovuta a Padre Melchiorre Milazzo ed opera egregia di maestranze
maltesi (Carlo Troisi ed il figlio Paolo nella città di Valletta nel 1719).
Nel
1692, dietro sua richiesta, fu donata al popolo narese la sacra reliquia
dell'osso omerale del protettore San Calogero, preso dal Monastero di San
Filippo di Fragalà (ME) dei Padri Benedettini, da Silvestro Napoli Lanza,
Barone di Longi (ME), conservata, ancora oggi, in un'artistica teca
d'argento, squisitamente lavorata, nel Santuario di San Calogero.
Ed,
altresì, l'Immacolata di Vito d'Anna (sec. XVIII), oltre i sei dipinti di
Fra' Felice da Sambuca: Sant'Antonio, San Calogero, la Stigmatizzazione di
San Francesco, Gesù Cristo con i SS. Lorenzo e Bartolomeo, la Buona e la
Mala morte, opere della
piena maturità dell'artista cappuccino.
Sempre
a P. Melchiorre Milazzo è dovuto l'altare Maggiore, con scene dell'ultima
cena e della Passione di Cristo, eseguito nel 1899 da Gaetano Vinci da Naro
ed, altresì, gli stalli corali, opere di maestranze locali. Allo stesso
committente, ancora, si deve la costruzione (1707) e la decorazione (1721)
della monumentale sacrestia che, recentemente restaurata, è uno degli
ambienti più fastosi del barocco narese.
 Gli
affreschi della volta con i quattro Evangelisti sono opera egregia di D.
Giuseppe Cortese da Venezia, mentre i prestigiosi armadi in noce, finemente
intagliati ed arricchiti con numerose figure e sculture, le cui ante
internamente sono artisticamente dipinte, sono opere settecentesche di
maestranze palermitane. Gli
affreschi della volta con i quattro Evangelisti sono opera egregia di D.
Giuseppe Cortese da Venezia, mentre i prestigiosi armadi in noce, finemente
intagliati ed arricchiti con numerose figure e sculture, le cui ante
internamente sono artisticamente dipinte, sono opere settecentesche di
maestranze palermitane.
Degno
di nota è un lavabo rococò in marmo nero, opera di maestranze trapanesi,
cui fa contrasto la bianca decorazione, pure marmorea, con la
stigmatizzazione di San Francesco.
Ed,
altresì, si possono ammirare nel secondo altare a destra il corpo
imbalsamato di Santa Colomba e nel secondo altare a sinistra quello di San
Domizio Leopardo, che unitamente al corpo di San Torpedo sono particolarmente venerati dai numerosi pellegrini,
che vengono a Naro per la festa di San Calogero.
Accanto
a P. Melchiorre e a Donna Felice, la sorella nubile e timorata di Dio, cui
è dedicata la biblioteca comunale, si segnalò per meriti letterari anche
il fratello Baldassare, pure conventuale minore a Roma.
Due
ritratti ad olio dei fratelli Melchiorre e Baldassare, erano custoditi nei
locali della Biblioteca "Feliciana", ma recentemente sono stati
trafugati da ignoti.
Ci
restano, però, due erme collocate dentro nicchie nel chiostro (1763)
dell'ex convento di san Francesco,oggi Palazzo di Città.
Fino
al 1890 gli Uffici del Comune si trovavano nei magazzini affittati di D.
Giuseppe Palmeri, siti nella via dei Monasteri, oggi Via Dante.
Il
convento, con verbale del 27 agosto 1890, fu acquistato dallo Stato per
trasformarlo in sede del Comune, i cui lavori furono appaltati ai fratelli
Giovanni e Giuseppe Saieva di Favara con atto n. 70 del 9 Maggio 1891.
Dei
preziosi cimeli conservati, si può ancora ammirare la pantofola sinistra di
San Pio V, in broccato veneziano di velluto, seta ed oro, nonché arredi
sacri in argento e ricchi paramenti, mentre la reliquia del cordone di San
Francesco, tre statuette di alabastro sono state trafugate, unitamente ad
altri preziosi oggetti.
Chiesa
di Sant'Agostino
Secondo
alcuni storici e fra essi Rocco Pirro, Frà Salvatore e Vito Amico, la
fondazione del convento di Sant'Agostino risale al VI secolo, quando alcuni
eremiti della regola di Sant'Agostino, creata da Fulgenzio, Vescovo di
Rugge, per sfuggire alle persecuzioni dei Vandali, dalla vicina Africa
sbarcarono in Sicilia.
Alcuni
di essi trovarono rifugio a Siracusa, altri vennero a stabilirsi a Naro,
fuori dell'abitato nelle grotte del colle chiamato "romito",
dove costruirono un chiesino, detto"chiesa del romito".
Accanto
ad essa, in seguito, costruirono un modesto convento, dove
rimasero fino all'invasione saracena. Pare che in quel primo convento sia
vissuto il venerabile San Eustachio da Naro, eremita intorno al 627, che
professò la regola di Sant'Agostino con alcuni frati e perciò restò a
lungo il nome di romito, come attesta Frà Saverio.
Scacciati
dai Musulmani tornarono a Naro nel 1086, grazie al Conte Ruggero e si
posizionarono in un luogo più comodo e più vicino all'abitato.
Nel
1117, abbandonato quel luogo, eressero la loro terza residenza di modeste
dimensioni nel sito, dove attualmente sorge la Chiesa con quel che resta
dell'antico convento. Fu ampliato nel 1254 e nel 1617.
Ulteriori
lavori, di abbellimento ed ampliamento al convento, furono eseguiti ancora
nel Seicento e nel Settecento. Nel convento, al centro del chiostro, vi era
una grande cisterna d'acqua.
Alcuni
anni fa, parte del convento è andato completamente distrutto per far posto
ad una incompiuta costruzione moderna.

Della
vecchia costruzione conventuale, ancora oggi, restano solo alcuni avanzi,
tra cui una bifora. Il pezzo più interessante, tuttavia, rimane il
pregevole portale dell'atrio incorporato nella sagrestia che, assieme alla
predetta bifora, apparteneva probabilmente alla sala del refettorio del
convento ed immetteva nel vecchio chiostro.
Finissima
è la decorazione di questo portale con arco a sesto acuto e con colonnine
di ordine corinzio, di grande effetto, che può farsi risalire a maestranze
locali del '300, ancora lontano dallo stile chiaramontano che influenzò
tutto un secolo e che è presente in altri organismi medievali della nostra
città.
Una
porta settecentesca in noce, con incisi nei pannelli episodi della vita di
Sant'Agostino,completa il portale di grande effetto. Nella sagrestia notiamo
molte opere di rilievo ad iniziare da una stampa con l'albero genealogico
dell'Ordine Agostiniano, dell'incisore piacentino Oliviero Gatti, che si
ispira al manierismo emiliano. Inoltre una porta dipinta dal Provenzani, cui
si devono i sei tondi con la Madonna del Soccorso e Santi
(nell'antisagrestia).
Tra
i numerosi ritratti dei priori si possono ancora ammirare i nove dovuti pure
al pennello del Provenzani ed inoltre un ricco "Cascerizzo"
settecentesco (1796), realizzato da Giacinto, Raimondo e Paolo Caci ed un
fine lavabo in marmo policromo fine Settecento, con influssi neoclassici.
Ma
l'opera più pregevole è la tela con "San Girolamo in
meditazione" del Provenzani, fra le migliori dell'artista palmense.
È,
per unanime concordanza dei critici, la massima espressione della sua arte e
fra le più alte della pittura siciliana del 700'.
Nell'antisagrestia
si conserva il monumento funerario barocco del notaio Don Lorenzo Favara
(1692), ancora legato al gusto manieristico.
La
chiesa progettata da Francesco Querni, fu iniziata nel 1707, ma rimase
incompiuta.
Fu
completata con l'aggiunta del secondo ordine del prospetto, che rispecchia a
grandi linee quello della basilica romana di San Giovanni in Laterano, nel
1815 ad opera di Don Felice Vinci, oriundo da Palma di Montechiaro e
capostipite di una grande famiglia di artisti di multiforme ingegno.
Fu
ornata da una balaustra con statue scolpite da Don Calogero Vinci da Naro,
figlio di Don Felice.
 La
chiesa è a croce latina con cupola e coro semicircolare, mentre le navate
laterali sono più basse e coperte da volte a crociera. La
chiesa è a croce latina con cupola e coro semicircolare, mentre le navate
laterali sono più basse e coperte da volte a crociera.
L'interno
è ricco di opere d'arte, tra cui sono degne di nota: un crocifisso ligneo
del 1535, la statua lignea di San Francesco di Paola, pregevole opera di
Nicolò Bagnasco, un'acquasantiera marmorea di gusto
rinascimentale-gaginesco, un pulpito ligneo di fine 500, dove al centro è
scolpita la conversione di San Paolo, il manieristico sarcofago di Francesco
Alacchi (1606) ed il monumentale organo costruito nel 1770 dall'agrigentino
Gaspare Di Franco.
Nel
presbitero un notevole coro ligneo tardo-settecentesco in due file, opera di
maestranze locali e due dipinti, l'Estasi di Sant'Agostino e la Madonna con
il Bambino ed i SS. Agostino e Scolastica, della scuola del Provenzani.
Di
notevole valore pure i dipinti: la Madonna della consolazione,
Sant'Agostino, San Tommaso di Villanova, San Giovanni da S. Facondo, San
Guglielmo e San Nicolò da Tolentino.
Interessanti
sono pure il transito di San Giuseppe dell'agrigentino Michele Narbone,
nonché la Samaritana al pozzo e la fuga in Egitto, opere fra le più
rappresentative del settecento locale.
Sottostante
alla chiesa è la cripta che fu realizzata per la sepoltura dei frati
dall'architetto Frà Girolamo Agostino De Cremissa, dell'ordine agostiniano,
come ci viene attestato da una lapide fatta apporre nella stessa cripta da
P. Prospero Favara.
La
cripta fino al 1891 servì da Cimitero.
Nel
1900 tutte le ossa furono raccolte e poste in un ossario. La cripta, divisa
in navate, racchiude in quella di centro alcuni caduti delle guerre mondiali
e delle campagne d'Africa.
Nelle
navate laterali nicchie vuote, dove venivano posti " a scolare"
dopo la morte, i monaci per l'imbalsamazione.
La
chiesa ed il convento sono conosciuti anche perché citati nel romanzo di
Luigi Natoli "Fra Diego La Mattina" il frate agostiniano che per
sfuggire alla cattura per ordine del Tribunale dell'Inquisizione, diventato
un avventuriero e popolare bandito, trovò rifugio per qualche tempo in
questo convento agostiniano.
Ma
successivamente, preso ed arrestato, finì sul rogo a Palermo.
Chiesa
di Sant'Erasmo
La
chiesa ha origini molto antiche. Si suppone che fu costruita nel luogo dove
si trova oggi, riadattando i locali di un grosso magazzino degli eredi di
Francesco Randazzo, con il nome di Sant'Erasmo, vescovo e martire, nel
lontano 1555 (a). Mentre il convento dei Padri della Madonna della Mercede
fu fondato nel 1590.
E
la chiesa preesisteva. Nel 1692 fu eletta Parrocchia filiale della chiesa
Madre e Don Vincenzo Bonnino fece alla Chiesa la donazione di alcune case
per il mantenimento del cappellano (vedasi atti del notaio Favara).
Ristrutturata varie volte, fu modellata nel 1775 per opera dei fratelli
Giuseppe e Calogero Principato.
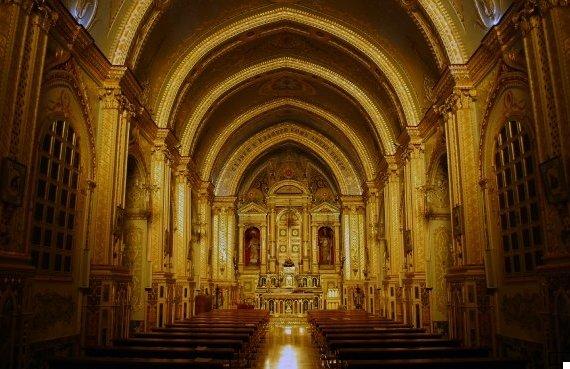 Nell'anno
1890 divenuta pericolante, fu chiusa al culto e si pensò di sconsacrarla.
Ma per l'intervento di Don Antonio Cutaja, parrocchiano di fede e di gran
possibilità economiche, fu ristrutturata e restituita al culto
(b).L'interno è ad unica navata in stile tardo-manieristico, con archi
ogivali e stucchi di discreta fattura nella volta. Nell'anno
1890 divenuta pericolante, fu chiusa al culto e si pensò di sconsacrarla.
Ma per l'intervento di Don Antonio Cutaja, parrocchiano di fede e di gran
possibilità economiche, fu ristrutturata e restituita al culto
(b).L'interno è ad unica navata in stile tardo-manieristico, con archi
ogivali e stucchi di discreta fattura nella volta.
Da
notare un pregevole altare maggiore in legno con specchi sparsi, eseguito
nel 1800 da Vincenzo Vinci da Naro (discendente da Felice Vinci, nativo di
Palma di Montechiaro, che si stabilì a Naro nella seconda metà del
settecento e che fu mandato a Roma per perfezionarsi nell'arte di Raffaello
dal principe Tomasi di Lampedusa), ed una statua di legno della Madonna di
Loreto del 1600, d'autore ignoto, una sacra Famiglia, tardo-settecentesca ed
un Crocifisso di carta pesta, ottocentesco di scuola siciliana.
Si
può ammirare anche la statua di legno di Sant'Erasmo, vescovo e martire,
cava all'interno e quella di Santo Stefano, Protomartire. Ed, altresì, la
statua di legno del Cristo risorto, opera egregia di un realismo singolare,
di un imprecisato autore locale "muto".
Ed,
ancora, in sacrestia si può ammirare un pregevole dipinto di Santa Lucia,
opera di ignoto autore proveniente dalla diruta chiesa campestre poco
distante dalla fonte di Favarelle, della quale si potevano osservare ancora
le vestigia fino al tempo di Fra Salvatore.
L'esterno
ha subito vari rifacimenti. Infatti, la torre campanaria, costruita nel 1694
nella parte Nord-Est e distrutta durante il bombardamento del 12 luglio
1943, è stata ricostruita artisticamente nella parte opposta della chiesa
(Nord-Ovest) per opera del maestro Domenico Vinci da Naro nel 1945. Era sede
della Congregazione di Sant'Erasmo (1569), sotto il titolo di Santa Maria di
Loreto.
Chiesa
Madre
La
fondazione della chiesa e del collegio della Compagnia di Gesù viene
attribuita a don Antonino Lucchesi, per opera del P. Gaspare Paraninfo
da Naro, religioso del medesimo ordine, nel 1619 con il contributo economico
anche delle famiglie Gaetani e Bandino, nonché del Comune di Naro, come
testimonia l'atto delle diverse donazioni, redatto dal notaio Vincenzo
Pagliaro da Naro, ottobre 1619, conservato nell'archivio di stato di Palermo
ed accettato dal Rev.do P. Don Panfilio Lambertenghi, Provinciale dei
Gesuiti, per istituire e fondare in Naro un collegio di studi diretto dai
Padri Gesuiti e secondo il loro metodo, in uno spazio enorme al centro della
città, lungo un asse longitudinale, dove le famiglie nobili edificano i
loro palazzi, realizzando nel tempo una vera e propria strada, la via
Maestra o dei Monasteri, odierna via Dante Alighieri.
 In
detto collegio venne fondata, infatti, una famosa scuola, florida per più
di un secolo, dove si teneva un corso di studi completo per avviare la
gioventù, proveniente anche da altre città, ai corsi universitari degli
insegnamenti di teologia, grammatica, retorica e filosofia, con una folta
schiera di letterati, tanto da essere paragonata per importanza
all'Università di Catania, unica allora in Sicilia. In
detto collegio venne fondata, infatti, una famosa scuola, florida per più
di un secolo, dove si teneva un corso di studi completo per avviare la
gioventù, proveniente anche da altre città, ai corsi universitari degli
insegnamenti di teologia, grammatica, retorica e filosofia, con una folta
schiera di letterati, tanto da essere paragonata per importanza
all'Università di Catania, unica allora in Sicilia.
Uno
degli alunni più illustri fu Bonaventura Attardi, famoso autore del libro
Monachesimo in Sicilia, come viene attestato da documenti esistenti presso
la Curia Vescovile e l'Archivio di Stato di Agrigento.
Fu
mantenuta in attività fino al 1863, quando fu chiusa per ordine del
Ministero della Pubblica Istruzione del regno d'Italia!
La
chiesa, dopo la chiusura del Vecchio Duomo, prese il titolo di chiesa Madre.
Subì varie modifiche nel 1702, nel 1734 e nel 1763.
Agli
inizi del novecento la facciata fu rifatta ad opera di Francesco Valenti,
che la divise in due ordini, mantenendo l'antico portale, mentre sostituì i
due ingressi laterali con due piccole finestre, il rifacimento del
finestrone con il balconcino e le finestre laterali dell'ordine superiore.
Originale
è la parte superiore del campanile L'interno è ad impianto longitudinale,
simmetrico con transetto e finta cupola. Internamente fu intonacato con
ricchi stucchi e pregevoli decorazioni ad opera del rettore P. Carlo Baldone
da Naro nel 1734.
Vi
si conservano molte opere provenienti dal Vecchio Duomo: Il fonte
battesimale, recante la data del 1484, di Nardo da Crapanzano; la Statua in
marmo della Madonna della Catena, opera iniziata nel 1534 da Antonello
Gagini, ma finita dal figlio Giacomo nel 1543; una Madonna col Bambino detta
della Pace, del secolo XIV, di pregevole fattura, di bottega Gaginesca; un
Crocifisso nell'atto di spirare di P. Domenico Di Miceli; diverse tele del
Provenzani, fra cui spicca l'Annunciazione (1780), opera che risente
dell'influenza del suo maestro Vito D'Anna e resta una delle opere più
riuscite dell'artista, (proveniente dal monastero delle Nunziatine o Badia
Piccola, per cura dell'arciprete Don Silvestro Cassarino, fu collocata nella
chiesa Madre nel 1785, quando la Chiesa ed il Collegio dei Gesuiti furono
concessi alle monache benedettine della SS. Annunziata); una Sacra Famiglia,
gruppo in marmo di scuola gaginesca. In sacrestia sontuoso
"Cascerizzo" del 1725, realizzato dai maestri agrigentini Gabriele
Terranova e Giuseppe Cardillicchia.

A
destra della chiesa, il Collegio che si articolava intorno ad un ampio
chiosco con porticato, del quale oggi rimane soltanto un lato originario ed
uno rifatto, con demolizione delle crociere originarie.
Il
portale d'ingresso riccamente intagliato nella pietra arenaria,
assume particolare rilievo per la forma architettonica e la decorazione.
Fu
in parte abbattuto il paramento murario negli anni 50", per far posto
ad un plesso scolastico ed all'ufficio collocamento.
Chiesa
di Gesù Maria e Giuseppe
Si
dice che la primitiva Chiesa fu fondata nel 1651 per merito di Don
Bartolomeo Barbara, nobile naritano. Quel che è certo che la chiesa è dei
primi del Settecento ed apparteneva ai Gesuiti.
Nel
1741 fu restaurata e nel 1774, dopo l'espulsione dei Gesuiti, la chiesa e
l'annesso giardino passarono sotto la giurisdizione di Ferdinando IV, re di
Napoli e di Sicilia.
Nel
1943 fu distrutta da un bombardamento aereo. Ricostruita nel 1950, si
presenta, ora, ad aula semplice, piccola, con altare e qualche statua.
Molto
interessante il prospetto principale con portale finemente lavorato,
completo armonicamente dalla facciata con due belle bifore, con esile
colonnine e dalla torre campanaria.


Chiesa
di San Paolo
Non
si conosce con esattezza l'anno della sua fondazione. Si dice edificata,
trasformando un magazzino della famiglia Timpanaro, prima del 1685, anno in
cui fu elevata a Parrocchia filiale. Nel 1760 stava per crollare e fu
risanata con il contributo economico dei Fratelli della Congregazione (di
San Paolo), quando furono costruite anche le due cappelle di San Paolo e di
San Giuseppe. Nel 1784 dai maestri Giovanni Farruggia, Calogero Viccica e
Mario Principato furono ripresi la facciata e la porta maggiore ed innalzato
il coro.
Tra
il 1803 ed il 1809 fu completata e decorata con stucchi da Tommaso Fasulo.
L'impianto
è ad aula semplice con piccolo coro d'ingresso e torre campanaria contigua
alla facciata principale. La copertura è a botte con archi trasversali
originati da paraste laterali.
Di
particolare interesse è un'edicola lignea contenente un'urna con Cristo
crocifisso morto, di pregiata fattura, tardo-cinquecentesco, di stile
manieristico, proveniente, come attesta Fra Saverio, da una chiesa campestre
detta a casazza, rovinata nel 700'.
Detto
Crocifisso, concesso per contratto stipulato dal priore della Collegiata D.
Francesco Costa alla chiesa di San Paolo, con il nome di Lazzaro, in epoca
alquanto recente, era solennizzato la Domenica prima di Pasqua, dai Fratelli
della Congregazione (contadini), con una singolare processione.
Vi
si conserva, altresì, un pregevole dipinto con l'Addolorata, di
Fra Felice da Sambuca, al secolo Gioacchino Viscosi.
Chiesa
di San Nicolò di Bari
La
chiesa con l'annesso convento venne eretta nel 1618 ad opera del
benefico Vincenzo Lucchesi, forse sui resti dell'antica pieve di San Nicolò
di Bari, Vescovo di Mira.
Per
antichissima tradizione sembra questa pieve essere stata in Naro la prima
chiesa, edificata alla fine del IV secolo e, precisamente, nell'anno 393,
con bolla di papa Siricio, che destinò a Naro un sacerdote di nome
Teodosio, insignito con il titolo di Priore, che in quel tempo aveva
l'autorità di un vescovo.
La
chiesa ebbe il nome di San Giuseppe, mentre il convento fu chiamato
"Collegio degli orfani". Nel 1636, sempre per sua iniziativa,
detto collegio fu mutato in Monastero femminile, con il titolo di Santa
Chiara. Dopo alcuni anni da Donna Deodata Lucchesi, monaca del Monastero del
SS. Salvatore o Badia Grande, prese il nome di Maria SS. Annunziata o Badia
Minore, con la regola di San Benedetto.
Nel
1785 la chiesa fu eretta a Parrocchia, con il titolo del glorioso San Nicolò
di Bari, Vescovo di Mira. Ha larga facciata in tufo giallino, con motivi
manieristici d'esuberante gusto spagnolesco, tipici della prima architettura
barocca siciliana.
 Sul
portone d'ingresso lo stemma nobiliare della famiglia Lucchesi Palli, che
trae origine da Adinolfo Palli, figlio di una sorella di Desiderio, re dei
Longobardi e, di seguito, tra i suoi discendenti, da Andrea Palli, che
essendo passato in Sicilia, aggiunse il nome Lucchese in memoria della sua
Patria Lucca. Sul
portone d'ingresso lo stemma nobiliare della famiglia Lucchesi Palli, che
trae origine da Adinolfo Palli, figlio di una sorella di Desiderio, re dei
Longobardi e, di seguito, tra i suoi discendenti, da Andrea Palli, che
essendo passato in Sicilia, aggiunse il nome Lucchese in memoria della sua
Patria Lucca.
La
facciata si articola su due ordini ed è, verticalmente, riportata in tre
parti simmetriche rispetto all'asse centrale. La parte superiore è dominata
da una grande finestra di forma rettangolare.
La
parte centrale mostra un pregevole portale d'ingresso, ricco di decorazioni,
sormontato da un frontone aperto.
Il
prospetto, scandito da un ritmo incrociato di cornici e paraste, è
affiancato dalla torre campanaria, dove fino al 1821 si trovava una
singolare campana proveniente dall'antica pieve greca, che si trovava sul
piano, vicino alla dimora della potente famiglia Gaetani, recante la data
del 580, come attesta Fra Saverio.
L'interno
ad impianto longitudinale simmetrico ad unica navata priva di transetto, con
giochi di luce della finestra, che sottolinea i contrasti plastici del coro
e dell'abside, sono ornati da stucchi realizzati nel XVIII secolo e da
alcune tele, degne di rilievo, di scuola siciliana.
Ed,
ancora, alcuni dipinti tra cui spicca una Sacra Famiglia,
attribuita alla scuola di Pietro d'Asaro, ma che invece è legata a formule
tardo-manieristiche, una Madonna Addolorata consolata da Gesù, di Francesco
Guadagnino e la tela della Deposizione, ornata da sette piccole tele,
attribuibile al Provenzani.
In
sagrestia è un bel Crocifisso ligneo settecentesco. Nella parete destra
sull'ingresso alla sagrestia, vi è una tavola tardo-cinquecentesca della
"Veronica".
Infine
un magnifico fonte battesimale recante la data del 1490, con le armi della
Casa Aragona, analogo a quello della Chiesa di Santa Caterina.
Fin
dal 1622 è sede della Congregazione del SS. Crocifisso, che cura ogni anno
una solenne processione con il Cristo morto fino al Calvario.
Originariamente
la Confraternita aveva sede nella distrutta chiesa del SS. Crocifisso, che
si trovava nella via Piave, sotto la dimora del Marchese Specchi, che in
seguito donò il Crocifisso (di detta chiesa), di sua proprietà, alla
chiesa di San Nicolò di Bari, con obbligo di esporlo nella Settimana Santa.
Da quel giorno la Confraternita si trasferì nell'attuale sede.
Chiesa
di Santa Maria di Gesù

È
opinione diffusa che la Chiesa ed il relativo convento, furono edificati
intorno al 1470 dai frati Minori Osservanti, dell'ordine dei Mendicanti, che
daranno vita, in seguito, al casale omonimo sotto l'influsso dei
Francescani, utilizzando l'impianto di una precedente torre di preguardia,
edificata durante la lotta contro i Turchi, al tempo di Carlo V.
Nel
1595 i locali, ampliati e ristrutturati, furono ceduti ai Padri Riformati,
ad opera di Francesco da Mazarino.
La
struttura originaria del convento è andata quasi del tutto perduta, a causa
di diversi rifacimenti.
Detto
convento, in origine sede di una comunità di oltre trenta religiosi, che
tenevano una scuola di filosofia e teologia, è completamente inglobato
nelle abitazioni circostanti.
In
esso dimorò per molti anni Fra' Giovanni Pantaleo, dei Padri Riformati,
prima di seguire Garibaldi ed i Mille, aderendo al proclama del Generale
indirizzato ai buoni preti del 14 maggio 1860, assieme al quale il 17
settembre 1860 entrò a Napoli, nella sua stessa carrozza.
Secondo
il Pitruzzella, la sua cella era visitabile fino al 1912, in seguito,
purtroppo, è stata inglobata in una abitazione privata.
Del
bellissimo chiostro, rimangono, molto degradate, le vecchie superfici ad
intonaco ed a faccia vista del colonnato, coperto da volte a crociera,
impostate su eleganti arcate su piedistalli di stile rinascimentale, alti
quasi un metro ed hanno una singolare base quadrangolare che funge da
piattaforma per lo slancio di ciascuna delle colonne del chiostro.
Ed,
altresì, l'antico pavimento del chiostro in mattoni pieni di laterizio
rossiccio, venuto alla luce durante i lavori di manutenzione dei locali
annessi alla chiesa nel 1986.
Ma
ancora in buono stato è il lato sud-ovest, coperto con volte a crociera su
ampi archi a sesto pieno.
La
chiesa, distrutta completamente nel 1781 da un incendio, venne rifabbricata
da Calogero e Giuseppe Principato con il contributo economico dei cittadini
e di Don Francesco Torricelli Leonardo.
Attualmente
la chiesa, dalla fine del secolo XVII, si presenta ad impianto longitudinale
ad unica navata con abside semicircolare, cappelle laterali e nicchie, che
modulano con grande effetto l'interno in stile tardo manieristico,
trasformato ed alterato a seguito di diversi interventi di restauro.
In
essa si conservano alcune statue lignee: un San Diego e un Sant'Antonio di
Padova, di ascendenza manieristica, nonché un San Francesco di gusto
barocco.
Ed,
altresì, una Madonna con il Bambino, statua quattrocentesca in marmo, un
Crocifisso ligneo a grandezza naturale, opera egregia di Frate Umile da
Petralia Soprana, al secolo Gianfrancesco Pintorno (1588-1639), che questa
chiesa poté avere per intercessione di Fra Bennardino da Naro, frate del
medesimo ordine e molto legato al Pintorno da grande amicizia.
Grande
figura di artista e di santo quella del Pintorno, che giace umilmente
sepolto nella chiesa di Sant'Antonino di Palermo. Amò Cristo fino allo
spasimo, tanto da scolpire ben 33 crocifissi, quanti gli anni di Cristo.
Ed,
ancora, si possono ammirare una sedia dell'officiatura, di gusto eclettico
ed un fonte in marmo per acqua benedetta, di Antonello Gagini (sec.XVI).
Chiesa
dei Cappuccini (Santo Spirito)

Un
piccolo convento con annessa chiesa, nel luogo denominato Grotte di San
Cataldo, fuori le mura della Città, in mezzo alla campagna, fu fabbricato
nel 1551 dai Cappuccini, guidati da P. Luca da Naro, della potente famiglia
Palmeri, originaria dalla Scandinavia, che fa risalire le sue origini a
Salvatore Palmeri Miles, venuto a Naro nel 1086 al seguito di Ruggero il
Normanno, con cui era imparentato, famoso per aver ucciso in duello
Mulcibiade Mulé( Melk - Kelb - Mule), Barone saraceno delle terre di
Ravanusa e dello Gibbesi.
Nel
1554 per opera dei nobili naritani Ippolito Lucchesi ed Ippolito Giacchetto,
si ampliò il piccolo convento, costruendone uno più grande e più solido.
La chiesa ed il convento furono successivamente ristrutturati ed ingranditi
nel 1690 e nel 1726.
La
sagrestia fu eretta nel 1726 per opera di P. Girolamo Alletti, allora
Guardiano del convento. Nel 1728 il convento fu fatto intonacare per volontà
di P. Giuseppe da Naro. Fu ristrutturato ancora nel 1723 e nel 1754.
 La
chiesa è ad unica navata longitudinale, con locali adiacenti a sagrestia.
Si riscontrano ancora i resti dell'antico convento, che fanno intuire
l'impianto originario, costituito da un cortile interno. Il portale in
pietra tufacea, austero e semplice, costituisce l'unico elemento
architettonico degno di nota. La
chiesa è ad unica navata longitudinale, con locali adiacenti a sagrestia.
Si riscontrano ancora i resti dell'antico convento, che fanno intuire
l'impianto originario, costituito da un cortile interno. Il portale in
pietra tufacea, austero e semplice, costituisce l'unico elemento
architettonico degno di nota.
Internamente
intonacata con gessino, è priva ormai di qualsiasi pittura. La chiesa
originariamente aveva cinque altari e molte opere d'arte. Nel 1866 con la
soppressione delle Congregazioni religiose, il convento fu chiuso e le opere
d'arte, ivi racchiuse, alcune sono andate in altre chiese, altre perdute per
sempre.
Recentemente,
grazie all'attiva presenza del parroco Sac. Don Filippo Barbera, sono
tornate al loro posto in chiesa, tra l'altro, uno splendido altare maggiore
settecentesco, in legno, che trae spunto dalle custodie
cappuccine-francescane, una statua della Madonna che dorme, in cera, dentro
un'urna di vetro.
Vi
si conservava vicino all'altare Maggiore, in cornu Evangelis, la tomba di
suor Serafina M. Pulcella, della famiglia Lucchesi, bizzocca cappuccina,
morta in odore di santità nel 1673. Le sue spoglie mortali furono traslate
il 2 dicembre 1939 dalla chiesa dei Cappuccini in quella di San Calogero,
nella cui cripta furono deposte.
Ed,
altresì, nella cappella maggiore vi era la tomba di P. Girolamo Caruso da
Cammarata, monaco cappuccino, morto pure in odore di santità nel 1627, al
cui processo di beatificazione partecipò il Maestro Provinciale degli
Agostiniani P. Agostino Priolo, naritano, incaricato dal Vescovo Mons.
Traina di Girgenti. Le sue ceneri, riesumate il 21/12/1973, sono state
traslate nel convento dei Cappuccini di San Giovanni Gemini.
È
stata riaperta al culto nel 1984 con decreto vescpvile del 13/3/1987 è
stata dedicata allo Spirito Santo e dichiarata comparrocchiale.
Recentemente sono venuti alla luce degli ambienti sotterranei di sepoltura
dei cappuccini del 1728.
Pag.
1 
 Pag.
3 Pag.
3 |