|
Chiesa
del SS. Salvatore
La chiesa
del Santissimo Salvatore, conosciuta anche come "'A Batìa"
(in siciliano)
fu
costruita nel 1398,
nel periodo in cui il re Martino
il Giovane e
l'infante Maria dimorarono in Naro,
insieme all'annesso monastero delle monache
benedettine, oggi
non più esistente poiché abbattuto per far spazio ad una scuola
elementare.
La
chiesa fu rimaneggiata nel 1530 e
completamente rinnovata nel periodo barocco (tra il secolo
XVII e il secolo
XVIII).
L'edificio
si trova in stato di abbandono ed è chiuso al pubblico e subisce
infiltrazioni d'acqua che ne indeboliscono la struttura.
Attualmente
è puntellata esternamente , ma il 19 Ottobre sono iniziati i lavori di
restauro, e sono stati completati il 12 Dicembre dello stesso anno (2016).
Rimaneggiata
nel 1530 con l'ampliamento del convento ed il rinnovo della facciata. Nel
1750 si ebbe la costruzione del campanile.
Negli
anni 50", il vecchio Monastero delle Benedettine venne demolito, per
far posto alla scuola elementare "San Giovanni Bosco", con il
plesso San Secondo. Il monastero che accoglieva donzelle di nobile progenie,
di Naro e della Comarca, in origine si divideva in due organismi: uno
superiore, con ingresso in Largo San Secondo, edificio modesto nel progetto,
con balconi in ferro battuto ed uno inferiore, in via Dante, complesso
severo ed austero con finestre difese da fitte grate panciute in ferro,
dove, accanto al portone d'ingresso, esisteva la "ruota della
miseria", in cui venivano abbandonati molti bambini
"indesiderati".
Dal
plesso inferiore si poteva accedere al plesso superiore tramite una scala
intagliata nella roccia (ancora esistente).
Del
fasto antico resta solo un cantonale d'angolo (denominato Quarto Nobile)
dalle poderose lesene e con balconi ornati di ricche mensole. L'ultima
Badessa è stata Donna Antonina Gaetani (1824/1923), nobile naritana.
Rimaneggiata
nel 1530, successivamente venne più volte rinnovata nei secoli XVI e XVII.
La
facciata a duplice ordine, dei quali quello superiore in pietrame, mai
ultimato, presenta in quello inferiore, che è il solo completo, ricchi e
fasti intagli tufacei di gusto spagnolesco di mirabile effetto plastico
coloristico e due nicchie con statue di S. Benedetto da Norcia, a sinistra e
della sorella Santa Scolastica a destra, con le insegne abbaziali, fondatori
dell'Ordine Benedettino, inquadrati da sei robuste paraste con piedritti e
capitelli di ordine corinzio.


Tra
una parasta e l'altra, nella parte superiore, sono inserite quattro finestre
difese da fitte grate di ferro.
Il
portale aggettante è inquadrato da colonne tortili aggiunti in pieno
seicento ed è sovrastato da una elegante edicola. Il campanile, tozzo e
massiccio, è del 1750, ma rimase incompleto.
Il
nascente Barocco è riprodotto in elegante e sobrio stile, scevro da ogni
esagerazione ed esprime grandiosità e fioriture d'ornati.
L'interno,
ad una sola navata, presenta una larga spazialità, scandita da elementi
decorativi alle pareti ed il rapporto pronao-aula è ben individuabile.
Mostra,
infatti, una ricca decorazione di stucchi e di affreschi sebbene molti
deteriorati. Gli affreschi della volta dovuti al pennello di Domenico
Provenzani, con episodi della vita di San Benedetto e della sorella
Scolastica, sono stati realizzati nel 1764.
In
particolare nell'affresco centrale è dipinta la glorificazione di San
Benedetto e del suo ordine monastico, nei due quadri minori della medesima
volta l'artista palmense raffigurò San Benedetto che dà la regola ai suoi
seguaci e "l'ascesa di San Benedetto".
Si
possono ancora ammirare un sarcofago di porfido nero del 600",
sostenuto da due leoni, che racchiude i resti di Giuseppe Lucchesi, Marchese
di Delia, ispirato al sacello di Federico II°, nella cattedrale di Palermo,
e l'altro, di marmo bianco, ancora legato a formule manieristiche,
contenente le ceneri del figlio Assuero, morto a 18 anni, ultimo rampollo
dei Duchi d'Alagona.
Ed,
altresì, una Madonna del rosario, in marmo del 1498, posta nel primo altare
a destra, detta comunemente la "Madonnina di Trapani", sec. XVI,
un Crocifisso ligneo settecentesco con motivi classici e baroccheggianti, la
statua settecentesca di San Benedetto di stile rococò e quella tardo
cinquecentesca, d'ispirazione manieristica, di San Eligio. La
macchina dell'altare, in legno intagliato, è opera egregia di Giosuè
Durando e Nicolò Bagnasco (1795).
Ed,
ancora, in un'artistica teca, in legno e vetro, viene religiosamente
conservato il corpo di San Torpedo, donato dalle autorità pontificie alle
conventuali, per intercessione di Suor Maria Vincenza Andolina Gaetani,
insigne letterata dello stesso convento (1632-1689). È da ammirare, altresì,
sebbene molto deteriorata la "natività, ultimo quadrone esistente
nella Chiesa, dei sei eseguiti nel 1735 dal P. Domenico Di Miceli,
monaco-pittore del 700". Al convento è legato un grave episodio di
sangue del 1411, all'epoca delle lotte fra la fazione latina e quella
catalana.
Naro
parteggiava per Bianca di Navarra, Vicaria del Regno di Sicilia, che tendeva
all'indipendenza dell'Isola, dopo la morte di re Martino, il Vecchio (1410),
favorendo l'avvento al trono di Fernando, Conte di Luna, figlio naturale di
detto Martino.
Di
contro, si opponeva Bennardo Cabrera, Conte di Modica, capo della fazione
catalana, che non voleva la Sicilia staccata dalla Corona Aragonese.
Il
Cabrera, a tradimento, nell'agosto del 1411 si impadronì del Castello di
Naro, trucidò il castellano, Lopez Leon, saccheggiò la Città e fece
seppellire viva l'innocente monaca Cannizzaro, badessa del convento,
colpevole soltanto di essere la cugina del castellano Lopez Leòn.
Del
fatto la regina Bianca diede l'annuncio ai fedeli feudatari del regno in
un'accorata lettera, riportata nell'archivio storico siciliano dal barone
Raffaele Starrabba, che è anche un documento della lingua siciliana
illustre, che era, all'epoca, la lingua ufficiale della Sicilia.

Chiesa
del Carmelo
Fu
edificata assieme al convento, di cui si mantiene la struttura, trasformata
all'interno in abitazione civile, e parte del chiostro, sul sito di un
preesistente chiesino, dal titolo di San Pietro, Principe degli Apostoli,
sul finire del XV secolo, presumibilmente nel 1478, anno in cui i
Carmelitani giunsero a Naro, per opera del MRR Padre Girolamo Guagliardo da
Naro, grazie alla concessione del terreno da parte dei giurati di Naro, con
atto di concessione datato 9 Novembre 1478, conservato in Municipio, ed alla
donazione di 200 scudi fatta dal Re Filippo II, il Cattolico, a ridosso
delle mura, la cui posizione è dominante rispetto al territorio vastissimo
a sud.
Tale
posizione felice garantisce, inoltre, il controllo della campagna
sottostante e rappresenta un passaggio obbligato per la presenza della Porta
Annunziata e si proietta su un piano di futura espansione fuori le mura, che
si attuerà in quella direzione alla fine del XVI secolo.
Il
convento, in cui dimoravano trenta religiosi, era detto anche delle
giummarre, perché nel giardinetto, all'interno dello stesso, esisteva
vicino ad uno specchio d'acqua un piede di palma silvestre, cioè giummarra. Fu ristrutturato nel
500, nel 600, nel 1764, (la costruzione del
Coro), nel 1772, quando fu demolito l'atrio d'innanzi l'entrata, e nel 1815,
quando era Priore P. Alberto Formica, ad opera dei Maestri Giuseppe Alaimo
ed Onofrio Miano e del perito intagliatore Mario Principato.
La
torre campanaria è stata rifatta nei primi del sec. XIX, mentre l'altare
Maggiore fu decorato dal Maestro Stefano Rugiano e stuccato da Francesco
Santalucia, come attesta Fra Salvatore.
Il
semplice portale in pietra viva, unico elemento di rilievo del prospetto,
risale al 1612.
L'interno,
con riminiscenze tardo-cinquecentesche, ad impianto longitudinale ad aula
unica, senza transetto, con abside quadrangolare (forse antica torre di
preguardia) con cappelle laterali e nicchie ricavate nello spessore dei muri
perimetrali, mostra alcune notevoli statue lignee, tra cui il Profeta
Sant'Elia, che calpesta la testa della regina Gezabele, del palermitano
Nicolò Bagnasco, la Madonna del Carmelo con il Bambino e San Domenico del
sec. XVIII, che si riallaccia alla tarda scuola gaginesca e San
Giuseppe con il Bambino, scultura settecentesca, in gesso, di gusto rococò
ed, altresì, il dipinto di San Domenico in gloria del 1780 di Domenico
Provenzani, Tabernacolo con il Cristo morto, dipinto attribuibile a Fra
Felice da Sambuca, olio su tela del sec. XVIII e L'Addolorata, olio su tela
ovale del sec. XVIII.


Chiesa
di Santa Caterina
È
il più artistico esempio di architettura d'epoca normanna, un fine gioiello
di stile gotico-normanno, a cui gli artisti siciliani seppero dare
un'impronta originale ed un gusto da caratterizzare uno stile ed un'epoca.
Nonostante
la mancanza di notizie sicure, è opinione diffusa, tra i maggiori studiosi,
che essa fu edificata da Matteo Chiaramonte, Conte di Modica e Signore di
Naro dal 1366, per volere di Federico III°, detto il Semplice, a seguito
della pace di Castrogiovanni, tra la fazione latina (i Chiaramonte, i
Ventimiglia, i Rosso, i Lancia e i Palizzi) e l'altra di origine catalana (i
Moncada, gli Aragona, i Valguarnera) che si disputavano il dominio
dell'Isola. Osservando le strutture interne, si può ipotizzare che la
Chiesa fu edificata sui resti di un Tempio musulmano, che fu restaurato,
ampliato ed arricchito di ornati.
Dell'antica
costruzione rimane l'impianto generale a tre navate, con absidi, scandite da
archi ogivali sorretti da massicci pilastri cilindrici. La navata
centrale è formata da due profonde campate, che ricevono luce da numerose
finestre lunghe e strette a sesto acuto.
L'abside
centrale, con volta a crociera costolonata, sorretta da quattro pilastri
angolari con capitello, riceve luce da una finestra strombata a feritoia,
posta sopra l'altare, d'ispirazione federiciana e presenta un'interessante
arco d'ingresso in stile chiaramontano e due bifore tribolate, mentre le due
absidi laterali presentano fastosi archivolti.
Originale
è pure il soffitto ligneo a capriate, un tempo dipinto, che richiama quello
coevo della chiesa agrigentina di Santa Maria dei Greci. Sulle pareti e
nelle absidi laterali sono ancora visibili resti di affreschi trecenteschi,
che raffigurano la Madonna con il Bambino e San Michele Arcangelo,
attribuibili a Cecco da Naro, il famoso pittore del 1300 che, con Simone da
Corleone e Pellegrino Darenu da Palermo, affrescò il soffitto della sala
Magna dello Steri di Palermo, l'Hosterium Magnum (Palazzo fortificato),
della potente famiglia dei Chiaramonte, voluto da Manfredi III.
La
Chiesa fu rimaneggiata nel 1725. A seguito di restauri eseguiti nel 1935-40,
per interessamento del Conte Alfonso Gaetani, benemerito della Città di
Naro anche per altre opere, e, di nuovo, nel 1959 dalla Soprintendenza ai
monumenti, sono state ripristinate le strutture originarie. Il prospetto,
risalente all'intervento settecentesco, quando fu rinnovata la porta
maggiore e rifatto il portale, è caratterizzato da scialbe formule
tardo-barocche.
Con
il recente ulteriore intervento di restauro e di rifacimento del pavimento,
è venuto alla luce un vano con, al centro, una fossa adibita a sepoltura e
lungo i lati delle pareti diverse sedie-scolatoio, testimonianza
dell'esistenza di un ambiente adibito a sepoltura. Ben poco resta del ricco
patrimonio artistico che si conservava nella Chiesa.
Attualmente
si possono ammirare: un fonte battesimale del 1400, in marmo, in un unico
blocco, con lo stemma degli aragonesi e quello della Città di Naro, la
ruota, simbolo del martirio di Santa Caterina d'Alessandria e le Chiavi
della Chiesa; il così detto Arco Romano, d'ispirazione rinascimentale
(1565), dove sono scolpite scene della Via Crucis, scene di vita monastica,
lo stemma della Confraternita di Sant'Antonio ed un ovale con croce,
proveniente dalla diruta chiesa di Sant'Antonio, con alle basi i medaglioni,
probabilmente, dei due Scipioni o, forse, degli ecisti (fondatori) della
Città, la quattrocentesca Pietà, dovuta allo scalpello del gaginesco
Giuliano Mancini, proveniente, anch'essa, dalla chiesa di Sant'Antonio, di
cui colpisce il realismo del volto di Maria, simile alla pietà del Gagini,
che si trova a Soverato Alta (CZ) ed la Madonna delle Grazie (1497), che
fino al 1543 fu la Patrona di Naro, attribuibile a Giorgio da Brigno, da
Milano, di scuola gaginesca, proveniente dall'oratorio di Santa Barbara. Ed,
ancora, un Crocifisso ligneo del 1300, racchiuso in una artistica bacheca e
due statue lignee raffiguranti Santa Caterina e Santa Barbara, provenienti
dalla Chiesa omonima, che risentono ancora di formule gaginesche.
All'ingresso, due acqua-santiere di gusto chiaramontano. La Chiesa fu eretta
a Parrocchia nel Febbraio del 1542, dal vescovo Don Pietro D'Aragona
Tagliavia. È stata dichiarata Monumento Nazionale nel 1912.
Chiesa
della Madonna del Lume

La
sua fondazione, con il nome di Maria SS. del Lume nel Lazzaretto, risale
alla prima metà del 700' per opera di P. Giovanni Battista Timpanaro ed
apparteneva ai Padri Francescani.
Fu
ristrutturata nel 1738 e nel 1810, l'anno è inciso nel portale esterno
sopra la porta, quando fu eretto il coretto. L'interno, ad aula piccola,
presenta stucchi e cornici ben rifiniti.
Si
può ammirare la Madonna del Lume, interessante complesso statuario in legno, formato dalla Madonna che sulla mano sinistra sostiene il
Bambino, mentre con la destra afferra per un braccio un peccatore che sta
per cadere all'inferno.
La
facciata semplice, mette in risalto il pregevole portale di pietra da
taglio, finemente scolpito.
È
stata eretta parrocchia con decreto vescovile dell'1 gennaio 1959.
Palazzo
Malfitano e Museo della Grafica
Le
strutture originarie di quest'antico Palazzo Malfitano, dei Signori di
Giacchetto, risalgono al secolo XV. Con l'annesso ex ospedale di San Rocco
(in seguito chiamato Umberto I) costituisce un vasto quadrilatero ricadente
tra la Via Piave (una volta via Mazziotta Lauricella), Malfitano, Lucchesi e
Vitt. Emanuele, sul quale ricade il prospetto principale.
Esso
costituisce un esempio illustre dell'architettura civile della Città di
Naro.
Il
Palazzo fu donato da Donna Antonia Notarbartolo, marchesa di Malfitano e
discendente dei Giacchetti, dopo che i Minori Conventuali elevarono
l'attuale chiesa di San Francesco, che toglieva al palazzo la visuale del
mare e della vallata, alla città per alloggiarvi delle religiose che
dovevano educare le fanciulle d'ogni ceto nella fede ed in ogni genere di
lavoro femminile.
 Nel
1749 l'impegno fu assunto dalle suore del Collegio di Maria, ordine
istituito dal Cardinale Corradini a Sezze, che ebbe molta diffusione in
Sicilia. Nel
1749 l'impegno fu assunto dalle suore del Collegio di Maria, ordine
istituito dal Cardinale Corradini a Sezze, che ebbe molta diffusione in
Sicilia.
Così
divenne Collegio di Maria, per opera di Mons. Lorenzo Gioeni, Vescovo di
Agrigento.
Dichiarato
monumento nazionale, il palazzo comprendeva anche la chiesa di San Rocco,
con l'annesso ex ospedale, fondato nel 1544 per opera di Mazziotta
Lauricella, dei Signori di Giacchetto, per la cura dei pellegrini ed
ammalati poveri, dotandolo di ricche prebende.
Era
amministrato da quattro rettori laici ed era sede di un'arciconfraternita
d'artigiani e di sacerdoti, con il titolo di S. Maria degli agonizzanti, con
lo scopo di badare al seppellimento dei defunti poveri dell'ospedale ed alla
ricerca dei cadaveri d'indigenti, che si rinvenivano per strada.
Ristrutturato varie volte, nel 1676, nel 1772, nel 1776 e nel 1793.
Era
famoso sia per la ricchezza dell'edificio, sia per la bravura di molti
medici e chirurghi, che vi prestavano la loro opera gratuitamente.
Tutto
il fabbricato risente dell'influsso spagnolo, definito catalano, per lo
stile e la varietà delle soluzioni spaziali, costruttive e decorative.
Presenta
elementi architettonici della migliore tradizione costruttiva siciliana, nel
portale a piano obliquo, nel basamento esterno, nell'apertura incrinata e
nel contrafforte angolare.
Di
notevole interesse una magnifica finestra angolare con piattabanda, molto
rara per la difficile condizione di staticità cui è sottoposta, vera
genialità d'arte e di tecnica costruttiva, conservatasi benissimo durante
tanti secoli.
La
sottile colonnina è puramente ornamentale. Il frontone, molto pesante, si
regge da se, mediante un ingegnoso sistema d'archi interni, connessi fra
loro in modo tale che la risultante della forza centrale è non solo
equilibrata, ma superata dalla risultante della forza laterale.
Il
collegio fu chiuso nel 1914 per mancanza di fondi e l'ultima moniale, suor
Crocifissa, fu ospitata dalle Suore dell'Istituto Immacolata Concezione.

Fu
adibito, quindi, a pretura, a scuola ed a civile abitazione. Nel 1963 fu
riaperto da suor Felicita, ma, causa alcuni locali pericolanti, alcuni anni
dopo fu definitivamente chiuso.
Recentemente
è stato restaurato per destinarlo ad attrezzatura Polivalente (Museo della
grafica, del libro antico, del costume, etno-antropologico, etc.), di cui
già una sezione,quella della Grafica, è stata inaugurata l'11 giugno 2000,
con vivo successo di critica e di pubblico.
Il
Museo dell'arte grafica di Naro, voluto fortemente dal Maestro
Bruno Caruso, dal Sindaco Dr. Giuseppe Morello e dal Prof. Giuseppe
Camilleri è un importante evento culturale ed una validissima realtà
strutturale per altre lodevoli iniziative.
Il
Polo museale nato in un piccolo centro della Sicilia, assume rilevanza anche
a livello nazionale perché viene organizzato e gestito, per la prima volta,
da un'Ente locale. La stessa struttura, collocata nel cuore del centro
storico, si pone come richiamo per turisti e visitatori.
Consta
di una donazione di oltre 244 opere provenienti per la maggior parte dallo
stesso Maestro Bruno Caruso, (di cui 24 dello stesso Maestro), che
costituisce il nucleo originale della prestigiosa raccolta, sia dalle
successive acquisizioni di donazioni di altri insigni artisti, galleristi e
collezionisti.
Biblioteca Comunale "Feliciana"
La
fondazione della Biblioteca di Naro risale alla seconda metà del secolo
XVII, ad opera del Priore P.Melchiorre Milazzo da Naro, dell'ordine dei
Minori Conventuali Francescani, come si legge nella storia manoscritta di
Naro di Fra Saverio Cappuccino (1731), aiutato finanziariamente dalla sorella
Donna Felice, a cui la Biblioteca è dedicata.
È
situata nei locali del piano terra dell'ex Convento dei Frati Minori
Conventuali, oggi sede del Palazzo Comunale.
Del
suo prezioso patrimonio librario di circa 13.000 volumi, per la maggior
parte proveniente dall'ex Convento dei Francescani ed in minor parte dal
patrimonio librario dei Padri Minori di S. Maria di Gesù e dei Minori
conventuali Cappuccini, come si evince dallo stampo di appartenenza, fanno
parte:
a)
n. 23 incunaboli, contrariamente a quanto afferma l'annuario delle
biblioteche d'Italia, che ne ricorda solo 4. Tranne 2, i restanti sono di
argomento religioso. La stampa di questi volumi è curata da alcuni dei suoi
migliori cultori, quali Ottaviano Scoto, Andrea Torresani, Giorgio Arriva
Bene, Aldo Manunzio
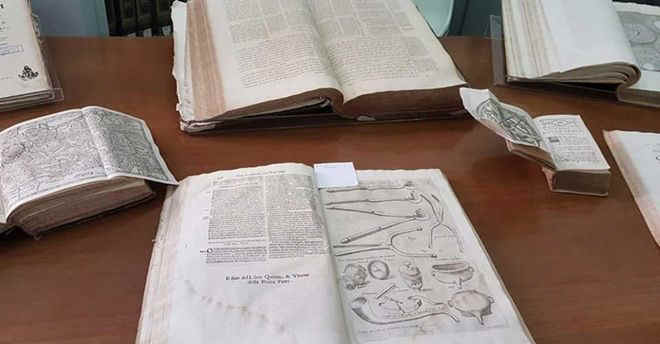 b)
n. 400 cinquecentine, circa, che abbracciano numerosi argomenti, quali
religioso, diritto, filosofia, letteratura. Provengono da diverse officine
tipografiche : quella di Andrea Torresani, dei Sessa, di Aldo Manunzio, di
Giovanni Scoto, degli Arriva Bene, dei Gregori. b)
n. 400 cinquecentine, circa, che abbracciano numerosi argomenti, quali
religioso, diritto, filosofia, letteratura. Provengono da diverse officine
tipografiche : quella di Andrea Torresani, dei Sessa, di Aldo Manunzio, di
Giovanni Scoto, degli Arriva Bene, dei Gregori.
c)
n. 56 manoscritti, contrariamente a quanto afferma l'annuario delle
Biblioteche d'Italia, che ne ricorda 47. Di questi manoscritti uno è di Fra
Salvatore da Naro e due sono di Fra Saverio Cappuccino, molto importanti
perché trattano della storia di questa Città dalle mitiche origini fino al
1825.
Ed,
altresì, n. 2 volumi "Segretia della Fulgentissima Città di Naro,
ovvero Costituzioni segreziali per Naro, del sec. XVIII.
Il
volume più pregiato è un codice pergamenaceo (sec. XII-XII)
"Breviarum Typis Gothicis-Pergamena Charta", in scrittura gotica
libraria miniata in oro, opera di amanuensi di scuola fiorentina, con fregi
e disegni allegorici rappresentanti figure animali, opera egregia di
amanuensi probabilmente di scuola bolognese, con influssi francesi.
Vi
sono, inoltre, numerose opere di narrativa, letteratura, scienze,
sociologia, saggistica, arte, storia, musica, nonché una sezione per
ragazzi ed una ricca gamma di opere siciliane, nonché una cineteca di feste
e tradizioni popolari.
La
biblioteca rimane aperta a disposizione del pubblico, con l'assistenza di
personale qualificato, tutti i giorni feriali.
Calvario
Un
Calvario fu fatto erigere nel 1619 per volontà di P. Gaspare Paraninfo,
della compagnia di Gesù, con il generoso contributo di Don Ottavio Specchi,
Cavaliere di Malta, Don Giovanni Tropia e Don Lorenzo Piaggia e di tutto il
popolo narese, fuori le mura, nel luogo ove si può ammirare ancora oggi.
Ristrutturato
varie volte nel corso dei secoli, nel 1925 venne ricostruito per opera del
Comm. Giovanni Filì ed, ancora restaurato, dalla di lui moglie, Ignazia
Dispinseri nel 1960, quando fece costruire anche la grande Croce in legno e
la ringhiera in ferro battuto, opera egregia di Ferdinando Rizzuto, esperto
artigiano locale.
Il
monumentale calvario si presenta oggi come uno dei più completi ed
armoniosi nella struttura della diocesi.
Nel
1630 il Vicario Generale, Don Antonino Bichetta, concesse alla chiesa di
Sant'Antonio Abate, i cui ruderi si possono ancora ammirare vicino al
Vecchio duomo, di solennizzare il Sepolcro il Giovedì Santo.
 E
da allora il Calvario, durante la settimana Santa, resta il luogo di
pellegrinaggio e di preghiera da parte dei fedeli. E
da allora il Calvario, durante la settimana Santa, resta il luogo di
pellegrinaggio e di preghiera da parte dei fedeli.
Da
parecchi anni il giorno del Venerdì Santo, diventa il sito della sacra
liturgia della Scinnenza Cruci, rappresentata con personaggi in costume.
Il
complesso monumentale si presenta in stile baroccheggiante, con due scale
aggettanti in ferro che si intrecciano fino ad arrivare alla base della
grande croce centrale, racchiusa da una piccola recinzione in ferro, con
accanto, fra due alberi di cipressi, le altre due croci, poste ognuna su un
grande piedistallo.
Al
piano terra vi è una cappelletta, dove la notte del Giovedì Santo viene
vegliato, per tutta la notte, il simulacro del Cristo morto, dai confrati
del SS. Crocifisso, con nenie e canti di dolore, chiamati lamienti.
Il
sepolcro è racchiuso da alte mura con cancello in ferro, mentre tutto
l'organismo monumentale è circondato da ringhiera in ferro chiusa da un
grande cancello.
Diga San Giovanni
La
diga San Giovanni sul fiume Naro, sorta per realizzare un serbatoio
artificiale, capace di circa 17 milioni di litri d'acqua, per l'irrigazione
di circa 5 mila ettari di terreno, ricadente nel comprensorio dei Comuni di
Naro, Agrigento, Favara e Palma di Montechiaro, rappresenta la tendenza ad
affermare condizioni per una agricoltura più moderna e redditizia.
L'invaso
ha una lunghezza di m. 3.200, con una larghezza massima di m. 950 e minima
di m. 220, circondato da una fascia di rispetto estesa H. 100, costituita da
un rimboschimento di circa 130.000 alberi di vario genere.
L'invaso,
non ancora attrezzato turisticamente, non è solo irrigazione, ma anche
sport. Oltre allo sfruttamento per l'uso irriguo, infatti, è utilizzato per
diverse attività sportive. È diventato, ormai, un punto di riferimento per
il canottaggio nazionale ed internazionale.
Il
primo appuntamento di grande risonanza è stato la XVI edizione della Coppa
Europea di canottaggio, svoltasi dal 26 al 28 luglio 1991, ripresa dalle
emittenti televisive nazionali in mondovisione, che hanno portato la Città
di Naro alla ribalta internazione dello sport remiero.
Un'altro
appuntamento di grande prestigio è stato il Trofeo internazionale dei
Templi, al quale è stata anche abbinata una lotteria nazionale. Ospita,
tutt'oggi, un ricco calendario remiero dei Campionati Regionali assoluti di
canottaggio, della Promozionale Montù e del Campionato Siciliano.

Catacombe
Sono
disseminate in varie zone vicino l'abitato: in contrada Canale, Coperta,
Donnaligara, Rio e Val Paradiso, Fontana di Rose, Muggiarra, formando un
complesso catacombale che potrebbe costituire un primo nucleo di parco
archeologico.
In
seguito ad opere di scavo vennero alla luce dei sepolcri incavati nella
roccia, dotati di vasi attribuiti all'età greco-sicula.
Da
un esame attento è stato stabilito che le scavature ed i vasi si succedono
in una disposizione diacronica. Differendo da sepolcro a sepolcro, infatti,
è stato ritenuto che la loro realizzazione era da collocare tra l'età
della pietra e la colonizzazione greca attraverso l'età del bronzo e del
ferro.
Nella
contrada Coperta, si possono rintracciare resti di un centro urbano con
materiale dal IV al V secolo a.C.
In
contrada Paradiso si potrebbe celare, secondo alcuni studiosi, una zona
archeologica di grande importanza.
Disseminati
sul terreno si possono notare frammenti di ceramica, blocchi di pietra
squadrati databile dal IV al II sec. a.C., resti forse di un impianto di
età romana imperiale.
Nella
contrada Rio alcune tombe sono andate perdute, resta qualcuna in pessime
condizioni.
Un'altra
chiamata l'Ammirabile è andata distrutta durante i lavori del troncone
ferroviario Naro-Canicattì nel 1906.
 Il
gruppo più importante e meglio conservato è quello delle catacombe
esistenti nel costone meridionale, in contrada Canale. Il
gruppo più importante e meglio conservato è quello delle catacombe
esistenti nel costone meridionale, in contrada Canale.
Questo
gruppo è caratterizzato da un lungo corridoio centrale con ingresso da Sud,
preceduto da dromos, lungo le pareti si aprono nicchie, in cui sono
collocate le sepolture.
La
più grande (ipogeo A) è conosciuta da sempre con il nome di Grotta delle
Meraviglie, esplorata dal francese Houel (1782), da due studiosi
tedeschi J. Fuehrer e V. Schultze (1872), dal Cavallari (1879), dal Salinas
(1896), fino ai naresi Domenico Riolo (1897) e Salvatore Pitruzzella (1938).
Essa è preceduta da un lungo dromos, che si allarga in un'area
semicircolare,alla quale si accede mediante un ingresso aperto nella parete
del dromos. L'ipogeo "B" è contiguo al gruppo "A", con
il quale comunica mediante un'apertura nella parete del dromos. L'ipogeo
"C" conserva l'arco d'ingresso, con corridoio centrale,ai cui lati
si aprono diverse nicchie con camere ipogeiche ed arcosoli a letto singolo e
bisomi.
Conserva
diverse sepolture, ancora intatte, con lastre di copertura.
L'ipogeo "D" si trova poco distante dagli altri. È in pessime
condizioni per diversi crolli. La datazione è del IV-V sec. a.C. Tutta la
zona Canale, scavata ed esplorata in maniera sistematica, potrebbe rilevare
altre catacombe, che potrebbero nel complesso costituire un grande parco
archeologico, davvero interessante.
Dal
punto di vista artistico la necropoli è poco importante, mentre dal lato
storico attesta che Naro già esisteva all'epoca cristiana ed il culto di
Cristo pare che debba rimontare all'anno 50 dell'era volgare ai tempi di San
Libertino, vescovo di Agrigento, mandato in Sicilia con Pancrazio, Filippo e
Berillo, dal Principe degli Apostoli, a divulgare la fede di Gesù Cristo.
È evidente che dalla dominazione romana alla conquista bizantina, Naro, da
Statio per il ristoro di uomini e di cavalli, divenne un fiorente villaggio,
con un numero di abitanti alquanto elevato, se si vuol considerare come
testimonianza questo vasto cimitero paleocristiano di contrada Canale.
Ed
ancora, numerose tombe nelle aree Serra Furore, Castellaccio, Siritino,
Deli.
Nella
contrada Noce, dove alle sepolture dell'età del bronzo si aggiungono tombe
paleocristiane, nella contrada Poggio Bisacce, dove resti di tegoloni
attestano nel sito la presenza greca. Ed, altresì, al periodo
ellenistico-romano pare che debba essere riferita la struttura di una villa,
scoperta in circostanze fortuite lungo la strada costruita sulla vecchia
linea ferrata a sud di Naro, vasto complesso che ancora oggi attende di
essere scavato.
Tradizioni
e folclore
La
sagra del mandorlo in fiore - La sagra
del mandorlo in fiore trova
origine a Naro, dove venne celebrata per la prima volta nel 1934. In
ricordo di ciò ogni anno si tiene in città, il lunedì successivo al
termine della sagra ormai spostatasi ad Agrigento,
la festa della primavera narese, che vede l'esibirsi di diversi gruppi
folkloristici locali ed internazionali e l'assegnazione del titolo di miss
primavera alla ragazza più bella e del trofeo aurea fenice.
La
festa di San Calogero - Il
patrono è san
Calogero, la cui
festa si tiene il 18 giugno, con una tradizionale processione durante la
quale la statua del santo nero, posta su una enorme slitta detta
"straula", viene trascinata dai fedeli con delle funi lunghe circa
200 metri, lungo le vie della città per circa un chilometro, dal santuario
di San Calogero fino
alla chiesa madre. Il periodo dei festeggiamenti ha inizio il 15 giugno con
"l'acchianata" del simulacro dalla grotta al Santuario e termina
il 25 giugno con la cosiddetta ottava di San Calogero. Durante questi dieci
giorni in città si svolgono diverse processioni con il simulacro del Santo
oltre a manifestazioni artistiche e culturali, le vie principali inoltre
sono allestite a fiera e mercato.
Durante
tutto l'anno il Santuario è meta di molti fedeli che vengono a ringraziare
il Santo per le molteplici grazie ricevute, uno dei modi più caratteristici
di ringraziare il Santo consiste nel portare al Santuario delle forme di
pane modellate come le parti del corpo guarite per intercessione del
patrono, san Calogero è infatti venerato come santo taumaturgo (che
guarisce dalle malattie). Queste forme di pane vengono benedette dai padri
guanelliani e poi distribuite ai fedeli. Il flusso di persone devote al
santo nero si fa più copioso a partire dal 18 maggio, inizio del mese di
San Calogero, e culmina con la festa del 18 giugno.
Secondo
la tradizione l'eremita sarebbe apparso, durante la grave pestilenza
dell'anno 1626,
a suor Serafina Pulcella Lucchesi, bizzoca cappuccina, sepolta nella grotta
del santuario di San Calogero, vissuta e morta in odore di santità. Nella
su apparizione il Santo annunciò che Dio si era placato per le sue
preghiere e che la peste sarebbe presto cessata. Le cronache inoltre narrano
che nel 1693 Naro,
sempre per intercessione del Santo, sarebbe stata preservata dal terribile
terremoto dell'11 gennaio, il fatto viene ricordato ogni anno con una
processione del simulacro per le vie cittadine. Ai tradizionali
festeggiamenti del 18 giugno e dell'11 gennaio da qualche anno si è
aggiunto un terzo appuntamento: la festa di "San Calò per gli
emigrati" che si svolge durante una delle domeniche di agosto con lo
scopo di permettere ai tanti emigrati che tornano durante le ferie estive di
poter festeggiare il Santo patrono.
La
statua del santo venne realizzata nel 1566 dallo
scultore Francesco Frazzotta di Militello, che morì prima di poter ultimare
l'opera che venne conclusa dalla figlia.

Pag.
2 
|