|
Le
origini di Sciacca sono antichissime, infatti si pensa che la cittadina sia
già stata abitata dall'era neolitica. Le prime testimonianze che il
territorio di Sciacca fosse abitato nella preistoria sono convalidate dai
reperti di scheletri umani e da alcuni massi intagliati, che probabilmente
servivano per sedersi o dormire. Il primo nucleo preistorico probabilmente
si estendeva tra la attuale via Figuli e la contrada Muciarè presso la foce
del torrente Bagni. Alcuni segni grafici, meglio visibili nel periodo in cui
visse il Fazello, si sono quasi cancellati, ma recenti studi ne hanno
confermato l'esistenza. Questi importantissimi segnali di civiltà remota si
sono trovati nella Grotta Stufa, sulla vetta del Monte Cronio. Sembra
certo, pertanto, che sin dai tempi più antichi, l'uomo abbia trovato in
questo monte il sollievo che scaturiva dalle sue sorgenti.
I
Saccensi – così vengono chiamati gli abitanti di Sciacca – ritengono
che l'antica città fosse ubicata nella valle formata dal Monte Nadore e
dal Monte San Calogero, a circa sei chilometri dall'odierna cittadina. In
questo posto sono venuti alla luce avanzi di fondamenta di grandi
dimensioni. Ciò confermerebbe l'esistenza dell'antica città abitata dai Sicani.
Un'altra testimonianza ci è data da una rupe situata a Caltabellotta (a
circa 15 km da Sciacca) dalla cui cima possono essere ammirate antiche celle
funebri sicane, le cosiddette grotte dei saracini.
Secondo
la leggenda, i Bagni a vapore (le cosiddette stufe di San Calogero) sul
Monte Cronio sarebbero stati impiantati da Dedalo circa mille anni prima
dell'era cristiana. Costui, fuggito da Creta per paura che Minosse lo
trucidasse, giunse in Sicilia dove venne accolto da Cocalo, re sicano
che viveva nella città di Inico. Grato per l'ospitalità ricevuta,
Dedalo costruì per il re il Castello di Camico su una cima di difficile
accesso, nel quale il sovrano custodì i suoi tesori. Minosse, venuto a
conoscenza del nascondiglio di Dedalo, raggiunse la Sicilia, in territorio
agrigentino, presso la città che dallo stesso prese il nome di Minoa.
Subito dopo, inviò dei messi a Cocalo affinché gli consegnassero il
fuggiasco. Cocalo accettò la proposta e invitò Minosse al suo castello, ma
mentre questi fece il bagno, lo fece soffocare dalle sue figlie, restituendo
il cadavere al suo popolo e giustificando la morte del re come se fosse
stata causata dall'essere scivolato nell'acqua calda.
Le
ceramiche ritrovate nelle grotte del Monte Cronio, risalenti al periodo di
transizione fra l'età della pietra e quella del bronzo, fanno
ritenere che la città di Cocalo fosse posta in questo sito. Secondo
accreditati storici, la spedizione militare in Sicilia di Minosse,
conclusasi con la sua uccisione, trova la sua spiegazione nel tentativo del
re cretese di conquistare quella città, così ricca di acque termali, luogo
di culto sacro a Cocalo, supremo sacerdote del dio delle acque. Poche sono
le notizie storiche certe.
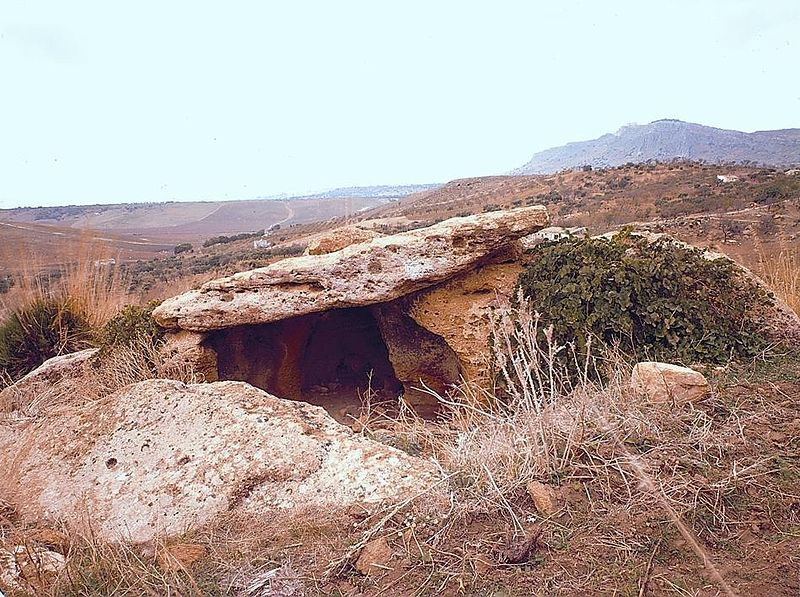
Le
iscrizioni fenicie rinvenute sul territorio saccense, invece,
confermerebbero il passaggio dei Fenici,una popolazione proveniente dal nord
della Palestina. I fenici ne fecero del territorio saccense (così come
l'intera Sicilia) un'importante rotta commerciale. Con la conquista dei
Greci i possedimenti siciliani dei Fenici si limitarono a Motya, Panormo e Solunto.
Nel VII
secolo a.C. Con la colonizzazione greca, secondo Tucidide, gli
abitanti di Selinunte (la cui fondazione risale al 628 a.C.)
formarono un agglomerato urbano e avevano costruito, come confine del loro
territorio, un castello a ovest nei pressi di Mazzara e uno ad est
nell'attuale territorio saccense che per le caratteristiche del luogo ricco
di acque minerali chiamarono Terme Selinuntine e la cui fondazione
è attribuibile al 620 a. C. Ciò si suppone che sia avvenuto non molto
tempo dopo la fondazione della stessa Selinunte. Il sito si trova
nell'odierna parte orientale di Sciacca. Questa parte di territorio
assommava le tre caratteristiche principali che la resero famosa, e che
furono la ragione della continuazione della sua esistenza: i bagni della
valle, le officine di ceramisti e le fosse scavate nella roccia per la
conservazione del grano.
Facendo
parte del territorio di Selinunte, Terme Selinuntine subì le
stesse vicende storiche. Con la sua caduta nel 409 a.C. in mano
cartaginese, Terme Selinuntine accolse parte della popolazione scampata alle
distruzioni della città, e fu anche teatro di due importantissime battaglie
durante la dominazione greco-punica. La prima battaglia, avvenuta nel 383
a.C., è stata quella della Cabala in cui Dionisio di Siracusa
ebbe la meglio sui Cartaginesi. Secondo la ricostruzione di alcuni storici
venne ucciso il duce Magone (tesi non condivisa dalle fonti
ufficiali, secondo le quali Magone perì durante il viaggiò di ritorno in
Africa) il quale fu sepolto nell'attuale contrada che porta il suo nome col
titolo di Baronia. Esistono delle pietre a forma di cono che gli stessi
storici hanno indicato come monumento funebre eretto dai Cartaginesi per
ricordare il loro capo.
Nella
seconda battaglia, quella di Cronio (avvenuta dov'era ubicata l'antica città,
come già ricordato, nella valle fra il Nadore e San Calogero) si ebbe nel 378
a.C. ed Imilcone, figlio di Magone, riuscì a conquistare con uno
stratagemma a danno di Dionisio il territorio selinuntino e quello
agrigentino, raggiungendo i confini del fiume Alico.
 A
tal proposito Pollieno ci racconta che Imilcone aveva posto il suo
quartier generale nella città di Cronio, i cui abitanti erano favorevoli ad
arrendersi. Ciò però non avvenne perché furono ostacolati dai generali di
Dionisio. Imilcone però non si arrese ed, approfittando del vento contrario
ai suoi nemici che si erano stabiliti nei pressi della città, incendiò il
bosco che li divideva. In questo modo il fumo gli permise d'entrare in città
senza essere notato dai capi siracusani. A
tal proposito Pollieno ci racconta che Imilcone aveva posto il suo
quartier generale nella città di Cronio, i cui abitanti erano favorevoli ad
arrendersi. Ciò però non avvenne perché furono ostacolati dai generali di
Dionisio. Imilcone però non si arrese ed, approfittando del vento contrario
ai suoi nemici che si erano stabiliti nei pressi della città, incendiò il
bosco che li divideva. In questo modo il fumo gli permise d'entrare in città
senza essere notato dai capi siracusani.
Le
guerre fra le due popolazioni, siceliota e punica, videro in sostanza il
territorio di Terme Selinuntine attraversato dagli eserciti di Dionisio,
Timoleone, Agatocle e Pirro.
Nel
III secolo d.C. Terme Selinuntine venne chiamata Aquae Labodes e
con i Romani, nel IV secolo d.C., divenne Stazione Postale per le
comunicazioni con l'Impero.
Successivamente
la città venne rappresentata sulla carta geografica da un grande edificio
di forma quadrangolare. Ciò fa supporre che nel periodo romano fosse
divenuta molto importante, forse la sede principale direzionale delle Poste
di tutta la Sicilia.
Durante
l'era romana il monte San Calogero era luogo di culto al dio Saturno.
Dopo
aver sbaragliato i Romani nel celebre sacco del 455 d.C., le città
siciliane vennero attaccate dalla popolazione di fede ariana poiché queste
erano ancora molto attaccate agli anti monaci greci. Fra le vittime di
questa persecuzione ne risentì il monaco San Calogero, che sfuggendo
dalle coste africane si rifugiò presso un antro del monte Kronio scacciò
i sacerdoti pagani, convertì la popolazione al cristianesimo e ridiede
vigore alle terme saccensi che, dopo la fine dell'impero romano, si
trovavano in stato di abbandono e disuso.
Nell'840 il
centro di Sciacca fu occupato dagli Arabi: da allora si chiamò col nome
attuale. Quello della dominazione araba fu un periodo di massimo splendore
dovuto anche al fatto che i sudditi siciliani potevano mantenere le loro
usanze in piena libertà. Nel paese oltre agli arabi convivevano perciò
altre identità culturali:ad oriente era abitato dai Figulini, che sin da
allora erano conosciuti per la lavorazione della creta. A mezzogiorno e
ponente soggiornavano gli Ebrei, poi la città si estese ancora, e sorse una
borgata che prese il nome di Rabato.
Fu
in questo periodo che Triocale assunse l'attuale nome di Caltabellotta e che
Terme Selinuntine fu mutato in Sciacca. Il nome "Sciacca" ha
origini diverse. Alcuni studiosi fanno derivare il nome dal vocabolo arabo
"Syac" che vuol dire "bagno"; altri da "al
Saqqah" che vuol dire la "separante"; comunque il più
attendibile risulta essere "Shaqqa" derivante da "Shai al
Quaaum".
Gli
arabi influenzarono molto il tessuto urbanistico della città, riscontrabile
ancor'oggi per esempio nel quartiere San Nicolò (anticamente chiamato Rabato e
abitato da musulmani) e nelle denominazione di alcuni quartieri (quali
Schiunchipani, Cartabubbo, Misilifurmi e Raganella) e diedero impulso
all'industria del cotone (ne è a testimonianza il complesso di origine
araba in contrada Lucchesi ormai in disuso dal 1600).
Nell'860 fu
distrutta Caltabellotta. Moltissimi profughi trovarono rifugio a
Sciacca e il Vescovado fu trasferito sul monte San Calogero ove
aveva sede l'antica Crono. Durante questa dominazione, per la città furono
anni prosperi per la sua popolazione. La città assurse grande importanza
non solo per la sua felicissima posizione, ma soprattutto perché a metà
strada fra due importantissime città, quali Mazara e Girgenti.
In questo periodo divenne capoluogo delle Circoscrizioni Territoriali e poté
godere dei pieni diritti di proprietà e di culto. Tra l'895 e il 1040 in
Sicilia vi furono contrasti fra Arabi e Berberi, e la popolosa città di
Sciacca subì le conseguenze dei suoi dominatori.
Nel
1038 il potere venne affidato a degli emiri; ciò portò a sanguinose guerre
interne e alla chiamata definitiva dei Normanni nel 1060.

Nel 1087 Sciacca
fu conquistata dai Normanni, i quali mantennero nel territorio le
divisioni che avevano compiuto gli Arabi e la città continuò ad essere il
capoluogo del suo territorio, rimanendo anche capitale delle vicine
circoscrizioni territoriali.
Secondo
il geografo arabo Edrisi, i confini erano delimitati nel modo seguente:
ad oriente dal fiume Platani, ad occidente dal fiume Belice, a nord dalla
catena di monti dopo Caltabellotta e a sud dal mare. Questi
confini furono ampliati successivamente dal Conte Ruggero I, con la
costruzione dei quartieri Ruccera (che collegava i quartieri Rabato e dei
Figuli) Cadda (quest'ultimo fatto costruire in seguito all'afflusso di ebrei
a Sciacca nel XIII secolo)e del "quartiere di masso" (costruito in
seguito delle migrazioni di genovesi, toscani, albanesi e veneziani)
Al
conte si deve anche la costruzione delle Fosse granarie del caricatore, la
riorganizzazione del servizio navale e l'imposizione del dazio sul grano da
esportare. Il caricatore, che si trovava a sud del Borgo della Cadda, rimase
in funzione sino al 1336, quando ne venne costruito un altro fuori
Porta del Mare.
Costruì
le mura e dei bastioni della città, restaurò il castello di Cocalo ed
l'edificò il castello Vecchio. Fuori le mura restarono i tre vecchi
sobborghi: quello dei Figuli, quello dei Musulmani detto Rabato,
Ruccera e quello degli ebrei chiamato Cadda. Tale nucleo sarà
conosciuto fino al XIX secolo col nome di Terra Vecchia.
Sciacca,
per lungo tempo, conservò il suo status di città demaniale, ad eccezione
del periodo in cui il conte Ruggero la concesse in feudo alla figlia
Giuditta (o Giulietta), sposa di Roberto Zamparrone.
A
tal proposito si racconta che Giuditta era fuggita con Roberto Zamparrone
contro la volontà del Conte, e per sfuggire alle ire del padre abbia
trovato rifugio in una grotta sul monte San Calogero. Il romita Mauro
dell'ordine Cluneacense, che abitava su quel monte, chiese clemenza al Gran
Conte, il quale perdonò i due fuggitivi che rientrarono al castello. Dopo
aver ottenuto la dispensa del Papa, il conte Ruggero li unì in matrimonio.
Le nozze si svolsero nella chiesa di San Pietro annessa al castello. Fu così
che il nome di Giuditta venne legato alla città di Sciacca.
Nello
stemma, usato fino al 1860, Giuditta volle raffigurata Santa Maria
Maddalena in mezzo a due leoni rampanti. Diverse sono state le
interpretazioni sul suo significato. Una vede nella Madonna la stessa
Giuditta, e nei due leoni il padre e il fratello Ruggero II. Un'altra
vede nella Madonna la città di Sciacca, e nei due leoni i fiumi Belice e
Platani. Lo stemma attuale che la città ha adottato è quello ritenuto
anteriore al periodo di Giuditta. Raffigura un cavaliere con la sua armatura
che corre verso il Castello delle tre Torri. Alcuni lo personificano in
Agatocle. A Giuditta si deve la costruzione della Torre del Fossato
(un'antica torre per banchetti oggi non più presente nel lato ovest della
città) delle chiese di San Nicolò la Latina, la Matrice, S.
Antonio Abate e San Pietro in Castro, il Monastero
delle Giummare. La sua morte avvenne tra il 1134 e il 1136.
Fra gli abitanti di Sciacca è sempre viva la sua memoria e da molti è
ricordata come la seconda fondatrice della città.

Durante
il periodo svevo in Sicilia, Sciacca ottenne parecchi privilegi, come
venivano riconosciuti in tutte le città demaniali. Il Comune venne retto da
un Magistrato, avente il diritto d'inviare i propri rappresentanti al
Parlamento. Nel 1231 il paese divenne centro commerciale per lo
scambio delle merci all'ingrosso, autorizzato dal Governo: lo scambio delle
merci al minuto venne affidato ad un giurato deputato. I beni della contessa
Giuditta passarono a Federico II che divenne erede anche dei feudi
normanni. Questi confermò i privilegi di cui godeva la città. A lui si
deve anche l'origine di alcuni casali fra i quali quello di Burgimilluso che
poi divenne Casale di Menfi.
A
Federico II successe il figlio Corrado II il quale, malgrado fosse
contrastato dal Papato, riuscì a regnare in Sicilia fino al 1254, anno
della sua morte. A quest'ultimo subentrò Manfredi che, incoronato
re nel 1258, mantenne Sciacca città demaniale con tutti i suoi
privilegi. Con la morte di Manfredi, e di Corradino scoraggiò
il governatore angioino che si ritirò a Messina.
Nel 1268 Sciacca
fu assediata da Carlo I d'Angiò, e l'anno successivo s'arrese. In
questo periodo la città fu sottoposta a soprusi d'ogni sorta. Con la rivolta
del Vespro a Sciacca (come in tutta la Sicilia) fu fatta strage di
francesi presso il Carmine. Per riconoscere i francesi si faceva pronunciare
la parola dialettale ciciri (ceci) che inconsciamente
pronunciavano come chichiri.
A
questo punto il paese si ribellò e si costituì in Comune libero. Capitano
fu eletto Isidoro Incisa, di nobile famiglia.
Quando Pietro
III d'Aragona, nella Chiesa della Martorana a Palermo, fu
proclamato re di Sicilia nel 1282, Sciacca contribuì a dare il suo
aiuto con le sue galere a sostegno delle lunghe guerre contro gli Angioini.
Fra le tante, per importanza, va ricordata la partecipazione di Sciacca e il
suo naviglio alla battaglia di Ponza nel 1300: in
quell'occasione fu fatto prigioniero il capitano della città Isidoro
Incisa, che poi riuscì a fuggire e mettersi in salvo. Un'altra grande
battaglia si combatté proprio a Sciacca nel 1302 e il suo assedio
durò quarantacinque giorni: gli abitanti resistettero fino all'arrivo delle
truppe di Federico II. Intanto nel campo nemico era scoppiata una
pestilenza che decimò l'esercito, costringendo Carlo II a ritirarsi e
chiedere la pace: venne firmata nel 1302 a Caltabellotta. Il
re, per riconoscenza dell'eroismo dimostrato, concesse l'immunità dei dazi
doganali e da ogni altro diritto della regia curia sulle merci importate ed
esportate, cosicché Sciacca divenne città franca.
Rotta
la pace di Caltabellotta nel 1312, ebbero nuovamente inizio gli assalti
degli Angioini in Sicilia, durati fino al 1373. Durante questo periodo
Sciacca divenne parecchie volte teatro di guerra e fu cinta d'assedio dalle
truppe angioine. Si difese eroicamente ma non poté evitare i contrasti con
fra le potenti nobili famiglie che parteggiavano per le due dinastie. In un
primo momento ebbero la meglio i Palizzi e i Chiaramonte sui Peralta e
i Ventimiglia, e Sciacca si schierò con gli Angioini a scapito degli
Aragonesi.

I
Peralta - Successivamente, nel 1355, la città passò in mano ai
Peralta e nel 1360, quando la principessa Costanza d'Aragona si
fermò a Sciacca per poi ripartire e raggiungere il consorte Federico III a Catania,
furono gli stessi Peralta a dimostrare che non era cessata la loro
solidarietà verso gli aragonese. In questo anni a Sciacca venne istituita
la carica di Capitano di guerra per la difesa della città. Tale compito fu
affidato a Guglielmo Peralta che divenne, durante il regno di
Federico III, il più potente e importante signore di Sciacca e del
territorio circostante.
Il
Peralta, oltre ad essere conte di Caltabellotta, poiché era apparentato col
re, possedeva vasti territori avuti in eredità, per occupazione o per
concessione regia. Dal re aveva ottenuto la rappresentanza della Magna
Curia, cioè l'istituzione di una suprema autorità con funzioni giudiziarie
inappellabili.
Forte
di questo appoggio, il Peralta riuscì persino a battere moneta ed istituire
una vera zecca. Grazie all'appoggio di altre nobili famiglie riuscì a
consolidare il suo potere tanto da essere investito dal re della facoltà
delle concessioni feudali. Alla morte del re, il Peralta fu uno dei quattro
vicari per la tutela della regina Maria di Sicilia appena
quindicenne. Gli altri tre vicari erano gli Alagona, i Chiaramonte e i
Ventimiglia. Nel 1390 la regina Maria si sposava col re Martino
il Giovane, ma i vicari e i baroni di Sicilia riunitisi a Castronovo
stabilivano di ricevere la regina Maria ma non Martino, condividendo la
volontà del papato che consideravano gli aragonesi scismatici.
Nel 1392 i
sovrani giungevano a Trapani e Guglielmo Peralta col figlio Nicolò
ed altri nobili si recavano per rendergli omaggio. Dei tre vicari si
schierava contro soltanto Chiaramonte e così Sciacca ebbe confermati tutti
i privilegi concessi dai sovrani precedenti. L'arresto e la condanna a morte
del Chiaramonte e il fermo dell'Alagona provocavano però una rivolta
popolare. Il re Martino chiedeva al Peralta il suo appoggio per domare i
rivoltosi ma questi in un primo momento si dimostrò contrario. Il figlio
Nicolò, poiché la rivolta si allargava a macchia di leopardo verso
l'entroterra, non tardava a convincere il padre ad affrontare le truppe
catalane comandate da Don Pietro Queralt. Nel territorio di Sambuca del 1395 ebbe
luogo una disastrosa battaglia e, malgrado la sconfitta subita dal Peralta,
le truppe nemiche non osarono avvicinarsi a Sciacca. Poco dopo moriva il
vecchio Guglielmo.
Nel
periodo in cui tenne il potere Guglielmo Peralta, a Sciacca venne realizzato
il Castello Nuovo, una vera fortezza inaccessibile costruita sulla roccia.
In seguito fu detto Castello dei Luna perché da loro in seguito abitato. Il
giovane Nicolò, figlio di Guglielmo, mantenne la carica di capitano della
città, e la carica di guardiano del Castello Vecchio e di quello Nuovo.

Età
moderna - Nel 1391 moriva anche Nicolò, e il re Martino,
recatosi a Sciacca per i funerali, alloggiò nel Castello Nuovo. Per
assicurarsi la continuità dei buoni rapporti, stabilì di dare in moglie
allo zio conte Artale Luna la figlia di Nicolò, Margherita
Peralta, malgrado l'amore della giovane era per il coetaneo Perollo,
figlio di un'altra nobile famiglia.
Le
nozze vennero celebrate a Sciacca nel 1400 alla presenza del re, e
furono causa di un triste episodio che passò alla storia come Caso di
sciacca. Infatti, la guerra civile che si scatenò ebbe origine dalle
controversie sorte tra la famiglia dei Perollo d'origine normanna e quella
dei Luna d'origine catalana durante il regno di Alfonso V in Sicilia, durato
dal 1400 al 1529 con immani conseguenze, riducendo la città in
uno stato di miseria ed abbandono. Dopo le suddette nozze, la famiglia
Perollo non sopportò la prepotenza del sovrano e scatenò un odio viscerale
verso la nobiltà catalana e straniera alla quale il Luna apparteneva. A
questo odio dei Perollo s'aggiunge quello di Bernardo Cabrera, conte di
Modica, che avrebbe pure preteso di fare sposare Margherita al figlio, in
modo da poter ancora di più ampliare il suo controllo territoriale.
Deceduti
Martino il Vecchio e il figlio Martino il Giovane, in Sicilia gli
abitanti aspiravano ad avere un loro re. Si erano intanto formati tre
fazioni: una catalana capeggiata da Bernardo Cabrera, un'altra dalla regina
Bianca, moglie di Martino il Giovane che il re aveva sposato dopo la morte
di Maria, e un'altra ancora della nobiltà siciliana a cui aderivano molti
Comuni che si erano ribellati alla regina. Il conte Luna seguiva la fazione
di Cabrera, ma gli abitanti di Sciacca rimasero fedeli alla regina. Nel 1411 il
Cabrera occupava la città, ma non il Castello Vecchio, difeso ad oltranza
da Pietro Garro. Un intervento della regina liberò il castello e la città.
Nel 1416,
il prestigio della famiglia Peralta passò ad Antonio, il figlio del Luna,
che ebbe dal re Alfonso la concessione della castellania di Sciacca. Dava
cioè il massimo onore oltre il diritto di dimora nel Castello Vecchio.

Durante
il periodo in cui regnò Alfonso V Sciacca, grazie alla sua posizione,
divenne una delle città più importanti della Sicilia. Ma ancora una
volta le rivalità tra le famiglie Luna e Perollo turbarono la sua prosperità.
Tale rivalità, estesasi alla popolazione, culminò nella lite che i Luna e
i Perollo ebbero per la rivendicazione della Baronia di San Bartolomeo. Nel 1438 intanto
la città veniva venduta a Giovanni Ventimiglia, marchese di Geraci,
ma nel 1443 veniva riscattata.
Nel 1448 l'intervento
del viceré faceva concordare una pace tra le famiglie Luna e Petrollo, ma
non passò molto tempo che fu violata. L'occasione s'ebbe nel 1459 quando
Antonio Luna stava partecipando alla processione della Santa Spina di
Cristo. Giunto dinanzi al palazzo dei Perollo, il Luna insultò il rivale
pubblicamente, forse convinto che non venisse ascoltato vedendo le finestre
chiuse. Le imposte s'aprirono improvvisamente e Pietro Perollo raggiunse il
corteo ferendo il rivale. I suoi uomini incendiarono le case dei Luna,
portarono lo scompiglio tra i fedeli e si rifugiarono nel castello di Geraci.
Dopo quest'atto terroristico, il viceré inviò a Sciacca il luogotenente
del Maestro Giustiziere, Giacomo Costanzo, per istruire un processo e punire
i fautori di questi fatti.
Ritornato
da Caltabellotta, Antonio Luna scatenò la sua vendetta, facendo
assassinare familiari e parenti dei Perollo, distruggendo le loro case, e
persino la città subì gravi danni. Il re Giovanni I, succeduto ad Alfonso
V, per evitare nuove sciagure alla città, esiliò i Luna e i Perollo dal
regno e confiscò tutti i loro beni.
Nel 1494 Ferdinando
V insigniva la città col titolo di Degna per la sua gloriosa storia, il suo
vasto territorio e per la sua bellezza. Giacomo Perollo diveniva
potente signore e otteneva la carica d'amministrare la giustizia e le
attività del Comune. Diveniva anche deputato al Parlamento.
Ma
gli odi non si erano sopiti e nel 1528 quando vennero uccisi sette
componenti della banda di Marco Lucchesi, accanito nemico del Perollo,
riesposero le rivalità. Non molto tempo dopo l'eccidio degli uomini di
Lucchesi, giungeva a Sciacca il corsaro Sina Bassà il quale offriva il
riscatto del barone di Solanto. Respinte le offerte del Luna accoglieva
quelle del Perollo. Il Luna per vendicarsi dell'affronto, nel 1529, con
un esercito d'un migliaio di uomini cinse d'assedio ed entrò nel Castello
Vecchio. Il Perollo, tradito da una spia, fu ucciso. I parenti però non
s'arresero, ottenendo un decreto con il quale il Luna veniva condannato a
morte ed i suoi beni confiscati.
Fuggito,
Il conte si recò a Roma per ottenere la clemenza di Carlo V e di
Clemente VII ma, non essendogli accordata, si suicidò buttandosi nel Tevere.
Nel 1542 gli abitanti Sciacca si rivoltarono contro le
persecuzioni del Sant'uffizio, rivolgendosi al Parlamento per fermare gli
inquisitori: l'abolizione in Sicilia avverrà due secoli dopo.

Età
contemporanea - Il periodo intercorrente tra il 1554 e il 1712 a
Sciacca è caratterizzato da terremoti, rivoluzioni, fame e miseria.
Malgrado ciò sorgono chiese e nuovi palazzi, mentre Filippo II conferma
Sciacca Urbs dignissima et fidelissima.
Nel 1647 la
città si ribella e vengono aboliti i dazi sul vino e sul macinato, non
prima però che i manifestanti raggiungessero il Comune, incendiando
l'archivio ed uccidendo il maestro notaro. Nel 1713 la Sicilia con Vittorio
Amedeo II di Savoia riaveva il proprio re e così anche Sciacca
festeggiava.
Nel 1718 la
Spagna mandava però la sua flotta per ristabilire il governo spagnolo in
Sicilia e anche Sciacca si sottomise. Ciò provocò la reazione dell'Austria
e la città fu messa nuovamente sott'assedio capitolando dopo tre giorni.
Era il 1720 e il presidio spagnolo venne smantellato, cosicché
Sciacca obbedì all'imperatore Carlo VI. Nel 1726 Carlo VI
concludeva la pace con la città di Tripoli, Tunisi e
Sciacca. Malgrado vivesse ancora nella miseria, venne agevolata nei suoi
commerci in quanto venne evitato il pericolo dei corsari che infestavano i
mari lungo quelle rotte. Nel 1734 Carlo di Borbone occupava la
Sicilia ed a Sciacca veniva istituito il consolato del mare. La città si
riprendeva dal suo torpore e venivano intensificati i traffici via mare,
nonché via terra con la costruzione dell'arteria per Palermo.
Nel 1759 a
Carlo III di Borbone succedeva Ferdinando I, il quale conferì a Sciacca la
facoltà di giudicare nelle cause civili e criminali. La Costituzione del 1820 aboliva
i privilegi ed affermava l'uguaglianza dei cittadini. Alla città venne
riconosciuto l'antico nome: Distretto di Selinunte con Sciacca capoluogo.
Nel 1821,
Ferdinando aboliva la Costituzione e Sciacca diveniva provincia di Girgenti.
Sorta la carboneria, la città partecipò con i suoi patrioti alle rivolte
per l'indipendenza dai Borboni. Nel 1860 giungeva Garibaldi a Marsala e
a Sciacca la notte tra il 13 e il 14 maggio i patrioti Bartolomeo Tommasi,
Luigi Azzara, Alfonso Friscia, Francesco Lombardo e Giuseppe Campione
inalberavano sull'aquila di pietra della vecchia casa comunale in via
maestranza, oggi Via Garibaldi, la bandiera tricolore. Acclamato dal
popolo, veniva riconosciuto il costituito Comitato rivoluzionario, il quale
dichiarava decaduto il governo borbonico e proclamata l'annessione al Regno
d'Italia. Sciacca divenne capoluogo di un circondario della provincia
di Girgenti.
Durante
la Seconda guerra mondiale, a Sciacca vi era una Base aerea, ben
mimetizzata, punto strategico del Mediterraneo, utilizzato dalla Regia
Aeronautica (1940 – 1943).
Itinerario
turistico

Il
territorio saccense si estende lungo la costa del Mediterraneo, del quale
mostra la varietà e la ricchezza del paesaggio, viene delimitato dai fiumi
Carboi e Verdura e il suo verde si estende fino alla piana di Menfi. Dal
mare Sciacca si innalza fino al Monte San Calogero, che si erge fino a 386m
s.l.m. Grazie alle sue fertili terre una delle attività economiche
prevalenti è l'agricoltura; ecco che dagli estesi uliveti viene prodotto un
olio eccezionale e dai verdeggianti vigneti un vino prelibato frutto di
"gioconda vite"; inoltre fedeli alla storia e alle tradizioni, le
terre saccensi pavoneggiano i sempreverdi agrumeti, che deliziano l'aria con
il loro denso profumo di zagara.
L'itinerario,
che vi consigliamo parte da Sciacca, un'antica e bella città costruita su
una collina dominante il mare. Percorrendo la costiera SS.115 che è un
continuo salire sui rilievi e scendere nel letto dei fiumi che sboccano a
mare, senza mai attraversare i paesi che sono tutti all'interno.
Dopo
circa 25 km da Sciacca lasciate la SS.115 in direzione di Borgo
Bonsignore e della Riserva naturale della foce del fiume Platani:
potete passeggiare per sentieri ben segnati nel bosco della riserva che si
affaccia sulla lunghissima, affascinante e solitaria spiaggia. Tornate poi
sulla SS.115 e dopo altri 4 km girare nuovamente a destra seguendo le
indicazioni per le rovine della città greca di Eraclea Minoa.
Posta
in meravigliosa posizione su un promontorio alto sul mare, Eraclea fu
fondata verso il VI sec. a.C. dai greci della vicina Selinunte e fu abitata
sino al I sec. d.C. quando venne inspiegabilmente abbandonata. Si visitano i
resti dell'abitato e del teatro e il piccolo museo che conserva reperti
rinvenuti in loco ma più che le rovine è eccezionale il sito da cui si
gode un vastissimo panorama sulla costa e sul bosco della riserva del fiume
Platani.
Sotto
la rupe di Eraclea, in una bella pineta, c'è un piccolo centro turistico:
da qui si apre un'altra lunghissima spiaggia bordata dalla pineta, un altro
posto fantastico per interminabili passeggiate sulla riva, bei bagni di mare
e rilassanti dormite in pineta.
 Si
ritorna nuovamente sulla SS. 115 proseguendo in direzione Agrigento: dopo
circa 4 km entrate nel paese di Montallegro seguite la strada vecchia,
lenta e tortuosa. Si
ritorna nuovamente sulla SS. 115 proseguendo in direzione Agrigento: dopo
circa 4 km entrate nel paese di Montallegro seguite la strada vecchia,
lenta e tortuosa.
Passate
Siculiana, tornate sulla strada nuova ma dopo altri 4 km riprendete la
strada vecchia che passa per Realmonte e raggiunge poi Capo Rossello,
un altro impressionante promontorio di roccia bianchissima che si butta in
un mare color turchese: ora la strada scorre vicinissima al mare offrendo
splendidi panorami. In breve arriverete a Porto Empedocle, il porto
peschiero e mercantile di Agrigento: poco prima del centro abitato, nei
pressi dell'hotel Madison si trova la spiaggia detta Scala dei Turchi, con
una grande roccia bianca a gradoni, molto caratteristica; altre spiagge
belle sono pochi km più avanti e quindi decidete voi cosa fare, se
stendervi a riposare o andare a visitare i dintorni.
Agrigento
fu fondata nel VI sec. a.C. da greci di Rodi e Creta, divenne una delle più
importanti città della Magna Grecia e uno dei maggiori centri della Sicilia
con i romani e poi con gli arabi e con i normanni. Restano monumenti di
tutte le epoche ma il vero gioiello di Agrigento è la Valle dei
Templi, un insieme di templi eretti nel V sec. a.C. dei quali è rimasto in
piedi lo splendido Tempio della Concordia. Si chiama Valle dei Templi
ma in realtà i templi sono eretti su un crinale fuori dalla città, in un
luogo panoramico con vista sulla piana che termina nel mare: un consiglio è
di visitare il sito appena aprono.
Poco
lontano, a Villaseta, si trova la casa natale di Pirandello nella quale
è allestito un piccolo museo dedicato allo scrittore. Anche il centro
storico di Agrigento merita una visita con le strette vie e i numerosi e
interessanti edifici antichi: l’abbazia di S. Spirito (del sec. XIII, con
il chiostro), la bella via S. Girolamo con vari palazzi settecenteschi,la
Cattedrale e la chiesa di S. Maria dei Greci (sec. XIV).
Si
riprende la strada costiera che porta al borgo di S. Leone per proseguire
correndo accanto a una lunga spiaggia sinché la strada piega verso
l’interno sino a raggiungere la SS. 115 che imbocchiamo in direzione Gela-Siracusa:
dopo circa 4 km si trova sulla sinistra l’imbocco di una strada minore che
porta alla Ciavolotta, una delle tante miniere di zolfo che si trovano tra
Agrigento ed Enna (altre miniere si trovano a Delia, Serradifalco e dietro
la stazione di Campofranco). Le miniere di zolfo si svilupparono nel corso
dell’Ottocento raggiungendo il massimo della produzione nei primi anni del
Novecento, per poi calare sino a scomparire negli anni Ottanta: è in queste
miniere che i, bambini a partire dai sette anni, venivano reclutati dai
picconieri per trasportare il minerale dall’interno della miniera
all’aperto.
Dopo
aver dato uno sguardo a quanto resta della miniera e delle attrezzature
produttive (si scavava il minerale a trecento metri sotto terra) si ritorna
sulla SS.115 sino a raggiungere Palma di Montechiaro, paese natale di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (autore del famoso romanzo “Il Gattopardo”,
ambientato in Sicilia nella seconda metà dell’Ottocento: dietro alla
bella chiesa barocca si trova il settecentesco palazzo Tomasi di Lampedusa).
A circa 5 km da Palma si trova, su una scogliera a picco sul mare, il
trecentesco castello di Palma, in posizione panoramica.
Lasciata
Palma si prosegue seguendo la strada che si inoltra nell’arido entroterra,
si passa Camastra e si raggiunge Naro, un’antica città dominata da un
castello quattrocentesco e caratterizzata da numerosi palazzi e chiese
barocche, tra le quali S. Salvatore e il Duomo normanno, in rovina.
Da
Naro si prosegue in direzione Canicattì percorrendo una strada tortuosa tra
le spoglie colline dove si percepisce una strana solitudine che nel passato
doveva essere ben maggiore e più opprimente.
Poco
prima di Canicattì si gira a sinistra imboccando la SS. 122 in direzione
Agrigento, correndo prima per bei rettilinei e poi arrampicandosi sui
versanti della Sella Monello e poi giù nella valle del torrente Iacono sino
a raggiungere Favara, cittadina di origine araba, che conserva un castello
quattrocentesco eretto dalla famiglia di Chiaramonte e la barocca Chiesa
Madre.

 Pag.
2
Pag.
2 |