|
Storia,
folklore e gastronomia si fondono in maniera perfetta in una splendida
provincia nel cuore della Sicilia, Caltanissetta. Una provincia che affonda le proprie radici in un passato
lontanissimo, che rivive attraverso le testimonianze degli scavi
archeologici e nei castelli sparsi
sul territorio.
La
storia della provincia di Caltanissetta è costellata dal passaggio
di molte dominazioni che hanno
lasciato la loro impronta: greca, romana, araba-normanna, sveva,
angioina, aragonese e castigliana.
Il periodo di massimo splendore è legato allo sfruttamento dei grandi
giacimenti di zolfo,
oggi dismessi, che sono entrati a far parte del patrimonio
storico-naturalistico di questa provincia.
Dirigendosi
verso il confine agrigentino,
il paesaggio ancora mostra i segni delle antiche miniere,
con i pozzi e le gallerie che hanno modificato il profilo delle
montagne.
Le colline
brulle e giallognole in primavera si trasformano in un verde
intenso, cambiando radicalmente il paesaggio. Dolci rilievi degradano
verso il breve tratto di costa che segna lo sbocco sul mare della
provincia. I vivaci colori delle coltivazioni di
uliveti, vigneti e agrumeti animano l’intera zona per poi confondersi
con l’azzurro del mare. Il Nord è
segnato da monti, colline e ampi valloni, habitat ottimale per la
coltivazione di noccioli, vigne e ulivi.
Il toponimo deriva
dall'arabo Qalʿat
an-nisāʾ,
letteralmente traducibile come "rocca delle donne", o
"castello delle donne", che è il nome con cui il geografo
arabo Idrisi indica
la città nel 1154.
Il motivo per cui la località fosse appellata in questo modo rimane
sconosciuta e l'ipotesi che il castello
di Pietrarossa fosse un harem a
servizio dell'emiro di Palermo sembra essere smentita dalla natura
militare della fortezza. Secondo la storica nissena Rosanna Zaffuto
Rovello il nome era dovuto al fatto che gli uomini, a causa della
distanza dei campi coltivati, fossero costretti a dimorare fuori dal
villaggio, dando così l'impressione che fosse abitato solo dalle donne.
Con
l'arrivo dei Normanni,
nell'XI secolo la città incominciò ad assumere il nome latinizzato di Calatenixet,
secondo la versione del Malaterra, o Calatanesat, in una
traslitterazione dall'Arabo di un testo di Muhammad
al-Idrisi. Già alla
fine del XII
secolo, lo storico Ugo
Falcando, nel suo Liber
De Regno Sicilie, parla
di Caltanixettum, che risulta essere la traduzione
ufficiale dell'odierno nome in latino.
Secondo
una ricerca dello studioso Luigi Santagati, il
toponimo dimostrerebbe l'esistenza, mai confermata, di un borgo
preesistente di origine bizantina. Secondo questa teoria, nisā,
"donna" in arabo, sarebbe la storpiatura di Nissa,
il nome della città dell'Anatolia da
cui provenivano gli stratioti bizantini che
avrebbero costruito il castello
di Pietrarossa e il
vicino villaggio, che avrebbero chiamato Nissa, lì dove sorge il
quartiere degli Angeli. In seguito alla conquista da parte degli Arabi,
questi avrebbero aggiunto al nome originale del borgo il prefisso Qalʿat,
"castello", analogamente a quanto fecero a Henna, l'odierna Enna,
che rinominarono Qasr Yannae, divenuta poi Castrogiovanni, e
in altre località di cui storpiarono o integrarono il nome bizantino.

Gli
albori di Caltanissetta vanno cercati in epoca molto antica: reperti
dell'età
del bronzo trovati nei
pressi della città indicano che la zona è abitata fin dal IV
millennio a.C. La
posizione strategica fu certamente il motivo per cui gruppi di uomini,
già a partire dall'ultimo neolitico,
decisero di insediarsi in questa particolare zona della Sicilia centrale,
su delle alture da cui si poteva dominare tutto il paesaggio
circostante, molto vicini alla costa settentrionale e collegati alla
costa meridionale dall'Imera
meridionale, fiume che
all'epoca risultava essere navigabile.
Il
primo nucleo urbano, di origine sicuramente sicana,
si formò nella zona del monte Gabal
al Habib, attestato da
un'epigrafe del 397
a.C. nella quale si sarebbe
letto per la prima volta il nome Nissa che, con
l'arrivo dei Greci intorno
al VII
secolo a.C., sarebbe stata
posta sotto il presidio di Siracusa.
Dopo
la seconda
guerra punica, la Sicilia
passò sotto il controllo dei Romani.
Fino a qualche anno fa si pensava che nel 123
a.C. il territorio
nisseno fosse stato invaso dai Romani guidati dal console Lucio
Petilio, che vi avrebbero
installato una colonia chiamata "Petiliana" in suo onore. Dopo
recenti studi, si tende a pensare che la colonia Petiliana corrisponda
alla vicina Delia.
Ciononostante si è voluto che il presunto passaggio del console
rimanesse un segno indelebile nella toponomastica della zona, per
esempio a Borgo
Petilia, in realtà nome
attribuito dal Fascismo nel XX secolo. Un importante indizio della
presenza latina risiede nei resti di una villa a nord-ovest di Sabucina,
da dove provengono vari reperti archeologici, tra cui un busto
dell'imperatore Geta.
Durante
il dominio
arabo, delle famiglie di
origine berbera si stanziarono in un borgo corrispondente all'attuale
quartiere degli Angeli, che battezzarono Qalʿat
an-nisāʾ("castello
delle donne").
In
base ai suoi studi sull'origine del toponimo Caltanissetta,
lo studioso Luigi Santagati sostiene che i primi ad abitare nell'attuale
luogo della città potrebbero essere stati i Bizantini,
che nella seconda metà dell'VIII
secolo avrebbero
edificato il castello
di Pietrarossa e
l'annesso borgo che avrebbero chiamato Nissa dal
possibile nome della città di provenienza degli stratioti fondatori
sita in Cappadocia. Con l'arrivo degli Arabi,
intorno all'846,
il nome sarebbe diventato Qalʿat
an-nisāʾper
assonanza con il vecchio nome bizantino.

Nel 1087,
la città venne occupata dai Normanni,
e divenne possedimento del Gran
Conte Ruggero, che la
trasformò in feudo per vari membri della sua famiglia e fondò
l'abbazia in stile romanico di Santo Spirito, laddove si trovava un
villaggio rupestre e un convento basiliano sorto forse sui resti di una
fattoria di origine romana. Primo feudatario di Caltanissetta, dopo
Adelasia, nipote del Gran Conte Ruggero, fu Gosfredo di Lecce, signore
di Montecaveoso forse dal 1153 al 1155.
Durante
il dominio
aragonese nel 1296 Federico
III nominò conte Corrado
I Lancia. Nel 1361 i
baroni Francesco
Ventimiglia e Federico
Chiaramonte assediarono Federico
IV nel Castello di
Pietrarossa, dove aveva trovato rifugio, e fu salvato dai nisseni, che
non sopportavano la prepotenza dei due baroni.
Nel 1365 Guglielmo
Peralta, che già controllava Sciacca e Caltabellotta divenne
il signore di Caltanissetta. Nel 1358 aveva
riunito nel Castello di Pietrarossa gli altri tre uomini più potenti
della Sicilia di allora: Artale
Alagona, Manfredi
Chiaramonte, Francesco
Ventimiglia, che si
spartirono l'intera Sicilia nel cosiddetto Governo
dei Quattro Vicàri, che
tuttavia durò fino al 1392,
quando Martino I
di Sicilia intervenne
militarmente. Il re Martino I regnò fino al 1409,
quando gli successe il padre Martino
I di Aragona, che però morì
un anno dopo, nel 1410.
Nel 1407 Caltanissetta
passò ai Moncada di Paternò (con
la nomina di Matteo
II Moncada conte da
parte di Martino I), a cui resterà per 405 anni, fino all'abolizione
della feudalità in Sicilia, nel 1812.
Nel 1553 fu
costruito il ponte
Capodarso sul fiume Salso,
a un'unica arcata, alta quasi 20 metri, per facilitare le comunicazioni.
La costruzione è tutt'ora esistente e percorribile, pur avendo subito
alcune modifiche nel tempo.
Nel
febbraio del 1567 un
forte terremoto colpì la città, e il castello di Pietrarossa ne rimase
gravemente danneggiato. A quel punto i ruderi del castello vennero
utilizzati come cava per la ricostruzione del resto della città, e
rimasero in piedi solo i resti di tre torri, due delle quali sono ancora
visibili.
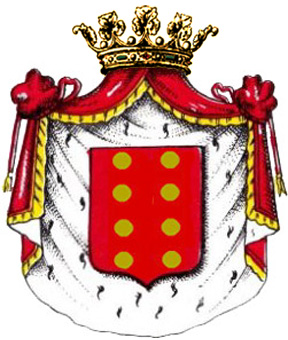 Nel 1718 a
Caltanissetta scoppiò una rivolta antisavoiarda, come in molti altri
centri siciliani.
L'11 luglio di quell'anno le truppe sabaude di Vittorio
Amedeo II di Savoia, guidate Nel 1718 a
Caltanissetta scoppiò una rivolta antisavoiarda, come in molti altri
centri siciliani.
L'11 luglio di quell'anno le truppe sabaude di Vittorio
Amedeo II di Savoia, guidate
dal vicerè Annibale
Maffei attraversarono la
città. Durante la battaglia ci furono 53 vittime tra i nisseni e 17 tra
i soldati piemontesi.
Nel 1787 vi
soggiornò il poeta Goethe,
che nel suo saggio Viaggio
in Italia la
descrisse come una «città ben situata e ben costruita».
Nel 1816,
in pieno periodo
borbonico, Caltanissetta fu
elevata a capoluogo
di provincia, grazie alla
mediazione del giurista Mauro
Tumminelli. Per
questo motivo la popolazione nissena si rifiutò di partecipare ai moti
separatisti di Palermo del 1820,
e la città dovette subire un saccheggio da parte di alcune bande
armate, formate da galeotti ed ex carcerati, capitanate da Salvatore
Galletti, principe di San
Cataldo, che devastarono la
città dopo un sanguinoso combattimento nei pressi del Convento
di Santa Maria della Grazia,
a quei tempi posto all'ingresso della città. Da questo evento nacque la
ormai proverbiale rivalità tra le due città.
La
città fu colpita dal colera nel 1837 e
successivamente per altre due volte (1854 e 1866).
Aderì
ai moti rivoluzionari e indipendentisti del 1848-1849,
guidati da Ruggero
Settimo, che ebbero termine
proprio a Caltanissetta, dove fu firmata la capitolazione dei
rivoluzionari.
Garibaldi e
i suoi Mille giunsero
a Caltanissetta il 2 luglio 1860 e
vi fecero ritorno il 10 agosto. Come l'intera Sicilia venne annessa al Regno
d'Italia lo stesso anno.
Dopo
l'Unità
d'Italia fu interessata
da un grande boom economico dovuto soprattutto ad un'intensa attività
mineraria, che però fu spesso accompagnata da varie sciagure: il 27
aprile 1867 morirono
47 persone a causa di un'esplosione di grisou nella miniera
di Trabonella, 65 minatori
persero la vita a Gessolungo il
12 novembre 1881 sempre
per un'esplosione, e altri 51 nel 1911 a Deliella e
a Trabonella.
In
questo periodo, la vita politica nissena è dominata da due figure
importanti: Berengario Gaetani (che fu sindaco
dal 1891 al 1894 e
poi dal 1897 al 1911)
e Ignazio
Testasecca, importante
imprenditore minerario che venne eletto alla Camera
dei deputati per ben
otto legislature consecutive nel collegio di Caltanissetta. Durante la
sindacatura di Gaetani si realizzarono numerose opere pubbliche, come
l'allargamento della strada che conduceva al Convento
dei Cappuccini, che venne
intitolata alla Regina
Margherita, mentre Testasecca
donò mezzo milione di lire per la costruzione di un ospizio di
beneficenza in contrada Palmintelli, a lui intitolato, che gli valse il
titolo di conte concessogli
da re Umberto
I tramite motu
proprio. Altra figura
politica di rilievo fu quella dell'avvocato Agostino
Lo Piano Pomar, che fu
dirigente della sezione nissena dei Fasci
siciliani e poi nel 1905 uno
dei fondatori della Camera
del Lavoro di
Caltanissetta, che nasceva dalle rivendicazioni di giustizia sociale dei
minatori nisseni.
 Le
strade rotabili la collegavano a Piazza Le
strade rotabili la collegavano a Piazza
Armerina, Barrafranca e Canicattì fin
dal 1838,
ma la ferrovia arrivò
solo nel 1878,
con l'apertura della stazione
ferroviaria e la
costruzione della via Cavour, che doveva collegare lo scalo al centro
della città. Nel 1867 giunse
l'illuminazione
a gas, nel 1914 l'arrivo
dell'elettricità permise
l'apertura del primo cinematografo.
Nel 1920 le
elezioni amministrative videro la vittoria del fronte social-riformista,
con l'elezione a sindaco di Agostino
Lo Piano Pomar, che però
produssero numerosi disordini tra le varie formazioni politiche, alcuni
dei quali sfociarono nell'uccisione di Gigino
Gattuso, che verrà poi
celebrato come "martire fascista". Durante la Seconda
guerra mondiale, tra il 9 e
il 13 luglio 1943,
Caltanissetta fu teatro di pesanti
bombardamenti da parte
delle forze aeree anglo-americane nel quadro dello sbarco
degli Alleati in Sicilia,
durante i quali persero la vita 350 civili. Tali eventi furono
anticipati da un mitragliamento aereo occorso in città la notte tra il
17 e il 18 giugno precedenti. Inoltre, alla fine dello stesso mese, una
colonna tedesca venne mitragliata nelle vicinanze del ponte
Capodarso.
Truppe
americane sbarcarono a Licata la
mattina del 10 luglio 1943 alle
ore 2,45 nella spiaggia di Mollarella con la 3ª divisione fanteria e il
18 luglio occuparono la città.
Pochi
mesi prima, il 21 marzo 1943,
un grave incidente ferroviario interessò un treno militare che
trasportava 800 soldati del 476º battaglione costiero da Castrofilippo
a Termini Imerese, causando 137 morti e 360 feriti.
Pian
piano Caltanissetta incominciò a rimarginare la maggior parte delle
ferite ricevute in eredità dopo la guerra: negli anni cinquanta
incominciò il restauro della Cattedrale, distrutta
dai bombardamenti dell'aviazione americana
nel 1943 e
le strade erano state liberate dalle macerie negli anni precedenti.
Negli anni cinquanta-sessanta, con l'approvazione di un nuovo piano
regolatore, la città ha conosciuto una notevole espansione urbanistica,
che ha portato alla nascita di nuovi quartieri e di nuove arterie di
comunicazione. Nei primi anni settanta venne meno il settore
dell'estrazione dello zolfo:
la crisi irreversibile del settore, incominciata a partire dagli anni
venti grazie al nuovo processo
Frasch messo a punto
negli USA,
raggiunse in quegli anni il punto di non-ritorno e furono così chiuse
anche le ultime solfare nissene.
Castello
di Pietrarossa
Il
castello di Pietrarossa è una fortezza dell’XI secolo che sorge a
ridosso della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, nel vecchio quartiere arabo
di Caltanissetta.
Le
origini dell’edificio, di cui oggi rimangono solo i ruderi di alcune torri
in pietra rossa e del ponte di comunicazione, è piuttosto controversa. Non vi
sono infatti documenti a sostegno della sua presenza nel territorio prima dei
Normanni, ma per il momento si presume ancora possa essere stato
costruito dai bizantini tra il 750 e l’800.
Vi
sono anche altre ipotesi, che tenderebbero ad attribuire al fortilizio,
un’origine ancora più antica; secondo alcuni, la struttura sarebbe infatti stata
eretta dai Romani su un gruppo di antiche fabbriche, altri credono invece
che il castello risalga all’Epoca Greca, e in particolare che la rocca fosse
di proprietà dei siracusani, e che poi fosse stata attaccata dagli ateniesi,
in un fallito tentativo di presa. Altri ancora pensano invece che fosse un
possedimento più recente, di origine saracena, dato che testimonianze più
attuali sembrerebbero confermare la sua impressionante estensione, che
comprendeva, oltre alle mura, ai camminamenti e alle torri, anche giardini e
coltivazioni, elementi tipici delle costruzioni arabe; questa ipotesi farebbe
pensare, che all’interno delle mura del castello, vivessero qualcosa
come 300 nuclei famigliari, di cui 70 armati. Altri invece ne ipotizzano la
nascita al tempo di un insediamento sicano.

L’origine
araba del castello, sarebbero però la più accreditata, in quanto potrebbe
anche spiegare l’origine del toponimo di Caltanissetta: derivante dal
termine arabo Qal'at an-nisah, che tradotto significa ‘castello delle
donne’; un’espressione che starebbe ad indicare il fatto che per un lungo
periodo dell’anno, gli uomini si ritrovavano ad occupare le terre
circostanti, in qualità di contadini, lasciando alle donne il presidio
del fortilizio. Del castello rimangono oggi testimonianze sorte sulla base
degli studi effettuati sulla rocca, che ci confermano come il castello avesse
planimetria e struttura imponenti; a Siviglia vi è infatti una versione del
castello, in formato plastico, così come doveva apparire nell’Antichità,
stesso discorso per un’illustrazione degli inizi del Novecento, e per uno
degli affreschi ubicati presso la ‘Galleria delle Carte Geografiche’,
all’interno dei Musei Vaticani.
Il
castello fu teatro di diversi eventi di rilievo, che caratterizzarono il
periodo della dominazione angioina di Sicilia; in particolare: durante il
periodo dei Vespri, il castello venne attaccato, e i cittadini, una volta
cacciati i regnanti, ivi istituirono il "Libero Comune di Caltanissetta".
Ma il periodo più splendente delle "murra di l’Anciuli", è
sicuramente quello aragonese.
Salito al governo Pietro III d’Aragona, il castello tornò infatti nelle
mani regie; i possedimenti perduti non vennero più recuperati, ma tra le sue
mura vennero ospitati i tre Parlamenti generali siciliani.
Alla
morte di Federico IV, avvenuta nel 1378, la rocca calcarea che domina la valle
del Salso, venne occupata dai quattro vicari di Sicilia, tra cui Guglielmo
Peralta e Manfredi Chiaramonte, i quali diedero vita al cosiddetto
‘Governo dei Quattro Vicari’.
Nel 1407, il castello, e il feudo
circostante, passa alla famiglia Moncada, (nelle cui mani rimarrà fino alla
fine del Feudalesimo), e in particolare a Matteo II, primo conte di
Caltanissetta, il quale si dice ospitò tra le sue stanze la Regina Bianca di
Navarra, per difenderla dagli oppositori che non la volevano a capo del Regno.

Nella
notte del 27 febbraio 1567 il castello crollò, si presume per un
terremoto; i Moncada si occuparono di preservarne ciò che ne restava ma,
contemporaneamente, diedero anche l’ordine, come si evince dagli scritti, di
iniziare ad utilizzarla come cava per estrarre il prezioso materiale che
sarebbe asservito alla costruzione dei nuovi edifici della città.
Le
demolizioni continueranno per tutto il XVII secolo; la pietra del castello
contribuì alla costruzione del Convento dei Francescani, delle cappelle del
vicino cimitero, e delle abitazioni del Quartiere degli Angeli.
Oggi,
dell’antica struttura e planimetria è dunque rimasto ben poco, ma alcuni
scavi promozionati nel Settecento, portarono alla luce un antico
passaggio, subito dopo ricoperto, che ha determinato la nascita dell’antica
leggenda dei "cuniculi": ovvero passaggi sotterranei, che si dice
colleghino diverse costruzioni della città, tra cui anche antichi palazzi e
chiese.
 Sempre
nei pressi del castello, venne ritrovato un sepolcro, con all’interno quello
che si presume possa essere il corpo della nipote di Ruggero d’Altavilla.
La salma fu poi traslata presso la chiesa di San Domenico, ma ancora oggi si
pensa che la rocca sia infestata dal suo fantasma. Sempre
nei pressi del castello, venne ritrovato un sepolcro, con all’interno quello
che si presume possa essere il corpo della nipote di Ruggero d’Altavilla.
La salma fu poi traslata presso la chiesa di San Domenico, ma ancora oggi si
pensa che la rocca sia infestata dal suo fantasma.
Un’altra
leggenda, alimentata dalle possibili origini arabe del castello, sembrerebbe
invece confermare la nascita di uno dei dolci più famosi di Sicilia: il
cannolo. Secondo la tradizione infatti, le donne arabe preparavano questo
dolce in occasione del ritorno dei propri mariti. La cialda, spessa e
croccante, veniva realizzata in maniera che potesse essere conservata per
giorni; una volta che i mariti furono tornati dai campi, le donne si
dedicavano così al riempimento della cialda con un fresco ripieno di ricotta:
in questo modo, i loro uomini avrebbero potuto gustare il dolce come fosse
appena fatto.
Planimetricamente
articolato su vari livelli, il castello risultava costituito da tre torri
collegate da cortine murarie, delle quali oggi risultano visibili resti di
quella centrale, alta circa 25 metri e della torre di vedetta nord. La grande
torre centrale è costruita su una roccia bipartita da una profonda fenditura
che la attraversa longitudinalmente.
Nel
lato sud, a cavallo di quest'ultima, sono visibili una feritoia in pietra da
taglio e inferiormente un'apertura con arco a sesto acuto privo del concio di
chiave, presumibilmente preceduta da una scala d'accesso esterna, oggi non
più esistente. Il fianco sud-ovest è rinforzato da un cantonale in pietra da
taglio, probabilmente eseguito nel XVI secolo, dopo un parziale crollo della
parte superiore della torre; tale tesi è sostenuta dall'esistenza nel
cantonale di conci tagliati a sguincio, facenti parte, in origine, di una
finestra ubicata alla sommità, lato ovest, della quale restano solo il
davanzale ed uno stipite. In cima alla torre è posizionata una cisterna per
liquidi rivestita con intonaco che ingloba frammenti ceramidi invetriate
piombifere databili tra la fine del XII secolo ed i primi del XIII.
Ai
piedi della torre, nell'area dello sperone, lo scavo delle murature
parzialmente interrate ha portato alla definizione di un ambiente la cui
esatta consistenza non è individuabile a causa del crollo della parete ovest,
dovuto all'utilizzo della roccia come cava da costruzione.
Alla
fine del percorso d'accesso al castello, resti di murature addossate alla
roccia fanno pensare all'originaria presenza di ambienti di servizio coperti
con strutture lignee; poco distante è sita una profonda ed ampia cisterna
intonacata, interamente interrata.
In
prossimità del castello, a seguito di uno sprofondamento del terreno, si scoprì
un condotto sotterraneo, scavato nella roccia, avente ingresso nella strada
rotabile d'accesso al cimitero. La galleria aveva parete verticali e copertura
voltata, era alta mediamente m. 1,77 e larga m. 1,27; fu esplorata per circa
10 metri e successivamente, per motivi di sicurezza, ne fu chiuso l'accesso.
Monumento
al Redentore

Il
monumento al Redentore si trova sulla vetta più alta del Monte San Giuliano,
che sovrasta tutta Caltanissetta. Si tratta di un piedistallo contenente nel
suo interno una cappella, che inizia a pianta quadrata e diventa circolare per
concedere un adeguato appoggio alla statua del Redentore.
All’inizio
del XX secolo vennero commissionati da papa Leone XIII diciannove monumenti a
Cristo Redentore, una in ogni regione d’Italia (all’epoca 19). Tra le
regioni che risposero all’appello del Papa vi fu la Sicilia che scelse come
luogo per l’erezione del monumento la vetta del Monte San Giuliano, nel
cuore dell’isola. Il progetto fu affidato all’architetto Ernesto Basile,
figlio di Giovan Battista Filippo Basile (l’architetto del Teatro Massimo di
Palermo).
La
prima pietra venne posata il 13 maggio 1900. La statua del Redentore arrivò
da Roma il 30 luglio, ma non furono fatti grandi festeggiamenti perché il re
d’Italia Umberto I era stato appena assassinato a Monza ed era stato
proclamato il lutto nazionale. Sempre per questa ragione l’inaugurazione del
monumento venne rimandata: dalla fine di agosto fino al 30 settembre del 1900
in città vi furono grandi festeggiamenti e l’inaugurazione avvenne alla
presenza di cardinali, vescovi, clero e popolo venuti da tutta la Sicilia.
Piazza
Garibaldi e Fontana del Tritone

Piazza
principale del centro storico, in essa si incrociano i due corsi
principali, corso
Umberto I e corso
Vittorio Emanuele.
Vi si affacciano il municipio, la Cattedrale
e la chiesa di San Sebastiano; al centro vi si trova la "fontana
del Tritone".
La
fontana costituita da un gruppo bronzeo raffigurante un tritone che tenta di
domare un cavallo marino di fronte a due mostri marini che lo insidiano.
Ispirata alla mitologia greca il Tritone
è un dio marino con il corpo per metà uomo e per metà pesce, figlio
di Poseidone
e Anfitrite.
La figura mitologica è stata spesso usata nella costruzione di fontane
e ninfei,
anche il Bernini
lo ha collocato nella sua famosa fontana a Roma.
Fu scolpita dal nisseno Michele
Tripisciano nel 1890
e inizialmente posta nell'androne di Palazzo
del Carmine: la
fontana fu creata dall'architetto Gaetano
Averna per essere
posta nella sua attuale locazione, al centro di Piazza
Garibaldi, dove fu
inaugurata il 15 dicembre 1956,
in sostituzione ad un vecchio lampione
in ferro a cinque luci.
Tra la fine del 2008
e l'inizio del 2009,
l'intera piazza Garibaldi è stata sottoposta a lavori di pavimentazione
in basoli
di pietra lavica
per impedire il passaggio di automobili e consentire il libero transito
dei pedoni.
In questa occasione anche la fontana del tritone è stata restaurata e
vi sono stati installati impianti di illuminazione che l'hanno riportata
così all'antico splendore.
Monumento
ai caduti

Sito
in fondo al viale Regina Margherita, commemora i 291 militari nisseni
caduti durante la Grande
Guerra. Si tratta
di una statua bronzea che riproduce due figure umane: la prima, in
posizione eretta, rappresenta la Patria, e cinge un elmetto contornato
da ramoscelli di lauro e quercia, con una mano regge un libro e una
palma, con l'altra indica verso il basso, dove si trova la seconda
figura, l'eroe, che stringe il tricolore.
La statua è collocata su un
basamento che presenta una gradinata sulla parte anteriore, e alla base
due cannoni e una corona d'alloro in bronzo.
Fu inaugurato il 16
dicembre 1922 per volontà di un comitato appositamente costituitosi e
presieduto dal dottore Luigi Sagona, che nel conflitto aveva perso
congiunti. Inizialmente collocato a poca distanza dal seminario
vescovile, in una zona adiacente al viale Regina Margherita che venne
chiamata viale delle Rimembranze, nel 1965 fu spostato nell'attuale
sito, a 500 m da quello originario.
Fu realizzato su progetto dello
scultore Cosimo Sorgi utilizzando il bronzo sottratto al nemico dalla
fonderia Laganà di Napoli. È sede cittadina delle commemorazioni
del 4 novembre.
Ponte
Capodarso

Situato
in un luogo selvaggio e impervio, protetto da piccole ripide alture che
chiudono il fiume in una stretta gola, prende il nome dal vicino monte
Capodarso).
Il
ponte fu costruito nel 1553 sull'Imera meridionale (comunemente
detto "Salso") per ordine di Carlo V per evitare il guado del
fiume, particolarmente pericoloso durante le piene. Originariamente aveva
l'aspetto di un ponte a un solo arco a schiena d'asino, che poteva essere
attraversato solo dai pedoni. Il pittore francese Jean Houel ne
fece un disegno ad acquarello alla fine del XVIII secolo, in quanto
considerato assieme all'Etna e alla fonte Aretusa di Siracusa,
una delle meraviglie della Sicilia («un monte, un ponte e un fonte»).
Sebbene
fosse collocato esattamente sul confine con Castrogiovanni, il ponte
rimase di pertinenza nissena, come attestato da un documento del 1620 in cui
si attribuiva alla municipalità di Caltanissetta la manutenzione dell'intera
opera.
Nel
1842 fu interessato da un restauro commissionato dal consiglio
provinciale, ma solo dopo l'Unità d'Italia (o già nel biennio
1847-48, secondo altra fonte) la forma originaria venne totalmente
stravolta: furono realizzati due piccoli archi laterali affiancati all'arco
principale che lo resero piano, e venne allargato per renderlo adatto al
passaggio dei carri. Alla fine dei lavori, nel 1866, fu inserito
nell'itinerario della strada rotabile Caltanissetta-Piazza Armerina.
Il
ponte fu distrutto il 9 luglio 1943 dai tedeschi in ritirata, e ricostruito
l'anno successivo. Il 10 aprile 1961 crollò nuovamente in seguito a una piena
eccezionale; fu riaperto al traffico il 27 gennaio 1962.
 Pag.
2
Pag.
2
|