|
Castello
Nuovo (o dei conti Luna)
Tutte le città che si rispettino in
Italia e, possiamo dire, in tutti i Paesi di antica storia, hanno il loro
bravo castello, più o meno imponente, più o meno restaurato e messo in
evidenza. E come il quadro antico dell'illustre antenato che spesso vediamo
in bella mostra nelle case di quelle famig1ie che possono vantare di
appartenere a un nobile casato. Anche Sciacca, che vanta antica e nobile
origine, possiede un castello medievale, non privo di imponenza, che fu dei
conti Luna, e che di recente è stato acquistato dall'Ente Regionale
Palazzi e Ville di Sicilia allo scopo di salvarlo e valorizzarlo.
Fu fatto costruire nel 1380 da
Guglielmo Peralta, conte di Caltabellotta, che fu, dopo la morte del re
Federico III (1377), uno dei quattro Vicari del regno di Sicilia. Passò poi
in possesso dei Luna quando, morto Nicolò Peralta (figlio di Guglielmo),
una delle sue tre figlie, Margherita, andò sposa al conte Artale di Luna,
catalano, zio di re Martino.
 Sorge sulla viva roccia, in posizione dominante, nella parte alta e
orientale della città, ed è inserito nel perimetro delle antiche mura che
tuttora, in buona parte, esistono. Comprende quattro parti: la cinta, il
mastio, il palazzo comitale e la torre cilindrica. La cinta che serviva alla
difesa esterna, ha pianta poligonale ed è formata di alte e robuste mura,
capaci di resistere ancora per molti secoli all'usura del tempo. Entro il
perimetro della cinta, a nord, si ergeva il mastio, cioè la torre maestra,
a pianta quadrangolare, che di molto superava l'altezza del complesso dei
fabbricati e che aveva la funzione di sorvegliare la cinta il terreno
esterno e il cortile interno.
Sorge sulla viva roccia, in posizione dominante, nella parte alta e
orientale della città, ed è inserito nel perimetro delle antiche mura che
tuttora, in buona parte, esistono. Comprende quattro parti: la cinta, il
mastio, il palazzo comitale e la torre cilindrica. La cinta che serviva alla
difesa esterna, ha pianta poligonale ed è formata di alte e robuste mura,
capaci di resistere ancora per molti secoli all'usura del tempo. Entro il
perimetro della cinta, a nord, si ergeva il mastio, cioè la torre maestra,
a pianta quadrangolare, che di molto superava l'altezza del complesso dei
fabbricati e che aveva la funzione di sorvegliare la cinta il terreno
esterno e il cortile interno.
Di esso, rimasto integro fino al
1740, oggi resta solo la base, ma possiamo farcene un'idea attraverso un
disegno di Ignazio di Mino che lo ritrae così come era nel 1867, prima che
l'Amministrazione comunale del tempo, provvedesse a farlo demolire perché
danneggiato in seguito alle scosse sismiche del 13 giugno 1740 e del 27
ottobre 1855.
Esiste, invece, tuttora, sempre
inserita nel perimetro della cinta, a sud, una torre cilindrica, a due
piani, dalle volte costruite con conci accostati a coltello, come usa coi
mattoni di terracotta.
Il palazzo del Conte, a pianta
rettangolare, occupava il lato ovest del Castello, compreso tra il mastio e
la torre cilindrica.
Era composto di un piano terreno, adibito come abitazione della servitù, e
di un piano superiore dove abitava il Conte con la sua famiglia.
Di esso oggi resta l'alto muro
esterno con quattro ampie finestre dalle quali si può ammirare tutta la
pittoresca, multiforme distesa di tetti, terrazzi e logge delle case di
Sciacca, tutto il panorama della città con le sue torri e le chiese e i
campanili e le cupole e le vie e le piazze e i giardini e il porto e il
mare.
L'ingresso era situato a nord ed era
munito di ponte levatoio. Da esso si entrava nel cortile dove a sinistra
erano le scuderie e i locali degli uomini d'arme, nonché una cappella
dedicata a S. Gregorio, e a destra una scala che portava al piano nobile del
palazzo. Nel complesso il castello dei Luna di Sciacca non è di dimensioni
sesquipedali, come qualcuno, spinto dall'amor di campanile, ha voluto
descriverlo, tuttavia, nell'insieme, non è privo di una sua solenne
monumentalità, e, oltre a rappresentare per il suo profilo caratteristico
uno dei più interessanti esempi di architettura civile e militare del '300
esistenti in Sicilia, per la sua posizione dominante su tutto l'abitato di
Sciacca, costituisce un elemento insopprimibile del panorama della nostra
città a cui conferisce lustro e decoro, e una fisionomia inconfondibile.
Oggi
l'edificio si compone di quattro parti: la cinta muraria, la torre grande
(mastio) e quella cilindrica entrambe a nord, e il Palazzo del Conte a
ovest. La cinta è formata da alte mura che servivano alla difesa. Della
grande torre a pianta quadrangolare rimane la base, mentre la torre
cilindrica che si presenta a due piani con accostati a coltello, si conserva
ancora. Rimane ben poco invece del Palazzo del Conte, posizionato fra mastio
e torre cilindrica e di cui ci resta solo i tetti e gli alti muri, dove si
possono notare dipinti dell'epoca e ammirare (tramite le sue finestre) un
bel panorama di Sciacca.
Castello
Vecchio (o dei Perollo)
Così detto
per distinguerlo dal Castello Nuovo o dei Luna, che fu eretto dal Gran Conte
Ruggero insieme con le prime mura che come una morsa chiudevano la città al
tempo dei Normanni. Passò ai Perollo, secondo la tradizione locale, in
seguito al matrimonio della contessa Giulietta, figlia del gran conte
Ruggero, con Gilberto Perollo (sec. XII) e ai Perollo rimase fino alla sua
quasi totale distruzione operata dai partigiani di Sigismondo Luna nel 1529,
durante il famoso Caso di Sciacca. Situato nella parte orientale della città,
all'incirca tra Porta S. Pietro, Porta Bagni e il Monastero di S. Caterina,
comprendeva gli attuali cortili Chiodi, Rizza e Carini. Secondo il Savasta
entro le mura del Castello erano "cinque grandiosi palagi con corti e
sale e nobili quartieri abitati dai cinque rami principali della famiglia
Perollo".
 Il castello aveva tre entrate. La porta principale, detta del Cotogno, era
vicina a Porta Bagni, un'altra detta di S. Pietro, era così detta perché
vicina alla omonima chiesa del castello, detta S. Pietro in Castro, la terza
era rivolta a oriente e si trovava fuori le mura della città. Delle tre
entrate rimane oggi solo quella che guarda a occidente, attraverso la
quale si accede all'attuale Cortile Chiodi, in origine spazio interno
dell'antica Rocca normanna.
Il castello aveva tre entrate. La porta principale, detta del Cotogno, era
vicina a Porta Bagni, un'altra detta di S. Pietro, era così detta perché
vicina alla omonima chiesa del castello, detta S. Pietro in Castro, la terza
era rivolta a oriente e si trovava fuori le mura della città. Delle tre
entrate rimane oggi solo quella che guarda a occidente, attraverso la
quale si accede all'attuale Cortile Chiodi, in origine spazio interno
dell'antica Rocca normanna.
Il castello
era munito di torri angolari, come può vedersi da un vecchio disegno di
Ignazio Di Mino.
La torre
principale, detta di S. Nicolò, doveva essere non lontana dalla omonima
chiesa. Si vuole, dice il Ciaccio, che il castello avesse avuto
anche dei sotterranei, da cui potevasi nell'occorrenza evadere sia dal
castello che dalla città.
Dall'antica
rocca ruggeriana ben poco oggi avanza e questo poco viene di giorno in
giorno manomesso e compromesso dai privati cittadini che, infischiandosene
del suo valore storico, ne vanno facendo scomparire ogni traccia. Fino a non
molti anni or sono, dal cortile Carini o dalla parte superiore di via
Valverde era ancora visibile la torre angolare di sud-est che poi è stata
trasformata in casa privata.
Oggi resta
solo la porta ad arco che guarda ad occidente con il sovrastante stemma
marmoreo dei Perollo.
- Castello
Incantato
-
Alle
falde del Monte Kronio e a pochi chilometri da Sciacca, sorge il “Castello
Incantato”, suggestivo museo all’aperto, ricco di mistero e fascino.
È
un giardino con un’infinità di misteriosi volti scolpiti nella roccia e
nei tronchi d'ulivo saraceni, realizzati dalla insolita creatività di
Filippo Bentivegna. Un personaggio che per oltre 50 anni non ha fatto altro
che scavare e scolpire teste, creando più di tremila volti, alcuni forse
somiglianti a illustri personaggi storici, altri con espressioni stralunate,
dal sorriso inquieto e indescrivibile, altri ancora bifronte.
Un
individuo dalla mente forse compromessa ma che dimostrava una grande abilità
nella attività manuale finalizzata alla creazione delle sue sculture,
dimostrando una notevole capacità ideativa ed espressiva. Sicuramente una
figura molto eccentrica e in una certa misura forse anche delirante.
La
storia personale di Bentivegna fu inconsueta e bizzarra ed è fondamentale
per comprendere il suo operato artistico ed è strettamente legata al suo
mondo immaginario ed incantato fatto di teste umane scolpite nella pietra.
Nato
a Sciacca il 3 Maggio 1888, figlio di pescatori, a causa delle misere
condizioni economiche, vive nell’alfabetismo e nella precarietà. A
vent’anni, nel 1908, si arruola nella marina e vi rimane fino al 1912.
Povero e disoccupato, nel 1913 emigra negli Stati Uniti, prima a New York
poi a Chicago dove è assunto da una compagnia che lavora alla costruzione
delle grandi linee ferroviarie.
Lì
la vita si rivelò per lui alquanto amara, non riuscì ad inserirsi né a
convivere con persone che avevano idee troppo diverse dalle sue, basate
sulla discriminazione razziale e sulla sopraffazione. Per la sua indole e
per le sue idee poco conformiste venne duramente emarginato.
Si
racconta che la sua ispirazione artistica sia legata all’amore per una
donna. Innamoratosi di una giovane americana il saccense è coinvolto in una
rissa dal rivale in amore da cui viene violentemente malmenato. Il
conseguente trauma gli provoca alterazioni psichiche rimaste celate sino a
quel momento. Tornato a Sciacca per curarsi, Filippo Bentivegna è ormai un
uomo completamente diverso.

Acquista
un piccolo podere nell’attuale Contrada S. Antonio, iniziando la sua nuova
impulsiva vita d’artista involontaria. Analfabeta e mai interessato ad
alcuna forma d’arte, comincia a dipingere e scalpellare alberi e massi che
estraeva dalle pareti rocciose, sviluppando una forma d’espressione
“inconsapevole” che gli permette di sviscerare i propri ricordi
sublimandoli. La sua arte ha come unico soggetto le teste umane d’ogni
forma e dimensione.
Le
sue sculture sono tutte diverse e raffigurano personaggi famosi e non, a cui
dava anche un nome e che, nel suo immaginario, rappresentavano i sudditi del
regno che egli aveva creato (il giardino incantato) e di cui era il
“Signore”, amava infatti farsi chiamare dalla gente “Sua
Eccellenza”.
Al
centro del podere sorge la casetta dove il Bentivegna viveva, le cui pareti
sono decorate da disegni raffiguranti grattacieli che ricordano il suo
soggiorno in America e un pesce che contiene nel proprio ventre un pesce più
piccolo che forse simboleggia la traversata dell’artista all’interno
della nave che lo condusse a New York.
Teneva
in gran conto una sua opera composta da alcune teste terminanti in una
specie di fallo, definito da lui “chiave dell’incanto”. Si dice che si
aggirasse per le vie della città con in mano un corto bastone che reggeva
come fosse uno scettro, autoproclamandosi “Signore delle caverne” per i
numerosi cunicoli che scavava nella terra per trovarvi energia.
Filippo
Bentivegna trascorse gran parte della sua vita nel proprio podere e, in
solitudine, vi rimase fino alla morte avvenuta l’1 marzo 1967.
L’anno
successivo alla morte di Bentivegna, con il suo lavoro in stato di abbandono
e talvolta oggetto di furto e sciacallaggio, arriva a Sciacca un
collaboratore di Jean Debuffet che riconosce l’importanza artistica
dell’opera del “Pazzo di Sciacca”.
Oggi
alcune teste di Bentivegna sono esposte al museo dell’Art Brut di Losanna,
istituito in memoria di Dubuffet.
Porte
e Torri


Le tre
porte d'accesso alla città sono tutte rimaneggiate:
Porta
Palermo, che collega Piazza Don
Luigi Sturzo con Piazza Guglielmo
Marconi e fu riedificata nel 1753 durante
il regno di Carlo III di Borbone – ha delle belle colonne in cima adornate
da un gruppo scultoreo con una grande aquila, in stile barocco.
Porta San
Salvatore, del XVI secolo, che si trova in Piazza Carmine, è ricca di belle
sculture rinascimentali.
Porta San
Calogero, che dà le spalle all'omonimo monte e funge da ingresso per il
quartiere di San Michele, è del 1536.
A queste si
aggiungono 2 porte ormai scomparse ma di altrettanta importanza, che insieme
alle 3 precedenti, formano le cosiddette "5 Porte" di Sciacca:
Porta
Bagni, fra Corso Vittorio Emanuele e Parco della Vittoria;
Porta di
Mare, che permetteva il collegamento fra Marina e il centro (probabilmente
situata fra Campidoglio e Terme).
 Queste
cinque sono quelle più importanti soprattutto dal punto di vista
politico-storico, ma esistono altre porte meno importanti, come quella di
San Pietro e quella di San Nicolò La Latina Queste
cinque sono quelle più importanti soprattutto dal punto di vista
politico-storico, ma esistono altre porte meno importanti, come quella di
San Pietro e quella di San Nicolò La Latina
Particolare
attenzione meritano le torri: la Torre Campanaria si trova nella salita di
San Michele a poca distanza dalla Chiesa di San Michele, risalente al 1550.
La Torre medievale si trova all'angolo della via Molinari e risale al XV
secolo. La Torre del Pardo si trova in via Incisa (appartenente prima agli
Incisa e poi al mercante catalano Antonio Pardo) risale al XV secolo e si
compone di tre piano (nel primo abbiamo una finestra la cui cornice è retta
da due cariatidi).
Torre
Ficani, fu eretta da Calogero Ficani nel 1453, al tempo della caduta di
Costantinopoli in mano ai Turchi, per la difesa dalle incursioni dei pirati.
La Torre, coronata dai merli piani con feritoie, è a pianta quadrangolare
con solidi cantonali in conci di dura pietra di intaglio della Perriera, è
composta da un piano terra e da due piani sopraelevati. Un tempo isolata,
oggi è inserita nell' angolo Sud-Est di un vasto baglio, al quale si accede
attraverso un possente portale ad arco.
Chiesa
di Maria SS. del Soccorso]

La prima
Chiesa Madre fu fondata dalla contessa normanna Giulietta agli inizi del
sec. XII e durò fino al 1656. Dell'antica chiesa rimangono le tre
absidi utilizzate dal Blasco per la nuova, mentre le volte a crociera
costolonate, recentemente rimesse in luce e restaurate, e due portali ad
arco gotico sono del sec. XIV. La chiesa attuale, eretta tra il 1656 e il
1683, su progetto di Michele Blasco, pittore e architetto, benché
realizzata in piena età barocca, ci offre un bell'esempio di equilibrata
architettura che richiama alla mente classiche forme rinascimentali. È
l'unica chiesa di Sciacca che, oltre che per la facciata principale,
si fa ammirare anche per quelle laterali e per il corpo triabsidato di età
normanna che si conserva quasi intatto.
La facciata
principale, rimasta incompleta, è ornata di tre bianche statue di marmo
provenienti dall'antica chiesa, collocate, una, raffigurante S.
Maria Maddalena, sopra il frontone della porta principale, e
le altre (S. Pietro e S. Paolo) in nicchie ad edicola situate sopra i
frontoni delle due porte laterali.
Altre due statue di marmo (S. Giovanni Battista e S. Calogero), pure
provenienti dall'antica chiesa normanna e della
stessa mano, sono collocate, pure in nicchie ad edicola, la prima sopra la
porta della fiancata settentrionale e la seconda sopra la porta della
fiancata meridionale alla quale si accede con un'ampia scala a due rampe dal
corso Vittorio Emanuele. Tutte e cinque le statue sono opera di Antonio e
Gian Domenico Gagini.
La
ringhiera con colonnine e pilastri di pietra che recinge il sagrato dinanzi
alla facciata principale è stata realizzata di recente su disegno dello
scultore saccense, prof. Giuseppe Cusumano. Alla facciata mancano, sul lato
destro, il corpo (campanile) che dovrebbe fare pendant con quello realizzato
sul lato sinistro e il frontone.
L'interno suddiviso
da due file di pilastri in tre navate, comprende dieci cappelle, oltre a
quella dell'altare maggiore. La decorazione delle navate e delle
cappelle in stucco è stata realizzata su disegni di Salvatore Gravanti
negli anni 1830-31 e 1839-40. La vastità dell'insieme, il vivo senso di
luminosa spazialità creano una suggestiva atmosfera di solennità e di
eleganza insieme.
 Componente
di spicco, inoltre, all'interno il vasto affresco della volta a botte della
navata centrale, raffigurante l'Apocalisse ed episodi della vita di Maria
Maddalena, capolavoro di Tommaso Rossi (1778-1862), figlio e allievo di
Mariano Rossi, uno dei più rinomati affreschisti italiani del sec. XVIII
(Sciacca 1731 - Roma 1807). Componente
di spicco, inoltre, all'interno il vasto affresco della volta a botte della
navata centrale, raffigurante l'Apocalisse ed episodi della vita di Maria
Maddalena, capolavoro di Tommaso Rossi (1778-1862), figlio e allievo di
Mariano Rossi, uno dei più rinomati affreschisti italiani del sec. XVIII
(Sciacca 1731 - Roma 1807).
Sono
inoltre degni di nota le seguenti opere d'arte, quasi tutte provenienti
dall'antica chiesa Madre: all'inizio della navata sinistra, fonte
battesimale in marmo del 1495, alla cui base si può leggere la data e il
nome dell'arciprete di quel tempo, Antonio De Piscibus, e del donatore
Andrea Burgio.
L'opera è
attribuita ai Gagini. Dietro il fonte battesimale, un rilievo raffigurante
la Decollazione di S. Giovanni Battista, del sec. XVI, che faceva parte di
altro fonte battesimale appartenente all'antica chiesa di S. Pietro in
Castro (sec. XI) oggi non più esistente.
Proseguendo nella navata sinistra, nella seconda cappella, sull'altare,
una statua della Madonna di Monserrato e in una nicchia, a sinistra,
un'altra della Madonna delle Grazie, entrambe di marmo, provenienti
dall'antica chiesa.
Nella
cappella in fondo alla navata, a sinistra del presbiterio, un interessante Crocifisso ligneo
del '500.
Sull'altare
maggiore è collocata la statua della Madonna del Soccorso, dal 1626
patrona della città; è opera di Giuliano Mancino e Bartolomeo Birrittaro
(1503).
Ai lati
dell'altare maggiore sono: a destra una Crocifissione di S. Pietro e
a sinistra una Sacra Famiglia, dipinti su tela dei quali non si
conosce il nome dell'autore.
Nella cappella a destra del presbiterio è una icona marmorea di Antonio
Gagini (1581). Rappresenta: (in ordine, dall'alto in basso) Padre
Eterno benedicente, episodi della passione di Gesù, Resurrezione,
Crocifissione, con ai lati, in nicchia, S. Pietro e S. Paolo,
Angeli in adorazione e ai lati, in sei scomparti, altre scene della Passione
e Santi Apostoli.
Nel lato
destro della crociera è la statua di marmo raffigurante la Madonna della
Catena (1457), proveniente dall'antica chiesa normanna.
Sul
penultimo altare della navata destra, la statua lignea di S. Calogero,
l'arcario e la cerva è attribuita al trapanese N. Milante. Sono pure di
qualche interesse, sebbene assai rovinati due sarcofaghi cinquecenteschi di
marmo, dei quali uno di Bartolomeo Tagliavia, collocato attualmente nella
prima cappella della navata destra, le cui caratteristiche stilistiche e
iconografiche sono simili a quello del Conte Gaspare II Naselli esistente
nella chiesa dell'Immacolata di Comiso, attribuito ad Antonello Gagini, e
altro di Gerardo Noceto, famoso botanico saccense del '500, che si trova in
un locale a piano terra, sottostante alla sagrestia, adibito a circolo
ricreativo di giovani cattolici.
In un angolo della sagrestia c'è, posata a terra, una Madonna degli Angeli,
statua marmorea di mano gaginesca e, appesi alle pareti, una Maria
Maddalena, antico dipinto su tela di Ignoto, e un interessante Crocifisso
ligneo che in origine era attaccato al centro del soffitto dell'antica
chiesa. Anche nell'ufficio dell'arciprete sono conservate alcune opere
d'arte meritevoli di attenzione. Sono due formelle marmoree del 1577
raffiguranti S. Maria Maddalena tra due leoni rampanti, che è l'antico
stemma religoso e civico di Sciacca (oggi solo religioso), e sotto di esse
due stemmi delle nobili famiglie Perollo e Garro-Maurici provenienti
dall'antica chiesa.
Nel
luglio del 1991 papa Giovanni Paolo II l'ha elevata alla
dignità di basilica minore.
Chiesa
del Carmine

È questa la terza chiesa
eretta nello stesso sito. La prima, dedicata al Salvatore, fu fondata
dal conte Ruggero subito dopo la liberazione della città dalla dominazione
musulmana (1087). Prese il nome del Carmine con la venuta a Sciacca, verso
il 1200, dei Carmelitani i quali fondarono, attiguo all'antica chiesa
normanna il loro convento.
Nel
sec. XVI, demolita l'antica chiesa normanna perché fatiscente, fu costruita
una seconda chiesa di più grandi dimensioni che fu aperta al culto nel
1579. Divenuta anche questa pericolante, si pose mano verso la fine del '700
alla terza chiesa che è quella attuale, contigua da mezzogiorno alla
precedente chiesa e di questa più grande, che fu aperta al culto
nel 1817. Di questa terza chiesa è autore il noto architetto A.
Giganti (1731-1787), un sacerdote trapanese, le cui prime opere sono di
gusto barocco (vedi ad esempio il Palazzo Bonagia a Palermo, gravemente
danneggiato dai bombardamenti durante l'ultima guerra mondiale e ridotto a
brandelli e assunto oggi quasi a simbolo della più nobile ed elegante
architettura palaziale barocca), mentre le successive sono di stile Impero
(vedi ad es. la chiesa di S. Paolino dei Giardinieri del 1786 sempre a
Palermo).
La facciata è una sorta di palinsesto architettonico che ci consente di
leggere le tre fasi della costruzione: la prima di età normanna (periodo
della Contea), la seconda cinquecentesca e la terza neoclassica. Essa,
infatti, ingloba, insieme a un brano della facciata della seconda chiesa,
l'intero prospetto della chiesa del Salvatore con i suoi spioventi del tetto
a capanna, con le sue finestre originarie rettangolari strombate con le sua
struttura a piccoli conci di bianco tufo marmoso a faccia vista, tipica
delle costruzioni di età normanna, nonché il rosone che è un inserto
di età gotica, realizzato con la venuta dei carmelitani a Sciacca (sec.
XIII). Oltre che in facciata, resti della seconda chiesa cinquecentesca
si trovano incorporati nell'abside. A differenza del prospetto della chiesa
del Salvatore che è costruito con piccoli conci di pietra bianca, quello
neoclassico, rimasto incompiuto, è costruito con blocchi di tufo
conchigliare compatto della Perriera, di colore giallo-dorato.
Anche
il campanile, attiguo alla chiesa da est, è coevo alla seconda chiesa.
Da notare, al sommo della costruzione, la cornice che ha la stessa sagoma
della cornice del vicino palazzo Argomento-Perollo, prospettante in via
Incisa le due sculture raffiguranti due teste di mori, un ricordo-simbolo
delle incursioni piratesche, frequenti in quel tempo, e gli altri elementi
lapidei aggettanti nei quali venivano infisse le bandiere (o le torce)
durante le festività.
La chiesa è sormontata da una scenografia cupola, datata 1807. Sull'alto
tamburo, 4 finestre che si aprono tra coppie di pilastri ionica a faccia
vista, permettendo alla luce di fiottare abbondantemente nell'interno. La
calotta, insieme alla soprastante lanterna, è rivestita di mattonelle
invetriate di un bel verde smeraldo in parte rifatte in seguito a un recente
restauro 1985.
Chiesa
di S. Caterina

Quella attuale è la terza
chiesa dedicata a S. Caterina, Vergine e Martire alessandrina, il cui culto
a Sciacca ha antiche origini. La prima, non più esistente, fu fondata,
stando all'iscrizione in lingua latina che si trova sulla
facciata interna sopra la porta, nel 1109 da Giulietta, Comitis Siciliae
Rogerii Filia, e si trovava nelle vicinanze di Porta S. Pietro; la
seconda, che era dove oggi c'è quella attuale, fu eretta nel 1520, anno
in cui fu ampliato l'antico piccolo monastero annesso alla prima chiesetta normanna;
la terza chiesa è il risultato dell'ampliamento della
seconda della quale ingloba il presbiterio, già ricostruito nel 1722, parte
dei muri perimetrali e lo stesso prospetto del quale, a causa del recente
scrostamento dei muri, attualmente si può notare un arco a tutto
sesto. La terza chiesa, iniziata nel 1796 e terminata in rustico nel
1825, fu rifinita nel 1838-39 su progetto Salvatore Gravanti. La facciata,
intonacata a calce, delimitata ai lati da robusti cantonali in conci di tufo
conchigliare a vista che ne accentuano lo sviluppo verticale, è ravvivata
al centro da un alto portale dal timpano curvilineo e soprastante balcone
(fino a pochi anni fa chiuso da grata di ferro) e alla sommità da una
pittoresca loggia-campanaria di sobrio stile barocco.
L'interno, ad una sola navata, aveva originariamente cinque altari costruiti in
muratura incrostata da cristalli colorati in disegni in oro, dei quali
rimane solo l'altare maggiore, essendo stati gli altri quattro
di recente demoliti. Sull'altare maggiore di marmo
è una pregevole statua lignea cinquecentesca di S.
Caterina di recente restaurata a cura della Soprintendenza ai Beni Storici e
Artistici di Palermo. La bella antica spada, sulla cui elsa la Santa
appoggia la mano, è prezioso dono dei marchese S. Giacomo.
Sugli altri altari notevoli sono i dipinti SS. Annunziata e Strage
degli Innocenti di Gaspare Testone. Il secondo è ritenuto una delle
opere artisticamente più valide di questo nostro artista che fu maestro di
Mariano Rossi. Un terzo dipinto, raffigurante La diramazione
dell'ordine di S. Benedetto (primo altare a sx), di cui gli eruditi
locali non fanno alcun cenno, per lo stile e il colore a me sembra che possa
attribuirsi a Michele Blasco. (Di questo artista vedasi specialmente L'Immacolata che
si trova nel primo altare a sx della chiesa del Collegio), di recente (1987)
restaurata. Di buona mano sono anche due statue di marmo di ignoto autore,
raffiguranti S. Benedetto e S. Scolastica,attualmente sistemati in due
nicchie ai lati del presbiterio, e un Crocifisso ligneo collocato nel
secondo altare a sx. Eliminati i quattro altari laterali e scomparsi gli
"arredi sacri e vasi preziosi" dei quali era "discretamente
Provvista" la chiesa appare oggi agli occhi del visitatore squallida e
disadorna.
Chiesa
di S. Michele Arcangelo

È
questa la terza chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo. La prima si
trovava all'incirca nel sito dove è il cappellone della chiesa di S. Maria
dell'Itria. La seconda, ancora oggi esistente ma di recente assai manomessa
all'interno, si trova attigua da sud alla terza. Fondata dal conte Guglielmo
Peralta nel 1371, terminati pochi anni dopo di rustico, fu rifinita in
seguito da Artale Luna, genero ed erede, di Nicolò Peralta, figlio di
Guglielmo.
Questa chiesa doveva essere molto bella se il Fazello la definisce fanum
insigne. Sin dal 1400 ospitava la Confraternita di S. Michele. Oggi, assai
manomessa, ospita ragazzi delle scuole elementari. La terza chiesa fu
costruita per volontà di Natale Amodeo, ricco conciapelle e calzolaio, il
quale, prima di morire, spinto da pietà religiosa verso l'Arcangelo S.
Michele, dispose che tutto il suo patrimonio fosse destinato a tale opera.
La costruzione, iniziata nel 1614, fu terminata nel 1620 e aperta al culto
nel 1638.
La facciata, dallo schema architettonico lineare, ha chiare superfici
intonacate a calce esaltate dalle paraste di pietra dorata a vista ed è
completa, a differenza delle altre chiese di Sciacca del periodo barocco che
in genere mancano di qualcosa. Il primo ordine è contrassegnato da tre
portali. Sul timpano della porta principale, che guarda a ponente, è
collocata una quattrocentesca statua di marmo bianco di S. Michele che era
nella seconda chiesa dedicata al Santo. Sotto l'arco del portale, ornato di
fini motivi barocchi, è la data di inaugurazione della chiesa, 1638.
L'interno, con pianta a croce latina, è diviso in tre navate da una serie
di snelle colonne sulle quali poggiano gli archi a tutto sesto. Nonostante
le più o meno recenti manomissioni (è stato, ad esempio, sostituito
l'antico pavimento in ceramica con altro in fredde piastrelle di marmo di
Carrara) questa chiesa, per la vastità dell'insieme, è una delle più
belle di Sciacca. Sul lato interno della facciata è un'imponente tribuna
cantoria del sec. XVIII, fastosamente intagliata con gusto barocco, e un
organo costruito nel 1832 da Francesco La Grassa. Nella navata destra sono
conservate alcune pregevoli opere di scultura e pittura, provenienti da
antiche chiese non più esistenti.
Sul lato interno della facciata si ammira una preziosa Croce lignea in stile
gotico catalano, nella prima cappella, Dormitio virginis, bassorilievo
marmoreo del XV secolo, diviso in due scomparti, in cui sono raffigurati, in
quello inferiore il Transito della Vergine e in quello superiore
l'Assunzione di Maria. Segue un S. Girolamo, dipinto su tavola del XV secolo
proveniente dall'antica chiesa di S. Michele eretta dai Peralta ed ora non
più esistente. Il dipinto porta la data e il nome del committente: Hoc
opus fieri fecit Iacopu Amodeo et Margaritella uxor 1454. Si ignora,
invece, il nome dell'artista.
Murato
vicino è un Angelo Raffaele e il bambino Tobia, bassorilievo
marmoreo del secolo XV proveniente dall'antica chiesa. Sul secondo
altare è stato collocato di recente un S. Giovanni e l'Addolorata, dipinto
su tela del saccense Vincenzo Tresca, firmato e datato 1788, che prima era
in sagrestia. Sull'altare maggiore è una seicentesca statua lignea
raffigurante S. Michele fatto scolpire in in Roma nel 1380 da Guglielmo
Peralta (G. Licata).
Rappresenta il Santo giovinetto, dal volto fanciullesco incorniciato da
una prolissa chioma inanellata, nell'atto di tenere il piede destro sul
corpo atterrato del demonio, dalla lunghissima coda a tortiglione, che,
invano, tenta divincolarsi aiutandosi con le mani e coi piedi dalle dita
unghiute come artigli di rapace. (Il corpo snello e forte del Santo sembra
non sentire il peso della preziosa armatura della quale è vestito).
Nella
navata sinistra tra le cose degne di nota sono: un Fonte battesimale dì
marmo, del 1586, ornato di angeli, racemi e fiori, proveniente dalla seconda
chiesa, una Annunciazione di G. Sabella (1818) e in fondo alla navata, ai
piedi di un Crocefisso, in nicchia chiusa da un minicancello, un
Ostensorio-reliquiario d'argento dorato nel quale si conservano due spine
della corona di Cristo. Per finire: presso la prima colonna della
navata centrale, a s. e un'antica acquasantiera di marmo bianco, ornata con
testine di angeli finemente scolpiti, e presso la prima colonna a destra
altra pila per l'acqua santa di marmo rosso, proveniente dall'antica chiesa.
 Tra la chiesa di S. Michele e il campanile vi è la piazzetta detta
comunemente dai vecchi del quartiere "Firriatu di S. Michele"
perché in origine aveva forma circolare ed era circondata da un'inferriata.
In questo spazio era nel sec. XV il cimitero di una confraternita di nobili
che aveva la sua sede nell'antica chiesetta, oggi trasformata in scuola, che
confina a sud con la scalinata attraverso la quale si scende in via Pietre
Cadute.
Tra la chiesa di S. Michele e il campanile vi è la piazzetta detta
comunemente dai vecchi del quartiere "Firriatu di S. Michele"
perché in origine aveva forma circolare ed era circondata da un'inferriata.
In questo spazio era nel sec. XV il cimitero di una confraternita di nobili
che aveva la sua sede nell'antica chiesetta, oggi trasformata in scuola, che
confina a sud con la scalinata attraverso la quale si scende in via Pietre
Cadute.
Nell'edificio
attiguo alla chiesa, di cui avanza il portale gotico, erano fino a non molti
anni fa conservati dei cadaveri imbalsamati disposti ritti lungo le pareti.
Dalla
piazzetta si gode un vasto panorama di tetti che comprende buona parte del
centro storico della città, caratterizzato e dominato dalle eminenti moli
del Castello Luna, della chiesa di S. Caterina, della Chiesa Madre e di
quanto resta del Castello Vecchio. Il mare, sullo sfondo, è la
stupenda cornice del quadro.
Dalla
chiesa di S. Michele ha inizio il corso Tommaso Fazello dove, quasi a metà
strada, al n. 98, è la casa natale di Mario Ciaccio, storico di
Sciacca, alla cui memoria nel 1931 è stata murata sulla facciata una lapide
di marmo e collocato su una mensola un busto, opera dello scultore
saccense Giuseppe Cusumano. Accanto è il vasto Cortile Celso nel quale si
entra attraverso un antico portale ad arco ribassato che in origine, come
tutti gli antichi cortili, per ragioni di difesa, era chiuso da una robusta
porta.
La torre campanaria si trova, isolata, nella
piazzetta detta comunemente dagli anziani del quartiere Firriatu di
S. Michele, a pochi metri di distanza dalla chiesa omonima. Fu eretta,
secondo gli eruditi locali, nel 1550 dalla Confraternita di S. Michele. La
poderosa costruzione, di forme perfettamente geometriche, con base quadrata,
un parallelepipedo dalle nude superfici di conci a vista prive di finestre,
tranne una sul lato meridionale, ha tutte le caratteristiche di un'opera di
difesa. La sua struttura massiccia (i muri perimetrali hanno uno spessore di
oltre due metri) è assai simile a quella delle coeve opere di
fortificazione (Porta Salvatore, bastioni di S. Margherita e di S. Agata,
Porta S. Calogero, mura di Vega ecc.) costruite a Sciacca al tempo di Carlo
V (sec. XVI) quando più pressante era la minaccia di incursioni da parte
dei pirati barbareschi e il pericolo di uno sbarco dei Turchi.
Non a torto si ritiene che la torre sia stata originariamente innalzata per
l'avvistamento e successivamente utilizzata come campanile. Confermerebbe
questa ipotesi il fatto che la più grande delle campane collocate in cima
alla torre fu fusa nel 1587 cioè 37 anni dopo l'erezione dell'edificio, e
che i supporti in muratura che la reggono hanno tutti i caratteri di una
costruzione posticcia che, sia per la forma sia per la struttura, è in
netto contrasto con il possente fabbricato di pure forme geometriche. In
cima alla torre sono tre campane delle quali la maggiore, opera di Natale
Garbato, del 1587, pesa circa 1800 chili. Su quest'ultima, oltre alla data,
è la seguente Iscrizione: Piango i morti, respingo i fulmini, chiamo i
vivi.
Ai piedi della torre campanaria (lato sud-est), in via Gallo, sono alcune
abitazioni in grotta le cui origini risalgono a tempi remoti. Il luogo
è raggiungibile attraverso la scalinata che fiancheggia l'antica chiesetta
di S. Michele, detta via Pietre Cadute. Da questa via può
interessare raggiungere il cortile Grotte (dove sono altre abitazioni
scavate in parte nella roccia) sul quale si affacciano le finestre di una
casa d'età catalana, delle quali una reca incisa sull'architrave di pietra
la data 1559 e la sigla I H 5 (Jesus Hominum Salvator). La casa, che
appartiene alla famiglia Grisafi, si trova all'interno del cortile omonimo
al quale si accede attraverso un portale ad arco ribassato da via Amato.
Altre finestre cinquecentesche si affacciano sullo spiazzo Gallo
raggiungibile dal vicolo Castello.
 Chiesa
di S. Francesco da Paola Chiesa
di S. Francesco da Paola
Iniziata nel 1627, fu portata a termine nel 1749. Successivamente, il 7 maggio 1768
si aprì la chiesa. A una sola navata, secondo il gusto francescano
settecentesco, con crociera e cappelle affondate, ha nove altari.
Tra
le opere d'arte che si conservano in questa chiesa meritano particolare
menzione i dipinti Sacra famiglia, Madonna della Luce e Deposizione di
Mariano Rossi, e il Crocifisso ligneo sull'altare a sinistra provenienti
dalla demolita chiesa di Santa Lucia.
Quando
nel 1580 vennero a Sciacca i Padri Minimi di San Francesco di Paola, in un
primo tempo furono ospitati in alcune case annesse alla chiesa di S. Vito e
in seguito (1610) nella casa grande dei Signori Tommaso e
Giuseppe Medici e Tallarita, che fu adattata a convento con lavori che
si protrassero a lungo e furono portati a compimento nel quinquennio
1744-49.
Allo
stato attuale l'edificio conserva sostanzialmente integro il prospetto sulla
via Licata, mentre all'interno risulta manomesso a causa delle
trasformazioni subìte in relazione all'uso cui sono stati destinati i
locali del convento dopo la soppressione del'66.
Ospita
da vari anni l'Archivio Notarile. Distrettuale e altri uffici.
Chiesa
di S. Calogero

È
questa la terza chiesa eretta sul monte Kronio o pendici (la prima,
costruita subito dopo la morte di S. Calogero e dedicata a S. Maria di
Dolcevalle, si trovava in contrada Lucchesi, la seconda, dedicata a
S.Giacomo Apostolo, in contrada La Chiave).
La
costruzione, iniziata nel 1530 da don Mariano Manna, priore di S. Nicolò la
Latina, fu portata a termine nel 1644. Notevoli lavori all'interno della
chiesa e del convento attiguo furono compiuti nel XVIII sec. ad opera di
Diego Noguera e Giacomo Giuseppe Serra, due nobili spagnoli che, abbandonato
il secolo, vestirono l'abito degli eremiti di San Calogero, assumendo
rispettivamente il nome di Fra Placido e Fra Calogero. L'interno è di
età barocca. Sull'altare maggiore è una stupenda statua marmorea di San
Calogero, opera di Antonello e Giacomo Gagini (1535-38). Ai lati dell'altare
maggiore san due dipinti a olio dei primi del'900: a dx San Calogero
che scaccia i demoni dalla montagnadi Luciano Vitabile, e a sx San Calogero
che sale al monte di Benedetto Violante.
Sugli otto altari, ai lati dell'unica navata, sono varie opere di pittura
del Sei-Settecento non prive di qualche interesse. Lato destro: 1° altare, S.
Margherita da Cortona; 2°, S. Girolamo, dipinto su tela di forme michelangiolesche
e rosseggiante, che qualcuno vorrebbe attribuire al nostro Mariano Rossi; 3°,
Natività di Ignoto (sec. XVII); 4°, S. Ignazio di Lojola e S.
Francesco Saverio di Ignoto.
Lato
sinistro: 1° altare, S. Zosimo che fa la comunione a S.
Maria Egiziana, bella tela di Gaspare Testore, che ci dà la misura della
validità di questo dignitoso pittore saccense che fu degno maestro di
Mariano Rossi; 2° Immacolata di Ignoto; 3° Crocifisso reliquiario (sec.
XVII); 4° Madonna della Mazza patrona civitatis, di ignoto autore.
Tutti
gli altari sono in legno e di età barocca (sec. XVIII). I putti in stucco
sulle arcate delle cappelle, di gusto serpottiano, rappresentati in vivaci
atteggiamenti naturali, nonché le statue in gesso di Santa Rosalia e
di S. Maria Maddalena, sono dello scultore saccense Emanuele Bentivenga e
furono realizzati tra il 1914 e il 1918. La chiesa è stata elevata
alla dignità di Basilica Minore da Papa Giovanni Paolo II il 20 settembre
1979.
Attaccato al Santuario è il convento. L'antico eremo, fondato nel sec. XVI,
è stato ristrutturato e ammodernato alcuni anni or sono, dopo che, insieme
con la chiesa, è stato ceduto dall'Amministrazione dell'Ospedale di Sciacca
ai Padri del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco (1948).
Chiesa
del Collegio

È
una delle più belle chiese di Sciacca per la grandezza, per l'eleganza e
per la magnificenza dell'architettura. Sorge nell'area dov'era il palazzo di
G. B. Perollo, che fu demolito per dar luogo alla costruzione. È
dedicata a S. Giovanni Battista in omaggio al fondatore, G. B. Perollo,
il quale per erigere chiesa e Collegio dei Gesuiti donò quindicimila scudi.
La costruzione fu terminata nel 1626 ma i lavori di rifinitura all'interno
si protrassero fin verso la metà del '700. Fu aperta al culto dai Gesuiti
nel 1615, mentre era ancora incompleta. Fu consacrata il 16 ottobre 1825 dal
Vescovo di Siracusa, Mons. Giuseppe Amorelli, come si legge su una lastra di
marmo affissa al muro.
La facciata, incompleta, a sviluppo verticale, dallo schema che riecheggia
forme fondamentalmente manieristiche, è divisa in due ordini. Pilastri
binati (paraste) la dividono in tre campate nell'ordine inferiore, in due
nel superiore. La campata centrale, in basso, è animata da un elegante
portale barocco, costituito da corinzie e scanalate, impostate su alti
zoccoli e sormontate da timpano ad arco spezzato. Di sagoma barocca sono
anche le due nicchie (ai lati del portale) a forma di finestre a edicola.
L'interno, a pianta basilicale con una sola grande navata di tipo
vignolesco, (m. 62 x m. 24) fiancheggiata da cappelle con nove altari tra
loro comunicanti, e collegata con il presbiterio in modo da formare un continuum strutturale,
e con la cupola sull'intersezione del transetto con la navata. Componenti
interessanti della suggestiva atmosfera chiesastica sono l'organo, sei
tribune con le grate dorate dalle quali i religiosi una volta assistevano
alle sacre funzioni, la fastosa decorazione in stile rococò e i
bassorilievi in stucco eseguiti da maestranze locali nel 1765. Non mancano
opere d'arte pregevoli.
Sull'altare maggiore è una grande tela, raffigurante S. Giovanni
Battista, attribuita al Domenichino, e, ai lati del presbiterio, due teli
raffiguranti, a sinistra Decollazione di S. Giovanni e a
destra S. Giovanni che battezza Gesù, eseguite nel 1850 dal Sac.
Giovanni Patricolo, palermitano, allievo di Giuseppe Velasco e Giuseppe
Patania. Degni di nota anche quattro busti-reliquiari in legno dorato del
Seicento, simili a quelli esistenti nella Chiesa dei Cappuccini,
raffiguranti i Santi Cosma e Damiano. Altre opere d'arte sono nelle
cappelle. Lato destro della navata: nella prima cappella, I Re Magi,
tela di Giovanni Portaluni da Licata. In questo dipinto quello dei
tre Re Magi che guarda verso l'osservatore è forse il ritratto del pittore.
Gli altri due Re Magi guardano rapiti il Bambino. Nella seconda cappella,
Crocifisso ligneo di età barocca cui fa da sfondo un coevo grande
reliquiario dorato.

Ai
piedi della Croce, sulla destra, statua dell'Addolorata e Angelo piangente.
Lato sinistro: Nella prima cappella, immacolata, ovvero Incoronazione
di Maria, tela di Michele Blasco, e recentemente restaurata a cura della
Soprintendenza ai Beni Culturali (1987). Nella seconda e terza
cappella le statue del Cuore di Gesù e della Sacra Famiglia sono
lavori realizzati negli anni Venti. Nel braccio sinistro della crociera,
nella cappella dedicata al SS. Redentore, la statua proviene da Napoli
(1840). Sotto l'altare sono le reliquie di S. Privato. Ai lati a
sinistra, Trasfigurazione, a destra Trionfo della Croce,
dipinti su tela di Tommaso Rossi. Nel braccio destro della crociera,
sull'altare statua lignea di S. Alfonso, che regge con la sinistra il
Crocifisso e con la destra lo indica.
Ai lati dell'altare, S. Alfonso in estasi dinanzi alla visione della
Madonna e S. Alfonso che consegna la regola alle suore e ai padri
redentoristi, dipinti su tela di Tommaso Rossi. Dei due dipinti il
primo è copia di un originale attribuito a Domenico Provenzani (1736-1794).
Sotto l'altare, dentro un'urna, sono le reliquie di S. Vittore Martire. In
questa cappella si trova inoltre il sarcofago marmoreo di G. B. Perollo,
fondatore della chiesa. Altre opere d'arte si trovano in vari ambienti. In
un locale di passaggio, che dalla chiesa porta in sagrestia, è un ritratto
di Giovanni Portaluni, e un'epigrafe, che ricorda ai posteri che la chiesa
fu fondata a spese del munifico barone. Qui si trova pure una grande tela
raffigurante Gesù che regge la Croce. Altre due grandi tele si trovano
vis-a-vis nel corridoio che porta alla sagrestia. Di esse una rappresenta la Sacra
Famiglia, ed è copia dell'omonima opera di Mariano Rossi, esistente nella
chiesa di S. Francesco di Paola, eseguita dal figlio Tommaso, l'altra, la Pietà,
opera datata 1790, ma non firmata.
Altre opere meritevoli dell'attenzione degli amatori d'arte si trovano,
infine, nella sagrestia. Sono: Immacolata e Madonna di Trapani di
Michele Blasco, Madonna della Mazza e Santa Rosalia, Sacra
Famiglia e S. Agnese, Madonna e S. Stanislao che tiene in braccio Gesù
Bambino di autori ignoti.
Da
segnalare, infine, La morte di re Ciro, tela attribuita a Pietro
Novelli, il Monrealese, che attualmente si trova nel corridoio del piano
superiore, attuale dimora dei Padri Redentoristi. Per gli amatori degli
arredi di sagrestia c'è qui da ammirare un grande armadio barocco e per gli
intenditori un bellissimo chiavistello in ferro battuto recante la data 1631
e il nome del fabbro, Barresi. Sempre in sagrestia, una Addolorata in
cera, chiusa in cornice barocca a cassetta incassata nel muro. Un'altra
immagine sacra in cera dello stesso formato faceva pendant a questa ma non
si sa dove sia andata a finire.
Numerosissime
le reliquie: del legno della S. Corona, del braccio di S. Martino, dello
stinco di S. Saturnino e di S. Benigno, della spalla di S. Faustino e di S.
Marcello, della gamba di S. Simplicio, delle ossa di S. Vittorino, della
coste di S. Corona, della gamba di S. Pantaleone e di S. Massimo, della
testa di S. Proto ecc. ecc.
Chiesa
di San Domenico

Fondata
contemporaneamente al convento nel sec. XVI, è stata rifatta e
ampliata tra il 1776 e il 1791 su disegno di Ermenegildo Vetrano. Una
lapide, posta sopra la porta d'ingresso all'interno della chiesa, ricorda
inoltre che questa è stata restaurata nel 1859.
La facciata, semplice e severa, costruita, come
il lato nord della chiesa, con blocchetti di tufo conchigliare, è animata
dal portale, da una finestra, in asse con esso, e dall'aggettante cornice
sommitale, elementi che con le loro zone d'ombra sottolineano la nuda
superficie del paramento murario.
L'interno, di sobrie forme barocche, a una sola
navata, comprende otto cappelle (tre in più rispetto alla prima chiesa
fondata dal Fazello), oltre alla cappella maggiore. Sugli altari della
navata, a destra sono tre quadri raffiguranti: S. Tommaso d'Aquino, S.
Giacinto (179S), S. Domenico e una scultura, raffigurante il SS. Crocifisso.
A sinistra: SS. Crispino e Crispiniano, tela di Giuseppe Tresca, datata
1784, Assunzione della Vergine, lavoro giovanile di Giuseppe Sabella. Sul
dipinto si può leggere il nome del donatore e la data, 1804. Seguono
una statua del Sacro Cuore, e una statua lignea di S. Vincenzo Ferreri
che proviene dall'Oratorio della Congregazione, fondato nel 1650 e poi
rifatto nel 1770, che si trovava in fondo all'arcata destra della
portineria. Sull'altare maggiore, attorno al simulacro della Madonna
del Rosario, lo stellario è opera di Vincenzo Tresca Junior.
Lo stemma sulla volta dei presbiterio è della famiglia Del Medico. Dei due
seicenteschi sarcofaghi marmorei attualmente collocati all'inizio della
navata, quello a destra, di Giacomo Tagliavia, proviene dalla cappella
di S. Giacomo. Quello a sinistra conserva i resti di Caterina del Medico,
baronessa del Nadore e della Culla, figlia di Antonio Li Medici, fondatrice
della cappella gentilizia. Delle varie tombe di nobili famiglie
saccensi esistenti nella chiesa non rimane più traccia, essendo state di
recente distrutte le pietre tombali in occasione del totale rifacimento del
pavimento. Anche l'iscrizione riguardante l'antica sepoltura dei congregati,
collocata nel 1724 nella cappella dei SS. Crispino e Crispiniano, non esiste
più.
Il Convento, fondato nel 1534, fu ricostruito su progetto di P. M.
Ermenegildo Vetrano e portato a termine nel 1742. In seguito alla legge
della soppressione dei conventi del 1866, passato al demanio dello Stato, è
stato destinato a sede di vari uffici e scuole. All'interno di notevole c'è
il chiostro per il quale è previsto un radicale restauro per riportarlo
alle sue forme originarie, e, conservato in un locale attiguo, il portale
dell'antica chiesa di S. Luca Evangelista che si trovava vicino a Porta
Bagni.
Chiesa
di Santa Margherita

Era una
delle più ricche chiese di Sciacca. Gli anziani raccontano che il suo
pavimento di maiolica veniva lavato ogni anno con il moscato. È chiusa
al culto e completamente abbandonata dal 1907. Fu fondata nel 1342 da
Eleonora d'Aragona, nipote di Federico III d'Aragona e moglie di Guglielmo
Peralta, conte di Caltabellotta e capitano a guerra di Sciacca, che fu uno
dei quattro vicari del regno di Sicilia al tempo della regina Maria. Verso
il 1350 venne concessa ai Cavalieri Teutonici, che vi annerissero il loro
Ospizio o Grancia, che avevano stabilito pochi anni prima nella vicina
chiesetta di S. Gerlando (Ciaccio). Soppresso l'Ospizio, nel 1390 la
chiesa fu aggregata alla chiesa della Magione di Palermo al cui regio abate
era soggetta. Fu completamente trasformata e ampliata nel 1594, avendo il
ricco mercante catalano Antonio Pardo destinato, con testamento del 14
febbraio 1393, metà del suo patrimonio a beneficio della chiesa della
quale, a giusto titolo, è considerato secondo fondatore. Tracce della prima
chiesa, che è inglobata nella seconda, sono visibili all'esterno nei muri
perimetrali, specialmente nel lato meridionale.
Una visione globale dell'edificio si può avere da piazza del Carmine.
Isolata da tre lati, la chiesa si delinea nettamente come un blocco
geometrico dalle piatte superfici animate da ampie finestre e due portali,
mentre le paraste angolari e le possente trabeazione in pietra conchigliare
locale, sottolineano la geometria delle forme. Chiude l'alzato un
aggettante poderoso cornicione lapideo, sostenuto da una serie continua di
modiglioni finemente intagliati, dal quale sporgono, come bocche da fuoco,
10 pesanti gronde di pietra. Sulla facciata principale, che è rivolta a
occidente,notevole è l'originario portale, in stile gotico-catalano,
caratterizzato, al vertice, da un fiorone e ai lati, da due pilastri
ottagonali, posti quasi come contrafforti della triplice
ghiera a bastoni che continuano nei piedritti.
Un altro portale, di marmo bianco, eseguito nel 1468, impreziosisce con la
finezza dei suoi rilievi scultorei il lato settentrionale della chiesa.
Questo portale, quasi certamente, apparteneva alla prima chiesa fondata da
Eleonora d'Aragona e fu poi adattato alla seconda. Da un sommario esame
salta agli occhi, la discordanza stilistica tra l'arco inflesso del
fastigio, che è gotico, e l'arco della lunetta che è rinascimentale.
L'arco rinascimentale è un'aggiunta successiva e il suo inserimento tra
l'arco inflesso e l'architrave ha determinato lo spostamento dei due
pilastrini e l'aggiunta di lastre di marmo tra pilastrini e stipiti del
portale.
L'interno è una festa di colori: di oro,
di stucchi e di grandi bei quadri; ove si celebravano splendide funzioni
solenni. Entrando in chiesa, si è subito attratti dalla magnificenza
della decorazione barocca. Stupefacente è la decorazione del presbiterio e
del transetto eseguita da Orazio Ferraro, rinomato stuccatore siciliano del
Seicento. Angeli, santi, putti in stucco, medaglioni, volute, rabeschi,
festoni, ghirigori coprono tutte le superfici. Le pareti laterali del
presbiterio sono occupate da due affreschi di grandi proporzioni.
Raffigurano, quello a sinistra la Crocifissione, l'altro, a destra, la
Madonna dell'Itria. Sono di Orazio Ferraro, che, oltre che scultore, fu
anche pittore. Una serie di medaglioni, raffiguranti episodi della Via
Crucis, opera di Giovanni Portaluni orna l'intradosso dell'Arco Trionfale.
Anche nel transetto angeli e puttini in stucco del Ferraro, disposti in vari
atteggiamenti, formano un insieme ricco e fastoso. Movimentata una SS.
Trinità tra un coro di santi e angeli e non priva di delicatezza una
Annunciazione alla Vergine che indubbiamente è il lavoro più
interessante del Ferraro in questa chiesa. Rozzamente modellato appare
invece un Adamo gigantesco collocato a sinistra dell'Annunciazione.
Sempre nel transetto sono inoltre due quadroni, Adorazione dei Magi e
Nascita di Gesù di Gaspare Testone e un sarcofago con iscrizione latina,
recante la data 1602, nel quale sono conservate le ceneri di Antonio Pardo
che prima erano nella vicina chiesa di S. Gerlando. Passando dal transetto
alla navata, la decorazione si attenua, la plastica dello stucco si
appiattisce, le statue a tutto tondo cedono il posto a figure di minore
rilievo. Qui, sulle pareti spaziose sono sei grandi quadri, dipinti a olio,
del celebre pittore licatese Giovanni Portaluni.
Sul lato
destro della navata vi è l'unica cappella della chiesa ed è dedicata a S.
Barbara. Qui si trova una icona marmorea dallo schema compositivo simile a
quello della icona di A. Gagini che si trova nella Chiesa Madre. L'opera è
di Giuliano Mancino e di Bartolomeo Birrittaro, scultori carraresi operanti
nel '500 a Palermo. Nella stessa cappella si trova anche una bella tela di
Michele Blasco, pittore saccense del '600. Rappresenta l'invenzione del
corpo di S. Stefano ed è interessante esempio dell'arte di questo pittore
che nella violenza delle tonalità e nell'oscuro marcato delle ombre ci fa
vedere chiaramente la sua derivazione dall'arte tenebrosa che il Caravaggio
prima introdusse in Sicilia e che Pietro Novelli largamente diffuse
nell'isola. Anche gli altri dipinti, affreschi della volta e tele sulle
pareti (in alto) sono del Blasco e furono eseguiti nel 1658.
Chiesa
di Santa Maria dell'Itria

Sorge nella
parte piè alta della città e forma, insieme con l'annesso monastero, detto
comunemente Badia Grande, il complesso monumentale più imponente della città.
Fu fondata
nel 1380 dal conte Guglielmo Peralta, che fu uno dei quattro vicari del
regno di Sicilia dopo la morte di Federico III, e ricostruita di pianta tra
il 1776 e il 1784 su progetto dell'ing. Luciano Cambino di Trapani.
La facciata, dallo schema compositivo estremamente semplice nel primo
ordine, simile ad altre antiche chiese di Sciacca, assume slancio imponente
e preziosità barocche grazie alla sovrastante scenografica loggia e
all'attico.
L'interno,
a una sola navata, con sei cappelle, tre per lato, è ricco di decorazione
in oro zecchino e di opere d'arte. Sull'altare maggiore, è una tela
raffigurante Maria SS. dell'Itria e ai lati due tele S. Michele Arcangelo a
destra, e Angelo Custode a sinistra opere di Gaspare Testone. Dello stesso
pittore sono gli altri dipinti che sono: a dx sul primo altare Santa
Scolastica, sul secondo Sacra Famiglia, sul terzo S. Benedetto che rovescia
gli idoli e scaccia i demoni da Monte Cassino; a sinistra sul primo altare
Martirio di S. Eufemia, sul secondo Il transito di S. Giuseppe.
Altari e pavimenti sono tutti di marmo rosso di Sciacca. In chiesa c'è pure
una lapide sepolcrale delle religiose, sebbene esse siano sepolte nella
tomba che si trova dentro la clausura.
Chiesa
di San Nicolò La Latina

È la
chiesa più antica di Sciacca e uno dei più interessanti esempi di
quell'arte siculo-bizantina che, ricca di elementi d'arte islamica, fiorì
sotto la dominazione normanna. Risale al periodo più antico di tale
dominazione. Come quasi tutte le chiese di questo periodo, anche di S. Nicolò
la Latina si ignora il nome dell'architetto, si sa solo che fu fondata, tra
il 1100 e il 1136, dalla contessa Giulietta, figlia del gran conte Ruggero. La
chiesa, in parte nascosta da casupole addossate ai suoi lati, sorge in uno
dei quartieri più caratteristici di Sciacca che al tempo degli arabi e dei
normanni restava fuori la cerchia delle antiche mura e costituiva il borgo
del Rabato.
Dedicata a S. Nicolò di Bari, venne, nel 1172, denominata S. Nicolò la
Latina, perché in tale anno passò alle dipendenze dell'abazia di S.
Filippo di Argirò, a sua volta dipendente dal monastero benedettino di S.
Maria la Latina di Gerusalemme. Ad essa era annesso un monastero
benedettino, dalla fine del '500 non più esistente, del quale rimane
qualche traccia nell'attiguo cortile S. Nicolò, e un orto. S. Nicolò la
Latina è di piccole dimensioni e di estrema semplicità.
Un portale e tre finestre con le loro cornici a doppio rincasso ravvivano la
nuda superficie del paramento murario a piccoli conci, la cui parte
superiore aggetta leggermente su quella inferiore, creando un suggestivo
contrasto di luce e ombra.
Tre piccole
absidi di forma cilindrica, simili a quelle, imponenti come torri di
mastodontico castello, della coeva chiesa madre, anch'essa fondata dalla
contessa Giulietta, accentuano, con la loro perfetta geometria, i caratteri
arabi di tutto l'edificio.
La pianta è a forma di croce latina, con una sola navata, coperta da
soffitto ligneo e le nude pareti sono ravvivate in alto da piccole
finestre strombate che richiamano alla mente le feritoie del vicino castello
dei Luna. La nudità delle pareti e la mancanza di elementi decorativi,
insieme con la rustica semplicità del tetto a capriate, mettono
maggiormente in evidenza la bellezza e la coerenza strutturale e stilistica
della costruzione, dominata dalla solennità degli archi acuti su alti
piedritti, di pure forme islamiche, del transetto, del presbiterio e delle
absidi.
Costruzioni
civili

Posto
sulla vetta del monte Kronio, adiacente al Santuario del Santo, Il Grand
Hotel San Calogero è una delle opere incompiute più longeve d'Italia. Dal
1954, data di inizio dei lavori ad oggi, la struttura ha avuto ben due
ristrutturazioni ed altrettante inaugurazioni, ma non è mai stato aperto al
pubblico.
In
piazza Duomo si trova la Casa Museo Scaglione, che conserva oggetti
artigianali, ceramiche, tele ed oggetti vari d'inestimabile valore. Il
Bastione di Sant'Agata si trova in Piazza Mariano Rossi.
Degno
di nota è anche il Palazzo Manno, residenza settecentesca della nobile
casata siculo-fiorentina. L'edificio non è più visibile integralmente per
come era in passato, a causa delle ristrutturazioni a cui fu sottoposto per
essere trasformato in albergo nel XX secolo.
Non
poco lontano dalle terme vi è una colonna votiva con in cima una statua
bronzea raffigurante Notre-Dame de Fourvière. Tale colonna fu fatta
erigere per volere di don Michele Arena in seguito all'incidente del
dirigibile francese Dixmude nel 1923.
Pregevoli
sono le costruzioni civili: Palazzo Amato nell'omonima via del XIII secolo;
Palazzo San Giacomo Tagliavia, XV secolo, con le sue facciate in
stile impero sul Corso Vittorio Emanuele e in Via Licata e con quella forse
più ricca di fascino rivolta a levante sulla Piazza S. Fricia in stile
neogotico opera dell'architetto Gravanti; Palazzo Arone di Valentino sempre
in Corso Vittorio Emanuele del XIX secolo; Palazzo Bertolino-Tommasi dalla
candida facciata neoclassica opera dello stesso architetto Gravanti in Corso
Vittorio Emanuele; Palazzo Ventimiglia nel Vicolo Gino del XV secolo;
Palazzo Graffeo o Grifeo nel Vicolo Orfanotrofio del XVIII secolo;
Palazzo Inveges nell'omonima piazza del XVII secolo; Palazzo Maurici in
Piazza Scandagliato del XVIII secolo; Palazzo Ragusa in via Licata del 1770;
Palazzo Perollo in via Incisa del XV secolo e Palazzo Steripinto o
Sortino in via Gerardi del XVI secolo, esempio d'arte spagnola, Palazzo
Venuti. Tra le residenze di campagna si ricorda la Villa Venuti Tagliavia,
residenza settecentesca in stile barocco e che comprende anche una cappella.
Terme

I romani,
rinomati cultori delle terme, sfruttarono per primi e in modo compiuto le
acque calde di Sciacca chiamandole “Thermae Selinuntinae”. Le prime
notizie scritte sul loro utilizzo risalgono al Medioevo, quando nell’eremo
di San Calogero i religiosi le usavano per curare gli infermi.
Nel XVIII e
nel XIX secolo due scienziati, Bellitti nel 1783 e Farina nel 1864,
accertarono le qualità terapeutiche di queste acque sulfuree. Tra la fine
dell’800 e gli inizi del ‘900 fu inaugurato il collegamento ferroviario
per Sciacca, facendo di fatto uscire la cittadina dal suo isolamento: fu così
promossa la costruzione di uno stabilimento termale, che si sviluppò negli
anni ‘50, ma chiuse dopo pochi anni. Solo negli anni ‘70,
contestualmente alla costruzione di alberghi termali e due centri sanitari,
Sciacca è tornata in auge come località di turismo termale oltre che
balneare.
Il
patrimonio idro-termo-minerale di Sciacca è fra i più ricchi e completi,
ma storicamente non è stato del tutto utilizzato. Bagni e fanghi sulfurei
risultano efficaci per la cura di patologie osteoarticolari e reumatiche,
mentre inalazioni, nebulizzazioni, humages, irrigazioni e aerosol curano le
malattie dell’apparato respiratorio e la sordità rinogena. Il complesso
termale è dotato di attrezzature moderne utili anche per trattamenti
riabilitativi ed estetici.
Famose sono
anche le Grotte vaporose di San Calogero: secondo la leggenda furono opera
di Dedalo il quale convogliò in questi antri i vapori che emergevano dal
sottosuolo.
Ceramiche
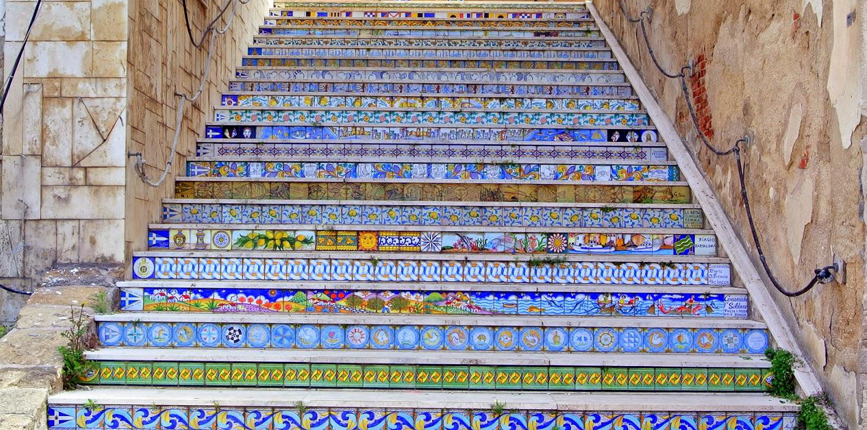
La
ceramica di Sciacca costituisce un importante elemento di attrazione per i
turisti e rappresenta il fiore all’occhiello della produzione artistica ed
artigianale della città.
A
Sciacca la tradizione del maestri maiolicari risale probabilmente al XIV
secolo, ma è solo 200 anni dopo che la città diventa una delle capitali
della ceramica artistica nazionale.
Ritrovamenti
di manufatti di ceramica di Sciacca a Gela e ad Agrigento confermano come la
maiolica saccense adornava i palazzi nobiliari dell'epoca. Il ritrovamento a
Sciacca di forni per la cottura e pezzi di maiolica consentono inoltre di
affermare che la città era centro di produzione e di commercializzazione di
ceramica fin dai tempi più remoti. I rinvenimenti danno la possibilità di
conoscere i nomi dei maestri che lavoravano la ceramica tra il XV e il XVII
secolo: Lu Xuto, Scoma, Francavilla, Piparo, Di Facio, Lo Boj, Bonachìa e
Lombardo.
La
ceramica saccense nei secoli ha contribuito all'arricchimento artistico di
monumenti, chiese e nell'arredamento urbanistico, come il Duomo di Monreale,
decorato con migliaia di mattoni del maestro Lombardo (1498), la locale
chiesa di S. Margherita, decorata con mattoni forniti dai maestri Scoma e
Francavilla (1496).
Attualmente
una cinquantina di botteghe producono, con le stesse antichissime tecniche
piatti, vasi, anfore, statue, piastrelle e oggetti di varie forme e
dimensioni nelle tradizionali sfumature dei colori del giallo, del verde e
del blu cobalto. I giovani che vogliono intraprendere questa preziosa
attività artigianale possono frequentare i corsi del Liceo Artistico
Bonachia ed ottenere il diploma d'istruzione superiore secondaria.
Da
anni in città si tenta di istituire un Museo della Ceramica, un luogo dove
esporre in modo permanente alcuni pezzi pregiati della maiolica saccense,
oggi custoditi nei musei di tutta Italia o in collezioni private. di Giuseppe
Recca
Carnevale

Città del
mare e della ceramica, Sciacca ospita una festa che conta oltre cento anni
di storia e che monopolizza ogni anno un pubblico di circa 200.000
visitatori, conquistando sul campo un ruolo di primissimo piano tra gli
appuntamenti del divertimento in Italia.
Le
origini del Carnevale di Sciacca risalgono forse all’epoca romana, quando
venivano festeggiati i Saturnali; con più probabilità si collocano nel
1616, quando il viceré di Sicilia Pedro Téllez-Girón (1574-1624), terzo
duca di Osuna, stabilì che l’ultimo giorno di festa tutti dovessero
vestirsi in maschera.
Le
prime manifestazioni sono ricordate come una festa popolare in cui venivano
consumate salsicce, cannoli, vino e il popolo si riversava per le strade,
travestito in vari modi. Successivamente furono fatti sfilare i primi carri
addobbati alla meglio, che portavano la gente in costume sulle sedie in giro
per le viuzze della città.
Negli
anni venti compare una grande piattaforma addobbata, trascinata da buoi o
cavalli, recante comitive in maschera.
Nel
dopoguerra i carri vennero intitolati, e iniziarono a fare chiaro
riferimento alle novità del progresso. Stelle filanti e coriandoli
incominciavano a essere lanciati dai carri in movimento.
Di
lì a poco, la folla in delirio fece sorgere le prime Compagnie di rivista,
e furono allestiti carri allegorici sempre più sofisticati che riprendevano
temi e personaggi locali in chiave satirica. Oggi i carri allegorici vengono
ideati, progettati e realizzati nei mesi antecedenti la festa, coinvolgendo
numerosi abitanti.

Il carnevale
di Sciacca si vive per le strade e per le piazze della città dove impazzano
dieci giorni di vivaci attività, con ospiti, grandiose sfilate in maschera
e maestosi carri allegorici. Il primo a parlare della festa popolare di
Sciacca è stato lo studioso palermitano Giuseppe Pitrè nel 1889, ma un
anno dopo lo storico saccense Ciaccio fa riferimento ad un
"Carnevale". Una volta la festa era una sorta di gioiosa
manifestazione cittadina con gente che si vestiva in maschera e si divertiva
ballanda e bevendo vino. C'era un personaggio, "Peppe Nappa", che
è stato adottato dai saccensi come maschera locale, un pupazzo di
cartapesta che apre e chiude la festa. Per oltre tre mesi migliaia di
giovani imparano musiche, canzoni, coreografie.
L'artigianato
locale, con ceramisti, pittori, scultori e artisti vari, è pienamente
coinvolto per la costruzione dei carri e delle maschere.
I carri
allegorici vengono costruiti ogni anno da gruppi ed associazioni di persone
che si riuniscono per realizzare nuove idee. Sono costruiti con cartapesta
ma con una struttura portante in ferro che permette di realizzare i
caratteristici movimenti che rendono unici i carri allegorici. Terminata la
costruzione, i singoli pezzi dei carri allegorici vengono trasportati e
quindi assemblati all'esterno.Poi le sfilate
per le vie della città e le esibizioni in piazza Scandaliato, dove ogni
carro dà vita anche ad una recita satirica in dialetto.
"Filippu
di li testi" e il suo giardino
Ai
piedi del monte Kronio, a pochi chilometri da Sciacca, sorge il Castello
Incantato, un museo-giardino unico nel suo genere, dall’atmosfera
grottesca e magica al contempo, dove si trovano migliaia di sculture
realizzate da Filippo Bentivegna, detto “Filippu di li testi”. Lo
spettacolo che appare al visitatore è straordinario, unione di creatività
umana e natura, dove, tra gli ulivi e i mandorli, si affacciano le teste
scavate e scalpellate nella roccia da uno dei maggiori esponenti dell’Art
Brut (o Outside Art).
Alla
domanda "Perché scavate nella pietra?” Rispose "Cerco la Grande
Madre... Dentro la terra è il seme dell'uomo."
 La
storia di Filippo Bentivegna ebbe origine a Sciacca il 3 maggio del 1888, le
tracce della sua vita e della sua famiglia giungono a noi tanto confuse
quanto scarne, dipanate solo da leggende e dicerie popolari. Ritenuto da
tutti un contadino, in effetti le sue origini familiari si dipartono dai
quartieri della marina di Sciacca dato che il padre era un pescatore, mentre
la madre era una laboriosa casalinga. La
storia di Filippo Bentivegna ebbe origine a Sciacca il 3 maggio del 1888, le
tracce della sua vita e della sua famiglia giungono a noi tanto confuse
quanto scarne, dipanate solo da leggende e dicerie popolari. Ritenuto da
tutti un contadino, in effetti le sue origini familiari si dipartono dai
quartieri della marina di Sciacca dato che il padre era un pescatore, mentre
la madre era una laboriosa casalinga.
Filippo,
nel 1913, imbracciò la classica valigia dell’emigrante per andare oltre
oceano, negli Stati Uniti, sulle orme dei suoi due fratelli maggiori e di
una sorella. Infatti, a Boston, lo aspettava la sorella ed in quella terra
il giovane emigrante analfabeta riponeva le speranze di una vita nuova. Ma
come sappiamo non tutti gli emigranti ebbero fortuna nel Nuovo Mondo e
Filippo Bentivegna fu tra questi.
Tante
sono le versioni che ci raccontano di questo sfortunato sogno Americano, ma
è accertato che il manovale saccense in terra d’America, subì un grave
trauma cranico per cui patì anche di amnesia e non fu più in grado di
lavorare: “considerato improduttivo e dichiarato inabile al lavoro fu
rimpatriato”.
Fra
le leggende che accompagnano questo ulteriore enigma del Bentivegna, si
narra che Filippo si accese d'amore per una bellissima donna dagli occhi
neri, ma questa era già promessa per cui l’ardito immigrato siciliano
sfidò il rivale ed ebbe la peggio subendo un colpo in testa che chiuse
definitivamente le porte degli Stati Uniti, ma aprì all’ignaro innamorato
le porte senza tempo dell’arte. Dopo circa sei anni dalla partenza fece
così ritorno alla nativa Sciacca, anche se quello che tornò era un Filippo
differente da quello che era partito.
Nel
1919, l'Italia era reduce dalla Grande Guerra ed il Bentivegna emigrante,
nel frattempo, essendo iscritto nelle liste della leva di mare era stato
dichiarato disertore e condannato in contumacia a tre anni di carcere, per
cui una volta rientrato allo scopo di eseguire la condanna venne sottoposto
ad una visita psichiatrica. La commissione di visita non ebbe alcun dubbio:
il disertore Filippo Bentivegna era pazzo.

Nella
sua città natale, con i soldi che era riuscito a risparmiare durante
l’avventura Americana, acquistò un appezzamento di terreno alle falde del
monte Kronio, ove si ritirò in eremitaggio per mezzo secolo e li realizzò
il suo “Castello incantato”. Museo a cielo aperto, sito culturale di
interesse unico.
Le
sue sculture sono tutte diverse e nel suo immaginario rappresentavano i
sudditi del regno da lui creato e di cui era Signore (amava infatti farsi
chiamare “Sua Eccellenza”). Al centro del podere sorge la casetta dove
egli viveva, le cui pareti sono decorate da disegni raffiguranti grattacieli
che ricordano il suo soggiorno in America e un pesce che contiene nel
proprio ventre un pesce più piccolo, probabilmente simbolo della traversata
dell’artista all’interno della nave che lo condusse a New York. Morì
nel 1967, all’età di settantotto anni. Un gruppo di quattordici sue opere
sono esposte presso il Museo dell’Art Brut di Losanna.
L'oro
di Sciacca

Esistono
al mondo ventisette specie di corallo rosso, ma solo cinque di esse sono
lavorabili. Tra queste vi è il Corallo di Sciacca, una tipologia dalle
caratteristiche uniche al mondo: si tratta infatti prevalentemente di un
sub-fossile già morto per un processo naturale - pertanto ecosostenibile -
e che presenta tonalità di colore diverse e uniche allo stesso tempo.
Grazie
al microclima eccezionale creatosi conseguentemente ai fenomeni vulcanici
(come ad esempio quello che diede origine all’Isola Ferdinandea), vennero
alla luce vaste estensioni di banchi di corallo che, a causa dei frequenti
terremoti e delle eruzioni, furono strappate dalla roccia vulcanica e si
depositarono sul fondale marino, dando origine a tre grandi giacimenti.
Nel
corso dei secoli, l’azione dei fanghi e dei gas vulcanici ne modificarono
la struttura genetica, trasformando il Corallo Rosso del Mediterraneo
(Corallium rubrurri), che cresce copioso di fronte a Sciacca, nello
straordinario e unico Corallo di Sciacca: esso si distingue per le
incredibili tonalità di colore che vanno dall’arancio intenso al salmone
rosa pallido, caratterizzato da macchie brunastre e talvolta nere proprio a
testimoniare e a “certificare” le sue origini vulcaniche.
Il
Corallo di Sciacca grezzo, appena pescato, appare opaco, mentre una volta
pulito e accuratamente lavorato presenta una lucentezza vitreo-porcellanosa.

Pag.
1  |