|
La
storia
di
una
città
è
fatta
(anche)
dai
suoi
nomi:
nel
nostro
caso,
alla
greca
Akràgas
seguono
la
romana
Agrigentum,
la
Girgenti
araba
e
normanna
e
infine,
dal
1927,
la
moderna
Agrigento
dei
nostri
giorni.
Un
unico
nome
in
forme
diverse
è
certamente
il
segno
di
una
storia
lunga
e
gloriosa,
ma
anche
complessa
e
tormentata,
ricca
assieme
di
gloria
e
di
contraddizioni.
La
colonia
greca
di
Akràgas,
secondo
la
tradizione,
fu
fondata
nel
582
a.C.
dagli
abitanti
di
Gela,
a
sua
volta
edificata
cent'anni
prima
da
coloni
di
stirpe
dorica
provenienti
da
Rodi
e
Creta.
La
tradizione
ci
ha
tramandato
anche
i
nomi
dei
due
uomini,
Aristonoo
e
Pistilo,
che
avrebbero
guidato
i
coloni
e
cui
spetterebbe
quindi
il
titolo
di
ecisti
cioè,
in
greco,
"fondatori"
della
città.
La
fase
più
antica
della
storia
di
Agrigento
è
legata
al
dominio
di
alcuni
tiranni,
sulla
cui
biografia
spesso
la
verità
storica
si
mescola
alla
leggenda.
Il
primo
è
Falaride,
che
sarebbe
stato
tiranno
della
città
per
oltre
quindici
anni,
fra
il
572
e
il
556
a.C.
Originario
secondo
alcune
fonti
dell'isola
greca
di
Astipalea
(oggi
Stampalia),
secondo
altre
rampollo
di
una
nobile
famiglia
di
Rodi,
giunse
ad
Agrigento
quando
la
città
era
ancora
un
gigantesco
cantiere
e
vi
esercitò
l'incarico
di
esattore
delle
imposte.
Ottenuto
un
importante
appalto
per
la
costruzione
del
tempio
di
Zeus
sull'acropoli,
Falaride
utilizzò
il
denaro
ricevuto
dalla
città
per
assoldare
un
piccolo
esercito
personale,
di
cui
si
servì
per
prendere
il
potere.
Potere
che
avrebbe
esercitato
con
il
pugno
di
ferro,
non
senza
una
buona
dose
di
sadismo.
La
leggenda
più
famosa
tramandata
su
di
lui
è
quella
che
riguarda
la
statua
di
bronzo
raffigurante
un
toro
a
grandezza
naturale,
vuota
all'interno
e
dotata
di
uno
sportello,
di
cui
si
sarebbe
servito
per
eliminare
gli
oppositori.
Questi
venivano
chiusi
all'interno
della
statua
collocata
sopra
un
falò
acceso,
fino
a
morire
fra
atroci
tormenti,
ustionati
dal
metallo
arroventato.
Ma
non
basta:
la
leggenda
vuole
che
il
tiranno
avrebbe
provato
un
particolare
piacere
nell'ascoltare
le
loro
grida
disperate,
grida
che
il
metallo
avrebbe
trasformato
in
suoni
simili
al
muggito
di
un
toro.
Fra
le
opere
pubbliche
più
significative
intraprese
da
Falaride
ci
fu
la
costruzione
della
prima
cinta
di
mura,
che
con
il
tempo
raggiunse
un'estensione
di
ben
dodici
chilometri.
Dotate
di
nove
porte,
le
mura
di
Agrigento
seguivano
sostanzialmente
la
conformazione
naturale
del
terreno,
in
quanto
Agrigento
venne
costruita
su
una
piattaforma
rocciosa
che
in
diversi
punti,
specialmente
a
sud,
si
eleva
a
strapiombo
sulla
piana
circostante.

Dopo
la
morte
di
Falaride,
nel
555
a.C,
Agrigento
attraversò
un
periodo
di
governo
oligarchico,
durato
quasi
settant'anni,
del
quale
abbiamo
scarse
notizie.
Sembra
che
in
questa
fase
il
potere
sia
stato
esercitato
da
una
"Assemblea
dei
Mille",
mentre
in
città
veniva
progressivamente
affermandosi
il
potente
clan
degli
Emmenidi,
che
nel
488
a.C.
presero
il
potere
con
l'inizio
della
tirannia
diTerone.
Secondo
la
tradizione,
Terone
rimase
al
potere
per
quasi
vent'anni
(fino
alla
morte,
nel
472
a.C),
riprendendo
in
politica
estera
l'approccio
aggressivo
di
Falaride,
espandendo
il
territorio
controllato
da
Agrigento
verso
Gela,
Selinunte
e
Himera.
Queste
mire
espansioniste
furono,
tuttavia,
accompagnate
da
un'accorta
strategia
diplomatica
che
culminò
con
il
doppio
matrimonio
tra
sua
figlia
e
Gelone,
tiranno
prima
di
Gela
e
successivamente
di
Siracusa,
il
quale
gli
offri
la
mano
della
nipote.
Ma
nel
frattempo
una
nuova
minaccia
incombeva
sull'intero
mondo
greco:
guidati
dal
re
Serse,
i
Persiani
erano
intenzionati
a
invadere
la
Grecia.
Questo
progetto,
dopo
la
vittoria
alle
Termopili,
fu
vanificato
dalla
sconfitta
nella
battaglia
navale
di
Salamina,
nel
480
a.C.
Contemporaneamente
Cartagine,
che
controllava
la
parte
occidentale
della
Sicilia
e
aveva
il
suo
centro
nevralgico
nella
colonia
di
Palermo,
decise
di
scendere
in
guerra
contro
le
colonie
greche
dell'isola
per
ottenerne
il
controllo.
La
battaglia
decisiva
si
svolse
sulla
terraferma,
nei
pressi
dell'antica
Himera.
Anche
in
questo
caso,
come
a
Salamina,
la
vittoria
arrise
ai
Greci
e
permise
ad
Agrigento,
nonostante
i
rapporti
con
Siracusa
non
fossero
sempre
sereni,
di
assurgere
al
ruolo
di
grande
potenza
all'interno
della
Sicilia.
 Nei
pressi
del
tempio
di
Eracle
sorge
un
monumento
che
per
secoli
la
fantasia
popolare
identificò
con
la
tomba
di
Terone:
in
realtà
si
tratta
di
un
edificio
di
età
romana. Nei
pressi
del
tempio
di
Eracle
sorge
un
monumento
che
per
secoli
la
fantasia
popolare
identificò
con
la
tomba
di
Terone:
in
realtà
si
tratta
di
un
edificio
di
età
romana.
Alla
morte
di
Terone,
nel
472
a.C.,
il
potere
ad
Agrigento
passò
nelle
mani
del
figlio
Trasideo,
cui
il
padre
aveva
in
precedenza
assegnato
il
governo
di
Himera.
Secondo
lo
storico
Diodoro
Siculo,
il
suo
potere
sarebbe
durato
solamente
pochi
mesi:
sconfitto
in
battaglia
da
Cerone,
tiranno
di
Siracusa,
fu
deposto
e
la
tirannide
sostituita
da
un
governo
oligarchico.
Iniziò
allora
un
periodo
piuttosto
confuso
della
storia
agrigentina,
sul
quale
le
fonti
antiche
non
offrono
molte
certezze.
Quel
che
sappiamo
è
che
alla
prosperità
economica
si
accompagnò
un
clima
politico
molto
teso
all'interno
della
città,
a
causa
degli
scontri
tra
fazione
oligarchica
e
fazione
democratica.
A
questo
periodo,
caratterizzato
da
grande
prosperità
economica,
risale
l'edificazione
dei
templi
dedicati,
secondo
la
tradizione,
a
Giunone,
ad
Asclepio,
a
Vulcano
e
alla
Concordia.
Secondo
lo
storico
Diodoro
Siculo,
in
quest'epoca
la
città
arrivò
a
contare
duecentomila
abitanti,
di
cui
almeno
ventimila
erano
cittadini
con
pieni
diritti.
Dopo
la
fallita
spedizione
ateniese
contro
Siracusa
dell'anno
415
a.C,
sull'isola
si
impose
progressivamente
l'egemonia
di
Cartagine,
che
conquistò
Himera
nel
409
a.C.
e
nel
406
espugnò
e
distrusse
la
stessa
città
di
Agrigento.
Nei
decenni
successivi
la
città
cercò
faticosamente
di
recuperare
il
prestigio
perduto,
dapprima
alleandosi
con
Siracusa
contro
Cartagine
in
un
lungo
conflitto
dagli
esiti
alterni.
La
rifondazione
di
Agrigento
fu
guidata
secondo
la
tradizione,
da
Magillo
e
Feristo
a
capo
dei
coloni
provenienti
da
Elea
(nell'attuale
provincia
di
Salerno).
A
seguito
di
questi
eventi
la
città
conobbe
una
nuova
fase
di
fioritura
economica
e
architettonica,
testimoniata
dai
ritrovamenti
archeologici
relativi
al
cosiddetto
"quartiere
ellenistico-romano";
per
quanto
riguarda
invece
l'edilizia
pubblica,
sempre
a
quest'epoca
risalgono
le
nuove
sedi
del
governo
cittadino,
destinate
ad
accogliere
l'assemblea
dei
cittadini
e
il
"governo"
della
città.
Il
III
secolo
a.C.
fu
un
periodo
determinante
per
la
storia
di
Agrigento.
Ebbe
inizio
con
un
avvenimento
di
grande
importanza
simbolica,
cioè
la
distruzione
della
madrepatria
Gela
nel
282
a.C.
ad
opera
del
tiranno
Finzia
e
proseguì
con
la
sconfitta
subita
ad
opera
dell'esercito
siracusano
nel
280.
A
quest'epoca
risalgono
alcune
guerre
fra
Roma
e
Cartagine,
note
come
Prima
(264-241
a.C.)
e
Seconda
guerra
punica
(218-202
a.C);
Agrigento
scelse
l'alleanza
con
i
vecchi
nemici
cartaginesi,
e
ne
pagò
le
conseguenze.
Nel
262
a.C,
infatti,
fu
cinta
d'assedio
da
due
eserciti
consolari
che
riuscirono
a
conquistarla
dopo
sette
duri
mesi
d'assedio,
nel
corso
dei
quali
i
Romani
subirono
anche
un
attacco
cartaginese
dall'esterno,
che
riuscirono
tuttavia
a
respingere
riportando
una
vittoria
decisiva
in
quella
che
è
nota
come
"battaglia
di
Agrigento
".
La
città
fu
abbandonata
al
saccheggio
e
più
di
20.000
dei
suoi
abitanti
furono
venduti
come
schiavi.
Il
poco
che
sopravvisse
fu
a
sua
volta
distrutto
dai
Cartaginesi
allorché
ripresero
la
città
nel
255
a.C.
Nel
corso
della
Seconda
guerra
punica
Roma
dovette
di
fatto
riconquistare
e
pacificare
nuovamente
l'intera
Sicilia,
occupata
dagli
eserciti
cartaginesi
nel
213
a.C.
La
riconquista
di
Agrigento
da
parte
del
console
Marco
Valerio
Levino,
nel
210
a.C,
costituì
di
fatto
l'ultimo
atto
della
campagna;
la
città
fu
nuovamente
saccheggiata
dai
legionari
e
ancora
una
volta
moltissimi
cittadini
furono
venduti
come
schiavi.
Proprio
a
Levino,
secondo
alcune
fonti,
si
deve
l'avvio
della
trasformazione
del
territorio
di
Agrigento,
così
come
dell'intera
Sicilia,
in
quello
che
verrà
poi
chiamato
il
"granaio
di
Roma".
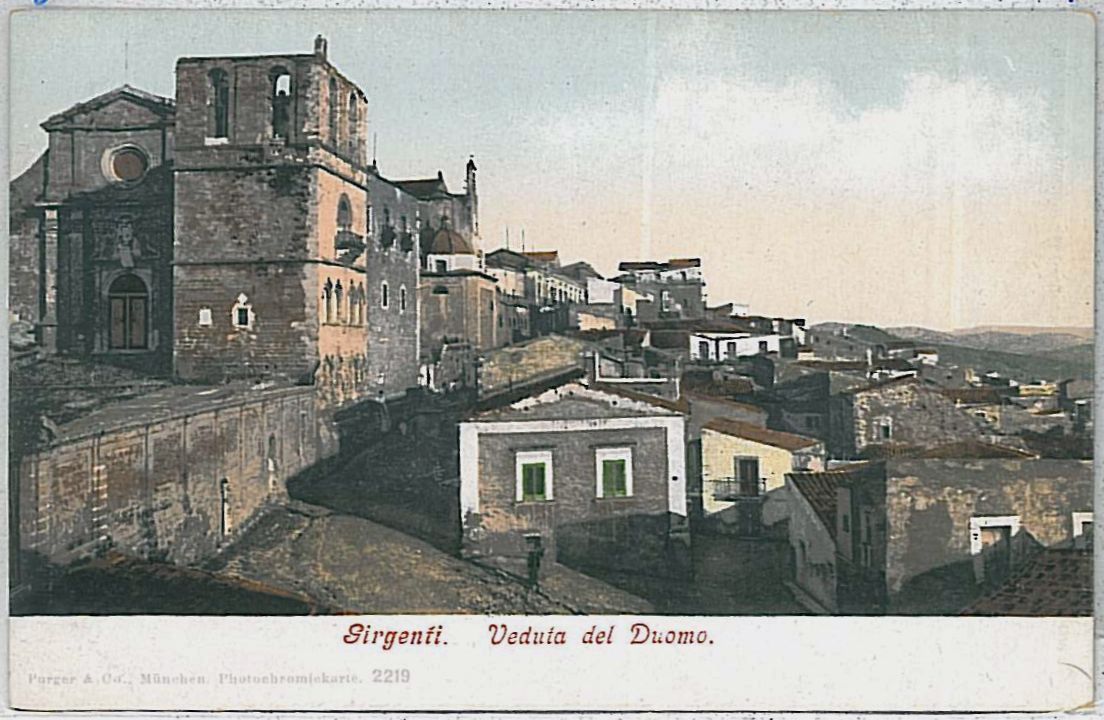
Proprio
l'agricoltura,
assieme
al
commercio,
consentirono
alla
città
di
mantenere
una
discreta
prosperità
nel
corso
degli
ultimi
due
secoli
della
repubblica.
Prosperità
che
conobbe
di
fatto
solo
tre
battute
d'arresto
significative.
Le
prime
due
in
occasione
delle
rivolte
degli
schiavi
che
sconvolsero
l'intera
Sicilia
fra
il
136
e
il
132
a.C.
e
poi
nuovamente
fra
il
104
e
il
99
a.C;
la
terza
nel
corso
dei
tre
anni,
fra
il
73
e
il
71
a.C,
in
cui
fu
propretore
dell'isola
il
famigerato
Gaio
Licinio
Verre,
il
quale
si
macchiò
di
soprusi
e
ruberie
di
ogni
genere.
A
seguito
delle
prove
a
suo
carico
raccolte
da
Cicerone
in
occasione
del
processo
che
i
Siciliani
gli
intentarono
nell'anno
70,
Verre
abbandonò
Roma
e
l'Italia
prima
ancora
della
sentenza,
rinunciando
alle
sue
ambizioni
politiche.
Fra
le
vittime
dei
suoi
saccheggi
di
opere
d'arte
c'era
anche
Agrigento,
cui
il
propretore
aveva
sottratto
una
statua
in
marmo
di
Apollo
ospitata
nel
tempio
di
Asclepio.
Solo
la
pronta
reazione
dei
cittadini
aveva
invece
impedito
il
furto
della
statua
in
bronzo
di
Eracle,
realizzata
dal
grande
artista
Mirane
nel
V
secolo
a.C.
e
conservata
nel
tempio
consacrato
all'eroe.
Senza
contare
le
centinaia
di
"appropriazioni
indebite"
perpetrate
all'interno
di
case
private.
Con
l'avvento
al
potere
di
Augusto,
quarantanni
più
tardi,
si
ebbe
la
piena
assimilazione
al
nuovo
regime
imperiale
della
città
di
Agrigento,
elevata
al
rango
di
municipium:
i
suoi
cittadini
ottennero
in
tal
modo
la
cittadinanza
romana.
In
questa
fase
la
città
conobbe
una
notevole
prosperità
economica
grazie
all'agricoltura,
all'allevamento,
alle
attività
estrattive
legate
in
particolare
allo
sfruttamento
delle
miniere
di
zolfo
e,
naturalmente,
alla
presenza
del
suo
porto,
uno
dei
pochi
che
sorgeva
sulla
costa
meridionale
dell'isola.
La
ricchezza
raggiunta
dall'aristocrazia
terriera
ed
imprenditoriale
della
città
è
testimoniata
in
particolare
da
diverse
abitazioni
private,
scoperte
dagli
archeologi,
nonché
di
alcune
tombe
della
grande
necropoli
che
sorse
a
sud
della
Valle
dei
Templi.
Con
il
tardo
impero
e
poi
la
successiva
della
caduta
dell'impero
d'occidente,
nel
476
d.C,
iniziò
infine
la
decadenza
della
città,
testimoniata
storicamente
e
archeologicamente
dal
fatto
che
gran
parte
dell'antica
area
urbana
venne
progressivamente
abbandonata
e
gli
abitanti
si
ritirarono
sulla
collina
di
Girgenti,
nell'angolo
nord-occidentale
della
città.
A
partire
dall'anno
828-829,
quando
fu
conquistata
dagli
arabi,
Agrigento
conobbe
una
momentanea
rinascita
economica
e
demografica,
unita
ad
un
profondo
riassetto
della
struttura
urbana.
I
nuovi
occupanti
ne
fecero
la
loro
capitale
ribattezzandola
Gergent,
Girgenti,
nome
che
la
città
mantenne
fino
al
1927.
Conquistata
dai
Normanni
nel
1087,
l'anno
successivo
la
città
venne
elevata
a
sede
vescovile
con
la
nomina
a
vescovo
di
Gerlando
di
Besancon
che
resse
la
diocesi
per
dodici
anni
(1088-1100).
Durante
il
suo
episcopato
fu
promotore
non
solo
della
costruzione
della
Cattedrale
(1096-1102),
che
venne
edificata
nell'area
più
rilevante
della
città
e
dedicata
alla
Vergine
e
a
San
Giacomo,
ma
anche
della
fortificazione
del
castello
di
Agrigento
da
cui
successivamente
la
città
prese
nome.
Proclamato
santo
nel
1159,
divenne
patrono
della
città
e
a
lui
venne
dedicata
la
Cattedrale.
Successivamente,
nel
corso
del
secolo
XIV
le
potenti
famiglie
dei
Chiaramonte
e
dei
Montaperto
costruirono
una
nuova
cinta
di
mura
al
cui
interno
furono
ospitati
i
conventi
di
San
Francesco
e
San
Domenico.
Una
nuova
fase
di
incremento
demografico
e
di
espansione
urbana
si
ebbe
a
partire
dal
secolo
XVIII;
l'elevazione
di
Girgenti
a
capoluogo
di
provincia,
nel
1817,
sancì
di
fatto
l'avvenuta
rinascita
di
questa
antica
e
gloriosa
città.
Centro
storico

Il centro
storico
di
Agrigento è
individuabile
sulla
sommità
occidentale
della
collina
dell'antica
Girgenti.
Risalente
all'età
medioevale
del
XI
e
XV,
conserva
ancora
oggi
vari
edifici
medioevali
(chiese,
monasteri,
conventi
e
palazzi
nobiliari).
Da
aprile
del 2016 è
tornato
a
chiamarsi
ufficialmente Girgenti,
toponimo
dell'intera
città
dismesso
nel 1927 su
volere
di Benito
Mussolini.
Nel
centro
storico
sono
custodite
significative
testimonianze
dell'arte
arabo-normanna,
tra
cui
in
particolare
la
cattedrale
di
San
Gerlando,
il
Palazzo
Steri
sede
del
seminario,
il
palazzo
vescovile,
la
Basilica
di
Santa
Maria
dei
Greci
ed
il
complesso
monumentale
di
Santo
Spirito
e
le
porte
delle
cinta
muraria.
Dal
disegno
di
autore
Anonimo
del
1584,
tratta
dall'Atlante
Storico
della
Sicilia di
L.
Dufour,
si
rileva
una
rara
immagine
della
città
medievale,
circondata
da
una
cinta
muraria
e
da
un
tessuto
urbano
poco
differenziato.
In
alto
spiccano
i
più
importanti
edifici
quali
lo
Steri,
la
Cattedrale,
il
Castello,
la
Chiesa
di
Santa
Maria
dei
Greci.
Al
centro
si
nota
un
burrone
che
taglia
a
metà
il
Colle,
detto
della
Via Bac
Bac.
Ancora
non
sono
visibili
altri
edifici
che
verranno
costruiti
successivamente
alla
stampa
del
disegno.
Il
Centro
Storico
di
Agrigento
è
databile
intorno
al
XI
e
il
XIII
secolo,
sorto
per
necessità
difensive,
logistiche
e
commerciali,
in
relazione
alla
vicinanza
del
porto.
Gli
ultimi
abitanti
dell'antica
Akragas,
minacciati
dall'invasione
musulmana
e
per
l'eccessiva
vicinanza
delle
antiche
mura
troppo
estese
e
quasi
vicine
al
mare,
si
arroccarono
nel
colle
occidentale
dell'Acropoli,
dove
costruirono
un
Castello
ed
un
recinto
murario
attorno
alla
città
medioevale
che
poi
prese
il
nome
di
Girgenti,
creando,
quindi,
una
vera
e
propria
fortezza.
Anche
se
le
condizioni
di
vita
risultarono
decadenti,
iniziò
l'espansione
urbanistica
all'interno
della
città
muraria,
passando
dalla
città
antica
a
moderna,
arricchendo
l'abitato
con
Palazzi,
Chiese
e
Monasteri,
artisticamente
influenzate
da
scambi
culturali
arabo-normanna.
Nel
XIV
secolo
si
diffuse
in
Sicilia
uno
stile
architettonico
che
prese
il
nome
di Stile
chiaramontano.
Si
tratta
di
applicazioni
in pietra
bianca
di
Comiso con
modanature
a
zig
zag,
incastonate
nelle
ghiere
merlettate
di
portali
e
bifore
a
sesto
acuto,
con
il
fine
da
rendere
più
suggestive
e
abbellire
le
facciate
esterne
ed
interne
di
Chiese,
Palazzi,
Monasteri,
conventi
e
ospedali.

Le
mura
La
costruzione
delle
prime
mura
di
Agrigento
ebbe
inizio
quasi
certamente
fin
dall'epoca
del
primo
tiranno,
Falaride
(572-556
a.C),
e
venne
proseguita
all'epoca
di
Terone
(488-472
a.C).
Oggi
buona
parte
di
queste
imponenti
fortificazioni
è
scomparsa
a
seguito
dello
sviluppo
della
città
moderna,
ma
in
epoca
antica
si
trattava
di
un
circuito
di
ben
12
chilometri
che
racchiudeva
al
suo
interno
una
superficie
di
quasi
450
ettari,
dalla
Valle
dei
Templi,
a
sud,
fino
alla
Collina
di
Girgenti,
a
nord-ovest:
decisamente
eccessiva
rispetto
alle
reali
esigenze
urbanistiche
della
città,
tanto
che
diverse
aree
comprese
all'interno
delle
mura
rimasero
di
fatto
inabitate
e
furono
utilizzate
per
attività
agricole
e
pastorali.
Questa
particolare
situazione
era
frutto
certamente
di
una
volontà
propagandistica,
ma
anche
e
soprattutto
del
fatto
che
le
mura
furono
realizzate
sfruttando
l'elevazione
naturale
del
terreno:
Akragas
fu
costruita
su
un
altopiano
di
natura
calcarea
che
si
eleva
dal
territorio
circostante
con
pareti
in
generale
molto
scoscese.
Le
difese
offerte
dalla
natura,
unite
all'intervento
dell'uomo,
offrivano
pertanto
alla
città
un
formidabile
sistema
difensivo,
dotato
anche
di
torri
di
avvistamento,
che
nel
corso
della
plurisecolare
storia
della
città
ne
garanti
in
diverse
occasioni
la
salvezza,
o
costituì
comunque
per
i
nemici
un
ostacolo
particolarmente
difficile
da
superare.
Agli
occhi
di
un
osservatore
esterno
la
città
doveva
apparire
difesa
da
una
muraglia
ininterrotta
formata
dalla
roccia
naturale,
in
alcuni
tratti
appena
sbozzata
dalle
mani
dell'uomo,
integrata
da
settori
evidentemente
artificiali,
realizzati
con
blocchi
di
pietra
calcarea.
In
mancanza
di
testimonianze
dettagliate
sulle
diverse
fasi
di
realizzazione
della
cinta
muraria,
gli
archeologi
hanno
ipotizzato
che
la
sua
realizzazione
abbia
preso
l'avvio
dal
versante
meridionale
dell'altopiano,
la
cosiddetta
Collina
dei
Templi,
meno
elevato
e
pertanto
più
facilmente
aggredibile.
A
nord
la
parete
dell'altopiano
scende
praticamente
verticale
sulla
piana
sottostante,
mentre
a
est
e
a
ovest
una
formidabile
difesa
naturale
è
assicurata
dai
profondi
valloni
scavati
nel
corso
dei
millenni
dai
fiumi
Akragas
e
Hypsas
(oggi
rispettivamente
San
Biagio
e
Sant'Anna).
Nel
circuito
delle
mura
vennero
aperte
diverse
porte,
destinate
a
collegare
la
città
con
il
suo
vasto
territorio.
Gli
archeologi
ne
hanno
identificate
ben
nove:
due
a
est
(Porte
I
e
Porta
II),
tre
a
sud
(Porta
III,
Porta
IV
e
Porta
V),
due
a
ovest
(Porta
VI
e
Porta
VII)
e
due
a
nord
(Porta
Vili
e
Porta
IX).
L'esistenza
infine
di
una
decima
porta
a
nord
è
stata
fino
ad
ora
solamente
ipotizzata.
Porta
II
e
Porta
VI,
chiamate
anche,
rispettivamente,
Porta
di
Gela
e
Porta
di
Eraclea,
collegavano
Agrigento
alla
grande
arteria
che
attraversava
la
Sicilia
meridionale
collegando
il
territorio
di
Agrigento
con
quello
di
Gela
(a
est)
e
di
Selinunte
(a
ovest).
Di
particolare
suggestione
è
certamente
Porta
II
alla
quale
si
accedeva
percorrendo
una
strada
scavata
nella
viva
roccia
sulla
quale
sono
ancora
perfettamente
visibili
i
solchi
tracciati
dalle
ruote
dei
carri
che
per
secoli
la
percorsero,
portando
uomini
e
merci
dentro
e
fuori
la
città.
Questo
accesso
era
inoltre
difeso
da
ben
tre
torrioni,
uno
più
grande
e
due
di
dimensioni
minori.
Da
Porta
IV
(nota
anche
come
Porta
Aurea
forse
già
a
partire
dall'età
bizantina),
ubicata
nel
giardino
di
Villa
Aurea,
tra
i
templi
della
Concordia
(a
est)
e
quello
di
Èrcole
(a
ovest),
partiva
la
strada
che
collegava
la
città
al
suo
porto.
Parzialmente
demolite
a
seguito
della
conquista
cartaginese
nel
406
a.C.,
le
mura
furono
riedificate
dopo
il
339
all'epoca
di
Timoleonte.
Il
circuito
non
cambiò
rispetto
a
quello
originario
e
neppure
i
materiali
di
costruzione;
diversi
ingressi
alla
città,
come
Porta
II,
Porta
III,
Porta
IV
e
PortaVI,
vennero
ricostruiti
e
dotati
di
possenti
baluardi
difensivi
e
torri
di
avvistamento.
In
particolare
all'esterno
di
Porta
II
(la
Porta
di
Gela)
fu
realizzato
un
bastione
a
tenaglia,
costituito
da
due
muraglioni
fra
loro
paralleli,
che
resero
l'accesso
praticamente
inespugnabile
da
parte
di
eventuali
nemici.
Nuovi
lavori
di
ristrutturazione
furono
realizzati
ancora
nel
III
secolo
a.C,
utilizzando
questa
volta
una
tecnica
di
tradizione
romana:
due
cortine
parallele,
una
esterna
e
una
interna,
riempite
di
pietrame
e
materiale
di
risulta.
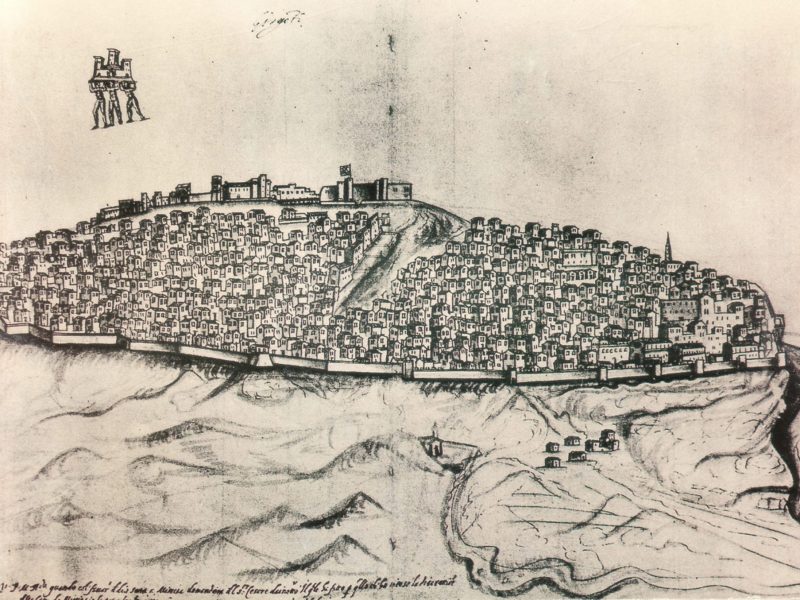
 Pag.
2
Pag.
2
Agosto
2018
|